ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
|
|
|
- Italo Martina
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
2
3 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), novembre 2006 FIRENZE 2012
4 ENTI PROMOTORI Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e P.I. Comune di San Cipirello Unione de Comuni Monreale Jetas Centro Siciliano di Preistoria e Protostoria Archeoclub di Corleone COMITATO D ONORE A. Buttitta, N. Bonacasa, E. De Miro, S. Lagona, V. La Rosa, G. Rizza, E. Tortorici, M. Tosi, V. Tusa, G. Voza CON IL SOSTEGNO DI Soprintendenza BB CC AA Agrigento Soprintendenza BB CC AA Caltanissetta Soprintendenza BB CC AA Catania Soprintendenza BB CC AA Enna Soprintendenza BB CC AA Messina Soprintendenza BB CC AA Palermo Soprintendenza BB CC AA Ragusa Soprintendenza BB CC AA Siracusa Soprintendenza BB CC AA Trapani Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini Museo Archeologico Regionale, Agrigento Museo Archeologico Regionale A. Salinas, Palermo Museo Archeologico Regionale P. Orsi, Siracusa Museo Agostino Pepoli, Trapani Museo Archeologico Regionale della Villa del Casale di Piazza Armerina Museo Archeologico Regionale di Camarina Museo Archeologico Regionale di Gela Museo Archeologico Regionale Eoliano L. Bernabò Brea Museo della Ceramica di Caltagirone Museo di storia naturale e del carretto di Palazzo d Aumale, Terrasini Parco Archeologico Regionale di Agrigento COMITATO SCIENTIFICO Paleolitico e Mesolitico: M.R. Iovino, F. Martini Neolitico: V. Tinè, S. Tusa Eneolitico: A. Cazzella, D. Cocchi Genik, L. Maniscalco Età del Bronzo: N. Bruno, M. Cavalier, M.C. Martinelli, F. Nicoletti, E. Procelli, S. Tusa Età del Ferro: R.M. Albanese Procelli Interazioni Sicilia - Mediterraneo: A.M. Bietti Sestieri, M. Marazzi Coordinamento: S. Tusa SEGRETERIA ORGANIZZATIVA C. Buccellato, A. Scuderi, A. Vintaloro, E. Viola REDAZIONE DEGLI ATTI Enrico Procelli In copertina: Vaso della cultura di Serrafarlicchio Istituo Italiano di Preistoria e Protostoria, 2012 Via S. Egidio, Firenze tel. 055/ fax 055/ iipp@iipp.it
5 COMUNICAZIONI Paleolitico-Mesolitico
6
7 SALVATORE CHILARDI * - ALESSANDRO DE DOMINICIS ** - DANIELA ZAMPETTI ** La frequentazione preistorica di Grotta Emiliana (Erice, TP) LO SCAVO Nell ambito di un progetto avviato nel 2004, volto ad approfondire la conoscenza della frequentazione preistorica delle grotte del trapanese, sotto la direzione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani ed in collaborazione con la cattedra di Paletnologia dell Università La Sapienza di Roma 1, è stata avviata una campagna di indagini archeologiche a Grotta Emiliana, nel territorio del comune di Erice (TP), situata a NE dell abitato moderno di Trapani (fig. 1A). La grotta, posta a circa 55 m slm, si affaccia verso il mare e dista circa 200 m dall attuale linea di costa e fa parte di un complesso al quale appartengono altre due grotte, Grotta Polifemo (in cui sono state trovate pitture preistoriche su parete) e Grotta del Maltese (Chilardi et alii in questo volume), poste lungo la stessa falesia, ai piedi del Monte S. Giuliano e anch esse inserite nel medesimo progetto di ricerca (fig. 1B). La cavità ha una profondità massima di ca. 25 m ed una larghezza media di ca. 20 m con un ampia apertura, di ca. 25 m, orientata verso NW. Lungo le pareti (fig. 2) si notano alcune rientranze e cunicoli di origine naturale: una, stretta e profonda oltre 4 m, posta lungo la parete di fondo sud-orientale, un altra, invece, lungo la parete meridionale. Una nicchia si apre sulla parete orientale ma ad una quota superiore (ca. 2 m) rispetto all attuale piano di calpestio: probabilmente essa rappresenta un antico solco di battente. La grotta era già nota in letteratura, poiché esplorata verso la fine * Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa - Laboratorio di Scienze e Tecniche Applicate all Archeologia, via Santa Caterina da Siena 37 I, Napoli; chilasher@netscape.net. ** Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell Antichità - Università degli Studi di Roma La Sapienza, Via Palestro 63, Roma; tel. 06/ ; e- mail: alededominicis@tiscali.it; daniela.zampetti@uniroma1.it. 1 Progetto POR Sicilia , Itinerario grotte preistoriche del trapanese coordinato dal prof. S. Tusa.
8 11. chilardi - de dominicis - zampetti copia.qxp:campione_17x24_daniela 276 S. CHILARDI :12 - A. DE DOMINICIS - D. ZAMPETTI Fig. 1 - Grotta Emiliana : A) Localizzazione su supporto I.G.M. di Grotta Emiliana; B) Veduta del complesso delle grotte dall esterno. Pagina 276
9 LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA DI GROTTA EMILIANA 277 Fig. 2 - Grotta Emiliana: planimetria interna della grotta, con indicazione dei settori di scavo. dell 800 dal Dalla Rosa e dal Vaufrey, i quali individuarono all interno di essa un deposito archeologico rappresentato da livelli antropizzati riferibili al Paleolitico superiore e forse anche al Neolitico (Dalla Rosa 1870; Vaufrey 1927). Tale deposito oggi risulta tuttavia completamente asportato da continui interventi recenti, di cui sono ancora ben visibili le tracce. Per più di cento anni, infatti, la grotta è stata utilizzata dai pastori come rifugio per le greggi e dai contadini come fonte di fertilizzante naturale. Inoltre negli ultimi anni ha vissuto un lungo periodo di completo abbandono. Prima dello scavo, infatti, la superficie interna si presentava quasi completamente ricoperta da materiali di rifiuto e interessata, in particolare nella parte E/SE, da numerose buche scavate probabilmente dai conta-
10 278 S. CHILARDI - A. DE DOMINICIS - D. ZAMPETTI dini che prelevavano da qui il guano per la fertilizzazione dei campi. Un muro a secco con orientamento EW (fig. 2), realizzato ed usato come recinto dai pastori durante i primi anni del 900, sbarra parzialmente l accesso alla parte più interna. Nella zona NW (settori N10, O10, N11) lo scavo ha permesso di individuare, al di sotto del muro, tracce di una struttura infossata di forma ellittica, in cui sono stati rinvenuti strati di bruciato costituiti da terra, cenere, pietre di calcare esposte all azione diretta del fuoco e materiali di età recente: in base anche alla testimonianza dei pastori della zona, essa sembrerebbe essere stata utilizzata in epoca moderna per la fabbricazione della calce. Anche di fronte all entrata della cavità sono stati impostati alcuni settori di scavo (saggi T ed U) allo scopo di verificare la presenza di tracce di frequentazione all esterno della grotta: tali saggi hanno però messo in evidenza come fenomeni di erosione e forse anche interventi umani, abbiano cancellato eventuali testimonianze archeologiche, poiché la roccia di base compariva immediatamente al di sotto dello strato di superficie. Tuttavia, nonostante i numerosi interventi distruttivi recenti ad opera dell uomo, le indagini svolte all interno della grotta, in particolare nell area centro-occidentale ed in quella meridionale, hanno portato a risultati di estremo interesse scientifico. Nei settori I9, L9, I10, L10 (fig. 2), infatti, immediatamente a sud del muro a secco cui si accennava precedentemente, è stato messo in luce, al di sotto della superficie, un deposito costituito da uno strato biancastro di natura limosa, denominato US 4 che a sua volta copriva un altro livello, l US 5, di matrice simile: in entrambi, ma in particolare nell US 5, sono stati rinvenuti numerosi resti di fauna pleistocenica (fig. 3A). Si tratta di ossa non in connessione, riferibili in particolare, come si vedrà nel dettaglio in seguito, a più di un esemplare di ippopotamo. Oltre alle ossa, si notano alcune pietre piatte, di medie e grandi dimensioni con angoli smussati ed un numero rilevante di piccoli ciottoli di forma subarrotondata e appiattita, probabilmente a causa di un intensa e continua azione di fluitazione. Il deposito sembra proseguire al di sotto uno strato sterile di colore rossastro (US 3), coperto a sua volta da una crosta calcarea piuttosto compatta (US 2), asportata da rimaneggiamenti recenti in alcuni punti, ma ancora presente in tutta l area sudoccidentale della grotta. Il livello inferiore che contiene i resti di fauna (US 5) poggia al di sopra di uno strato molto compatto (US 6), formatosi probabilmente per deposito di particelle calcaree ad opera dell acqua (sottoforma di stillicidio), il quale si estende verso S, in prossimità della parete di fondo. In prossimità di quest area (settori F6, G6) (fig. 2) ed in altre zone all interno della grotta (in particolare nell area orientale), tale
11 LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA DI GROTTA EMILIANA 279 strato sembra essere stato asportato parzialmente da tagli moderni che hanno permesso di mettere in luce, immediatamente al di sotto di esso, altri resti di fauna (US 7) (fig. 3B) anche in questo caso riferibili ad esemplari di ippopotamo. In associazione con i resti di fauna, in particolare quelli rinvenuti nella zona centro-occidentale (settore I9), sono state rinvenute alcune schegge di selce di piccole dimensioni insieme ad alcuni manufatti litici che potrebbero attestare una frequentazione umana molto antica della grotta. Fig. 3 - Grotta Emiliana: A) Planimetria dei settori di scavo I9, I10, L9, L10; B) Planimetria dei settori di scavo F6, G6.
12 280 S. CHILARDI - A. DE DOMINICIS - D. ZAMPETTI L INDUSTRIA LITICA L industria litica raccolta durante lo scavo ammonta a 43 manufatti, per lo più con patine e tracce di fluitazione da leggera a forte e nella loro quasi totalità frammentari (86%). Queste caratteristiche confermano la ricostruzione degli episodi di formazione del deposito e rendono plausibile l ipotesi di un rimaneggiamento dei materiali provenienti da livelli differenti (vedi infra S. Chilardi). La composizione tipologica (tab. I) indica la presenza di tipi (grattatoi, lame e lamelle a dorso, lame e lamelle) inquadrabili nel Paleolitico superiore (fig ). Pochi pezzi tuttavia potrebbero supportare l ipotesi di un attribuzione al Paleolitico inferiore o medio. Si tratta di 3 beccucci su ciottoli di calcare selcioso (fig ), un probabile nucleo da schegge su ciottolo di calcare selcioso, molto fluitato (misure: lungh. 44,5 mm, largh. 21 mm, spess. 12,5 mm) e di un frammento di scheggia pseudo-levallois, con tallone liscio, in selce (fig. 4.3). Questa piccola serie di manufatti proviene dalle unità stratigrafiche che contengono i resti di ippopotamo, ed infatti due dei ciottoli trasformati in beccuccio mostrano concrezioni biancastre assai simili a quelle riscontrate sui resti di ippopotamo. La formula dubitativa per quanto riguarda l attribuzione di questi pochi pezzi è dovuta a vari elementi che inducono ad una certa cautela: 1. La necessità di approfondire lo studio del contesto stratigrafico che, come si evince dalla ricostruzione effettuata da S. Chilardi, è molto articolato; 2. La scarsità numerica dei manufatti che non consente di avere a disposizione una gamma tecno-tipologica su cui ragionare per costruire delle ipotesi interpretative; 3. La necessità di accertare la provenienza dei ciottoletti di calcare selcioso usati come supporto per i tre beccucci; 4. Il fatto che i tre beccucci siano poco elaborati dal punto di vista tecnico. Sono infatti caratterizzati da due, al massimo tre scheggiature convergenti cosicché, pur potendo rientrare nella categoria di manufatti del Paleolitico inferiore o medio, non sono particolarmente diagnostici come potrebbero esserlo dei choppers o dei choppingtools ad es.; 5. Il frammento di scheggia classificato come pseudo-levallois induce a considerare due possibilità di classificazione/attribuzione in alternativa: a. per l attribuzione non è del tutto da scartare l ipotesi di un manufatto di epoca tarda, se si prende in considerazione la possibilità che tecniche di scheggiatura di tipo musteroide siano adottate anche nel Tardoglaciale/Olocene (Escalon De Fonton 1953); b. potrebbe essere identificato invece che come pseudo-levallois, derivante da un nucleo discoidale, come il prodotto di una tecnica di scheggiatura bipolare, che, per quanto attestata già nel Paleolitico inferiore (vedi ad es. Isernia: Crovetto et alii 1994), non è automaticamente da considerare un elemento
13 LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA DI GROTTA EMILIANA 281 diagnostico dal punto di vista cronologico; 6. La mancanza di confronti proponibili non solo per tutto quanto già esposto ma anche perché a tutt oggi non vi sono, nel territorio siciliano, dei contesti di riferimento ben datati (Mussi 2001; Palma di Cesnola 1996; Piperno 1997; Zampetti et alii 2000). Fig. 4 - Grotta Emiliana: 1) Denticolato su scheggia dall US 4 (settore I9); 2) Frammento di grattatoio dall US 4 (settore I9); 3) Frammento di scheggia pseudo-levallois dall US 7 (settore G6); 4-6) Manufatti su piccoli ciottoli dall US 5 (settore I9).
14 282 S. CHILARDI - A. DE DOMINICIS - D. ZAMPETTI Tab. I - Grotta Emiliana: industria litica (scavi 2004). TIPOLOGIA RIT. I9 US4 I9 US5 G6 US7 G7 US7 TOTALE Fr. di Grattatoio Fr. di Punteruolo Fr. di Lama a dorso 1 1 Fr. di Lamella a dorso 1 1 Fr. di Intaccatura 1 1 Fr. di Denticolato 1 1 Troncatura 1 1 Fr. di manufatto ritoccato Becco su ciottolo 3 3 TOTALE TIPOLOGIA SCARTI I9 US4 I9 US5 G6 US7 G7 US7 TOTALE Nucleo su ciottolo 1? 1 Fr. di Lama 2 2 Fr. di Lamella Fr. di Lamella corticata 1 1 Fr. di Scheggia 2 1pseudo- Levall. 3 Scheggia corticata Fr. indeterminato 9 9 Chip TOTALE
15 LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA DI GROTTA EMILIANA 283 LA FAUNA I reperti esaminati provengono dalle UUSS 4, 5, 7 e dall US 18, 16 e 23. Tutta la fauna determinata (meno di una quarantina di reperti), che rappresenta solo una parte di quella messa in luce nel corso dello scavo, è ascrivibile all ippopotamo, ad eccezione di un probabile tarsale d elefante inglobato quasi completamente in un blocco concrezionato di sedimento proveniente dall US 23 e di un frammento distale di tarso-metatarso sinistro di uccello proveniente dall US 4. Molti i denti, tra cui tre frammenti di canino inferiore: due provenienti dall US 5, uno dall US 4. Entrambi i frammenti dell US 5 presentano margini arrotondati, indicando come conseguenza di una fluitazione più o meno prolungata. Anche se il numero dei reperti esaminati è molto esiguo, l associazione faunistica appare inquadrabile all interno del cosiddetto complesso ad Elephas mnaidriensis ed Hippopotamus pentlandi, secondo alcuni autori collocabile cronologicamente tra lo stadio 8 e lo stadio 4 (Di Maggio et alii 1999). Ad Acquedolci gli ippopotami sono presenti in alcuni livelli posteriori all Eutirreniano (Bonfiglio 1992, 1997) ed a Capo Tindari (Grotta di Fata Donavilla) essi sono associati a un cervide di taglia relativamente ridotta ed a Ursus sp. (Casentino e Gliozzi 1988; Gliozzi e Malatesta 1984). Anche a Carburangeli sembra verificarsi la medesima situazione con l ippopotamo associato a Crocuta, lupo, cervidi e cinghiale (Zampetti et alii 2000). LA GENESI DELLA CAVITÀ E DEL DEPOSITO Raymond Vaufrey tracciò un profilo altimetrico dell area ove è situata la cavità, individuando quattro piattaforme d abrasione marina poste alla quota di 135, 90, 55 e 15 m sul livello del mare ed assegnando grotta Emiliana alla spianata da lui individuata a quota 55 (Vaufrey 1929). La presenza di numerose grotte in corrispondenza delle fasce altimetriche individuate, nonché i solchi di battente ed i numerosi fori di litodomi ancora oggi ben visibili convinsero Vaufrey del fatto che il mare avesse giocato un ruolo di primo piano nella genesi delle cavità. Riteniamo di poter essere d accordo con tale ipotesi, sicché le cavità (tra cui Grotta Emiliana) avrebbero origine mista marino-carsica: in pratica l azione del mare ha agito allargando e rimodellando fessure o comunque piccole cavità legate al reticolo idrografico sotterraneo. Tuttavia, almeno per quanto è visibile ancora oggi all interno di grotta Emiliana, tale azione di rimo-
16 284 S. CHILARDI - A. DE DOMINICIS - D. ZAMPETTI dellamento è stata piuttosto complessa ed articolata. Al tempo di Dalla Rosa, secondo quanto riferisce Vaufrey (1929), era visibile sulla parete di fondo un importante breccia ossifera dello spessore di un metro e mezzo ca., un tempo estesa probabilmente a tutta la grotta. Sempre secondo Dalla Rosa essa si divideva in due intervalli: 1) Un livello superiore con ossa, carboni, cenere, selci, scarti di cucina e conchiglie che gli davano l aspetto di un kjokkenmodding (termine testuale), con (perfino) un po di ceramica ed un disco di materiale fittile. Le conchiglie erano soprattutto Patelle, mentre la fauna descritta è quella tipica del Tardoglaciale della Sicilia: Uro, Cervo, cinghiale ed Equus probabilmente idruntino. 2) Un livello inferiore molto duro e concrezionato da cui recuperò soltanto dei frammenti di una zanna d elefante. Nessuna traccia di industria litica. Lembi di deposito, vagamente somigliante a quello descritto dal Dalla Rosa, sono ancora oggi visibili lungo le pareti di fondo della grotta: esiste persino un livello discontinuo caratterizzato da un alta concentrazione di molluschi (prevalentemente gasteropodi), tuttavia la stratigrafia appare ben più articolata. Esistono inoltre alcuni lembi di un pavimento stalagmitico sospeso a poco più di 2 m di altezza rispetto all attuale piano di calpestio, pavimento al di sotto del quale sono visibili depositi a terra rossa concrezionati inglobanti piccoli frammenti ossei di colore biancastro. Questo modello stratigrafico sembra avere molti punti di contatto con quanto documentato in numerose cavità della Sicilia sud orientale (Marziano e Chilardi 2005). Come abbiamo già descritto, le Unità Stratigrafiche contenenti la fauna a pachidermi sono ricoperte da un livello fortemente concrezionato che, sebbene non esplorato in modo estensivo, potrebbe essere un secondo pavimento stalagmitico che sigilla i terreni precedenti la serie stratigrafica tardiglaciale. D Angelo e Vernuccio (1996), descrivono i terrazzi marini dell estremità occidentale della Sicilia, individuando nell area compresa tra Trapani e Mazara del Vallo il Grande Terrazzo Superiore tra 140 e 160 m di quota ed altri sette ordini di terrazzi alle quote di 100, 75, 50, 30, 20, 10 e 3 m sul livello del mare. Anche se l area di nostro interesse è situata più a settentrione, non si può non notare una certa corrispondenza tra le quote delle piattaforme d abrasione segnalate da Vaufrey e di alcuni dei terrazzi citati. In un lavoro successivo (D Angelo et alii 2001) è stata individuata una serie di otto terrazzi anche lungo la costa meridionale della Sicilia (tra Torretta Granitola e Capo Passero): il GTS (Grande Terrazzo Superiore) con orli compresi tra 115 e 214 m, ed altri sette ordini di terrazzi
17 LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA DI GROTTA EMILIANA 285 (90-114; 70-88; 55-69; 25-53; 23-24; 9-10 ed il deposito tirreniano quasi al livello del mare), correlati cronologicamente agli stadi isotopici 15, 13, 11c, 11a, 9, 7, 5c. Ciò che colpisce è la possibile correlazione esistente tra il terrazzo di quota m e la posizione altimetrica di Grotta Emiliana. Nel corso dello stesso lavoro, gli autori sottolineano l importanza delle piccole oscillazioni interne ai singoli stadi nei processi erosivi e deposizionali legati alle variazioni del livello del mare. Alla luce di tutto ciò sembra corretto collocare la formazione della cavità nel corso dello stadio 11 (meglio, sottostadio 11c), cui segue la formazione del deposito continentale a terra rossa ed ossa minute sottostante il pavimento stalagmitico sospeso e, in fase umida con stillicidio abbondante, del pavimento stesso. Una nuova fase erosiva si innesta sulla precedente nel corso del sottostadio 11a: il deposito continentale viene eroso e la cavità stessa rimodellata; è appunto lo stesso meccanismo proposto per le grotte costiere della Sicilia sud-orientale (Marziano e Chilardi 2005). La successiva regressione (ed anche il progressivo innalzamento del blocco di calcare) riportano condizioni continentali stabili: il reticolo idrografico sotterraneo si imposta e interviene nei meccanismi di rimodellamento della cavità. È difficile attribuire con certezza ad uno stadio isotopico ben definito i livelli a pachidermi riportati alla luce nel corso dello scavo. Considerazioni di ordine faunistico-ecologico (ippopotami abbondanti) e sedimentologico-stratigrafico farebbero propendere per una fase a clima caldo e piuttosto umido (penultimo interglaciale? uno dei picchi dello stadio 5?) come sembrano dimostrare i ciottoli subarrotondati frammisti alla fauna e le condizioni stesse di alcuni reperti dalle superfici chiaramente fluitate. Ciò fa pensare ad un vero e proprio ruscellamento, forse in parte responsabile della genesi del deposito. Una contrazione delle acque circolanti trasformerà poi il ruscellamento in stillicidio con la formazione del crostone stalagmitico rappresentato dalla US2. Su questo livello si imposta,come abbiamo già visto, il resto della serie stratigrafica, i cui livelli più recenti (Pleniglaciale con le sue oscillazioni interne, tardoglaciali, ma anche olocenici?) furono scavati da Dalla Rosa. Diventa quindi fondamentale il ruolo dell US2: la sua continuità ed integrità equivarrebbero ad una esclusione di possibili commistioni tra fauna a pachidermi ed industrie litiche meno antiche, ma non sembra questo il nostro caso. Nelle aree esplorate la US2 non copriva più (a causa di fenomeni erosivi anche dovuti all antropizzazione della cavità) le UU. SS. 4, 5 e 7, per cui risulta difficile dimostrare che non vi siano stati episodi di rimaneggiamento che potrebbero avere determinato l associazione qui esaminata.
18 286 S. CHILARDI - A. DE DOMINICIS - D. ZAMPETTI Cosa ci dicono le ossa? In una simile situazione, si è comunque cercato di verificare se fossero presenti sulle ossa fossili recuperate nel corso dello scavo, elementi utili a provare che tale associazione non sia frutto di fenomeni postdeposizionali. L esame dei reperti osteologici non ha però prodotto prove decisive in alcun senso. Le superfici ossee sono state esaminate nel tentativo di rilevare l eventuale presenza di tracce imputabili all azione dell uomo e connesse con il depezzamento o la scarnificazione dell animale. Purtroppo nessun punto d impatto che facesse pensare ad una frammentazione volontaria (volta sia alla ripartizione della carcassa, sia all estrazione del midollo) è stata osservata: le diafisi delle ossa lunghe appaiono generalmente integre o, comunque, in buone condizioni, con l intera circonferenza ben conservata. Anche l osservazione compiuta alla ricerca di cutmarks non ha dato alcun esito: in due casi (un frammento di costa proveniente dalla US 7, settore G6 ed un frammento del terzo prossimale di un femore di ippopotamo dalla US 5, settore I) erano presenti strie dall andamento subrettilineo, la cui posizione appariva compatibile con una ipotetica azione di scarnificazione e/o deprezzamento. Tuttavia le osservazioni compiute al microscopio ottico binoculare ed ancor più al SEM, hanno messo in evidenza famiglie di strie disordinate da abrasione superficiale prima invisibili ad occhio nudo e margini dei due solchi oggetto dello studio irregolari, fondo del solco non ben leggibile per forma e caratteristiche di dettagli. Anche le tracce di apparente combustione subita da alcuni resti non costituiscono una prova certa in favore di una presenza umana insieme agli ippopotami: la grotta è stata utilizzata per la produzione di calce e vasti fuochi vi sono stati accesi, talvolta a contatto con lembi affioranti delle US da noi esaminate. S. C. Si desidera ringraziare: il prof. S. Tusa per aver richiesto il nostro intervento; la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani per aver concesso il permesso di studiare i materiali; il prof. A. Cazzella dell Università degli Studi La Sapienza di Roma per i preziosi consigli; la dott.ssa M. Fiore per aver offerto il suo contributo ad un analisi preliminare dei resti faunistici ed il dott. E. Cancellieri per aver collaborato ad un primo studio dei reperti litici.
19 LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA DI GROTTA EMILIANA 287 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI BONFIGLIO L. 1997, Il deposito lacustre a ippopotami di Acquedolci (Messina), in Prima Sicilia, pp COSENTINO D., GLIOZZI E. 1988, Considerazioni sulle velocità di sollevamento di depositi eutirreniani dell Italia meridionale e della Sicilia, Memorie della Società Geologica Italiana, 41, pp CROVETTO C., FERRARI M., PERETTO C., VIANELLO F. 1994, 6. Le industrie litiche in PERETTO C., a cura di, Le industrie litiche del giacimento paleolitico di Isernia La Pineta, C. Iannone ed., Isernia, pp D ANGELO U., PARRINO G., VERNUCCIO S. 2001, Il Quaternario della fascia costiera compresa fra Punta Granitola e Portopalo (Sicila sud occidentale), Naturalista Siciliano, S. IV, XXV, pp D ANGELO U., VERNUCCIO S. 1996, I terrazzi marini quaternari della estremità occidentale della Sicilia, Geologica Romana, 51, pp DALLA ROSA G. 1870, Ricerche paleoetnologiche nel litorale di Trapani, s.l., pp DI MAGGIO C., INCANDELA A., MASINI F., PETRUSO D., RENDA R., SIMONELLI C., BOSCHIAN G. 1999, Oscillazioni eustatiche, biocronologia dei depositi continentali quaternari e neotettonica nella Sicilia nord-occidentale (penisola di S. Vito Lo Capo Trapani), Il Quaternario, 12, pp ESCALON DE FONTON M. 1953, La technique de faille musteroïde de l Epipaléolithique méditerranéen, BSPF, L, pp GLIOZZI E., MALATESTA A. 1984, A megacerine in the Pleistocene of Sicily, Geologica Romana, 21 (1982), pp MARZIANO C., CHILARDI S. 2005, Contribution to knowledge of the Pleistocene mammal-bearing deposits of the territory of Siracusa (southeastern Sicily), in O CONNOR T., Biosphere to Lithosphere. New Studies in vertebrate taphonomy, Oxford, Oxbow, pp MUSSI M. 2001, Earliest Italy, Plenum Publishers, New York. PALMA DI CESNOLA A. 1996, Le Paléolithique infèrieur et Moyen en Italie, J.Millon Ed., Paris. PIPERNO M. 1997, Il popolamento della Sicilia. Il Paleolitico inferiore, in Prima Sicilia, pp PRIMA SICILIA - TUSA S., a cura di, 1997, Prima Sicilia. Alle origini della società siciliana, Palermo. VAUFREY R. 1927, Observation de Paléontologie humaine in Sicile, Tunisie et Italie méridionale, comunication à l Institut français d Anthropologie, L Anthropologie, XXXVIII, pp VAUFREY R. 1928, Le Paléolitique italien, Archives de l Institut de Paléontologie Humaine, Memoires 3, Paris, p. 196.
20 288 S. CHILARDI - A. DE DOMINICIS - D. ZAMPETTI VAUFREY R. 1929, Les élèphants nains des îles méditérranéennes, Archives de l Institut de Paléontologie Humaine, Masson, Paris. ZAMPETTI D., CALOI L., CHILARDI S., PALOMBO M. R. 2000, Le peuplement de la Sicile pendant le Pleistocène: l homme et les faunes, in MASHKOUR M., CHOYKE A.M., BUITENHUIS H., POPLIN F., Archaeozoology of the near east IVA, Proceedings of the fourth international symposium of southwestern Asia and adjacent areas, ARC Publicatie, Groningen, pp RIASSUNTO. - LA FREQUENTAZIONE PREISTORICA DI GROTTA EMILIANA (ERI- CE, TP). - Gli autori presentano i risultati di una campagna di indagini archeologiche svolta a Grotta Emiliana, situata nel territorio del comune di Erice (Trapani), in cui sono stati rinvenuti livelli contenenti sia resti di fauna pleistocenica, attribuibili ad esemplari di ippopotamo, che manufatti in selce frammentati e fluitati. Il deposito a pachidermi sembrerebbe essersi generato per azioni di ruscellamento: ciò renderebbe problematica una attribuzione cronologica sicura dei materiali litici, che tuttavia sembrerebbero riferibili anche a fasi antiche del Paleolitico. SUMMARY. - THE PREHISTORIC OCCUPATION OF GROTTA EMILIANA (ERICE, TP). - The Authors present the results of the archaeological researches held in Grotta Emiliana, in the area of Erice (Trapani), where levels containing remains of Pleistocene fauna belonging to hippos, together with fragmented and floated stone tools have been found out. The pachyderm deposit seems to be the result of run-off actions: this hypothesis would make doubtful the chronological dating of the stone tools; however it seems also possible to date them to early phases of the Palaeolithic period.
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
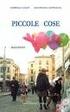 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche
 Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
Grotte Naturali di Palermo
 Grotte Naturali di Palermo Tra le Riserve Naturali della Provincia di Palermo vi sono alcune grotte molto particolari, per la loro storia e per la loro conformazione Sono Grotta Conza, Grotta di Carburangeli,
Grotte Naturali di Palermo Tra le Riserve Naturali della Provincia di Palermo vi sono alcune grotte molto particolari, per la loro storia e per la loro conformazione Sono Grotta Conza, Grotta di Carburangeli,
Regione Siciliana FRUIZIONE BENI CULTURALI IN SICILIA ANNO 2013 ANNO 2014
 Agrigento Museo archeologico 15.769 36.137 51.906 165.542,50 15.612 34.060 49.672 166.272,66 Agrigento Parco archeologico della Valle dei Templi AG Biblioteca Museo "Luigi Agrigento Pirandello" Cattolica
Agrigento Museo archeologico 15.769 36.137 51.906 165.542,50 15.612 34.060 49.672 166.272,66 Agrigento Parco archeologico della Valle dei Templi AG Biblioteca Museo "Luigi Agrigento Pirandello" Cattolica
PRIMO SEMESTRE 2013 PRIMO SEMESTRE 2014
 + 11.000 visitatori con biglietto acquistato presso Agrigento Museo archeologico 6.516 23.774 30.290 70.342,00 6.274 28.755 35.029 67.923,00 Agrigento Parco archeologico della Valle dei Templi AG Biblioteca
+ 11.000 visitatori con biglietto acquistato presso Agrigento Museo archeologico 6.516 23.774 30.290 70.342,00 6.274 28.755 35.029 67.923,00 Agrigento Parco archeologico della Valle dei Templi AG Biblioteca
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Manciano. Sito Complesso Architettonico 1. Francesca Cheli. Corpo di Fabbrica 1. Piano 1. Piano 2
 Manciano Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 325, n. 27.1; COLLAVINI 1998, pp. 199n, 323-24, 363, 375n, 377n, 409, 561; CORRIDORI 2004, p. 409-415; MACCARI, NOCCIOLI 1995; Repertorio
Manciano Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 325, n. 27.1; COLLAVINI 1998, pp. 199n, 323-24, 363, 375n, 377n, 409, 561; CORRIDORI 2004, p. 409-415; MACCARI, NOCCIOLI 1995; Repertorio
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4
 Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
Calendario della aperture dei siti culturali nel periodo 18 dicembre gennaio 2017
 Calendario della aperture dei siti culturali nel periodo 18 dicembre 2016 8 gennaio 2017 Agrigento: Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento: apertura da martedì a 9,00-19,30; lunedì 9,00-13,30. festivi
Calendario della aperture dei siti culturali nel periodo 18 dicembre 2016 8 gennaio 2017 Agrigento: Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento: apertura da martedì a 9,00-19,30; lunedì 9,00-13,30. festivi
L analisi stratigrafica delle murature in elevato
 Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA
 FORMIA LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p. 1459 PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA L appezzamento di terreno, circa 5.000 mq., di proprietà Centola (F. 13, p. 1459) è situato in località Taliento e rimane
FORMIA LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p. 1459 PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA L appezzamento di terreno, circa 5.000 mq., di proprietà Centola (F. 13, p. 1459) è situato in località Taliento e rimane
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE)
 Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
 presenta re Direzione Generale 6204111 - - infoweb@riscossionesicilia.it direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it Ambito Occidentale Palermo 6204111 6204730 6204608 infopalermo@riscossionesicilia.it
presenta re Direzione Generale 6204111 - - infoweb@riscossionesicilia.it direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it Ambito Occidentale Palermo 6204111 6204730 6204608 infopalermo@riscossionesicilia.it
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
REGIONE SICILIANA. Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana.
 REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento
REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento
COMUNE DI MATELICA. Provincia di Macerata
 DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
Grotta di Polla (Cp 4) - esplorazioni del 1998
 ESPLORAZIONI 223 Grotta di Polla (Cp 4) - esplorazioni del 1998 Rilievo 1998: U. Del Vecchio, A. Lala, M. E. Smaldone 234 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DI POLLA (CP 4) La Grotta di Polla si trova nel settore
ESPLORAZIONI 223 Grotta di Polla (Cp 4) - esplorazioni del 1998 Rilievo 1998: U. Del Vecchio, A. Lala, M. E. Smaldone 234 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DI POLLA (CP 4) La Grotta di Polla si trova nel settore
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
 COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
Capitolo 6 Rilevamento geologico
 Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
FRUIZIONE BENI CULTURALI IN SICILIA ANNO 2011 - ANNO 2012
 ANNO - ANNO AG Agrigento Museo archeologico 14.151 42.495 56.646 147.872,50 12.664 34.760 47.424 137.376,50 Agrigento Agrigento Parco archeologico della Valle dei Templi Biblioteca Museo "Luigi Pirandello"
ANNO - ANNO AG Agrigento Museo archeologico 14.151 42.495 56.646 147.872,50 12.664 34.760 47.424 137.376,50 Agrigento Agrigento Parco archeologico della Valle dei Templi Biblioteca Museo "Luigi Pirandello"
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
 PREMESSA Sezione lucida stratigrafica (NorMal 14/83): il campione, viene dapprima inglobato in resina poliestere e orientato in modo da ottenere una sezione perpendicolare alla superficie originaria. Successivamente
PREMESSA Sezione lucida stratigrafica (NorMal 14/83): il campione, viene dapprima inglobato in resina poliestere e orientato in modo da ottenere una sezione perpendicolare alla superficie originaria. Successivamente
 RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE Enti Liste codici Ente schedatore Altri Enti attivi Aggiornato al 31/12/2013 Piemonte Soprintendenza
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE Enti Liste codici Ente schedatore Altri Enti attivi Aggiornato al 31/12/2013 Piemonte Soprintendenza
Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
 Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari
 Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
La stratigrafia archeologica
 La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia
 Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
Cana. Sito Complesso Architettonico 1. Corpo di Fabbrica 1. Riccardo Bargiacchi
 Cana Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.3; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364, 460; CORRIDORI 2004, p. 268-270; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148; Repetti
Cana Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.3; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364, 460; CORRIDORI 2004, p. 268-270; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148; Repetti
STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
COMUNI DI TORRE DEL GRECO-TORRE ANNUNZIATA
 Partita I.V.A. e C.F. 07457550635 Capitale sociale uro 100.000 i.v COMUNI DI TORRE DEL GRECO-TORRE ANNUNZIATA COMMITTENTE: GORI S.p.a. OGGETTO: Riabilitazione della rete fognaria interna e collettamento
Partita I.V.A. e C.F. 07457550635 Capitale sociale uro 100.000 i.v COMUNI DI TORRE DEL GRECO-TORRE ANNUNZIATA COMMITTENTE: GORI S.p.a. OGGETTO: Riabilitazione della rete fognaria interna e collettamento
Pozzetto P - abitato di Mortella terreno di riporto Argille varicolori (Oligocene) Argille marnose poco consistenti di colore verdastro e a struttura
 Studio Tecnico Geol. Domenico Laviola - Corso Metaponto, 7505 Pisticci Tel/Fax 0855876 Cell 856805 e-mail: laviolam@alice.it COMUNE DI ROTONDELLA Provincia di Matera REGOLAMENTO URBANISTICO Legge Regionale
Studio Tecnico Geol. Domenico Laviola - Corso Metaponto, 7505 Pisticci Tel/Fax 0855876 Cell 856805 e-mail: laviolam@alice.it COMUNE DI ROTONDELLA Provincia di Matera REGOLAMENTO URBANISTICO Legge Regionale
Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
QUINTA CAMPAGNA DI SCAVO NELLA STAZIONE DEL PALEOLITICO INFERIORE A CASTEL DI GUIDO PRESSO ROMA
 .Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 91 (1984) pagg. 369-375, fig g. 3. A.M. RADMILLI (*) QUINTA CAMPAGNA DI SCAVO NELLA STAZIONE DEL PALEOLITICO INFERIORE A CASTEL DI GUIDO PRESSO ROMA Riassunto
.Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 91 (1984) pagg. 369-375, fig g. 3. A.M. RADMILLI (*) QUINTA CAMPAGNA DI SCAVO NELLA STAZIONE DEL PALEOLITICO INFERIORE A CASTEL DI GUIDO PRESSO ROMA Riassunto
OGGETTO : RECUPERO, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CASALE MONFERRATO - 5/8 LOTTO DI LAVORI
 MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4
 RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO Centro Studi di Preistoria e Archeologia
 PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO 2015 Centro Studi di Preistoria e Archeologia Direttore Scientifico Nuccia Negroni Catacchio: Università degli studi di Milano e Centro studi di Preistoria
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO 2015 Centro Studi di Preistoria e Archeologia Direttore Scientifico Nuccia Negroni Catacchio: Università degli studi di Milano e Centro studi di Preistoria
OGGETTO: Rete Unitaria Amministrazione Regionale. Comunicazione indirizzi e password, modalità di accesso e gestione. Convocazione.
 REPUBBLICA ITALIANA Numero di Codice Fiscale 80012000826 Numero di Partita I.V.A. 02711070827 Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione Dipartimento Regionale
REPUBBLICA ITALIANA Numero di Codice Fiscale 80012000826 Numero di Partita I.V.A. 02711070827 Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione Dipartimento Regionale
La fauna pleistocenica di Isernia La Pineta (Molise): analisi archeozoologica delle US 3S1-5
 2007 volumespeciale2007 Annali dell Università degli Studi di Ferrara ISSN 1824-2707 Museologia Scientifica e Naturalistica volume speciale (2007) La fauna pleistocenica di Isernia La Pineta (Molise):
2007 volumespeciale2007 Annali dell Università degli Studi di Ferrara ISSN 1824-2707 Museologia Scientifica e Naturalistica volume speciale (2007) La fauna pleistocenica di Isernia La Pineta (Molise):
ACQUAVIVA DELLE FONTI. GSV-Gruppo Speleologico Vespertilio CENTRO ALTAMURANO RICERCHE SPELEOLOGICHE
 Grotta di Curtomartino Bari Curtomartino curtomartino 72 63 X X X grotta chiusa con cancello Privato. Vito abbrusci www.grottacurtomartino.it 500 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli
Grotta di Curtomartino Bari Curtomartino curtomartino 72 63 X X X grotta chiusa con cancello Privato. Vito abbrusci www.grottacurtomartino.it 500 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli
STUDIO DEI MATERIALI DI INCOLLAGGIO E STUCCATURA DELLA STATUA DI EROE APPARTENENTE ALLA COLLEZIONE DI PALAZZO LANCELLOTTI AI CORONARI, ROMA
 STUDIO DEI MATERIALI DI INCOLLAGGIO E STUCCATURA DELLA STATUA DI EROE APPARTENENTE ALLA COLLEZIONE DI PALAZZO LANCELLOTTI AI CORONARI, ROMA Dott.ssa Anna Maria MECCHI Dott.ssa Susanna BRACCI Dott. Fabio
STUDIO DEI MATERIALI DI INCOLLAGGIO E STUCCATURA DELLA STATUA DI EROE APPARTENENTE ALLA COLLEZIONE DI PALAZZO LANCELLOTTI AI CORONARI, ROMA Dott.ssa Anna Maria MECCHI Dott.ssa Susanna BRACCI Dott. Fabio
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 22_MES
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine 0701101122 * Scoglio Nero-inizio zona B Area Protetta Cinque Terre * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine 0701101122 * Scoglio Nero-inizio zona B Area Protetta Cinque Terre * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione
Le variazioni del livello del mare nel Quaternario
 Le variazioni del livello del mare nel Quaternario Trieste, 1875 (Venezia, 1872; Genova, 1884; Marsiglia, 1885: Marina di Ravenna, 1896) AA 2015-2106 GQt Livello mare 1 Alla fine degli anni 60. Le calotte
Le variazioni del livello del mare nel Quaternario Trieste, 1875 (Venezia, 1872; Genova, 1884; Marsiglia, 1885: Marina di Ravenna, 1896) AA 2015-2106 GQt Livello mare 1 Alla fine degli anni 60. Le calotte
Comune di Piacenza- via S. Vincenzo - Ex scuola S. Vincenzo Saggi stratigrafici
 Alessandra D Elia Via G. Verdi, 13-29100 Piacenza Tel. & fax 0523384408 tel. cell. 3355877103 e. mail deliarestauri@yahoo.it pec alessandradelia@pec.laapc.it P.iva 01123600338 - C.F. DLELSN66L60F205O N.
Alessandra D Elia Via G. Verdi, 13-29100 Piacenza Tel. & fax 0523384408 tel. cell. 3355877103 e. mail deliarestauri@yahoo.it pec alessandradelia@pec.laapc.it P.iva 01123600338 - C.F. DLELSN66L60F205O N.
Regione sede cod. ICCD ente sigla. Piemonte TORINO 201 Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte DR
 Regione sede cod. ICCD ente sigla Piemonte TORINO 201 Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte DR TORINO 154 Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte del Museo delle
Regione sede cod. ICCD ente sigla Piemonte TORINO 201 Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte DR TORINO 154 Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte del Museo delle
PU_392. Grotta S.Angelo di Statte. Monte S.Angelo
 Taranto Monte S.Angelo 11 385-387 X X L'accesso della cavità è vincolata da vincolo archeologico.contattare la sovraintendenza archeologica del Museo di Taranto 0 Anelli Franco 11/11/1953 Centro di Speleologia
Taranto Monte S.Angelo 11 385-387 X X L'accesso della cavità è vincolata da vincolo archeologico.contattare la sovraintendenza archeologica del Museo di Taranto 0 Anelli Franco 11/11/1953 Centro di Speleologia
Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'italia * * * Arenile Nord. Sopralluogo del 30 marzo 2016 * * *
 Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'italia * * * Arenile Nord * * * Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio Aprile 2016 NT/SUO 2016/063 1 PREMESSA Il giorno 30 marzo i tecnici ISPRA
Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'italia * * * Arenile Nord * * * Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio Aprile 2016 NT/SUO 2016/063 1 PREMESSA Il giorno 30 marzo i tecnici ISPRA
Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana
 Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
Università degli Studi di Sassari. Dipartimento di Storia, Scienze dell uomo e della Formazione ITACA
 ITACA Innovation Technologies and Applications for Coastal Archaeological sites Palermo 28-29 Marzo 2014 Professore referente: Pier Giorgio Spanu Anno Accademico 2004-2005: istituzione corso di laurea
ITACA Innovation Technologies and Applications for Coastal Archaeological sites Palermo 28-29 Marzo 2014 Professore referente: Pier Giorgio Spanu Anno Accademico 2004-2005: istituzione corso di laurea
Parco Archeologico di Fregellae
 Parco Archeologico di Fregellae Fregellae Parco Archeologico Offerta formativa per l anno scolastico 2014/2015 Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova Museo Antropologico Gente di
Parco Archeologico di Fregellae Fregellae Parco Archeologico Offerta formativa per l anno scolastico 2014/2015 Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova Museo Antropologico Gente di
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO
 CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
Ingoglia Assia Kysnu INFORMAZIONI PERSONALI. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Curriculum vitae INFORMAZIONI PERSONALI Ingoglia Assia Kysnu assiakysnu.ingoglia@unife.it ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2012 alla data attuale Dottoranda Livello 8 QEQ Universidad de Cordoba, Cordoba (Spagna)
Curriculum vitae INFORMAZIONI PERSONALI Ingoglia Assia Kysnu assiakysnu.ingoglia@unife.it ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2012 alla data attuale Dottoranda Livello 8 QEQ Universidad de Cordoba, Cordoba (Spagna)
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012
 Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
III. I VETRI. BAUMGARTNER, KRUEGER 1988, p
 III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
COLLEGIO REGIONALE DEI COSTRUTTORI
 ANCE SICILIA COLLEGIO REGIONALE DEI COSTRUTTORI EDILI SICILIANI Via Alessandro Volta n. 44, Palermo - Tel. 091/333114/324724 Fax 091/6112913 E-mail: info@ancesicilia.it STUDIO DEI LAVORI POSTI IN GARA
ANCE SICILIA COLLEGIO REGIONALE DEI COSTRUTTORI EDILI SICILIANI Via Alessandro Volta n. 44, Palermo - Tel. 091/333114/324724 Fax 091/6112913 E-mail: info@ancesicilia.it STUDIO DEI LAVORI POSTI IN GARA
Mousterian industry, Middle Paleolithic, Tuscany.
 Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 100 (1993) pagg. 1 11, figg. 4 A. DANI (*), P. GIUNTI (**), F. MENICUCCI (***) L'INDUSTRIA MUSTERIANA DI QUERCE (FIRENZE) Riassunto - Gli autori descrivono un'industria
Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 100 (1993) pagg. 1 11, figg. 4 A. DANI (*), P. GIUNTI (**), F. MENICUCCI (***) L'INDUSTRIA MUSTERIANA DI QUERCE (FIRENZE) Riassunto - Gli autori descrivono un'industria
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA. PIANO del PARCO
 PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA PIANO del PARCO Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS): rinvii ai contenuti di cui all Allegato VI
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA PIANO del PARCO Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS): rinvii ai contenuti di cui all Allegato VI
COMUNE DI GUASILA. Provincia di CAGLIARI
 Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
 EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia
 Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia Rapporto sulla campagna 2010 (Michael Heinzelmann Manuel Buess) Dal 26/7 al 31/8/2010 l Istituto Archeologico dell
Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia Rapporto sulla campagna 2010 (Michael Heinzelmann Manuel Buess) Dal 26/7 al 31/8/2010 l Istituto Archeologico dell
nell'autunno-inverno 2015-'16
 nell'autunno-inverno 2015-'16 8 gennaio 2016 - Altopiano di Marcesina dal Rifugio Barricata di Grigno (1351 m s.l.m.) (maggio, 2016) INNEVAMENTO 2015-2016 L'autunno-inverno appena trascorso è stato caratterizzato
nell'autunno-inverno 2015-'16 8 gennaio 2016 - Altopiano di Marcesina dal Rifugio Barricata di Grigno (1351 m s.l.m.) (maggio, 2016) INNEVAMENTO 2015-2016 L'autunno-inverno appena trascorso è stato caratterizzato
Prospezioni magnetometriche Burnum (Croazia)
 Prospezioni magnetometriche Burnum (Croazia) Università degli Studi di Siena Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento LAP&T Data dei rilievi: 19-20/08/2006 Area del rilievo: Città antica
Prospezioni magnetometriche Burnum (Croazia) Università degli Studi di Siena Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento LAP&T Data dei rilievi: 19-20/08/2006 Area del rilievo: Città antica
C o l l i n e d e l F i o r a
 Colline del Fiora Castell Ottieri Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 393, n. 61.2; COLLAVINI 1998, pp. 277-278, 427; CORRIDORI 2004, p. 148-151; FUSI 2002, p. 473-475; Repertorio
Colline del Fiora Castell Ottieri Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 393, n. 61.2; COLLAVINI 1998, pp. 277-278, 427; CORRIDORI 2004, p. 148-151; FUSI 2002, p. 473-475; Repertorio
ANTHROPONET. antropologia scheletrica della Sardegna
 antropologia scheletrica della Sardegna archivio informatizzato del materiale scheletrico umano preistorico, protostorico e storico della Sardegna antropologia scheletrica della Sardegna Sergio Casu archivio
antropologia scheletrica della Sardegna archivio informatizzato del materiale scheletrico umano preistorico, protostorico e storico della Sardegna antropologia scheletrica della Sardegna Sergio Casu archivio
2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sono le acque dei fiumi e dei torrenti, le onde, le correnti marine ed i venti. Queste fratturano e consumano le strutture più resistenti degli organismi, per esempio i gusci e le
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sono le acque dei fiumi e dei torrenti, le onde, le correnti marine ed i venti. Queste fratturano e consumano le strutture più resistenti degli organismi, per esempio i gusci e le
Sulle tracce dei cacciatori paleolitici e mesolitici
 Sulle tracce dei cacciatori paleolitici e mesolitici MUSEO DELLE SCIENZE A CURA DI : GIAMPAOLO DALMERI e STEFANO NERI Sezione di Preistoria Dott. G. Dalmeri Dott. S. Neri, Dott.ssa R. Duches, Dott.ssa
Sulle tracce dei cacciatori paleolitici e mesolitici MUSEO DELLE SCIENZE A CURA DI : GIAMPAOLO DALMERI e STEFANO NERI Sezione di Preistoria Dott. G. Dalmeri Dott. S. Neri, Dott.ssa R. Duches, Dott.ssa
LA SPESA PUBBLICA IN SICILIA DAL 1996 AL 2007 SECONDO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
 on lliine REGIONE SICILIANA Servizio Statistica LA SPESA PUBBLICA IN SICILIA DAL 1996 AL 27 SECONDO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI La Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) è il risultato di un progetto
on lliine REGIONE SICILIANA Servizio Statistica LA SPESA PUBBLICA IN SICILIA DAL 1996 AL 27 SECONDO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI La Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) è il risultato di un progetto
31dicembre La produzione di greggio
 - Assessorato dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell Energia La produzione di idrocarburi in Sicilia - dati al 31dicembre 2011 Fig. 1.2 1 - La produzione di greggio Nel corso
- Assessorato dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell Energia La produzione di idrocarburi in Sicilia - dati al 31dicembre 2011 Fig. 1.2 1 - La produzione di greggio Nel corso
F O R M A T O E U R O P E O
 F O R M A T O E U R O P E O P E R IL C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo LOREDANA LAURETTA Via Damaggio Fischetti, 88 93012 Gela (CL) Telefono cell. 3497129195 E-mail Loredana.lauretta@tin.it
F O R M A T O E U R O P E O P E R IL C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo LOREDANA LAURETTA Via Damaggio Fischetti, 88 93012 Gela (CL) Telefono cell. 3497129195 E-mail Loredana.lauretta@tin.it
Reggio Emilia, Parco Nazionale dell Appennino Tosco-Emiliano Via Comunale, Sassalbo di Fivizzano (MS)
 GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
MASSERIA BONIFACIO L analisi di una vasta area archeologica (Dr. Vito Zullo)
 MASSERIA BONIFACIO L analisi di una vasta area archeologica (Dr. Vito Zullo) PREMESSA L area archeologica di Masseria Bonifacio è situata a Sud/Est della città di Santeramo, a circa 6 km, ed e a ridosso
MASSERIA BONIFACIO L analisi di una vasta area archeologica (Dr. Vito Zullo) PREMESSA L area archeologica di Masseria Bonifacio è situata a Sud/Est della città di Santeramo, a circa 6 km, ed e a ridosso
Acquarossa: tramonto.
 La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
n 24 GROTTE GROTTE TROIANO
 n 24 GROTTE GROTTE TROIANO GROTTE TROIANO (Descrizione : Giuseppe Sorino Presidente Archeoclub) Ubicate nel foglio di mappa, N. 21, particella N. 434, alla profondità di circa 5,00 mt., si snodano da sud
n 24 GROTTE GROTTE TROIANO GROTTE TROIANO (Descrizione : Giuseppe Sorino Presidente Archeoclub) Ubicate nel foglio di mappa, N. 21, particella N. 434, alla profondità di circa 5,00 mt., si snodano da sud
Sulle orme della Preistoria. Museo delle Origini. Servizi per la Didattica 2011/2012 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL ANTICHITÀ
 Sulle orme della Preistoria Museo delle Origini Servizi per la Didattica 2011/2012 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL ANTICHITÀ Sulle orme della Preistoria Museo delle Origini Università degli Studi di Roma
Sulle orme della Preistoria Museo delle Origini Servizi per la Didattica 2011/2012 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL ANTICHITÀ Sulle orme della Preistoria Museo delle Origini Università degli Studi di Roma
Provincia di Pesaro e Urbino AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE DEL PIANO CON IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA
 Comune di Cartoceto Provincia di Pesaro e Urbino AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE CON IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA Approvato con Deliberazione
Comune di Cartoceto Provincia di Pesaro e Urbino AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE CON IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA Approvato con Deliberazione
FAVIGNANA: ricognizioni archeologiche nelle grotte del Faraglione Giovanni Mannino
 FAVIGNANA: ricognizioni archeologiche nelle grotte del Faraglione Giovanni Mannino Il Faraglione detto anche il Grosso è quella piccola rupe situata nell estremità Nord dell isola, separata dal canale
FAVIGNANA: ricognizioni archeologiche nelle grotte del Faraglione Giovanni Mannino Il Faraglione detto anche il Grosso è quella piccola rupe situata nell estremità Nord dell isola, separata dal canale
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA
 DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
Con queste tre domande l'abate Henri Breuil formula, all'inizio del secolo, lo scopo della paleontologia umana.
 Tham Wiman Nakin Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Con queste tre domande l'abate Henri Breuil formula, all'inizio del secolo, lo scopo della paleontologia umana. In Tham Wiman Nakin, la Grotta
Tham Wiman Nakin Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Con queste tre domande l'abate Henri Breuil formula, all'inizio del secolo, lo scopo della paleontologia umana. In Tham Wiman Nakin, la Grotta
UNIVERSITÀ DI PISA. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
 UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
Annuario Siti contaminati. Autori: Salvatore Caldara, Alberto Mandanici.
 Annuario 2015 Siti contaminati Autori: Salvatore Caldara, Alberto Mandanici. Il sistema Geosfera comprende il suolo propriamente detto. Esso è un sistema polifasico costituito da particelle minerali ed
Annuario 2015 Siti contaminati Autori: Salvatore Caldara, Alberto Mandanici. Il sistema Geosfera comprende il suolo propriamente detto. Esso è un sistema polifasico costituito da particelle minerali ed
Le pietre e i cittadini a. s
 Progetto nazionale per l Educazione al Patrimonio Le pietre e i cittadini a. s. 2016-17 SCHEDA DI LETTURA E DI INDAGINE DEL PAESAGGIO Docente STEFANELLI DANIELA VERA... Tel. 3287470241... E mail sdanielavera@yahoo.it...
Progetto nazionale per l Educazione al Patrimonio Le pietre e i cittadini a. s. 2016-17 SCHEDA DI LETTURA E DI INDAGINE DEL PAESAGGIO Docente STEFANELLI DANIELA VERA... Tel. 3287470241... E mail sdanielavera@yahoo.it...
VERBALE DI RIUNIONE DEL 04 AGOSTO 2011
 Reggio Calabria - Scilla societa' consortile per azioni PRESENTI: ANAS Alta Sorveglianza : Direzione Lavori: Pool Tecnico: Comitato Piale: Contraente Generale: Consulente del CG: VERBALE DI RIUNIONE DEL
Reggio Calabria - Scilla societa' consortile per azioni PRESENTI: ANAS Alta Sorveglianza : Direzione Lavori: Pool Tecnico: Comitato Piale: Contraente Generale: Consulente del CG: VERBALE DI RIUNIONE DEL
APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici. Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste
 APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste CAPITOLO 3 IL CLIMA ONDOSO A LARGO DELLE COSTE ITALIANE
APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste CAPITOLO 3 IL CLIMA ONDOSO A LARGO DELLE COSTE ITALIANE
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO
 CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Per l anno scolastico 2015-2016 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Per l anno scolastico 2015-2016 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
Marzo 2006 Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica presso la I Scuola di Specializzazione in Archeologia.
 GLORIA GALANTE Nata a Roma il 03/02/1978 Residente in Via Meropia 41 00147 Roma C.F. GLNGLR78B43H501Z Tel. 06/5110924 Cellulare 320/4111047 E-mail: gloria.galante@alice.it, daisied@virgilio.it TITOLI DI
GLORIA GALANTE Nata a Roma il 03/02/1978 Residente in Via Meropia 41 00147 Roma C.F. GLNGLR78B43H501Z Tel. 06/5110924 Cellulare 320/4111047 E-mail: gloria.galante@alice.it, daisied@virgilio.it TITOLI DI
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
 DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il presente elaborato di valutazione del rischio archeologico, redatto in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109\2005 artt.2ter
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il presente elaborato di valutazione del rischio archeologico, redatto in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109\2005 artt.2ter
: CINTA URBANA E VIABILITÀ
 LAVINIUM: CINTA URBANA E VIABILITÀ Maria Fenelli Scienze dell Antichità 19.2-3 2013 Maria Fenelli LAVINIUM: CINTA URBANA E VIABILITÀ La cinta urbana è stata oggetto di studio dalle fasi iniziali della
LAVINIUM: CINTA URBANA E VIABILITÀ Maria Fenelli Scienze dell Antichità 19.2-3 2013 Maria Fenelli LAVINIUM: CINTA URBANA E VIABILITÀ La cinta urbana è stata oggetto di studio dalle fasi iniziali della
