Catalogo dei paesaggi lombardi. Sistema Sottosistema Unità di Paesaggio
|
|
|
- Livia Viola
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PC Piano culminale, coincidente con la fascia fitoclimatica dell'alpinetum, ubicato a quote superiori ai 1700 m (± 300 m). Comprende l orizzonte subalpino degli arbusti contorti, l'orizzonte alpino o dei pascoli, l'orizzonte alto-alpino con vegetazione discontinua e l orizzonte" nivale con vegetazione pioniera. il sottosistema PC, non presente nel territorio interessato dal progetto "carta pedologica", viene ugualmente inserito in legenda per completare il sistema "p". PM Piano montano, coincidente con le fasce fitoclimatiche del Picetum e del Fagetum, ubicato a quote comprese tra 700 e 1700 m (±300 m). Comprende l'orizzonte montano inferiore con boschi di latifoglie sciafile (Fagus sylvatica) e l'orizzonte montano superiore con boschi di aghifoglie (Picea excelsa, P. abies, Larix europea). PM1 Creste sommitali e/o versanti a morfologia accidentata con pendenze da molto elevata ad estremamente elevata ( 45%), caratterizzati da abbondanza di pietre, massi e rocce affioranti. PM2 Versanti con pendenze da elevate ad estremamente elevate ( 25%), solcati da numerosi impluvi che rendono le superfici a morfologia complessa, con forme perpendicolari alle curve di livello PM3 Versanti a morfologia complessa, con forme parallele alle curve di livello, caratterizzati da superfici con pendenze da elevate ad estremamente elevate ( 25%), intervallati da superfici subpianeggianti con pendenze basse o medie. P Rilievi montuosi lombardi, caratterizzati da substrato roccioso e, sovente, da affioramenti litoidi. PB Piano basale, coincidente con la fascia fitoclimatica del Castanetum, ubicato a quote inferiori ai 700 m (± 300 m). Comprende l'orizzonte submediterraneo con sclerofille (Quercus ilex, Olea europea) e l'orizzonte submontano con boschi di latifoglie eliofile (Quercus robur peduncolata, Q. petraea, Castanea sativa). PV Fondivalle montani di origine alluvionale, comprendenti le superfici di raccordo (di origine colluviale) con i versanti limitrofi, in cui trovano ampia diffusione le colture agrarie. PB1 Versanti con pendenze da elevate a estremamente elevate ( 25%), con soprassuolo a bosco di latifoglie termofile (occasionalmente mesofile) per la prevalente esposizione a meridione, da cui dipende il frequente utilizzo a pascolo, vigneto e frutteto, sulle superfici meno acclivi o artificialmente terrazzate. PB2 Versanti con pendenze da elevate ad estremamente elevate ( 25%), con soprasuolo a bosco di latifoglie mesofile, raramente interrotto dall'utilizzo a pascolo, per la prevalente esposizione a settentrione. PB3 Crinali arrotondati, superfici cacuminali blandamente convesse e versanti con pendenze da moderate a moderatamente elevate (5-25%), utilizzati prevalentemente a pascolo, prato e seminativo. PB4 Terrazzi morfologici o morfotettonici sub-pianeggianti od a bassa pendenza ( 5%), sovente espressione morfologica di un substrato molto alterabile. Sono sede di intensa attività pastorale. PB5 Pianori e superfici fortemente ondulate consubstrato idrosolubile responsabile dell'improntamorfologica di tipo carsico. Presenza di doline,imbuti, inghiottitoi, campi solcati e carreggiati. PV1 Valli a fondo piatto e piane intermontane con pendenze basse o nulle ( 5%), spesso interessate da una falda sottosuperficiale. PV2 Conoidi di deiezione ubicati allo sboccodelle valli laterali, aventi basse pendenze (2-5%), soggetti a gradonatura ed intenso modellamento antropico. Sono spesso utilizzati a frutteto o vigneto. PV3 Superfici pedemontane di raccordo con l'alta pianura, corrispondenti alle principali fasce colluviali di piede versante. Hanno pendenze basse o moderate (2-15%) e sono soggette a modellamento antropico.
2 M Anfiteatri morenici dell alta pianura. MA Depositi morenici antichi, prerissiani ("mindel" e "pre-mindel"?), costituiti da materiali di origine glaciale e fluvioglaciale molto alterati, sepolti da sedimentie eolici (loess) e/o colluviali. MI Depositi morenici intermedi ("rissiani"), costituiti da materiali di origine glaciale e fluvioglaciale mediamente alterati, sovente sepolti da coperture eoliche ("loessiche") e/o colluviali. MA1 Cordoni morenici arrotondati che si presentano sottoforma di ampie ondulazioni, per la prolungata azione modellatrice (erosivo-colluviale) a cui sono stati sottoposti. I versanti hanno generalmente pendenze da basse a moderate (2-15%). MA2 Superfici di raccordo con le piane fluvioglaciali limitrofe, a pendenze da basse a moderate (2-15%), costituite da sedimenti di origine colluviale; comprendono le scarpate erosive, con pendenze anche molto elevate in prossimità dei principali solchi vallivi. MA3 Valli, scaricatori e piane, a morfologia subpianeggiante o concava, in cui prevalgono depositi fluvioglaciali, localmente sepolti da coperture eoliche o colluviali. MI1 Cordoni morenici principali e secondari, a morfologia collinosa, con versanti che generalmente hanno pendenze da basse ad elevate (2-45%). MI2 Superfici di raccordo con le piane fluvioglaciali limitrofe, a pendenze da basse a moderate (2-15%), costituite da sedimenti di origine colluviale; comprendono le scarpate erosive, con pendenze anche molto elevate in prossimità dei principali solchi vallivi MI3 Valli, scaricatori e piane, a morfologia subpianeggiante o concava, in cui prevalgono depositi fluvioglaciali, localmente sepolti da coperture eoliche o colluviali. MR1 Cordoni morenici principali e secondari, compresi quelli addossati ai versanti montuosi, generalmente a morfologia netta, con pendenze da basse a molto elevate (2-75%), costituiti da depositi grossolani poco classati immersi in matrice fine (sabbie e limi). MR2 Superfici di raccordo fra i rilievi morenici e le piane fluvioglaciali o fluviolacustri, generalmente con pendenze basse o moderate (2-15%), prevalentemente costituite da depositi colluviali di piede versante e/o da materiali che sono caratteristici degli ambienti deposizionali con cui fanno da transizione. MR3 Terrazzi subpianegginati rilevati sulle piane fluvioglaciali interne (MR 4), spesso corrispondenti a depositi di contatto glaciale lacustri o deltizi ( kames ), costituiti generalmente da materiali fini, privi di pietrosità in superficie. MR Depositi morenici recenti ( wurmiani ) a morfologia aspra e costituiti da sedimenti glaciali e subordinatamente fluvioglaciali e fluvio-lacustri, generalmente poco alterati, con diffusa presenza di pietrosità in superficie e di scheletro nei suoli. MR4 Piane e valli a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulata, in cui prevalgono depositi fluvioglaciali generalmente ben classati, grossolani e permeabili, correlabili ai depositi dell alta pianura ghiaiosa. MR5 Superfici subpianeggianti, costituite da materiali tendenzialmente fini riconducibili ad ambienti deposizionali di tipo lacustre, ben drenate o senza spiccate evidenze di idromorfia, per la posizione altimetricamente favorevole rispetto alle aree idromorfe (MR6, specchi lacustri o corsi d'acqua) a cui fanno normalmente da contorno. MR6 Aree in cui l'idromorfia è dovuta alla falda subaffiorante, riscontrabile sia in corrispondenza di conche lacustri - parzialmente o completamente prosciugate e prive di drenaggio esterno naturale -, sia in prossimità di corsi d'acqua. Ove i ristagni idrici sono più superficiali, sono diffusi depositi organici e vegetazione spontanea igrofila. MR7 Piane retromoreniche ondulate e mal drenate, costituite da sedimenti fini addensati derivanti da depositi morenici di fondo. Costante presenza di fossi drenanti per favorire lo scolo delle acque.
3 MR8 Solchi vallivi che generalmente incidono le piane fluvioglaciali interne, rappresentativi del reticolo idrografico non più attivo (es. scaricatori fluvioglaciali), sovradimensionati rispetto ai corsi d'acqua presenti, che comunque svolgono la semplice funzione di colatori. Includono le scarpate dovute al modellamento fluvioglaciale.
4 R Terrazzi subpianeggianti, rilevati rispetto al livello fondamentale della pianura, costituenti antiche superfici risparmiate dall erosone e comprendenti la maggior parte dei rilievi isolati della pianura. RA Terrazzi superiori o pianalti ("mindeliani?) - più rilevati delle altre superfci terrazzate, costituiti da materali fluvioglaciali grossolani molto alterati, attribuiti al Pleistocene medio, generalmente ricoperti da sedimenti eolici e/o colluviali. Sono diffusi suoli antichi (paleosuoli) con orizzonti induriti a fragipan. RI Terrazzi intermedi o rissiani, rilevati rispetto al livello Fondamentale della pianura ma ribassati rispetto ai pianalti, costituiti da materiali fluvioglaciali grossolani mediamente alterati, attribuiti al Pleistocene superiore, generalmente ricoperti da sedimenti eolici e/o colluviali. Sono diffusi suoli antichi (paleosuoli). RA1 DISATTIVATA RA2 Superfici più rappresentative - modali - e meglio conservate del pianalto caratterizzate da una morfologia subpianeggiante o ondulata. RA3 Porzioni di pianalto degradate, a morfologia ondulata o collinosa, solcate da una fitta rete drenante proveniente dai rilievi montuosi o richiamata dalle limitrofe superfici ribassate. La pendenza dei versanti va da moderata a elevata (5-45%). RA4 Depressioni e valli a fondo piatto fossili (paleoalvei), prive di sedimentazione recente, separati dalla superfice modale (RA 2) da gradini morfologici o da raccordi in pendenza. RA5 Superfici di raccordo con quelle limitrofe poste a quote inferiori. Comprendono sia le scarpate erosive, con pendenze anche molto alte, sia le fasce colluviali ed i conoidi alluvionali stabili, con pendenze da basse a moderate. RA6 DISATTIVATA RI1 Superfici più rappresentative - modali - e meglio conservate dei terrazzi rissiani, caratterizzate da una morfologia subpianeggiante o ondulata. RI2 Depressioni e valli a fondo piatto fossili, (paleoalvei), prive di sedimentazione recente, separate dalla superfice modale da gradini morfologici o da raccordi in pendenza. RI3 Superfici di raccordo con quelle limitrofe poste a quote inferiori. Comprendono sia le scarpate erosive, con pendenze anche molto alte, sia le fasce colluviali ed i conoidi alluvionali stabili, con pendenze da basse a moderate. RI4 DISATTIVATA
5 L Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura (L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione ("würmiana"). LG Ampie conoidi ghiaiose a morfologia subpianeggiante o leggermente convessa, costituite da materiali fluvioglaciali grossolani non alterati, comprese fra le superfici rilevate (rilievi montuosi, apparati morenici e terrazzi antichi) ed il limite superiore della fascia delle risorgive ("alta pianura ghiaiosa"). LQ Porzione centrale di pianura con intensi fenomeni di idromorfia, riconducibili all'emergenza delle risorgive e/o alla presenza di una falda sottosuperficiale, caratterizzate da variabile presenza di scheletro nel suolo e di pietrosità in superficie ("media pianura idromorfa".) LF Porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di un'idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel suolo ("bassa pianura sabbiosa"). LG1 Superficie rappresentativa - modale - dell'"alta pianura ghiaiosa", a morfologia subpianeggiante e con evidenti tracce di paleoidrografia a canali intrecciati (braided). In prossimità dei principali solchi vallivi la morfologia è caratterizzata da ampie ondulazioni. LG2 Superfici antiche, morfologicamente prive di dislivelli morfologici significativi, in continuità con quelle modali e caratterizzate da materiali tendenzialmente fini, frutto di una spinta alterazione in posto dei materiali d'origine. LG3 Superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali che, rispetto alle attigue superfici modali, sono generalmente costituite da materiali leggermente più grossolani. Si presentano lievemente ribassate e delimitate da orli di terrazzi convergenti o raccordate in lieve pendenza nella direzione dei solchi vallivi. LG4 Paleoalvei o depressioni di origine torrentizia privi di sedimentazione attiva, delimitati da orli di terrazzo o raccordati alla pianura. Comprendono gli ampi fondivalle generati dall'antica azione dagli scaricatori fluvioglaciali. LG5 Superfici pianeggianti caratterizzate da consistenti depositi colluviali o alluvionali, che ricoprono le ghiaie inalterate o poco alterate. Sono riscontrabili rispettivamente alla base dei rilievi o nelle zone ove le correnti fluvioglaciali e fluviali entrarono in fase di stanca. LQ1 Principali depressioni e testate legate ai fontanili, con drenaggio molto lento per la presenza di una falda semipermanente prossima al pianocampagna. LQ2 Depressioni e superfici a drenaggio lento, prive di scolo esterno naturale delle acque eccedenti, spesso con presenza di dreni artificiali. LQ3 Superfici subpianeggianti interposte alle principali linee di flusso ed le zone più stabili, a drenaggio mediocre o lento. Comprendono anche le aree di transizione con l'alta pianura ghiaiosa. LQ4 Superfici modali stabili meglio conservate, a morfolologia subpianeggiante od ondulata, dotate di drenaggio mediocre o buono. LF1 Dossi isolati al centro della pianura a debole convessità ed ampio raggio di curvatura, spesso dolcemente raccordati con la superficie modale per l'assenza di significative incisioni operate da corsi d'acqua attivi o fossili. LF2 Superficie modale stabile, pianeggiante o leggermente ondulata, intermedia tra le aree più rilevate (dossi) e depresse (conche e paleoalvei). LF3 Depressioni di forma subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e baulature dei campi. LF4 Paleoalvei fossili o sovradimensionati rispetto ai corsi d'acqua che vi scorrono, delimitati da orli di terrazzo o raccordati alla pianura (LF 2), spesso con drenaggio mediocre o lento. LF5 Superfici limitrofe ai principali solchi vallivi poco ribassate rispetto alla pianura (LF 2), generate da antiche divagazioni di corsi d'acqua, delimitate da orli di terrazzo discontinui o raccordate alla superficie modale, talora dotate di pendenze molto basse. LF6 Dossi fluviali rilevati e di forma generalmente allungata, ubicati ai bordi delle scarpate erosive che delimitano i principali solchi vallivi di corsi d'acqua attuali o fossili.
6 VT Superfici terrazzate costituite da alluvioni antiche o medie, delimitate da scarpate d erosione, E variamente rilevate sulle piane alluvionali (Olocene antico). VT1 Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate dall idromorfia. VT2 Terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento, causato dal ristagno e dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Coincidono spesso con paleoalvei, conche e depressioni. VT3 Superfici di raccordo tra il L. F. d. P. e le piane alluvionali dei corsi d acqua attivi, generalmente poco inclinate (bassa pendenza), originatesi per sovralluvionamento e ricopertura dell orlo di terrazzo preesistente. VT4 Superfici variamente inclinate corrispondenti alle scarpate erosive che delimitano i solchi vallivi (terrazzi fluviali e vallecole), sovente modellate dall intervento antropico. Comprendono le vallecole dei corsi d acqua minori, anche a carattere torrentizio, che formano incisioni a fondo acuto, nell ambito dei rilievi morenici, dei terrazzi antichi e del livello fondamentale della pianura, in corrispondenza dei dislivelli morfoaltimetrici più consistenti. V Valli alluvionali corripondenti ai piani di divagazione dei corsi d acqua attivi o fossili, rappresentanti il reticolato idrografico olocenico. VA Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalenmente deposizionale, costituite da Sedimenti recenti od attuali (Olocene recente ed attuale). VA1 Dossi di forma generalmente allungata, poco rilevati e dolcemente raccordati alle superfici adiacenti. Sono diffusi soprattutto nelle piane alluvionali di tracimazione e meandriformi. VA2 Superfici subpianeggianti a forma di lobo, lingua o ventaglio, derivanti da rotte di argini artificiali o naturali. Sono diffuse soprattutto nelle piane di tracimazione e meandriformi. VA3 Superficie modale subpianeggiante della piana alluvionale a meandri e di tracimazione, facente transizione tra le aree più rilevate (dossi) e quelle più depresse (conche). VA4 Conche chiuse di forma subcircolare, artificialmente drenate, rappresentanti le parti depresse delle piane alluvionali di tracimazione e meandriformi, costituite da sedimenti molto fini da cui dipende lo scarso drenaggio interno dei terreni VA5 Golene protette da arginature artificiali, inondabili durante gli eventi di piena straordinaria, caratteristiche delle sole piane alluvionali di tracimazione e meandriformi. VA6 Superfici adiacenti ai corsi d acqua ed isole fluviali inondabili durante gli eventi di piena ordinaria. Nelle piane di tracimazione ed a meandri coincidono con le golene aperte ; nelle piane a canali intrecciati e rettilinei si identificano con gli alvei di piena a vegetazione naturale riparia. VA7 Superfici sede di passata attività fluviale corrispondenti ad alvei e meandri sovradimensionati rispetto ai corsi d acqua che vi scorrono attualmente ed a conche lacustri o palustri parzialmente bonificate, caratterizzate da marcati fenomeni di idromorfia. VA8 Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d acqua, da cui sono generalmente separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove dominano patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi. VP Piana alluvionale olocenica posta a sud del Po e connessa in prevalena alle dinamiche deposizionali dei id' di i VP1 Superfici residuali corrispondenti al più antico livello di alta pianura, in gran parte smembrato e sepolto dalle successive alluvioni e preservato solo in ristretti settori soggetti a sollevamento tettonico. VP2 Dossi e paleodossi di forma generalmente allungata e sinuosa, poco rilevati e dolcemente raccordati alle superfici adiacenti. VP3 Superfici modali antiche, a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulata, solo marginalmente interessate da apporti alluvionali più recenti.
7 AREE MISTE corsi d'acqua di provenienza appenninica codici usati nel S.I.T. della Regione Lombardia VP4 Superficie modale recente della piana alluvionale appenninica, in transizione tra le aree più rilevate (dossi) e quelle più depresse (valli) VP5 Depressioni antiche di forma subcircolare, costituite da sedimenti fini, con frequenti problemi di smaltimento esterno delle acque. VP6 Ampie depressioni artificialmente drenate (bonifica recente), costituite da sedimenti molto fini da cui dipende lo scarso drenaggio interno dei suoli. U Aree urbane e verde urbano A Corpi d'acqua e Ghiacciai R1 Affioramenti rocciosi R2 Cave R3 Discariche N3 Frane, Calanchi ed Aree in erosione attiva N4 Pietraie e Depositi fluviali attivi N5 Spiagge
SISTEMA INFORMATIVO PEDOLOGICO Base informativa Suolo - scala di semidettaglio
 SISTEMA INFORMATIVO PEDOLOGICO Base informativa Suolo - scala di semidettaglio METADATI IDENTIFICAZIONE Titolo: Base informativa Suolo a scala di semidettaglio, progetto Carta Pedologica versione 2. INFORMAZIONI
SISTEMA INFORMATIVO PEDOLOGICO Base informativa Suolo - scala di semidettaglio METADATI IDENTIFICAZIONE Titolo: Base informativa Suolo a scala di semidettaglio, progetto Carta Pedologica versione 2. INFORMAZIONI
Capitolo 8 Il sistema ambientale la redazione delle carte di idoneita localizzativa
 apitolo 8 Il sistema ambientale la redazione delle carte di idoneita localizzativa 8.1 - Introduzione Le maggiori competenze attribuite al PTP dall art. 15 della L.R. 12/05 in tema di tutela delle aree
apitolo 8 Il sistema ambientale la redazione delle carte di idoneita localizzativa 8.1 - Introduzione Le maggiori competenze attribuite al PTP dall art. 15 della L.R. 12/05 in tema di tutela delle aree
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche:
 Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
CITTA di DESENZANO AGENDA 21 L Relazione sullo Stato dell Ambiente Tema 3 IL SUOLO ISO ambiente srl IL SUOLO
 IL SUOLO Morfologia, litologia, pedologia Le attitudini L uso del suolo Morfologia, litologia, pedologia Il territorio comunale di Desenzano è caratterizzato da una morfologia riconducibile a diversi processi
IL SUOLO Morfologia, litologia, pedologia Le attitudini L uso del suolo Morfologia, litologia, pedologia Il territorio comunale di Desenzano è caratterizzato da una morfologia riconducibile a diversi processi
sponda Terrazzo Piana alluvionale Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo barra isola Canale di magra
 Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo sponda Terrazzo Piana alluvionale barra isola Canale di magra Canale di magra: parte dell alveo che risulta totalmente o parzialmente ricoperta di acqua per la maggior
Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo sponda Terrazzo Piana alluvionale barra isola Canale di magra Canale di magra: parte dell alveo che risulta totalmente o parzialmente ricoperta di acqua per la maggior
L inquadramento geologico e geomorfologico. Le ricerche storiche
 6 2. L inquadramento geologico e geomorfologico 2.1. Le ricerche storiche I terreni appartenenti agli anfiteatri glaciali della Brianza e ai corrispondenti terrazzi della Alta Pianura Milanese erano un
6 2. L inquadramento geologico e geomorfologico 2.1. Le ricerche storiche I terreni appartenenti agli anfiteatri glaciali della Brianza e ai corrispondenti terrazzi della Alta Pianura Milanese erano un
2. La fertilità dei suoli 1
 56 2. La fertilità dei suoli 1 Il presente lavoro scaturisce da una serie di attività svolte per conto del parco delle Groane a partire dal 1999 e fino al 2003. Il territorio del Parco è stato oggetto
56 2. La fertilità dei suoli 1 Il presente lavoro scaturisce da una serie di attività svolte per conto del parco delle Groane a partire dal 1999 e fino al 2003. Il territorio del Parco è stato oggetto
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio
 UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
SCHEDA ANOMALIA 28 BG
 Università degli Studi di Bergamo Centro Studi sul Territorio Lelio Pagani ANALISI DELLE FOTOGRAFIE AEREE SCHEDA ANOMALIA 28 BG Georeferenziazione dell anomalia su C.T.R. e stralcio dell elaborato di fotointerpretazione
Università degli Studi di Bergamo Centro Studi sul Territorio Lelio Pagani ANALISI DELLE FOTOGRAFIE AEREE SCHEDA ANOMALIA 28 BG Georeferenziazione dell anomalia su C.T.R. e stralcio dell elaborato di fotointerpretazione
CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE P.G.T. Piano di Governo del Territorio STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO RELAZIONE TECNICA
 Dott. geol. Rosario Spagnolo GEOLOGIA TECNICA-IDROGEOLOGIA V.Indipendenza, 16 46100 Mantova Tel & Fax 0376.262759-338.2949637 - E-mail: ro.spagnolo@tiscali.it REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA CITTÀ
Dott. geol. Rosario Spagnolo GEOLOGIA TECNICA-IDROGEOLOGIA V.Indipendenza, 16 46100 Mantova Tel & Fax 0376.262759-338.2949637 - E-mail: ro.spagnolo@tiscali.it REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA CITTÀ
di Francesco Galbusera Il paesaggio di Casatenovo origine e trasformazioni
 di Francesco Galbusera Il paesaggio di Casatenovo origine e trasformazioni Percorso e soste Arrivo Lunghezza - 5 km Durata - 2 h Partenza Partenza Frazione Rimoldo Partenza Frazione Rimoldo La Geomorfologia
di Francesco Galbusera Il paesaggio di Casatenovo origine e trasformazioni Percorso e soste Arrivo Lunghezza - 5 km Durata - 2 h Partenza Partenza Frazione Rimoldo Partenza Frazione Rimoldo La Geomorfologia
GUIDA NATURALISTICA La Lomellina, agricoltura e natura come conoscenza III INCONTRO - 23 FEBBRAIO 2013 CORTE GHIOTTA DI VELEZZO LOMELLINA
 GUIDA NATURALISTICA La Lomellina, agricoltura e natura come conoscenza III INCONTRO - 23 FEBBRAIO 2013 CORTE GHIOTTA DI VELEZZO LOMELLINA GEOLOGIA DELLA LOMBARDIA E DELL AREA DELLA LOMELLINA IL SUOLO ED
GUIDA NATURALISTICA La Lomellina, agricoltura e natura come conoscenza III INCONTRO - 23 FEBBRAIO 2013 CORTE GHIOTTA DI VELEZZO LOMELLINA GEOLOGIA DELLA LOMBARDIA E DELL AREA DELLA LOMELLINA IL SUOLO ED
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1
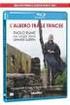 Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
Tecnologie per i Beni Culturali Corso di Cartografia tematica Dott. Maria Chiara Turrini
 Tecnologie per i Beni Culturali Corso di Cartografia tematica Dott. Maria Chiara Turrini La distanza di quota tra isoipse sarà costante e prende il nome di EQUIDISTANZA. Generalmente il valore dell equidistanza
Tecnologie per i Beni Culturali Corso di Cartografia tematica Dott. Maria Chiara Turrini La distanza di quota tra isoipse sarà costante e prende il nome di EQUIDISTANZA. Generalmente il valore dell equidistanza
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
 AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE ALLEGATO 4: UNITÀ DI TERRE SCHEDE. ELABORATO DEFINITIVO Settembre 2009
 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO Adottato con D.G.P. n. 622-590753/2007 in data 5 giugno 2007 Acquisito parere di conformità al PTR con D.G.R.
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO Adottato con D.G.P. n. 622-590753/2007 in data 5 giugno 2007 Acquisito parere di conformità al PTR con D.G.R.
Regione Friuli Venezia Giulia azienda dimostrativa MAURO ZANONE. Localizzazione. azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone
 Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti tra loro diversi per situazione
Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti tra loro diversi per situazione
Schede di progetto. Comune di Boltiere. Comune di Bonate Sotto. Comune di Dalmine. Comune di Filago. Comune di Madone. Comune di Osio Sopra
 Comune di Boltiere Comune di Bonate Sotto Comune di Dalmine Comune di Filago Comune di Madone Comune di Osio Sopra Comune di Osio Sotto DGR 11 maggio 2006 8/2512: 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi
Comune di Boltiere Comune di Bonate Sotto Comune di Dalmine Comune di Filago Comune di Madone Comune di Osio Sopra Comune di Osio Sotto DGR 11 maggio 2006 8/2512: 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi
Le coste: basse (foci fluviali, spiagge, lagune) e alte (ciglione carsico) FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 1
 Le coste: basse (foci fluviali, spiagge, lagune) e alte (ciglione carsico) FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 1 laguna di Marano FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 2 Rappresentazione imprecisa, difficile FVG 17 Lagune
Le coste: basse (foci fluviali, spiagge, lagune) e alte (ciglione carsico) FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 1 laguna di Marano FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 2 Rappresentazione imprecisa, difficile FVG 17 Lagune
La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana
 La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana L assetto geomorfologico della pianura padana è strettamente connesso al modello genetico della sua formazione. La Pianura Padana costituisce l avanfossa
La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana L assetto geomorfologico della pianura padana è strettamente connesso al modello genetico della sua formazione. La Pianura Padana costituisce l avanfossa
VAS COMUNE DI BULGAROGRASSO PROVINCIA DI COMO
 VAS COMUNE DI BULGAROGRASSO PROVINCIA DI COMO 4.5.Suolo e sottosuolo Il territorio di Bulgarograsso si estende nella fascia pedemontana prealpina della provincia di Como. Questa zona è caratterizzata,
VAS COMUNE DI BULGAROGRASSO PROVINCIA DI COMO 4.5.Suolo e sottosuolo Il territorio di Bulgarograsso si estende nella fascia pedemontana prealpina della provincia di Como. Questa zona è caratterizzata,
Basi Ambientali della Pianura Banca dati della Geomorfologia
 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) GESTIONE POLO CENTRALE Basi Ambientali della Pianura Banca dati della Geomorfologia Lo Schema fisico utente (Cover ArcInfo / Shape file) Versione 1.0 Dicembre
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) GESTIONE POLO CENTRALE Basi Ambientali della Pianura Banca dati della Geomorfologia Lo Schema fisico utente (Cover ArcInfo / Shape file) Versione 1.0 Dicembre
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005)
 SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. Circolare 7/LAP e N.T.E./99 L.R. 56/77 e s.m.i. NOVARA, marzo 2014
 COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Circolare 7/LAP e N.T.E./99 L.R. 56/77 e s.m.i. STUDIO GEOLOGICO RIVOLTA E GRASSI VIA G. PRATI, 4-28100 NOVARA Tel. e fax: 0321
COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Circolare 7/LAP e N.T.E./99 L.R. 56/77 e s.m.i. STUDIO GEOLOGICO RIVOLTA E GRASSI VIA G. PRATI, 4-28100 NOVARA Tel. e fax: 0321
COMUNE DI CANDIA CANAVESE
 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI CANDIA CANAVESE P.R.G.C. PROGETTO DEFINITIVO Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni di P.R.G. Vigente con le condizioni di
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI CANDIA CANAVESE P.R.G.C. PROGETTO DEFINITIVO Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni di P.R.G. Vigente con le condizioni di
Comune di SAN ROCCO AL PORTO Provincia di LODI
 Comune di SAN ROCCO AL PORTO Provincia di LODI STUDIO PER L INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO
Comune di SAN ROCCO AL PORTO Provincia di LODI STUDIO PER L INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda.
 La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
La montagna. Ghiacciai. Clima e vegetazione
 La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
Regione Friuli Venezia Giulia azienda dimostrativa EUROAGRICOLA di Denis Paron. Localizzazione
 Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Euroagricola di Denis Paron area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti di bassa
Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Euroagricola di Denis Paron area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti di bassa
Giardin Grande. Colle del Castello. Udine
 Giardin Grande Colle del Castello UD Udine TS G E O S I TO Colle di Udine Corrado Venturini C è un Grande Indiziato (secondo la Giuria Popolare) il Colle di Udine 26 m Attila COSA SI DICE luglio 452 d.c.
Giardin Grande Colle del Castello UD Udine TS G E O S I TO Colle di Udine Corrado Venturini C è un Grande Indiziato (secondo la Giuria Popolare) il Colle di Udine 26 m Attila COSA SI DICE luglio 452 d.c.
INCONTRI LARIANI: I SUOLI DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA. Cucciago (CO) sabato 24 settembre Programma dell escursione: INFO E PRENOTAZIONI:
 COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA! sabato 24 settembre 2016 INCONTRI LARIANI: I SUOLI DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA Cucciago (CO) A cura di Gruppo Naturalistico
COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA! sabato 24 settembre 2016 INCONTRI LARIANI: I SUOLI DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA Cucciago (CO) A cura di Gruppo Naturalistico
Schede sintetiche di classificazione
 Schede sintetiche di classificazione per aree con caratteristiche uniformabili Premessa La presente relazione descrive l insieme delle aree di nuova destinazione urbanistica distinguendole singolarmente
Schede sintetiche di classificazione per aree con caratteristiche uniformabili Premessa La presente relazione descrive l insieme delle aree di nuova destinazione urbanistica distinguendole singolarmente
LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA
 zona E LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA TEMPORALI VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. GIALLA Occasionale pericolo: fenomeni puntuali
zona E LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA TEMPORALI VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. GIALLA Occasionale pericolo: fenomeni puntuali
Studio G E O E C O S Dott. Geol. G. MENZIO. Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia. Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN)
 Studio Dott. Geol. G. MENZIO Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN) Tel0175977186-Fax1782737211-Cel.3402572786-mail:geoecos@libero.it Indirizzo di posta
Studio Dott. Geol. G. MENZIO Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN) Tel0175977186-Fax1782737211-Cel.3402572786-mail:geoecos@libero.it Indirizzo di posta
Legenda della Carta dei Pedopaesaggi della Toscana
 Legenda della Carta dei Pedopaesaggi della Toscana ordinata per livelli in base all'estensione territoriale Soil Region Sistema Sottosistema Unità descrizione dell'unità di Paesaggio Unità Cartografica
Legenda della Carta dei Pedopaesaggi della Toscana ordinata per livelli in base all'estensione territoriale Soil Region Sistema Sottosistema Unità descrizione dell'unità di Paesaggio Unità Cartografica
Comacchio, Sacca di Goro, Venezia, Caorle, Marano, Grado
 laguna di Marano Comacchio, Sacca di Goro, Venezia, Caorle, Marano, Grado Origine delle lagune: condizioni geologiche e idrologiche Costa bassa: pianura alluvionale e ampia piattaforma continentale Escursione
laguna di Marano Comacchio, Sacca di Goro, Venezia, Caorle, Marano, Grado Origine delle lagune: condizioni geologiche e idrologiche Costa bassa: pianura alluvionale e ampia piattaforma continentale Escursione
Geomorfologia Eolica
 Geomorfologia Eolica Forme determinate dall azione del vento Duna: rilievo di sabbia costruito dal vento Tipi più comuni di dune Barcana: duna isolata che in pianta assomiglia ad una mezzaluna Esempi di
Geomorfologia Eolica Forme determinate dall azione del vento Duna: rilievo di sabbia costruito dal vento Tipi più comuni di dune Barcana: duna isolata che in pianta assomiglia ad una mezzaluna Esempi di
Geomorfologia Fluviale
 Geomorfologia Fluviale Geomorfologia Fluviale: studia i processi che avvengono nel reticolo idrografico (erosione, trasporto solido, sedimentazione) e le forme da essi generate 507 BACINO IDROGRAFICO La
Geomorfologia Fluviale Geomorfologia Fluviale: studia i processi che avvengono nel reticolo idrografico (erosione, trasporto solido, sedimentazione) e le forme da essi generate 507 BACINO IDROGRAFICO La
STUDIO TERRITORIALE - AGRONOMICO. Indagine Conoscitiva Territoriale
 Regione Lombardia Provincia di Brescia STUDIO TERRITORIALE - AGRONOMICO Committente: Comune di Capriolo Via Vittorio Emanuele, 43 25031 - Capriolo (BS) - Italy Documento: A01SA Revisione: r00 Incarico:
Regione Lombardia Provincia di Brescia STUDIO TERRITORIALE - AGRONOMICO Committente: Comune di Capriolo Via Vittorio Emanuele, 43 25031 - Capriolo (BS) - Italy Documento: A01SA Revisione: r00 Incarico:
CAVA DI SCAGLIAME DI MARMO OFICALCE
 Regione Autonoma Valle D aosta Région Autonome Vallée d Aoste Comune di Verrayes Commune de Verrayes Committente : Menegoni S.r.l. Via Arberaz n 5 11023 Chambave (Ao) CAVA DI SCAGLIAME DI MARMO OFICALCE
Regione Autonoma Valle D aosta Région Autonome Vallée d Aoste Comune di Verrayes Commune de Verrayes Committente : Menegoni S.r.l. Via Arberaz n 5 11023 Chambave (Ao) CAVA DI SCAGLIAME DI MARMO OFICALCE
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4
 RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9220144 LAGO SAN GIULIANO E TIMMARI Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA
RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9220144 LAGO SAN GIULIANO E TIMMARI Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA
Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana
 Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
TIPI DI PAESAGGIO ITALIANI
 CARTA DELLA NATURA TIPI DI PAESAGGIO ITALIANI TIPI DI PAESAGGIO DI BASSA PIANURA SIGLA NOME DESCRIZIONE PA Pianura aperta - Descrizione sintetica: area pianeggiante, sub-pianeggiante o ondulata caratterizzata
CARTA DELLA NATURA TIPI DI PAESAGGIO ITALIANI TIPI DI PAESAGGIO DI BASSA PIANURA SIGLA NOME DESCRIZIONE PA Pianura aperta - Descrizione sintetica: area pianeggiante, sub-pianeggiante o ondulata caratterizzata
COMUNE DI SAN VERO MILIS
 RELAZIONE AGRONOMICA "$" % & ' ( ) * ' +,,, - 1 RELAZIONE AGRONOMICA (./01) + 2, 2, 3 4 5 )64.7789 ' $ 5 9, 2 RELAZIONE AGRONOMICA : ' $ ( $ ; 3/? 3 "$ ( ( @8A0 59B8B053
RELAZIONE AGRONOMICA "$" % & ' ( ) * ' +,,, - 1 RELAZIONE AGRONOMICA (./01) + 2, 2, 3 4 5 )64.7789 ' $ 5 9, 2 RELAZIONE AGRONOMICA : ' $ ( $ ; 3/? 3 "$ ( ( @8A0 59B8B053
COMUNE DI MATELICA. Provincia di Macerata
 DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
GEOMORFOLOGIA. Modellamento dei versanti
 GEOMORFOLOGIA La Geomorfologia ha per fine lo studio e l interpretazione delle forme e dei processi responsabili del modellamento del rilievo terrestre I processi geodinamici possono distinguersi in due
GEOMORFOLOGIA La Geomorfologia ha per fine lo studio e l interpretazione delle forme e dei processi responsabili del modellamento del rilievo terrestre I processi geodinamici possono distinguersi in due
COSTRUZIONI CASSARA DI CASSARA GEOM. ANTONINO C.SO TORINO, 55 VIGEVANO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA
 COMUNE DI VIGEVANO Provincia di Pavia COMMITTENTE COSTRUZIONI CASSARA DI CASSARA GEOM. ANTONINO C.SO TORINO, 55 VIGEVANO PROGETTO PL VIA VALLETTA FOGLIANO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott.Geol.
COMUNE DI VIGEVANO Provincia di Pavia COMMITTENTE COSTRUZIONI CASSARA DI CASSARA GEOM. ANTONINO C.SO TORINO, 55 VIGEVANO PROGETTO PL VIA VALLETTA FOGLIANO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott.Geol.
UNITÀ 5 L IDROSFERA. Lezione 1 Le proprietà dell acqua
 Lezione 1 Le proprietà dell acqua Approfondimento - Il bilancio idrico globale Calcolare il bilancio idrico globale significa analizzare l aspetto quantitativo del ciclo dell acqua cioè il valore numerico
Lezione 1 Le proprietà dell acqua Approfondimento - Il bilancio idrico globale Calcolare il bilancio idrico globale significa analizzare l aspetto quantitativo del ciclo dell acqua cioè il valore numerico
IL TERRITORIO DI BERGAMO NELLA NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA
 IL TERRITORIO DI BERGAMO NELLA NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA venerdì 30 maggio 2014, 9:30 17:30 Bergamo, Museo Civico di Scienze Naturali Sala Curò Piazza Cittadella 8 Geologia e modelli idraulici per l
IL TERRITORIO DI BERGAMO NELLA NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA venerdì 30 maggio 2014, 9:30 17:30 Bergamo, Museo Civico di Scienze Naturali Sala Curò Piazza Cittadella 8 Geologia e modelli idraulici per l
2 faglia certa M-STR-02a X X L. 3 faglia presunta M-STR-02b X X L. 4 limite di area di subsidenza o sprofondamento M-STR-03 X X L
 N SIMBOLO LEGENDA TIPO/CODICE GRAFIA GRAFIA PRIMITIVA Geomorfologia arcgis geomedia 6 FORME STRUTTURALI E VULCANICHE Stabilo 630 (10) RGB (129, 40, 3) 1 frattura M-STR-01 X X L 2 faglia certa M-STR-02a
N SIMBOLO LEGENDA TIPO/CODICE GRAFIA GRAFIA PRIMITIVA Geomorfologia arcgis geomedia 6 FORME STRUTTURALI E VULCANICHE Stabilo 630 (10) RGB (129, 40, 3) 1 frattura M-STR-01 X X L 2 faglia certa M-STR-02a
Aosta. 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone
 Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
AREALE A37 P.I.P A SUD DELLA ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE
 AREALE A37 P.I.P A SUD DELLA ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE Caratteristiche geologiche Unità fluviali del Pleistoceniche sup. ( fluviale-fluvioglaciale Würm auctt.), prevalentemente ghiaioso-sabbiose e coperture
AREALE A37 P.I.P A SUD DELLA ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE Caratteristiche geologiche Unità fluviali del Pleistoceniche sup. ( fluviale-fluvioglaciale Würm auctt.), prevalentemente ghiaioso-sabbiose e coperture
 ALLEGATO 1: MAPPA DI SINTESI ALLEGATO 2: MAPPA IDRO PLUVIOMETRICA ALLEGATO 2.1: CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI ELEMENTI MORFOLOGICI FQ10 16 Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo di
ALLEGATO 1: MAPPA DI SINTESI ALLEGATO 2: MAPPA IDRO PLUVIOMETRICA ALLEGATO 2.1: CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI ELEMENTI MORFOLOGICI FQ10 16 Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo di
Allegato D1. Descrizione dei suoli
 Allegato D1 Descrizione dei suoli 2 Profili pedologici descritti ex novo (2010) vedi Cap.2, paragrafo 2.4 P1 Località: Civiglio, a monte di San Nicola Coordinate: 1509351, 5073592 Quota: 730 m s. l. m.
Allegato D1 Descrizione dei suoli 2 Profili pedologici descritti ex novo (2010) vedi Cap.2, paragrafo 2.4 P1 Località: Civiglio, a monte di San Nicola Coordinate: 1509351, 5073592 Quota: 730 m s. l. m.
15/11/2015. Foglio Isola d Ischia-Napoli: Parthenope e Neapolis. d Ischia- Napoli: Vesuvio (isoipse) Foglio Isola d Ischia-Napoli: Campi Flegrei
 Tacche latidine 15/11/2015 Foglio Isola d Ischia-Napoli 1 30 00 41 00 00 Isole amministrative 1. Villaricca 2. Pomigliano d Arco 3. Portici Tacche longitudine Scala numerica e scala grafica Quadro d unione
Tacche latidine 15/11/2015 Foglio Isola d Ischia-Napoli 1 30 00 41 00 00 Isole amministrative 1. Villaricca 2. Pomigliano d Arco 3. Portici Tacche longitudine Scala numerica e scala grafica Quadro d unione
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESISTICA E AMBIENTALE AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA)
 AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO DI CARTOGRAFIA
 GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO DI CARTOGRAFIA a cura di S. Furlani A.A. 2016/2017 Programma OBIETTIVI FORMATIVI MORFOLOGIA, CARTOGRAFIA, EVOLUZIONE MORFOLOGICA Composizione dell atmosfera, idrosfera,
GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO DI CARTOGRAFIA a cura di S. Furlani A.A. 2016/2017 Programma OBIETTIVI FORMATIVI MORFOLOGIA, CARTOGRAFIA, EVOLUZIONE MORFOLOGICA Composizione dell atmosfera, idrosfera,
Relazione Agropedologica
 Comune di San Lorenzo del Vallo PSC Piano Strutturale Comunale LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE Relazione Agropedologica Rossano (CS) lì, 22 maggio 2008 Roberto Sabatino Dott. Agronomo
Comune di San Lorenzo del Vallo PSC Piano Strutturale Comunale LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE Relazione Agropedologica Rossano (CS) lì, 22 maggio 2008 Roberto Sabatino Dott. Agronomo
STUDIO DELLA COMPONENTE AGRONOMICA
 COMUNE DI LIVRAGA (PROVINCIA DI LODI) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ex L.R. 12/05 STUDIO DELLA COMPONENTE AGRONOMICA REVISIONE 01 aprile 2009 a cura di: 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) tel. 02 51.28.02
COMUNE DI LIVRAGA (PROVINCIA DI LODI) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ex L.R. 12/05 STUDIO DELLA COMPONENTE AGRONOMICA REVISIONE 01 aprile 2009 a cura di: 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) tel. 02 51.28.02
Mitigazione del rischio relativo ai dissesti dei corsi d acqua e dei versanti
 Mitigazione del rischio relativo ai dissesti dei corsi d acqua e dei versanti Criteri di approccio sistemico Da R. Rosso 2 Misure Strutturali di Manutenzione Straordinaria OBIETTIVI: riparazione, ricostruzione,
Mitigazione del rischio relativo ai dissesti dei corsi d acqua e dei versanti Criteri di approccio sistemico Da R. Rosso 2 Misure Strutturali di Manutenzione Straordinaria OBIETTIVI: riparazione, ricostruzione,
Acquiferi alluvionali della pianura padana
 Acquiferi alluvionali della pianura padana Paolo Severi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione Emilia - Romagna La struttura geologica degli acquiferi padani La Pianura Padana è una pianura alluvionale
Acquiferi alluvionali della pianura padana Paolo Severi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione Emilia - Romagna La struttura geologica degli acquiferi padani La Pianura Padana è una pianura alluvionale
3. - NOTE PER L'USO DELLA SIMBOLOGIA
 36 GRUPPO DI LAVORO PER LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA 3. - NOTE PER L'USO DELLA SIMBOLOGIA Ove non specificato diversamente, i simboli areali in colonna A vanno utilizzati nei seguenti modi: 1) sul colore
36 GRUPPO DI LAVORO PER LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA 3. - NOTE PER L'USO DELLA SIMBOLOGIA Ove non specificato diversamente, i simboli areali in colonna A vanno utilizzati nei seguenti modi: 1) sul colore
AREALE A27 S.U.E. VIA ANADONE
 AREALE A27 S.U.E. VIA ANADONE Caratteristiche geologiche Unità alluvionali oloceniche più esterne del F. Sesia ( alluvioni antiche auctt.), prevalentemente ghiaioso-sabbiose. Caratteristiche litotecniche
AREALE A27 S.U.E. VIA ANADONE Caratteristiche geologiche Unità alluvionali oloceniche più esterne del F. Sesia ( alluvioni antiche auctt.), prevalentemente ghiaioso-sabbiose. Caratteristiche litotecniche
2.4 APPLICAZIONE DELLA FOTOINTERPRETAZIONE: ESERCITAZIONI ED ESPERIENZE
 Capitolo 2.4 2.4 APPLICAZIONE DELLA FOTOINTERPRETAZIONE: ESERCITAZIONI ED ESPERIENZE 2.4.1 Effetto stereoscopico. Nella figure 2.4.1 e 2.4.2 vengono riprodotte porzioni di fotografie aeree adiacenti a
Capitolo 2.4 2.4 APPLICAZIONE DELLA FOTOINTERPRETAZIONE: ESERCITAZIONI ED ESPERIENZE 2.4.1 Effetto stereoscopico. Nella figure 2.4.1 e 2.4.2 vengono riprodotte porzioni di fotografie aeree adiacenti a
Definizione di una metodologia di indagine e classificazione idromorfologica dei corsi d acqua
 I Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale Sarzana 18 Giugno 2009 Definizione di una metodologia di indagine e classificazione idromorfologica dei corsi d acqua Massimo RINALDI 1, Nicola SURIAN
I Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale Sarzana 18 Giugno 2009 Definizione di una metodologia di indagine e classificazione idromorfologica dei corsi d acqua Massimo RINALDI 1, Nicola SURIAN
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 11 ART. 6 LR N.11/2004 Sig. BONADIMAN TIZIANO Area polifunzionale mista servizi e residenza Zona F per attrezzature e
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 11 ART. 6 LR N.11/2004 Sig. BONADIMAN TIZIANO Area polifunzionale mista servizi e residenza Zona F per attrezzature e
costituito dai seguenti comuni: Casnigo, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Vertova. La superficie territoriale del sub-ambito è di 51,71 km 2.
 costituito dai seguenti comuni: Casnigo, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Vertova. La superficie territoriale del sub-ambito è di 51,71 km 2. Figura 9 suddivisione della provincia di Bergamo in 24
costituito dai seguenti comuni: Casnigo, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Vertova. La superficie territoriale del sub-ambito è di 51,71 km 2. Figura 9 suddivisione della provincia di Bergamo in 24
Esame di Stato per l abilitazione alla professione di Geologo Vecchio ordinamento
 Compito 1 sondaggi a carotaggio continuo ivi eseguiti. Si ipotizzi che l area sia oggetto di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un opera di sbarramento fluviale. Ai fini della permeabilità
Compito 1 sondaggi a carotaggio continuo ivi eseguiti. Si ipotizzi che l area sia oggetto di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un opera di sbarramento fluviale. Ai fini della permeabilità
Di seguito, per ogni osservazione, vengono illustrate e motivate le integrazioni inserite nelle relative schede:
 Il presente elaborato riporta le Schede geologico-tecniche relative ad aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza. Il Settore Prevenzione del Rischio Geologico,
Il presente elaborato riporta le Schede geologico-tecniche relative ad aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza. Il Settore Prevenzione del Rischio Geologico,
TRATTO BI LOCALITA Bibione Pineda LUNGHEZZA 204 m AZIMUT 81 N TIPOLOGIA DIFENSIVA. QUOTE L argine ornamentale ha una quota media di 2.4 m.
 TRATTO BI LOCALITA Bibione Pineda LUNGHEZZA 204 m AZIMUT 81 N L area a parcheggio che costituisce l estremità di viale dei Lauri è separata dalla spiaggia emersa da un filare di tamerici, accompagnato
TRATTO BI LOCALITA Bibione Pineda LUNGHEZZA 204 m AZIMUT 81 N L area a parcheggio che costituisce l estremità di viale dei Lauri è separata dalla spiaggia emersa da un filare di tamerici, accompagnato
UNIVERSITÀ DI PISA. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
 UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
LE OPERE DI SBARRAMENTO
 LE OPERE DI SBARRAMENTO LE DIGHE Sono opere di sbarramento, di un corso d acqua, che determinano la formazione di un invaso o lago artificiale. L opera può avere diversi scopi: Regolare le portate fluviali
LE OPERE DI SBARRAMENTO LE DIGHE Sono opere di sbarramento, di un corso d acqua, che determinano la formazione di un invaso o lago artificiale. L opera può avere diversi scopi: Regolare le portate fluviali
Evoluzione dei litorali sabbiosi in relazione ai cambiamenti climatici nel periodo storico ORTOLANI F. 1, PAGLIUCA S. 2
 Evoluzione dei litorali sabbiosi in relazione ai cambiamenti climatici nel periodo storico ORTOLANI F. 1, PAGLIUCA S. 2 1 Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Università di Napoli Federico
Evoluzione dei litorali sabbiosi in relazione ai cambiamenti climatici nel periodo storico ORTOLANI F. 1, PAGLIUCA S. 2 1 Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Università di Napoli Federico
Il Quaternario in Friuli
 Il Quaternario in Friuli Anfiteatro morenico del Tagliamento II AA 2015-2016 GQt 08 1 AA 2015-2016 GQt 08 2 Divisioni dell ultimo Quaternario: la glaciazione wurmiana. Le età numeriche sono indicative
Il Quaternario in Friuli Anfiteatro morenico del Tagliamento II AA 2015-2016 GQt 08 1 AA 2015-2016 GQt 08 2 Divisioni dell ultimo Quaternario: la glaciazione wurmiana. Le età numeriche sono indicative
Analisi suolo e sottosuolo
 Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
Suolo e sottosuolo. RSA Provincia di Milano. Suolo e sottosuolo
 RSA Provincia di Milano Suolo e sottosuolo Il suolo è una matrice cruciale per l equilibrio degli ecosistemi e per il mantenimento dell equilibrio della biosfera, in quanto strato che ricopre la litosfera,
RSA Provincia di Milano Suolo e sottosuolo Il suolo è una matrice cruciale per l equilibrio degli ecosistemi e per il mantenimento dell equilibrio della biosfera, in quanto strato che ricopre la litosfera,
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 10 ART. 6 LR N.11/2004 L&D IMMOBILIARE Srl Centro Servizi per l Automobile con annessa struttura ricettiva autohotel VALUTAZIONE
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 10 ART. 6 LR N.11/2004 L&D IMMOBILIARE Srl Centro Servizi per l Automobile con annessa struttura ricettiva autohotel VALUTAZIONE
IL TEMA DELLA FALDA ACQUIFERA E DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELLA ZONA DEL SUD MILANO.
 IL TEMA DELLA FALDA ACQUIFERA E DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELLA ZONA DEL SUD MILANO. Laura Scesi Politecnico di Milano laura.scesi@polimi.it Premessa Gli aspetti idrogeologici hanno oggi acquistato un rilevante
IL TEMA DELLA FALDA ACQUIFERA E DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELLA ZONA DEL SUD MILANO. Laura Scesi Politecnico di Milano laura.scesi@polimi.it Premessa Gli aspetti idrogeologici hanno oggi acquistato un rilevante
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
REGIONE PIEMONTE COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE
 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE REVISIONE 2013 ai sensi della Circolare della Regione Piemonte 7/lap e s.m.i. L.R. n 56 del 5/12/1977
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE REVISIONE 2013 ai sensi della Circolare della Regione Piemonte 7/lap e s.m.i. L.R. n 56 del 5/12/1977
AGOGNA scheletrico-franca, fase tipica AGO1
 AGOGNA scheletrico-franca, fase tipica AGO1 Distribuzione geografica e pedoambiente Terrazzi medio-recenti posti in prossimità dei corsi d'acqua che li hanno generati: La morfologia è caratterizzata da
AGOGNA scheletrico-franca, fase tipica AGO1 Distribuzione geografica e pedoambiente Terrazzi medio-recenti posti in prossimità dei corsi d'acqua che li hanno generati: La morfologia è caratterizzata da
CORSO DI LAUREA IN URBANISTICA E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI Analisi della città e del territorio e SIT Prof.
 Descrizione della forma del suolo La geomorfologia è la scienza che ha per oggetto la descrizione e la spiegazione del rilievo terrestre; il termine morfologia implica la considerazione della forma, intesa
Descrizione della forma del suolo La geomorfologia è la scienza che ha per oggetto la descrizione e la spiegazione del rilievo terrestre; il termine morfologia implica la considerazione della forma, intesa
3.3 Il bacino del fiume Cavone
 3.3 Il bacino del fiume Cavone 3.3.1 Il territorio Il bacino del fiume Cavone (superficie di 675 kmq) presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, ad eccezione che nella porzione settentrionale
3.3 Il bacino del fiume Cavone 3.3.1 Il territorio Il bacino del fiume Cavone (superficie di 675 kmq) presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, ad eccezione che nella porzione settentrionale
DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO
 COMUNE DI OZZERO DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi dell'art.3 comma 114 del L.R. 1/2000 D.G.R. N.7/7868/2002 e s.m.i. Dott. Geol. Maurizio VISCONTI Corso Milano 2 VIGEVANO (PV) Collaborazione:
COMUNE DI OZZERO DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi dell'art.3 comma 114 del L.R. 1/2000 D.G.R. N.7/7868/2002 e s.m.i. Dott. Geol. Maurizio VISCONTI Corso Milano 2 VIGEVANO (PV) Collaborazione:
Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo
 Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo F. Pergalani, M. Compagnoni, M.P. Boni Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo F. Pergalani, M. Compagnoni, M.P. Boni Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
Introduzione...2 Inquadramento geografico...2 Geomorfologia...4 Idrografia...5 Geologia...5 Vincoli...5 Tipologia di interventi...
 Introduzione...2 Inquadramento geografico...2 Geomorfologia...4 Idrografia...5 Geologia...5 Vincoli...5 Tipologia di interventi...6 ALLEGATO 1-Estratto del Foglio 43 della Carta Geologica d Italia alla
Introduzione...2 Inquadramento geografico...2 Geomorfologia...4 Idrografia...5 Geologia...5 Vincoli...5 Tipologia di interventi...6 ALLEGATO 1-Estratto del Foglio 43 della Carta Geologica d Italia alla
fauna selvatica (Ha) Ardesio
 Oasi di protezione Cima vaccaro Superficie totale (Ha) 92,24 92,24 Ardesio L Oasi di protezione è in gran parte localizzata nella fascia La tipologia vegetazionale è prevalentemente riferibile al bosco
Oasi di protezione Cima vaccaro Superficie totale (Ha) 92,24 92,24 Ardesio L Oasi di protezione è in gran parte localizzata nella fascia La tipologia vegetazionale è prevalentemente riferibile al bosco
PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO DELLA PIANURA EMILIANO-ROMAGNOLA ALLA SCALA 1:50.000
 Conferenza del Dott. Paolo Severi di Giovedì 18 Marzo 2010 ore 15.00 tenuta presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell Università di Parma PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO
Conferenza del Dott. Paolo Severi di Giovedì 18 Marzo 2010 ore 15.00 tenuta presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell Università di Parma PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO
VARIANTE IN ITINERE AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE GENERALE. Progetto preliminare: delibera del C.C. n. 28 del
 VARIANTE IN ITINERE AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE GENERALE Progetto preliminare: delibera del C.C. n. 28 del 16.04.1999 SEZIONE UNICA DOTT. GIANFRANCO GARDENGHI G E O L O G O I-10152 TORINO -
VARIANTE IN ITINERE AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE GENERALE Progetto preliminare: delibera del C.C. n. 28 del 16.04.1999 SEZIONE UNICA DOTT. GIANFRANCO GARDENGHI G E O L O G O I-10152 TORINO -
INDICE. 1 CARTA DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA E DELLA SALVAGUARDIA Pag. 2
 INDICE 1 CARTA DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA E DELLA SALVAGUARDIA Pag. 2 1.1 Cenni generali Pag. 2 1.2 Analisi della legenda Pag. 2 1.3 Analisi della carta della pericolosità idraulica e della salvaguardia
INDICE 1 CARTA DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA E DELLA SALVAGUARDIA Pag. 2 1.1 Cenni generali Pag. 2 1.2 Analisi della legenda Pag. 2 1.3 Analisi della carta della pericolosità idraulica e della salvaguardia
La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con
 La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con la storia geologica del pianeta: quando, 4.600 milioni di anni fa, la superficie terrestre fino allora concentrata in una sola unità strutturale
La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con la storia geologica del pianeta: quando, 4.600 milioni di anni fa, la superficie terrestre fino allora concentrata in una sola unità strutturale
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE Il territorio comunale di Montebello Jonico ha una estensione di 55,67 Kmq ed è posizionato al margine meridionale dello spazio geografico che da secoli viene denominato con
INQUADRAMENTO TERRITORIALE Il territorio comunale di Montebello Jonico ha una estensione di 55,67 Kmq ed è posizionato al margine meridionale dello spazio geografico che da secoli viene denominato con
5.1.3 L indagine sulla risorsa suolo e sottosuolo I paesaggi pedologici e la carta dei pedopaesaggi
 491 5.1.3 L indagine sulla risorsa suolo e sottosuolo 5.1.3.1. I paesaggi pedologici e la carta dei pedopaesaggi Dalla lettura del Nuovo Catasto del 1887 emerge una sostanziale bipartizione tra il terreno
491 5.1.3 L indagine sulla risorsa suolo e sottosuolo 5.1.3.1. I paesaggi pedologici e la carta dei pedopaesaggi Dalla lettura del Nuovo Catasto del 1887 emerge una sostanziale bipartizione tra il terreno
COMUNE DI BRANDIZZO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N.3 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA
 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRANDIZZO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA Il Tecnico Dott. Geol. Secondo Accotto data Ottobre 2010 Dott. Geol. Secondo ACCOTTO
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRANDIZZO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA Il Tecnico Dott. Geol. Secondo Accotto data Ottobre 2010 Dott. Geol. Secondo ACCOTTO
A2.1 - Tabelle per il calcolo dei coefficienti di amplificazione sismica (secondo livello di approfondimento)
 ALLEGATO A2 TABELLE E FORMULE PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER LE ANALISI DEL SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI TOPOGRAFICI. A2.1 - Tabelle
ALLEGATO A2 TABELLE E FORMULE PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER LE ANALISI DEL SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI TOPOGRAFICI. A2.1 - Tabelle
Proposta di legenda Carta uso suolo 1:25.000 Gruppo di lavoro Uso e copertura del suolo presentata nel seminario di Napoli nel 2004.
 Proposta di legenda Carta uso suolo 1:25.000 Gruppo di lavoro Uso e copertura del suolo presentata nel seminario di Napoli nel 2004. Progetto Corine LC Scala 1:100.000 1 /2 /3 Livello Voci base comuni,
Proposta di legenda Carta uso suolo 1:25.000 Gruppo di lavoro Uso e copertura del suolo presentata nel seminario di Napoli nel 2004. Progetto Corine LC Scala 1:100.000 1 /2 /3 Livello Voci base comuni,
Variazioni del profilo di fondo alveo
 Assetto Schedatura morfologico dei tratti e idraulico fluviali Fiume: Baganza Ordine: III sx/dx Po: Destra P Lunghezza tratto (Km):,0 Tratto: PR_04000 - BA_01000 confluenza Baganza in Parma - località
Assetto Schedatura morfologico dei tratti e idraulico fluviali Fiume: Baganza Ordine: III sx/dx Po: Destra P Lunghezza tratto (Km):,0 Tratto: PR_04000 - BA_01000 confluenza Baganza in Parma - località
LE ACQUE DELLA PIANURA ISONTINA VODE SOŠKEGA ALUVIJA INTRODUZIONE AL PROGETTO GEP/ UVODNA BESEDA O PROJEKTU GEP
 EVENTO INFORMATIVO-DIVULGATIVO / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO LE ACQUE DELLA PIANURA ISONTINA VODE SOŠKEGA ALUVIJA INTRODUZIONE AL PROGETTO GEP/ UVODNA BESEDA O PROJEKTU GEP Franco CUCCHI Dipartimento
EVENTO INFORMATIVO-DIVULGATIVO / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO LE ACQUE DELLA PIANURA ISONTINA VODE SOŠKEGA ALUVIJA INTRODUZIONE AL PROGETTO GEP/ UVODNA BESEDA O PROJEKTU GEP Franco CUCCHI Dipartimento
