La ricostruzione del trofismo del Lago di Lavarone dalle diatomee
|
|
|
- Celia Corti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (25): ISSN Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 27 La ricostruzione del trofismo del Lago di Lavarone dalle diatomee Nicola ANGELI 1* & André F. LOTTER 2 1 Sezione di Limnologia e Algologia, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Via Calepina 14, 381 Trento, Italia 2 Institute of Environmental Biology, Faculty of Science, Utrecht University, Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, The Netherlands * dell Autore per la corrispondenza: angeli@mtsn.tn.it RIASSUNTO - La ricostruzione del trofismo del Lago di Lavarone dalle diatomee - Oggetto principale di questo lavoro è lo studio delle associazioni subfossili a diatomee di sedimenti del Lago di Lavarone (Provincia di Trento, Nord Italia). L analisi delle tafocenosi a diatomee si è basata sul prelievo di carote di sedimento tramite carotaggi a gravità e a pistone da piattaforma mobile galleggiante. Sono state calcolate le abbondanze relative di ogni specie e sono stati ricostruiti i principali parametri ambientali, come ad esempio il fosforo totale. Lo studio della tafocenosi a diatomee del Lago di Lavarone ha confermato come lo stato trofico (fosforo totale) del lago sia rimasto simile all attuale ovvero prossimo a una situazione di mesotrofia, meso-eutrofia, nonostante la presenza di fenomeni di eutrofizzazione recenti e passati. SUMMARY - Lago di Lavarone trophic reconstruction from diatoms - This study focussed on diatoms assemblages from sediment cores taken in Lago di Lavarone (Trento Province, northern Italy). Diatom analyses were carried out on sediment cores taken with gravity and piston cores. Relative diatom abundance was calculated and environmental factors such as total phosphorus were reconstructed. The study of diatom assemblages of Lago di Lavarone indicates a trophic status quite similar to the present day conditions, mesotrophic, meso-eutrophic situation in spite of recent and past regional eutrophication. Parole chiave: Lago di Lavarone, ricostruzione del trofismo, eutrofizzazione, diatomee subfossili Key words: Lago di Lavarone, trophic reconstruction, eutrophication, subfossil diatoms 1. INTRODUZIONE Il termine eutrofizzazione viene usato per indicare l arricchimento dei sistemi acquatici da parte di nutrienti vegetali inorganici, quali azoto e fosforo, che determina un aumento della loro produttività (Wetzel 1983). Generalmente, le cause di questo fenomeno possono essere naturali o dovute a un disturbo da parte delle attività dell uomo (eutrofizzazione antropogenica o culturale). Gli eventi di eutrofizzazione naturale sono piuttosto rari e attribuibili a episodi drammatici quali per esempio incendi boschivi (Hickman et al. 199 in Stoermer & Smol 1999) oppure cambiamenti climatici che determinano possibili aumenti di nutrienti nelle acque sotterranee (Webster et al in Stoermer & Smol 1999). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i problemi di eutrofizzazione delle acque sono determinati da input di nutrienti provenienti da attività agricole, erosione del suolo, scarichi domestici e industriali legati alla presenza antropica. L eutrofizzazione è sicuramente la forma più diffusa di inquinamento delle acque su scala globale e, oltre ad aumentare la produzione primaria degli ecosistemi acquatici, provoca dei cambiamenti considerevoli a livello di cicli biogeochimici e nelle comunità biologiche, con perdita della loro biodiversità (Tilman 1982; Williams 1964). Tra gli effetti secondari dell eutrofizzazione possiamo ricordare la diminuzione dell ossigeno disciolto nelle acque profonde e il conseguente instaurarsi di fenomeni anaerobici nell ipolimnio durante tutto il periodo di stratificazione delle acque; tale situazione determina, a sua volta, un impoverimento o, in casi estremi, la scomparsa della fauna bentonica della zona (Wetzel 1983). In molte regioni del mondo le attività umane hanno influenzato gli ecosistemi lacustri su scale temporali molto estese (secoli-millenni), mentre in altre gli impatti sono molto più recenti (ultimi 5-15 anni; Marchetto et. al. 24). In ogni caso, i laghi sono in grado di accumulare nei loro sedimenti molte informazioni sia biologiche sia chimiche, che possono essere usate per ricostruire la loro storia (Filippi & Festi 27). Uno di questi indicatori è dato dalle diatomee, un gruppo di alghe molto rilevante nella struttura e nel
2 31 Angeli & Lotter Eutrofizzazione a Lavarone funzionamento delle catene alimentari, dal momento che costituisce un importante fonte di cibo per gli erbivori (Round et al. 199 in Stoermer & Smol 1999). La risposta delle diatomee ai fenomeni di eutrofizzazione può quindi avere conseguenze anche considerevoli per le altre componenti dell ecosistema acquatico. La possibilità di operare delle determinazioni sui loro resti subfossili depositatisi nei sedimenti le rende così di particolare interesse per gli studi paleolimnologici. Sebbene le diatomee mostrino, a livello collettivo, un ampio campo di tolleranze lungo un gradiente di produttività, le singole specie sono legate ad habitat specifici e hanno precise esigenze per quanto riguarda i parametri chimici delle acque (Patrick & Reimer 1966; Round et al. 199; Werner 1977 in Stoermer & Smol 1999). Inoltre, vi sono distinte comunità di diatomee viventi per esempio nelle acque libere dei laghi (plancton), sulla superficie dei loro sedimenti (epipelon), sulla superficie delle rocce (epilithon), sulla vegetazione sommersa (epiphyton) e nella zona litorale, che possono essere usate per ricostruire cambiamenti nella produzione algale da litorale a planctonica ed eventuali diminuzioni della vegetazione macrofitica durante i periodi di eutrofizzazione. Le diatomee sono molto utili negli studi di eutrofizzazione lacustre, in quanto le singole specie sono molto sensibili ai cambiamenti nella concentrazione di nutrienti (Tilman 1977; Tilman et al. 1982), con optima e tolleranze molto specifici. Rappresentano, quindi, un ottimo strumento per quantificare i cambiamenti ambientali che accompagnano l eutrofizzazione e il suo ripristino. Inoltre, la tassonomia delle diatomee è ben documentata (Krammer & Lange-Bertalot ; Krammer & Lange-Bertalot 24; Krammer 2-23) e il loro riconoscimento è essenzialmente morfologico; infine, le loro valve di silicio (Si) solitamente si conservano molto bene nei sedimenti. Prelevando delle carote di sedimento e analizzando le associazioni sub-fossili a diatomee è quindi possibile ricostruire le passate condizioni ambientali attraverso tecniche paleolimnologiche. Scopo del presente contributo è quello di ricostruire, proprio attraverso l applicazione di tecniche paleolimnologiche, l evoluzione del trofismo delle acque del Lago di Lavarone, esaminando le tafocenosi a diatomee durante tutto il record sedimentario nel quale esse sono presenti. 2. MATERIALI E METODI Nell ambito del progetto OLOAMBIENT, nel 23 sono state prelevate alcune carote a gravità e a pistone in prossimità della zona più profonda del lago. La carota a gravità LA3_S2, lunga 1 cm, è stata analizzata ad alta risoluzione nella sua parte superiore per le diatomee, utilizzando campioni prelevati ogni centimetro fino alla profondità di 4 cm. Dettagli sulla datazione della parte recente della sequenza sedimentaria di Lavarone sono riportati nell articolo di Arpenti & Filippi (27). Le carote a pistone LA3_P1 e P2, lunghe circa 9,5 metri (Filippi et al. 27), sono state analizzate con una maglia di campionamento di 5 cm fino a circa 5,5 m. Tutte le carote sono state prelevate a centro lago, servendosi di una piattaforma galleggiante mobile (Ditta Uwitec, Mondsee, Austria). Inizialmente, sono state compiute analisi preliminari (ogni 3 cm circa) su tutta la lunghezza delle carote prelevate tramite carotiere a pistone, al fine di verificare la presenza e lo stato di conservazione delle diatomee. I campioni di sedimento delle carote per l analisi delle diatomee sono stati quindi preparati in un bagnomaria a caldo, aggiungendo perossido di idrogeno e acido cloridrico e, successivamente, sono stati lavati in centrifuga con acqua distillata. È stata eseguita una preparazione quantitativa delle diatomee, pesando inizialmente una quantità nota di sedimento secco (circa,1 g) e aggiungendo alla fine con una micropipetta una quantità nota di microsfere di divinilbenzene (1 ml = microsfere). Successivamente, si è provveduto a montare i campioni tramite resina ad alto indice di rifrazione (Naphrax ) su vetrini portaoggetti, osservandoli al microscopio ottico Zeiss Axioskop 2 plus a 1 ingrandimenti e avendo cura di contare almeno 45 valve per vetrino portaoggetti. Per l elaborazione grafica e una prima analisi dei dati sono stati usati i programmi Tilia, Tiliagraph e Coniss (Grimm 1987). I valori di fosforo totale (TP) sono stati ricostruiti dalle associazioni subfossili di diatomee delle carote basandosi su un training set ottenuto da un gruppo di laghi (68) localizzati nelle Alpi Svizzere (Lotter 1989, 1998; Lotter et al. 1997a, 1997b, 1998). Per l applicazione di questi training sets e delle relative tranfer functions è stato utilizzato il programma C2 (Juggins 23). Per la determinazione delle specie di diatomee ci si è avvalsi delle seguenti chiavi di determinazione: Krammer & Lange-Bertalot ( , 24) e Krammer (2-23). Le specie più interessanti o che presentavano le maggiori difficoltà di identificazione sono state studiate e fotografate con il microscopio elettronico a scansione Zeiss Evo 4 del Museo Tridentino di Scienze Naturali. 3. RISULTATI Il sedimento della carota a gravità LA 3 S2 è rappresentato nei suoi primi 4 cm (ultimi 7 anni circa) da una tafocenosi a diatomee planctonica, corrispondente a quella rinvenuta nelle carote a pistone (Filippi et al. 27). I taxa di diatomee planctoni-
3 Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (25): Fig. 1 - Variazioni con la profondità della tafocenosi a diatomee rinvenuta nella carota di sedimento LA 3 S2. Fig.1 - Diatom diagram of core LA 3 S2. che rinvenuti sono i seguenti: Asterionella formosa Hassal, Cyclotella delicatula Hustedt, C. distinguenda Hustedt, C. pseudostelligera Hustedt, Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot, Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann, Stephanodiscus hantzschii Grunow e S. minutulus (Kützing) Cleve & Möller (Fig. 1). I taxa bentonici sono costituiti dalle specie Achnanthes minutissima Kützing, A. rosenstockii Lange-Bertalot, A. ziegleri Lange-Bertalot, Amphora pediculus (Kützing) Grunow, Cymbella microcephala Grunow, Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow, F. pinnata Ehrenberg, Navicula diluviana Krasske e Nitzschia sp. Hassall. Le diatomee planctoniche superano sempre l 8% dell abbondanza in specie. Partendo dalla profondità di 4 cm della carota a gravità, è possibile distinguere le seguenti zone (Fig. 1): - da 4 a circa 12 cm si nota un periodo relativamente stabile in cui la tafocenosi è costituita principalmente dalle specie Cyclotella delicatula, C. distinguenda e C. pseudostelligera e i valori di fosforo totale si attestano mediamente intorno ai 26 µg l -1 (Fig. 2); - da 12 a 3 cm si registra la comparsa prima di Asterionella formosa e poi di Cyclotella radiosa, S. minutulus e S. hantzschii, specie tipiche di acque con trofismo più elevato (TP max= 56,5 µg l -1 a 8 cm), mentre altre specie come C. delicatula e C. distinguenda diminuiscono fino a scomparire; - da 3 cm fino alla superficie della carota si assiste a un parziale ripristino della situazione precedente l eutrofizzazione, con un incremento di Cyclotella delicatula e valori di fosforo totale attestati intorno ai 28 µg l -1 (Figg. 1-2). Il raffronto dei valori di fosforo totale, ricostruiti attraverso l applicazione di un apposita funzione di trasferimento per la tafocenosi a diatomee, tra la carota a gravità e la parte superficiale della carota a pistone ha mostrato un buon accordo tra gli stessi (Fig. 3). L analisi quantitativa delle tafocenosi a diatomee della carota a gravità ha permesso, inoltre, di risalire al tasso annuale di accumulo delle valve di diatomee (n valve cm -2 anno -1 ), evidenziando come questo sia aumentato dalla seconda metà dell Ottocento ad oggi, con dei picchi localizzati intorno agli anni 196 e 198, parallelamente a un incremento dei valori di fosforo totale ricostruiti sulla base delle tafocenosi a diatomee. L analisi quantitativa delle tafocenosi a diatomee delle carote a pistone ha evidenziato una composizio-
4 312 Angeli & Lotter Eutrofizzazione a Lavarone TP (μg l -1 ) MAR N valve/cm diatomee 2 anno (N valve/cm2 anno) TP μg l -1 L Milioni di valve/cm 2 anno Fig. 2 - Variazioni nel tempo del tasso di accumulo di valve di diatomee (n valve cm -2 anno -1 ) e delle concentrazioni di fosforo totale (µg l -1 ) stimate a partire dalla composizione della tafocenosi nella carota di sedimento LA 3 S2. Età stimata col metodo del 21 Pb fino alla profondità di 23 cm. Fig. 2 - Diatom accumulation rates (valves cm -2 year -1 ) and diatom-inferred epilimnetic total phosphorus concentration (µg l -1 ) for sediment cores LA 3 S2. Estimated age with 21 Pb until 23 cm depth. cm TP μg l TP S2 (μg l -1 ) TP PC (μg l -1 ) Fig. 3 - Comparazione delle concentrazioni di fosforo totale (TP, µg l -1 ) stimate a partire dalla composizione della tafocenosi nelle carote a gravità LA 3 S2 (triangoli) e nel record superficiale delle carote a pistone LA 3 PC (quadrati). Scala di profondità (asse x) espressa in cm, errore standard quadratico medio espresso dalle linee. Fig. 3 - Comparison of diatom-inferred total phosphorus concentrations (TP, µg l -1 ) in cores LA 3 S2 (triangles) and the topmost record of piston core LA 3 PC (squares). Depth in cm, lines represent the mean squared error of TP prediction.
5 Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (25): Miliardi di diatomee/g Diatomee/g Età: migliaia di anni BP TP TP µg l Fig. 4 - Variazioni nel tempo (anni BP) del numero di valve di diatomee grammo -1 di sedimento secco e delle concentrazioni di fosforo totale (µg l -1 ) stimate a partire dalla composizione della tafocenosi nelle carote a pistone LA 3 P1 e P2 del Lago di Lavarone. Fig. 4 - Changes of diatom concentrations (valves g -1 dry sediment) and diatom-inferred epilimnetic total phosphorus concentrations (µg l -1 ) through time for Lago di Lavarone cores LA 3 P1 and P2. Fig. 5 - Variazioni con la profondità della tafocenosi a diatomee rinvenuta nelle carote a pistone LA 3 P1 e P2 del Lago di Lavarone. Fig. 5 - Diatom percentage diagram for Lago di Lavarone piston cores LA 3 P1 and P2. Age estimates are based on 14 C.
6 314 Angeli & Lotter Eutrofizzazione a Lavarone ne in specie del tutto analoga a quella della carota a gravità e ha consentito di ricostruire l andamento del trofismo (TP) e della concentrazione espressa come numero di valve su grammo di sedimento secco durante gli ultimi 13. anni di storia del lago (5,5 m di sedimento). Tale ricostruzione viene riportata in figura 4 e confrontata con l andamento dei valori di fosforo totale ricostruiti dalle tafocenosi di diatomee. La concentrazione di diatomee su grammo di sedimento secco si attesta intorno a un valore medio di 88.., mentre il fosforo totale intorno a un valore medio di 32 µg l -1 ; tali dati permettono quindi di affermare che il Lago di Lavarone è stato caratterizzato per tutto l Olocene da una condizione di mesotrofia. Nel record delle carote a pistone sono stati anche individuati, oltre a quello recente meglio rappresentato nella carota a gravità, altri periodi di eutrofizzazione lacustri negli intervalli compresi tra 15 e 2 anni BP ( cm circa) e tra 26 e 6 anni BP (22-37 cm circa) (Figg. 4-5), caratterizzati dalla abbondante presenza di specie che si sviluppano in acque con un basso rapporto Si:P e con scarsa intensità luminosa (Lund 195; Tilman et al. 1982; Bradbury 1988; Kihlam et al. 1996) quali Asterionella formosa, Stephanodiscus minutulus e Cyclotella radiosa, Cyclotella pseudostelligera e Fragilaria ulna. 4. DISCUSSIONE Grazie all analisi quantitativa delle tafocenosi a diatomee, è stato possibile documentare con grande dettaglio, mediante i tassi di accumulazione delle diatomee stesse, il recente (anni 5-8) fenomeno di eutrofizzazione antropica delle acque del lago e registrare un sensibile miglioramento dello stato trofico delle acque negli ultimi anni, che, tuttavia, non ha riproposto una composizione della associazioni simile a quella originaria. L analisi degli eventi sub-recenti di eutrofizzazione farebbe inizialmente pensare, vista anche la scala temporale assai estesa in cui questi si sono presentati, a fatti del tutto naturali; i fenomeni di eutrofizzazione antropica infatti si sviluppano nell arco di pochi decenni (Lotter 21), come è stato possibile osservare per il periodo recente. Per quanto riguarda gli eventi passati (sub-recenti) di eutrofizzazione delle acque del Lago di Lavarone, localizzati in particolare tra 15 e 2 anni BP e 26 e 6 anni BP, è necessario prestare particolare attenzione alla loro interpretazione per via dei molteplici fattori che possono averli determinati. Bisogna infatti considerare le variazioni climatiche (in termini di temperatura e precipitazioni) intervenute nel corso dell Olocene ed espresse come variazione dell isotopo * 18 O contenuto nella calcite di speleotemi localizzati in un area omogenea (versante SE delle Alpi) dal punto di vista paleoclimatologico (Frisia et al. 25; Bar- Matthews et al. 23; Bar-Matthews & Ayalon 24), le variazioni di livello dei laghi durante l Olocene (Magny 24), nonché la presenza di attività umana nel territorio limitrofo in base a evidenze paleoarcheologiche (Dallemule 24; Bersani 25). In base a queste premesse, possiamo notare come il periodo compreso tra 15-2 anni BP, e dunque ricadente nell età romana imperiale, sia stato caratterizzato da una graduale diminuzione della piovosità (Bar-Matthews et al. 23; Bar-Matthews & Ayalon 24), con valori tuttavia inferiori al record attuale; al tempo stesso si assiste a un abbassamento generale del livello dei laghi, con livelli minimi in corrispondenza di 15 anni BP (Magny 24), mentre le temperature risultano complessivamente simili o di poco inferiori a quelle attuali: si tratta infatti del massimo di temperature registrato nell età romana (Roman Warm Period), localizzato tra 24 e 2 anni BP, e l inizio della prima fase fredda, tra 155 e 13 anni BP (Frisia et al. 25). Il periodo compreso tra 26 e 6 anni BP, ricadente tra l età del Bronzo antico e l età del Rame, è stato caratterizzato da valori di piovosità mediamente superiori, ad eccezione di un minimo localizzato intorno a 51 anni BP (Bar-Matthews et al. 23), da temperature in crescita con minimi localizzati a 6-64, 45 e 3-25 anni BP (Frisia et al. 25), e da un abbassamento generale del livello dei laghi con dei massimi compresi tra 6 e 55 anni BP e intorno a 3 anni BP. Molteplici sono le possibilità di interpretazione che potremmo attribuire a questi due episodi sub-recenti di eutrofizzazione delle acque del Lago di Lavarone. Da una parte si potrebbe pensare all influenza dell uomo sul territorio della Provincia di Trento, per quei periodi ormai accertata (Dallemule 24; Bersani 25; Frisia com. pers.); tuttavia, l esame pollinico (Arpenti & Filippi 27) delle carote di sedimento non ha dimostrato un impatto antropico sul lago, come invece rilevato altrove per altri laghi. Dall altra parte questi due periodi sono entrambi caratterizzati da un livello dei laghi mediamente basso e da temperature simili o superiori a quelle attuali, che possono aver favorito una naturale concentrazione dei nutrienti nel bacino lacustre e una loro maggior permanenza nel lago stesso. Potremmo quindi ipotizzare che vi possa essere stata un influenza predominante di fattori naturali per quanto riguarda l eutrofizzazione del lago, senza tuttavia escludere un impatto umano nell area dell Altopiano di Lavarone non immediatamente prossima al lago stesso. Dopo aver visto come il lago sia stato interessato da molteplici fenomeni di eutrofizzazione, potremmo chiederci quale sia lo stato trofico naturale o di riferimento di un lago anche in vista della reale necessità di operare degli interventi di ripristino dello stato trofico delle acque del lago stesso.
7 Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (25): Nel caso si prenda come stato teorico di riferimento il valore di 39,2 µg l -1 ottenuto dall applicazione dell Indice di Vighi & Chiaudani (1985), che permette di stimare lo stato trofico naturale in base al rapporto tra i valori di conducibilità media delle acque (29 μscml -1, Corradini com. pers.) e la profondità media del lago (7,4 m, Tomasi 24) è possibile notare come l insieme dei dati ottenuti in base all esame del record a diatomee recente e passato del Lago di Lavarone permetta di definire uno stato trofico delle acque mediamente intorno a una condizione di mesotrofia, di poco inferiore allo stato teorico e simile a quanto descritto nell ultimo rapporto sulle condizioni attuali delle acque del lago (IASMA 1998) in cui si parla di meso-eutrofia. Grazie all analisi dettagliata delle associazioni subfossili a diatomee del Lago di Lavarone, è stato quindi possibile ricostruire le condizioni ambientali passate del lago attraverso l utilizzo di specifiche tecniche paleolimnologiche: si è mostrato come da una parte il bacino lacustre sia stato interessato da diversi episodi di eutrofizzazione e dall altra abbia avuto una buona capacità di ritornare a una condizione naturale molto vicina a quella teorica. RINGRAZIAMENTI Il presente studio fa parte della ricerca OLOAMBIENT (Risposte dell ambiente e degli ecosistemi alla variabilità climatica dell Olocene in Trentino basata su serie di dati-proxy da sedimenti lacustri, latte di monte e tufo calcareo) finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento. Si ringraziano la dott. sa Maria Letizia Filippi, la dott.sa Silvia Frisia e il dott. Marco Cantonati per gli utili suggerimenti durante tutto il corso della ricerca, e il dott. Aldo Marchetto per la rilettura critica del manoscritto. Si ringraziano, inoltre, il dott. Wolfram Scheffler (Leibniz- Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei im Forschungsverbund Berlin e.v. Abteilung Geschichteter Seen, Germania), la dott.sa Hedy Kling (Freshwater Institute, Winnipeg, Manitoba, Canada) e il prof. Eugen Rott (Istituto di Botanica, Università di Innsbruck, Austria) per la conferma dell identificazione di alcune diatomee centriche subfossili di Lavarone. BIBLIOGRAFIA Arpenti & Filippi M.L., 27 - Evoluzione della vegetazione nei pressi del Lago di Lavarone (TN) negli ultimi 2 anni. Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (25): Bar-Matthews M. & Ayalon A., 24 - Evidence from speleothems isotopic records for abrupt climatic change and their impact on human settlements in the Eastern Mediterranean region. Atti del convegno Dopo i ghiacci: rapidi cambiamenti climatici ricostruiti da stalagmite L impatto sulle società nel Mediterraneo (Trento, 16 dicembre 24). Bar-Matthews M., Ayalon A., Gilmour M., Matthews A. & Hawkesworth C.J., 23 - Sea land oxygen isotopic relationships from planktonic foraminifera and speleothems in the Eastern Mediterranean region and their implications for paleorainflall during interglacial intervals. Geoch. et Cosmoch. Acta, Vol. 67, No 17: Bersani M., 25 - Cambiamenti climatici nel territorio alpino dalla fi ne del bronzo medio, a.c., al V secolo d.c. Tesina Corso Paleontologia e Paleoecologia, Mod. A, inedita. Università degli Studi di Trento, 16. Bradbury J.P., A climatic-limnologic model of diatom succession for paleolimnological interpretation of varved sediments at Elk Lake, Minnesota. J. Paleolimnol., 1: Dallemule M., 24 - La Tor Quadra di Novaledo. Approccio paleoclimatologico allo studio di un manufatto medievale. Tesina Corso Paleontologia e Paleoecologia, Mod. A, inedita. Università degli Studi di Trento: 39 pp. Filippi M.L. & Festi, 27 - Paleolimnologia in Trentino: metodi e stato dell arte. Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (25): Filippi M.L., Heiri O., Arpenti E., Angeli N., Bortolotti M., Lotter A.F. & van der Borg K., 27 - Evoluzione paleoambientale dal Tardoglaciale a oggi ricostruita attraverso lo studio dei sedimenti del Lago di Lavarone (Altopiano di Folgaria e Lavarone, Trentino). Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol., 82 (25): Frisia S., Borsato A., Spötl C., Villa I.M. & Cucchi F., 25 - Climate variabilità in the SE Alps of Italy over the past 17 years reconstructed from a stalagmite record. Boreas, 34: Grimm E.C., CONISS: a Fortran 77 program for strati-graphically constrained cluster analyses by the method of incremental sum of squares. Comput. Geosci., 13: Hickman M., Schweger C.E. & Klarer D.M., Baptiste Lake, Alberta a late Holocene history of changes in a lake and its catchment in the southern boreal forest. Journ. of Palolimn., 4: IASMA, Caratteristiche limnologiche dei laghi del Trentino, (Rapporto): Juggins S., 23 - C2 User guide. Software for ecological and paleoecological data analysis and visualisation. University of Newcastle, Newcastle upon Tyne (UK): 69 pp. Khilam S., Theriot C. & Fritz S.C., Linking planktonic diatoms and climate change in the large lakes of the Yellowstone ecosystem using resource theory. Limnol. Oceanogr., 41 (5): Krammer K., Diatoms of Europe. Vol. 1. The genus Pinnularia: 73 pp.; Vol. 3. Cymbella: 584 pp.; Vol. 4. Cymbopleura, Delicata, Navicymbula, Gomphocymbellopsis, Afrocymbella: 53 pp. H. Lange Bertalot, A.R.G. Gantner Verlag K.G. Ruggell.
8 316 Angeli & Lotter Eutrofizzazione a Lavarone Krammer K & Lange-Bertalot H., Süßwasserflora von Mitteleuropa. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenhauer D. (eds), 2/1. Bacillariophyceae. Naviculaceae: 876 pp.; 2/2. Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae: 596 pp.; 2/3. Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae: 576 pp.; 2/4. Achnanthaceae: 437 pp. G. Fisher, Stuttgart, New York. Krammer K & Lange-Bertalot H., 24 - Süßwasserflora von Mitteleuropea. In: Ettl H., Gärtner G., Heynig H. & Mollenhauer D. (eds), 2/4. Bacillariophyceae. Achnanthaceae: 468 pp. G. Fisher, Stuttgart, New York. Lotter A.F., Subfossil and modern diatom plankton and the paleolimnology of Rotsee (Switzelrand) since 185. Aquat. Sci., 51: Lotter A.F., The recent eutrophication of Baldegersee (Switzerland) as assessed by fossil diatom assemblages. The Holocene, 8: Lotter A.F., 21 - The effect of eutrophication on diatom diversity: examples from six Swiss lakes. In: Jahn R., Kociolek J.P., Witkowski A. & Compère P. (eds), Gantner, Ruggell: Lotter A.F., Birks J.B., Hofmann W. & Marchetto A., 1997a - Modern diatom, cladocera, chironomid, and chrysophyte cyst assemblages as quantitative indicators for the reconstruction of past environmental conditions in the Alps. I. Climate. J. Paleolimnol., 18: Lotter A.F., Sturm M., Teranes J.L. & Wehrli B., 1997b - Varve formation since 1885 and high resolution varve analyses in hypertrophic Baldeggersee (Switzerland). Aquat. Scien., 59, Lotter A.F, Birks J.B., Hofmann W. & Marchetto A., Modern diatom, cladocera, chironomid, and cyst assemblages quantitative indicators for thereconstruction of past environmental conditions in the Alps II. Nutrients. J. Paleolimnol., 19: Lund J.W.G., Studies in Asterionella Hass. I. The origin and nature of the cells producing seasonal maxima. J. Ecol., 38: Magny M., 24 - Holocene climate variability as reflected by mid-european lake-level fluctuations and its probable impact on prehistoric human settlements. Quat. Internat., 113: Marchetto A., Lami A., Musazzi S., Masaferro J., Langone L. & Guilizzoni P., 24 - Lake Maggiore (N. Italy) trophic history: fossil diatom, plant pigments, and chironomids, and comparison with long term limnological data. Quat. Internat., 113: Patrick R. & Reimer C., The diatoms of the United States. Vol. 1. Academy of Natural Sciences, Philadelphia, PA: Round F.E., Crawford R.M. & Mann D.G The Diatoms: Biology & Morphology of the Genera. Cambridge University Press, Cambridge (UK): 747 pp. Tilman D., Resource competition between planktonic algae: An experimental and theoretical approach. Ecology, 58: Tilman D., Resource competition and community structure. Princeton University Press, Princeton: pp. Tilman D., Kilhamm S. & Kihlam P., Phytoplankton community ecology: the role of limiting nutrients. Ann. Rev. of Ecol. and System., 13: Tomasi G., 24 - I trecento Laghi del Trentino. Artimedia- Temi, Trento: 535 pp. Vighi M. & Chiaudani G., A simple method to estimate lake Phosphorous Concentrations resulting from Natural, Background loadings. Water res., 19: Webster K.E., Kratz T.K., Bowser C.J. & Magnusson J.J., The influence of landscape position on lake chemical responses to drought in northern Wisconsis. Limnol. & Oceanogr., 41: Werner D. (ed.), The Biology of Diatoms. Berkley, CA: University of California Press. Wetzel R.G., Limnology. 2 nd ed. CBS College publishing, New York (NY): 16 pp. Williams J.G., Possible relationships between plankton-diatom species numbers and water-quality estimates. Ecology, 45:
Le diatomee subfossili del Lago di Tovel
 Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81 (2004), Suppl. 2: 137-146 ISSN 0392-0542 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2006 Le diatomee subfossili del Lago di Tovel Nicola ANGELI 1* & Aldo MARCHETTO
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81 (2004), Suppl. 2: 137-146 ISSN 0392-0542 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2006 Le diatomee subfossili del Lago di Tovel Nicola ANGELI 1* & Aldo MARCHETTO
LE DIATOMEE BENTONICHE FLUVIALI ESPERIENZE APPLICATIVE DI ARPAV
 LE DIATOMEE BENTONICHE FLUVIALI ESPERIENZE APPLICATIVE DI ARPAV Federica Giacomazzi - Silvia Menegon ARPAV- Dipartimento Regionale Laboratori (con la collaborazione di Ermanno Bertuzzi ARPAV Dipartimento
LE DIATOMEE BENTONICHE FLUVIALI ESPERIENZE APPLICATIVE DI ARPAV Federica Giacomazzi - Silvia Menegon ARPAV- Dipartimento Regionale Laboratori (con la collaborazione di Ermanno Bertuzzi ARPAV Dipartimento
Wew32q4e2. Monitoraggio Diga del Pertusillo
 Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere
 Istituto Scienze della Terra Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana Ricerche sull evoluzione del Lago di Lugano Aspetti limnologici Triennio 2013-2015 Campagna 2015 Rapporto informativo
Istituto Scienze della Terra Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana Ricerche sull evoluzione del Lago di Lugano Aspetti limnologici Triennio 2013-2015 Campagna 2015 Rapporto informativo
Avigliana - Giugno 2011
 Avigliana - Giugno 2011 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE IPOLIMNICHE DEI LAGHI DI AVIGLIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL ASPORTAZIONE DI FOSFORO DAL FONDO DAL LAGO GRANDE Fabrizio Merati*, Gilberto
Avigliana - Giugno 2011 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE IPOLIMNICHE DEI LAGHI DI AVIGLIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL ASPORTAZIONE DI FOSFORO DAL FONDO DAL LAGO GRANDE Fabrizio Merati*, Gilberto
Monitoraggio Diga del Pertusillo
 We Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MARZO 2011 L attività dell A.R.P.A.B. di monitoraggio della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
We Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MARZO 2011 L attività dell A.R.P.A.B. di monitoraggio della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E.
 Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
Il fitoplancton come indicatore di qualità delle acque lacustri: dalla teoria ecologica all'applicazione pratica
 Il fitoplancton come indicatore di qualità delle acque lacustri: dalla teoria ecologica all'applicazione pratica Giuseppe Morabito CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 28922 Pallanza (VB) g.morabito@ise.cnr.it
Il fitoplancton come indicatore di qualità delle acque lacustri: dalla teoria ecologica all'applicazione pratica Giuseppe Morabito CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 28922 Pallanza (VB) g.morabito@ise.cnr.it
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
VALUTAZIONE DEL CARICO TROFICO
 VALUTAZIONE DEL CARICO TROFICO Le metodologie per la valutazione del carico trofico sono disponibili per il momento solo per i laghi naturali e artificiali, a causa del consumo umano di tali acque. CRITERI
VALUTAZIONE DEL CARICO TROFICO Le metodologie per la valutazione del carico trofico sono disponibili per il momento solo per i laghi naturali e artificiali, a causa del consumo umano di tali acque. CRITERI
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 2015
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 15 Agosto 15 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti,
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 15 Agosto 15 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti,
Limnological research on Lake Maggiore as a contribution to transboundary cooperation between Italy and Switzerland
 Limnological research on Lake Maggiore as a contribution to transboundary cooperation between Italy and Switzerland Rosario Mosello, R. Bertoni & P. Guilizzoni C.N.R. - Institute of Ecosystem Study Verbania
Limnological research on Lake Maggiore as a contribution to transboundary cooperation between Italy and Switzerland Rosario Mosello, R. Bertoni & P. Guilizzoni C.N.R. - Institute of Ecosystem Study Verbania
4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy
 4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy Nancy ATTOLICO Servizio Infrastrutture - Ambiente Autorità Portuale del Levante www.aplevante.org - a.attolico@aplevante.org
4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy Nancy ATTOLICO Servizio Infrastrutture - Ambiente Autorità Portuale del Levante www.aplevante.org - a.attolico@aplevante.org
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA
 RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
L esperienza dell Osservatorio del Lago di Varese
 L esperienza dell Osservatorio del Lago di Varese Valeria Roella, ARPA Lombardia La salvaguardia dei corpi idrici dagli scarichi delle acque reflue Varese, 27 settembre 2016. Istituzione Osservatorio Lago
L esperienza dell Osservatorio del Lago di Varese Valeria Roella, ARPA Lombardia La salvaguardia dei corpi idrici dagli scarichi delle acque reflue Varese, 27 settembre 2016. Istituzione Osservatorio Lago
la qualità dell Aria in Emilia-Romagna
 la qualità dell Aria in Emilia-Romagna aggiornamento al 2015 0T0TSINTESI 1 2 indice - i messaggi chiave 4 Pag. - la sintesi 5 - i fattori meteo climatici: 7 - giorni favorevoli all accumulo di PM 10 7
la qualità dell Aria in Emilia-Romagna aggiornamento al 2015 0T0TSINTESI 1 2 indice - i messaggi chiave 4 Pag. - la sintesi 5 - i fattori meteo climatici: 7 - giorni favorevoli all accumulo di PM 10 7
Evoluzione del clima in Veneto nell ultimo cinquantennio
 DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO Centro Meteorologico di Teolo Evoluzione del clima in Veneto nell ultimo cinquantennio Il Veneto si colloca in una zona di transizione confinante a Nord con
DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO Centro Meteorologico di Teolo Evoluzione del clima in Veneto nell ultimo cinquantennio Il Veneto si colloca in una zona di transizione confinante a Nord con
Recenti sviluppi nella classificazione ecologica dei laghi tramite i macroinvertebrati
 Recenti sviluppi nella classificazione ecologica dei laghi tramite i macroinvertebrati Boggero Angela CNR ISE a.boggero@ise.cnr.it http://www.ise.cnr.it/ AQUAE VENEZIA 2015 Research as a tool for freshwater
Recenti sviluppi nella classificazione ecologica dei laghi tramite i macroinvertebrati Boggero Angela CNR ISE a.boggero@ise.cnr.it http://www.ise.cnr.it/ AQUAE VENEZIA 2015 Research as a tool for freshwater
NUOVE METODICHE DI CAMPIONAMENTO DEI MACROINVERTEBRATI BENTONICI
 NUOVE METODICHE DI CAMPIONAMENTO DEI MACROINVERTEBRATI BENTONICI DELLE ACQUE LACUSTRI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE 1 CORSO NAZIONALE PROMOSSO DA APAT REALIZZATO DALL UNIVERSITÁ DI MILANO IN COLLABORAZIONE
NUOVE METODICHE DI CAMPIONAMENTO DEI MACROINVERTEBRATI BENTONICI DELLE ACQUE LACUSTRI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE 1 CORSO NAZIONALE PROMOSSO DA APAT REALIZZATO DALL UNIVERSITÁ DI MILANO IN COLLABORAZIONE
Valutazione dello stato dei piccoli laghi della Provincia di Varese attraverso lo studio delle comunità macrofitiche
 Valutazione dello stato dei piccoli laghi della Provincia di Varese attraverso lo studio delle comunità macrofitiche CISBA-CNR Pallanza, Valutazione degli ambienti lacustri. Stato dell arte a 10 anni dalla
Valutazione dello stato dei piccoli laghi della Provincia di Varese attraverso lo studio delle comunità macrofitiche CISBA-CNR Pallanza, Valutazione degli ambienti lacustri. Stato dell arte a 10 anni dalla
Il cambiamento climatico
 Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Limnological research on Lake Maggiore as a contribution to transboundary cooperation between Italy and Switzerland
 Limnological research on Lake Maggiore as a contribution to transboundary cooperation between Italy and Switzerland Rosario Mosello, R. Bertoni & P. Guilizzoni C.N.R. - Institute of Ecosystem Study Verbania
Limnological research on Lake Maggiore as a contribution to transboundary cooperation between Italy and Switzerland Rosario Mosello, R. Bertoni & P. Guilizzoni C.N.R. - Institute of Ecosystem Study Verbania
Stime costi annuali per la società legati all erosione a livello europeo (SEC (2006) 1165)
 Premessa: Questa presentazione ha lo scopo di illustrare, in modo estremamente semplificato, le cause di degradazione del suolo, così come esse sono state individuate dalla Soil Thematic Strategy dell
Premessa: Questa presentazione ha lo scopo di illustrare, in modo estremamente semplificato, le cause di degradazione del suolo, così come esse sono state individuate dalla Soil Thematic Strategy dell
Dipartimento Specialistico Regionale IdrometeoClimatico
 Dipartimento Specialistico Regionale IdrometeoClimatico ANALISI MENSILE DELL INDICE DI CALORE Maggio 2012 L indice di calore o Heat Index 1 (HI) stima il livello di disagio fisiologico avvertito dal corpo
Dipartimento Specialistico Regionale IdrometeoClimatico ANALISI MENSILE DELL INDICE DI CALORE Maggio 2012 L indice di calore o Heat Index 1 (HI) stima il livello di disagio fisiologico avvertito dal corpo
I RISULTATI WQI 1) BOD
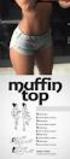 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
Analisi meteorologica mensile. agosto Bocca del ghiacciaio del Mandrone (23 agosto 2016) Efisio Siddi
 Analisi meteorologica agosto Bocca del ghiacciaio del Mandrone (23 agosto ) Efisio Siddi Agosto è risultato nella norma sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni. Le temperature sono
Analisi meteorologica agosto Bocca del ghiacciaio del Mandrone (23 agosto ) Efisio Siddi Agosto è risultato nella norma sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni. Le temperature sono
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente.
 Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Febbraio 2015 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Febbraio 2015 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
climaticamente questa vasta area ed eventualmente verificare se sono stati registrati cambiamenti significativi degli stessi
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE UMIDE CON ESTATE CALDA Introduzione Con questo articolo inauguriamo una rassegna sui climi italiani iniziando da quelli identificati, nella convenzione internazionale,
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE UMIDE CON ESTATE CALDA Introduzione Con questo articolo inauguriamo una rassegna sui climi italiani iniziando da quelli identificati, nella convenzione internazionale,
Tracciabilità geografica di prodotti alimentari basata sul rapporto isotopico 87 Sr/ 86 Sr. Daniela Manzini
 Tracciabilità geografica di prodotti alimentari basata sul rapporto isotopico 87 Sr/ 86 Sr Daniela Manzini Workshop di Spettrometria di Massa Inorganica Modena 10 giugno 2005 1 METALLI ISOTOPI nutrizione
Tracciabilità geografica di prodotti alimentari basata sul rapporto isotopico 87 Sr/ 86 Sr Daniela Manzini Workshop di Spettrometria di Massa Inorganica Modena 10 giugno 2005 1 METALLI ISOTOPI nutrizione
I fiumi. La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia
 I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
Analisi meteorologica mensile. maggio Belvedere Torbole sul Garda (24 maggio 2016)
 Analisi meteorologica maggio Belvedere Torbole sul Garda (24 maggio ) Maggio è risultato un po più freddo e più piovoso della media. (7 maggio ) CARATTERIZZAZIONE METEOROLOGICA DEL MESE DI Maggio, come
Analisi meteorologica maggio Belvedere Torbole sul Garda (24 maggio ) Maggio è risultato un po più freddo e più piovoso della media. (7 maggio ) CARATTERIZZAZIONE METEOROLOGICA DEL MESE DI Maggio, come
 RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
Sistema della ricerca agricola in Italia e le dinamiche del processo di innovazione
 Sistema della ricerca agricola in Italia e le dinamiche del processo di innovazione Filiberto ALTOBELLI Istituto Nazionale di Economia Agraria, INEA altobelli@inea.it Il suolo per l agricoltura Per l agricoltura
Sistema della ricerca agricola in Italia e le dinamiche del processo di innovazione Filiberto ALTOBELLI Istituto Nazionale di Economia Agraria, INEA altobelli@inea.it Il suolo per l agricoltura Per l agricoltura
I grandi biomi terrestri
 I grandi biomi terrestri BIOMA: complesso di ecosistemi di un area geografica caratterizzato dalla vegetazione dominate. Si distinguono per alcune caratteristiche delle piante quali struttura (le forme
I grandi biomi terrestri BIOMA: complesso di ecosistemi di un area geografica caratterizzato dalla vegetazione dominate. Si distinguono per alcune caratteristiche delle piante quali struttura (le forme
STIMA INCERTEZZA AMMONIO
 Pagina 1 di 6 REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR (firma) VERIFICATA DA RAQ (firma) APPROVATA DA AMM (firma) PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO 00 07/.2/13 / / MOTIVO Pagina 2 di 6 INDICE DELLA PROCEDURA 1.
Pagina 1 di 6 REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR (firma) VERIFICATA DA RAQ (firma) APPROVATA DA AMM (firma) PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO 00 07/.2/13 / / MOTIVO Pagina 2 di 6 INDICE DELLA PROCEDURA 1.
AgrelanWeb uno strumento per definire la concimazione ottimale
 AgrelanWeb uno strumento per definire la concimazione ottimale Paolo Giandon ARPAV - Servizio Osservatorio Suoli e Rifiuti AgrelanWeb: obiettivo La predisposizione di un piano di concimazione a partire
AgrelanWeb uno strumento per definire la concimazione ottimale Paolo Giandon ARPAV - Servizio Osservatorio Suoli e Rifiuti AgrelanWeb: obiettivo La predisposizione di un piano di concimazione a partire
1. Come si vive e lavora in Umbria: il posizionamento della regione nell ultimo decennio
 Estratto dal capitolo 1 della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull amministrazione regionale RESOCONTO DI LEGISLATURA (Pubblicata nel S.S. del B.U.R. n. 10 del3 marzo 2010)
Estratto dal capitolo 1 della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull amministrazione regionale RESOCONTO DI LEGISLATURA (Pubblicata nel S.S. del B.U.R. n. 10 del3 marzo 2010)
INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EFFETTI SULLA SALUTE A ROMA NEL MESE DI DICEMBRE Rapporto tecnico
 INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EFFETTI SULLA SALUTE A ROMA NEL MESE DI DICEMBRE 2015 Rapporto tecnico A cura del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio Roma, 31 Dicembre
INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EFFETTI SULLA SALUTE A ROMA NEL MESE DI DICEMBRE 2015 Rapporto tecnico A cura del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio Roma, 31 Dicembre
Utilizzo dei macroinvertebrati come indicatori biologici della qualità ecologica secondo la Direttiva 2000/60/CE
 Utilizzo dei macroinvertebrati come indicatori biologici della qualità ecologica secondo la Direttiva 2000/60/CE Zaupa Silvia Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali XXV Ciclo Relatore: Prof.ssa Roberta
Utilizzo dei macroinvertebrati come indicatori biologici della qualità ecologica secondo la Direttiva 2000/60/CE Zaupa Silvia Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali XXV Ciclo Relatore: Prof.ssa Roberta
ANALISI METEO LUGLIO 2013: SICCITA E TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA ANALISI DELLE PIOGGE MENSILI
 ANALISI METEO LUGLIO 2013: SICCITA E TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA Il mese appena trascorso è stato tra i più caldi, ma soprattutto tra i più secchi registrati da molti anni a questa parte. I dati che verranno
ANALISI METEO LUGLIO 2013: SICCITA E TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA Il mese appena trascorso è stato tra i più caldi, ma soprattutto tra i più secchi registrati da molti anni a questa parte. I dati che verranno
COMPRAVENDITE DI IMMOBILI A USO ABITATIVO IN CAMPANIA numero
 IL MERCATO IMMOBILIARE IN CAMPANIA Le compravendite. Il mercato immobiliare residenziale della Campania mostra nel 2007 una flessione degli immobili scambiati che si aggiunge a quella, più contenuta, già
IL MERCATO IMMOBILIARE IN CAMPANIA Le compravendite. Il mercato immobiliare residenziale della Campania mostra nel 2007 una flessione degli immobili scambiati che si aggiunge a quella, più contenuta, già
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO
 PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
Marciapiedi a vermeti. L ingegneria in natura
 Marciapiedi a vermeti. L ingegneria in natura Renato Chemello Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, Università di Palermo Biocostruzione: La capacità di certi organismi di edificare strutture
Marciapiedi a vermeti. L ingegneria in natura Renato Chemello Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, Università di Palermo Biocostruzione: La capacità di certi organismi di edificare strutture
COMUNE DI LUMEZZANE. (Provincia di Brescia)
 COMUNE DI LUMEZZANE (Provincia di Brescia) Variante di P.G.T. Relazione sulla struttura distributiva locale (L.R. 12/2005 D.C.R. 352/2007 Dgr 5913/2007- Dgr 6024/2007 s.m.i.- L.R. 6/2010) Dicembre 2013
COMUNE DI LUMEZZANE (Provincia di Brescia) Variante di P.G.T. Relazione sulla struttura distributiva locale (L.R. 12/2005 D.C.R. 352/2007 Dgr 5913/2007- Dgr 6024/2007 s.m.i.- L.R. 6/2010) Dicembre 2013
MONITORAGGIO DELL ESPOSIZIONE ALL INQUINAMENTO DA PIOMBO IN UN GRUPPO DI COMMERCIANTI IN ALCUNE ZONE DI PALERMO
 A. Milone, D. Arnone, V. Baiamonte, F. Campione 35 MONITORAGGIO DELL ESPOSIZIONE ALL INQUINAMENTO DA PIOMBO IN UN GRUPPO DI COMMERCIANTI IN ALCUNE ZONE DI PALERMO A. Milone*, D. Arnone*, V. Baiamonte*,
A. Milone, D. Arnone, V. Baiamonte, F. Campione 35 MONITORAGGIO DELL ESPOSIZIONE ALL INQUINAMENTO DA PIOMBO IN UN GRUPPO DI COMMERCIANTI IN ALCUNE ZONE DI PALERMO A. Milone*, D. Arnone*, V. Baiamonte*,
Precipitazioni intense del 20 settembre a cura di Andrea Piazza -
 Precipitazioni intense del 20 settembre 1999 - a cura di Andrea Piazza - 1. INTRODUZIONE La giornata del 20 settembre 1999 è stata caratterizzata da precipitazioni intense che hanno interessato l Italia
Precipitazioni intense del 20 settembre 1999 - a cura di Andrea Piazza - 1. INTRODUZIONE La giornata del 20 settembre 1999 è stata caratterizzata da precipitazioni intense che hanno interessato l Italia
Scenari di emissione SRES (Special Report on Emission Scenarios) e proiezioni globali
 Scenari di emissione SRES (Special Report on Emission Scenarios) e proiezioni globali Informazioni e grafici tratte dal IV rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Climate Change 2007:
Scenari di emissione SRES (Special Report on Emission Scenarios) e proiezioni globali Informazioni e grafici tratte dal IV rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Climate Change 2007:
La modellazione numerica nei progetti di riqualificazione fluviale: il caso Ewijkse Plaat, Paesi Bassi
 Sarzana 18-19 Giugno 2009 I Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale Sessione B: Strumenti e metodi per la riqualificazione fluviale La modellazione numerica nei progetti di riqualificazione fluviale:
Sarzana 18-19 Giugno 2009 I Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale Sessione B: Strumenti e metodi per la riqualificazione fluviale La modellazione numerica nei progetti di riqualificazione fluviale:
Flussi di energia e cicli della materia. Impatto delle attività umane sui cicli biogeochimici
 Flussi di energia e cicli della materia Impatto delle attività umane sui cicli biogeochimici I CICLI BIOGEOCHIMICI Molti elementi seguono un ciclo biogeochimico attraverso le due tappe dell organicazione
Flussi di energia e cicli della materia Impatto delle attività umane sui cicli biogeochimici I CICLI BIOGEOCHIMICI Molti elementi seguono un ciclo biogeochimico attraverso le due tappe dell organicazione
I modelli prospettano un futuro burrascoso
 www.atmosphere.mpg.de/enid/accentit > Speciale: Cicloni > R: Ricerca I modelli prospettano un futuro burrascoso Il surriscaldamento globale avrà delle conseguenze Cicli dell'attività degli uragani La ricerca
www.atmosphere.mpg.de/enid/accentit > Speciale: Cicloni > R: Ricerca I modelli prospettano un futuro burrascoso Il surriscaldamento globale avrà delle conseguenze Cicli dell'attività degli uragani La ricerca
Estate Monitoraggio Fiume Arno. Bollettino n 8. Settimana luglio
 Estate 2016 Monitoraggio Fiume Arno Bollettino n 8 Settimana 25 31 luglio Introduzione Il monitoraggio in continuo del Fiume Arno operato da ARPAT a partire dal 2007 dispone oggi di serie consistenti e
Estate 2016 Monitoraggio Fiume Arno Bollettino n 8 Settimana 25 31 luglio Introduzione Il monitoraggio in continuo del Fiume Arno operato da ARPAT a partire dal 2007 dispone oggi di serie consistenti e
Segnale e Rumore Strumentale
 Chimica Analitica dei Processi Industriali Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale Università degli Studi di Padova Segnale e Rumore Strumentale Andrea Tapparo Università degli Studi di Padova
Chimica Analitica dei Processi Industriali Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale Università degli Studi di Padova Segnale e Rumore Strumentale Andrea Tapparo Università degli Studi di Padova
Influenza del cambiamento climatico sulla biodiversità e sugli ecosistemi delle aree Protette
 Perché si parla di cambiamenti climatici? Queste sono alcune delle variazioni finora riscontrate (i fatti): Negli ultimi 150 anni la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa 0.74
Perché si parla di cambiamenti climatici? Queste sono alcune delle variazioni finora riscontrate (i fatti): Negli ultimi 150 anni la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa 0.74
Unità 8 - Il clima e le sue variazioni
 Unità 8 - Il clima e le sue variazioni 1 1. I climi del pianeta In base alle temperature e alle precipitazioni sono stati individuati 5 gruppi climatici fondamentali 2 1. I climi del pianeta Il climatogramma
Unità 8 - Il clima e le sue variazioni 1 1. I climi del pianeta In base alle temperature e alle precipitazioni sono stati individuati 5 gruppi climatici fondamentali 2 1. I climi del pianeta Il climatogramma
SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME
 SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME 1 Completa con i termini mancanti. a) L...si occupa delle interazioni tra individui della stessa specie, tra individui di specie diverse e tra gli
SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME 1 Completa con i termini mancanti. a) L...si occupa delle interazioni tra individui della stessa specie, tra individui di specie diverse e tra gli
Ufficio Aria Dipartimento Provinciale
 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E METALLI P.zza VITTORIO EMANUELE - POTENZA - ANNO 15 1 Gestione, Manutenzione ed Elaborazione a cura di: Ufficio Aria, Dip. prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I. Rocco Marino
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E METALLI P.zza VITTORIO EMANUELE - POTENZA - ANNO 15 1 Gestione, Manutenzione ed Elaborazione a cura di: Ufficio Aria, Dip. prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I. Rocco Marino
Dr. Valeria Roella. Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari
 Dr. Valeria Roella Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari Rete idrica provinciale Il quadro normativo a tutela delle risorse idriche è molto complesso e in evoluzione e ha introdotto sostanziali innovazioni
Dr. Valeria Roella Varese 16 marzo 2013 Sala Montanari Rete idrica provinciale Il quadro normativo a tutela delle risorse idriche è molto complesso e in evoluzione e ha introdotto sostanziali innovazioni
TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA
 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM Componente acque sotterranee Obiettivi specifici Descrizione dell area
TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM Componente acque sotterranee Obiettivi specifici Descrizione dell area
Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali
 Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali Daniele Nizzoli, Rossano Bolpagni, Marco Bartoli, Pierluigi Viaroli Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi
Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali Daniele Nizzoli, Rossano Bolpagni, Marco Bartoli, Pierluigi Viaroli Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Valutazione efficacia della terapia con campi magneto-elettrici ultradeboli ODONTOIATRIA. Risultati definitivi Marzo 2014
 Valutazione efficacia della terapia con campi magneto-elettrici ultradeboli ODONTOIATRIA Risultati definitivi Marzo 2014 1. Analisi descrittive sul campione Il campione è composto da 20 partecipanti, con
Valutazione efficacia della terapia con campi magneto-elettrici ultradeboli ODONTOIATRIA Risultati definitivi Marzo 2014 1. Analisi descrittive sul campione Il campione è composto da 20 partecipanti, con
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
"Da dove vengono I sedimenti scuri dell'arenile di Metaponto Lido "
 "Da dove vengono I sedimenti scuri dell'arenile di Metaponto Lido " Facciamo seguito al nostro comunicato stampa del 16 marzo 2016 sulla questione sabbie nere e radioattività dei sedimenti lungo l'arenile
"Da dove vengono I sedimenti scuri dell'arenile di Metaponto Lido " Facciamo seguito al nostro comunicato stampa del 16 marzo 2016 sulla questione sabbie nere e radioattività dei sedimenti lungo l'arenile
Il valore aggiunto del turismo in Piemonte. Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
 Il valore aggiunto del turismo in Piemonte Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte 22 maggio 2008 Il valore aggiunto del turismo in Piemonte Carlo Alberto Dondona - Istituto di Ricerche Economico
Il valore aggiunto del turismo in Piemonte Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte 22 maggio 2008 Il valore aggiunto del turismo in Piemonte Carlo Alberto Dondona - Istituto di Ricerche Economico
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia
 Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
La biosfera e gli ecosistemi
 La biosfera e gli ecosistemi La biosfera: l insieme di tutti gli ecosistemi L ecologia studia le interazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente a vari livelli: ECOSISTEMA COMUNITA POPOLAZIONE
La biosfera e gli ecosistemi La biosfera: l insieme di tutti gli ecosistemi L ecologia studia le interazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente a vari livelli: ECOSISTEMA COMUNITA POPOLAZIONE
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
IL MODELLO FLaIR. Descrizione sintetica del modello
 IL MODELLO FLaIR Descrizione sintetica del modello Il modello idrologico FLaIR (Forecasting of Landslides Induced by Rainfalls), proposto da Sirangelo e Versace nel 992, costituisce uno strumento di interpretazione
IL MODELLO FLaIR Descrizione sintetica del modello Il modello idrologico FLaIR (Forecasting of Landslides Induced by Rainfalls), proposto da Sirangelo e Versace nel 992, costituisce uno strumento di interpretazione
ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 216 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 216 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Struttura Semplice Siti Nucleari
 DIPARTIMENTO TEMATICO RADIAZIONI ATTIVITA DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL RINVENIMENTO DI FUSTI INTERRATI PRESSO IL SITO FN-SO.G.I.N. DI BOSCO MARENGO (AL) Relazione tecnica n. 8/SS21.02/2014 Redazione Verifica
DIPARTIMENTO TEMATICO RADIAZIONI ATTIVITA DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL RINVENIMENTO DI FUSTI INTERRATI PRESSO IL SITO FN-SO.G.I.N. DI BOSCO MARENGO (AL) Relazione tecnica n. 8/SS21.02/2014 Redazione Verifica
RELAZIONE EX ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE
 RELAZIONE EX ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE QUADRIENNIO 2008-2011 1. INTRODUZIONE INDICE 2. VALUTAZIONE DELLA QUALITA DELLE ACQUE 2.1 ACQUE SOTTERRANEE 2.2 ACQUE SUPERFICIALI 3. VALUTAZIONE DEI
RELAZIONE EX ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE QUADRIENNIO 2008-2011 1. INTRODUZIONE INDICE 2. VALUTAZIONE DELLA QUALITA DELLE ACQUE 2.1 ACQUE SOTTERRANEE 2.2 ACQUE SUPERFICIALI 3. VALUTAZIONE DEI
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
Influenza dei processi fisici e biologici sul sistema carbona6co nel Golfo di Trieste. Gianmarco Ingrosso
 Influenza dei processi fisici e biologici sul sistema carbona6co nel Golfo di Trieste Gianmarco Ingrosso (Doney, 2010) OCEAN ACIDIFICATION CO 2 Gli oceani assorbono circa 1/3 delle emissioni antropiche di
Influenza dei processi fisici e biologici sul sistema carbona6co nel Golfo di Trieste Gianmarco Ingrosso (Doney, 2010) OCEAN ACIDIFICATION CO 2 Gli oceani assorbono circa 1/3 delle emissioni antropiche di
I profili delle acque di balneazione nella gestione delle fioriture di cianobatteri. Roberta De Angelis, Massimo Scopelliti
 I profili delle acque di balneazione nella gestione delle fioriture di cianobatteri Roberta De Angelis, Massimo Scopelliti Roma, 21 Aprile 2015 Importante cambiamento nella gestione della qualità delle
I profili delle acque di balneazione nella gestione delle fioriture di cianobatteri Roberta De Angelis, Massimo Scopelliti Roma, 21 Aprile 2015 Importante cambiamento nella gestione della qualità delle
La fauna dei prati - 1
 Quaderni del Museo delle Scienze, 4/1 La fauna dei prati - 1 tassonomia, ecologia e metodi di studio dei principali gruppi di invertebrati terrestri italiani a cura di Mauro Gobbi Leonardo Latella Trento
Quaderni del Museo delle Scienze, 4/1 La fauna dei prati - 1 tassonomia, ecologia e metodi di studio dei principali gruppi di invertebrati terrestri italiani a cura di Mauro Gobbi Leonardo Latella Trento
Il monitoraggio del sistema climatico terrestre. Federico Porcù Dipartimento di Fisica, Università di Ferrara
 Il monitoraggio del sistema climatico terrestre Federico Porcù Dipartimento di Fisica, Università di Ferrara qualche definizione e impostazione del problema; evidenze della tendenza climatica; osservazioni;
Il monitoraggio del sistema climatico terrestre Federico Porcù Dipartimento di Fisica, Università di Ferrara qualche definizione e impostazione del problema; evidenze della tendenza climatica; osservazioni;
Progetto Una montagna di sassi
 a.s. 2011/2012 Progetto Una montagna di sassi Classe III D Scuola secondaria di primo grado J. Foroni Valeggio sul Mincio Ogni giorno noi camminiamo, andiamo in auto, in bici, in pullman, ma ci siamo mai
a.s. 2011/2012 Progetto Una montagna di sassi Classe III D Scuola secondaria di primo grado J. Foroni Valeggio sul Mincio Ogni giorno noi camminiamo, andiamo in auto, in bici, in pullman, ma ci siamo mai
LA POPOLAZIONE. Tabella 1. Struttura della popolazione residente nella provincia di Torino per classi di età e sesso, anno 2000
 LA POPOLAZIONE La struttura demografica di una popolazione rappresenta un importante determinante dello stato di salute atteso di una popolazione. Molte patologie sono correlate con l età ed hanno una
LA POPOLAZIONE La struttura demografica di una popolazione rappresenta un importante determinante dello stato di salute atteso di una popolazione. Molte patologie sono correlate con l età ed hanno una
Confronto tra suolo degradato e suolo ricostituito per la produzione di pomodoro
 Confronto tra suolo degradato e suolo ricostituito per la produzione di pomodoro Paolo Manfredi1, Chiara Cassinari2, Marco Trevisan2 1m.c.m. Ecosistemi s.r.l., Gariga di Podenzano, Piacenza 2Istituto di
Confronto tra suolo degradato e suolo ricostituito per la produzione di pomodoro Paolo Manfredi1, Chiara Cassinari2, Marco Trevisan2 1m.c.m. Ecosistemi s.r.l., Gariga di Podenzano, Piacenza 2Istituto di
Terreno naturale e terreno agrario. rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno
 Terreno naturale e terreno agrario il profilo del terreno rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno In relazione al tipo di profilo che un terreno presenta, possiamo distinguere:
Terreno naturale e terreno agrario il profilo del terreno rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno In relazione al tipo di profilo che un terreno presenta, possiamo distinguere:
I tirocini curriculari del corso di laurea magistrale in Scienze ambientali: incontro tra studenti ed enti/aziende
 I tirocini curriculari del corso di laurea magistrale in Scienze ambientali: incontro tra studenti ed enti/aziende Pisa, 10 Giugno 2014, Dipartimento di Scienze della terra ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA
I tirocini curriculari del corso di laurea magistrale in Scienze ambientali: incontro tra studenti ed enti/aziende Pisa, 10 Giugno 2014, Dipartimento di Scienze della terra ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA
La Laguna di Venezia. I Parametri
 La Laguna di Venezia La Laguna di Venezia rappresenta un ambiente unico al mondo. È collegata al mare Adriatico attraverso 3 bocche di porto: Chioggia, Malamocco e Porto Lido. Si tratta di un ecotono,
La Laguna di Venezia La Laguna di Venezia rappresenta un ambiente unico al mondo. È collegata al mare Adriatico attraverso 3 bocche di porto: Chioggia, Malamocco e Porto Lido. Si tratta di un ecotono,
Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Corso di Ecologia
 Corso di Laurea in Scienze Biologiche Corso di Ecologia Canale 2 (Lettere M-Z) Prof. Michele Scardi Email mscardi@mclink.it Telefono 335-6795190 http://www.michele.scardi.name/ecologia.htm Università di
Corso di Laurea in Scienze Biologiche Corso di Ecologia Canale 2 (Lettere M-Z) Prof. Michele Scardi Email mscardi@mclink.it Telefono 335-6795190 http://www.michele.scardi.name/ecologia.htm Università di
Dalla meteorologia alla climatologia (un excursus sui cambiamenti climatici)
 23 marzo 2015, Giornata Mondiale della Meteorologia Cambiamenti Climatici: capire per agire Dalla meteorologia alla climatologia (un excursus sui cambiamenti climatici) a cura di Alessandro M. S. Delitala
23 marzo 2015, Giornata Mondiale della Meteorologia Cambiamenti Climatici: capire per agire Dalla meteorologia alla climatologia (un excursus sui cambiamenti climatici) a cura di Alessandro M. S. Delitala
LABORATORIO MICROSCOPI OTTICI. Sala III Piano ISMAR - REGOLAMENTO
 LABORATORIO MICROSCOPI OTTICI Sala 504 - III Piano ISMAR - REGOLAMENTO Finalità 8 giugno 2011 Il Laboratorio Microscopi Ottici presente nell Istituto ISMAR UOS di Bologna, ha la finalità di supportare
LABORATORIO MICROSCOPI OTTICI Sala 504 - III Piano ISMAR - REGOLAMENTO Finalità 8 giugno 2011 Il Laboratorio Microscopi Ottici presente nell Istituto ISMAR UOS di Bologna, ha la finalità di supportare
COME EFFETTUARE L ANALISI DELLA CONCORRENZA
 Aprile Inserto di Missione Impresa dedicato allo sviluppo pratico di progetti finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. COME EFFETTUARE L ANALISI DELLA CONCORRENZA QUAL E L UTILITA DI ANALIZZARE
Aprile Inserto di Missione Impresa dedicato allo sviluppo pratico di progetti finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. COME EFFETTUARE L ANALISI DELLA CONCORRENZA QUAL E L UTILITA DI ANALIZZARE
Candidato: Alice Lucetta Giolitto Relatore: prof. A. Longhetto Co-Relatore: dott. M. Manfrin
 Università degli studi di Torino Facoltà di Scienze M.F.N. Corso di laurea in Fisica Candidato: Alice Lucetta Giolitto Relatore: prof. A. Longhetto Co-Relatore: dott. M. Manfrin 1 Sfruttando la teoria
Università degli studi di Torino Facoltà di Scienze M.F.N. Corso di laurea in Fisica Candidato: Alice Lucetta Giolitto Relatore: prof. A. Longhetto Co-Relatore: dott. M. Manfrin 1 Sfruttando la teoria
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Condizioni e siti di riferimento per le tipologie di corpi idrici nel bacino del Fiume Po
 Attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE Condizioni e siti di riferimento per le tipologie di corpi idrici nel bacino del Fiume Po Condizioni di riferimento e fitoplancton Giuseppe Morabito Istituto
Attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE Condizioni e siti di riferimento per le tipologie di corpi idrici nel bacino del Fiume Po Condizioni di riferimento e fitoplancton Giuseppe Morabito Istituto
Senato della Repubblica
 Ministero dello Sviluppo Economico Garante per la sorveglianza dei prezzi Senato della Repubblica Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi La dinamica dei prezzi dei carburanti ALLEGATO A 6
Ministero dello Sviluppo Economico Garante per la sorveglianza dei prezzi Senato della Repubblica Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi La dinamica dei prezzi dei carburanti ALLEGATO A 6
Emissione 6 25/11/2011 Approvazione DCRB Pag. 1 di 7
 Emissione 6 25/11/2011 Approvazione DCRB Pag. 1 di 7 PROGRAMMA DI VEQ PER TIROIDE A. Organizzazione del Programma MATERIALI DI CONTROLLO: sono costituiti da matrici naturali di origine umana e sono spediti
Emissione 6 25/11/2011 Approvazione DCRB Pag. 1 di 7 PROGRAMMA DI VEQ PER TIROIDE A. Organizzazione del Programma MATERIALI DI CONTROLLO: sono costituiti da matrici naturali di origine umana e sono spediti
Museo di Storia Naturale
 LAGUNA DI VENEZIA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO salvaguardia e prospettive Modificazioni nelle comunità biologiche acquatiche dovute agli interventi antropici in laguna Biologo marino Direttore Museo di
LAGUNA DI VENEZIA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO salvaguardia e prospettive Modificazioni nelle comunità biologiche acquatiche dovute agli interventi antropici in laguna Biologo marino Direttore Museo di
CARATTERISTICHE MINIME: qualora il sistema proposto non abbia le caratteristiche sotti riportate l offerta sarà considerta NON CONFORME
 Microscopio elettronico a scansione (SEM) in alto vuoto (HV), basso vuoto (LV/VP), Pressione estesa o modalità ambiente (ESEM/EP), dotato di sistema di microanalisi EDS CARATTERISTICHE MINIME: qualora
Microscopio elettronico a scansione (SEM) in alto vuoto (HV), basso vuoto (LV/VP), Pressione estesa o modalità ambiente (ESEM/EP), dotato di sistema di microanalisi EDS CARATTERISTICHE MINIME: qualora
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Idrosfera. Leonardo Beccarisi. 29 marzo a lezione. 1 a parte. Corso di Ecologia Università degli Studi di Roma Tre
 Idrosfera 1 a parte Leonardo Beccarisi Corso di Ecologia Università degli Studi di Roma Tre 29 marzo 2011 22 a lezione Sommario 1 Compartimenti idrici Classificazioni Volumi di acqua nei compartimenti
Idrosfera 1 a parte Leonardo Beccarisi Corso di Ecologia Università degli Studi di Roma Tre 29 marzo 2011 22 a lezione Sommario 1 Compartimenti idrici Classificazioni Volumi di acqua nei compartimenti
