ANTEPRIMA. Di seguito, alcune pagina del libro di Matteo Stefanori Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana.
|
|
|
- Sofia Sacchi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ANTEPRIMA Il 30 novembre 1943, con un ordinanza di polizia, il governo della Repubblica sociale italiana decise di arrestare e rinchiudere in campo di concentramento tutti gli ebrei che vivevano in Italia. Nel giro di poche settimane uomini, donne e bambini furono fermati dalle autorità, privati dei loro beni, condotti prima in campi provinciali e poi trasferiti in una struttura nazionale, a Fossoli di Carpi, vicino Modena. Di seguito, alcune pagina del libro di Matteo Stefanori Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine di gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano centocinquanta circa, ma entro poche settimane il loro numero giunse a oltre seicento. Si trattava per lo più di intere famiglie, catturate dai fascisti o dai nazisti per loro imprudenza, o in seguito a delazione. Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente, o perché ridotti alla disperazione dalla vita randagia, o perché privi di mezzi, o per non separarsi da un congiunto catturato, o anche, assurdamente, per 'mettersi in ordine con la legge ' In queste righe, tratte dal celebre romanzo Se questo è un uomo, Primo Levi descrive il suo arrivo al campo di concentramento di Fossoli di Carpi nel gennaio del 1944: come è noto, egli fu arrestato sulle montagne della Val d Aosta, dove era 'salito' insieme ad altri compagni partigiani. Trattenuto per qualche giorno nella caserma di Aosta, durante gli interrogatori preferì dichiarare la sua appartenenza alla 'razza ebraica' piuttosto che rivelare di essere un partigiano, confessione che altrimenti lo avrebbe esposto, come lui era convinto, a maggiori pericoli o addirittura a una fucilazione immediata. In quanto ebreo, dunque, venne trasferito al campo vicino Modena, da dove sarebbe stato deportato al lager di Auschwitz-Birkenau. Le parole di Primo Levi ci restituiscono un immagine molto efficace di coloro che, perseguitati per motivi razziali, finirono in quei mesi imprigionati nei campi di concentramento della Repubblica sociale: uomini, donne e bambini, catturati da zelanti agenti di Polizia fascisti o forse traditi dalla denuncia di un vicino di casa. In molti furono colti di sorpresa dall ordinanza di fine novembre 43 e si ritrovarono in una situazione nella quale mai avrebbero pensato di dover vivere: braccati e ricercati come fossero dei pericolosi criminali, portati in un carcere o rinchiusi tra le mura di un campo di concentramento, inconsapevoli di ciò che le autorità italiane e tedesche avessero ancora in mente per loro. Fino a quel momento, del resto, sebbene vi fosse in vigore da anni una normativa antiebraica, l Italia era stata considerata un rifugio da tantissimi ebrei che fuggivano alle persecuzioni nel resto d Europa. Un rifugio 'precario', in realtà, come lo definisce Klaus Voigt, perché dopo l 8 settembre ogni ebreo fu posto di fronte a una scelta obbligata, difficile ma decisiva per la sua sopravvivenza: scappare e vivere in clandestinità oppure sottostare, ancora una volta, alla legge del persecutore? La maggior parte degli ebrei sembrò consapevole del pericolo che correva ed ebbe la prontezza di nascondersi: riuscì in questo modo a non farsi prendere, anche grazie all aiuto di amici o di semplici sconosciuti. Migliaia di persone, invece, vennero arrestate e internate, finendo poi deportate in lager da cui tantissimi non fecero più ritorno. Vi fu chi, braccato, tentò la fuga, ma cadde lo stesso nella rete delle autorità; e chi, invece, non se la sentì di infrangere le regole stabilite dal nuovo Stato fascista e accettò, anche perché costretto a farlo, le misure di internamento: in qualche caso, gli ebrei si sentirono ancora cittadini del paese nel quale erano nati
2 e vissuti e, per questo, credettero che la sua legge li avrebbe tutelati dai pericoli provenienti dall esterno. 1. I numeri Grazie alle ricerche condotte dal Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano (CDEC), sappiamo che furono quasi gli ebrei arrestati con certezza nel territorio italiano dopo l 8 settembre 1943: di questi, furono deportati nei campi di concentramento e di sterminio dell Europa orientale (per lo più ad Auschwitz), circa 450 riuscirono a scappare e a evadere oppure furono rilasciati, mentre in 322 morirono nella penisola (una quarantina di questi si suicidarono). Tra i deportati accertati, gli ebrei di nazionalità italiana risultano essere quasi il doppio degli stranieri (più di contro poco meno di individui): sono divisi invece in numero uguale tra donne e uomini, con una leggera maggioranza a favore di questi ultimi (circa 400 in più). Quasi tutti i deportati erano adulti e una buona parte aveva superato i sessant anni. I giovani, coloro cioè che erano nati dopo il 1920, ammontano invece a 1.300, dei quali più di 700 bambini o ragazzi minori di sedici anni. Queste cifre ci mostrano l impatto della persecuzione antiebraica nei mesi di occupazione tedesca e di governo della RSI. Su un totale di ebrei presenti nel Centro-Nord d Italia, uno su cinque subì dunque l arresto e la deportazione. Solo 837 persone tornarono vive dai lager. Sempre secondo le ricerche del CDEC, le forze di Polizia tedesca catturarono un numero maggiore di ebrei rispetto a quelle italiane: circa contro poco meno di Tra le 300 e le 350 persone, invece, furono arrestate in operazioni condotte insieme. In queste cifre rientrano anche le persone fermate nelle regioni sotto il diretto controllo delle autorità germaniche (le zone di operazioni del Litorale Adriatico e delle Prealpi), dove ad eseguire i rastrellamenti furono principalmente i tedeschi, sebbene aiutati in molti casi da italiani ai loro ordini. Dell arresto di un significativo numero di ebrei (più di 2.000), in ogni modo, non si conoscono ancora con precisione i responsabili. Scendendo ancor più nel dettaglio, è possibile individuare periodi in cui la caccia all ebreo ebbe una più forte intensità. Tra il mese di settembre e quello di novembre 1943, in poche settimane le operazioni antiebraiche volute dai nazisti portarono nella rete della persecuzione circa ebrei: tra questi, vi sono le vittime della razzia del 16 ottobre a Roma (più di 1.000), gli ebrei stranieri provenienti dal Sud della Francia e deportati dal campo di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo (più di 300), e tutti coloro che finirono arrestati nel corso delle retate di ottobre e novembre nelle principali città del Nord Italia; infine, va incluso in questa cifra anche chi fu fermato alla frontiera con la Svizzera mentre tentava di fuggire dall Italia. Diversa, invece, la situazione che si venne a delineare a partire dalla fine di novembre, dopo l ordinanza n.5, quando anche la Polizia di Salò cominciò sistematicamente a ricercare gli ebrei. Nel periodo che va dal dicembre 1943 all estate del 1944, così, su un totale di circa ebrei, moltissimi (la maggior parte) furono arrestati dalle forze di Polizia italiane. Si è scelto qui di prendere come termine conclusivo l estate del 1944 per due motivi. Innanzitutto, il numero degli arresti successivi si attestò in media sulle poche decine di individui al mese contro le centinaia del periodo precedente: per dare un idea di quanto si sta dicendo, tra gennaio e agosto gli ebrei fermati furono quasi mentre tra settembre e dicembre intorno ai 250 e 'solo' 10 nei primi due mesi del Secondo motivo: da settembre i convogli di deportati non partirono più dal campo di Fossoli di Carpi o da Milano e Verona, ovvero dal territorio della RSI, bensì dalle zone di diretta occupazione tedesca. Salvo eccezioni, furono soprattutto gli ebrei arrestati in quelle province a essere rinchiusi nel lager di Bolzano Gries o nella Risiera di San Sabba a Trieste e a subire, poi, la deportazione. Quanti arresti, dunque, eseguirono di preciso gli italiani? Di certo, nelle loro mani finirono circa ebrei, poi deportati: ma la cifra è probabilmente più alta, se si tiene conto delle centinaia
3 di fermati di cui non si conoscono con esattezza i responsabili e di coloro che, arrestati, vennero rilasciati o non subirono per forza la deportazione. Inoltre, risulta difficile distinguere quanti furono presi dalle forze regolari di Polizia italiana, ovvero dipendenti dal Ministero dell Interno, e quanti dalle bande autonome fasciste presenti su tutto il territorio della RSI. A metà dicembre 1943, il governo di Mussolini provò a calcolare il numero degli ebrei arrestati fino a quel momento: il capo della Polizia, forse anche perché pressato dall alleato tedesco desideroso di avere informazioni a riguardo, chiese a tutte le prefetture gli elenchi degli internati in esecuzione dell ordinanza di Buffarini Guidi e dei ricercati. Sulla base delle risposte ricevute quasi subito da 12 province (Rieti, Forlì, Aosta, Venezia, Sondrio, Parma, Torino, Firenze, Ancona, Milano, L Aquila, Varese) si sarebbe dovuto trovare il modo di sistemare ebrei. Quindici giorni dopo, la cifra fu aggiornata grazie ai dati provenienti da altre località: in un appunto scritto al capo della Polizia si parlava di 'migliaia' di ebrei da smistare nei vari campi di concentramento. Grazie all azione di Polizia e carabinieri italiani, in effetti, il numero degli ebrei arrestati aumentò rapidamente in poche settimane, raggiungendo e superando anche i individui: risultati in linea, quindi, con quanto previsto dal Ministero. La caccia all ebreo non fu portata avanti mediante grandi rastrellamenti, come era avvenuto a opera dei tedeschi nei mesi precedenti (si pensi a Roma): salvo eccezioni, come a Venezia, quella voluta dalla RSI fu una persecuzione ramificata su tutto il territorio e attuata attraverso l arresto costante, ogni giorno, di singoli individui o di poche decine di ebrei, scovati casa per casa. Col passare dei mesi la previsione di arrestare migliaia di persone subì un forte ridimensionamento: non sempre, infatti, le ricerche degli individui 'irreperibili' portarono alla loro cattura e tantissimi riuscirono a scappare o a rimanere nascosti. A volte, inoltre, potevano capitare degli imprevisti dovuti alla guerra in corso: a Forlì, prima che fosse istituito un campo di concentramento, la questura inviò al capo provincia e al locale comando militare germanico un minuzioso elenco degli ebrei censiti nella provincia, completo di indirizzo, legami di parentela, proprietà immobiliari e terriere. Solo a Rimini, erano 70 le persone interessate dai provvedimenti di Polizia. Gli arrestati a dicembre, in attesa di essere trasferiti in un campo di concentramento, furono rinchiusi nella Rocca Malatestiana (all epoca una prigione), dalla quale però riuscirono a scappare dopo pochi giorni perché un bombardamento alleato ne ruppe il portone d ingresso. 2. Gli ebrei internati: uomini, donne e bambini Nei mesi che vanno dal dicembre 1943 all estate del 1944 furono almeno 800 gli ebrei che transitarono nei vari campi di concentramento provinciali. Questa cifra, messa in relazione con quelle appena presentate, indica che nelle zone in cui fu attivo un campo non si osserva in media un incremento significativo di arresti rispetto, ad esempio, a quelle località dove vennero utilizzate le carceri cittadine. Si può invece affermare che, laddove sorsero dei campi, la maggior parte degli arresti fu attuata dalle forze italiane della Pubblica sicurezza o cosiddette regolari, dipendenti cioè ufficialmente dal Ministero dell Interno, e si concentrò soprattutto tra il mese di dicembre 43 e quello di gennaio 44, a testimonianza di come queste strutture fossero strettamente funzionali al progetto antisemita di Salò, messo in atto con la disposizione di Buffarini Guidi. Non tutti gli internati nei campi provinciali alla fine furono deportati: un centinaio circa non vennero né trasferiti a Fossoli né consegnati alle autorità tedesche, ma liberati in applicazione degli ordini ministeriali. Alcuni esempi aiutano a chiarire quanto appena detto. A Padova, nel campo provinciale di Vo Vecchio, come si è visto, furono rinchiuse in tutto più di 70 persone, ma al momento dell incursione di luglio del comando germanico ne erano presenti 43: le altre erano state rilasciate in quanto anziane, malate o di famiglia mista. Anche a Grosseto, dove il capo della provincia Ercolani aveva dimostrato un particolare zelo antisemita, sempre per le stesse ragioni degli 80 ebrei finiti nel campo ne furono infine trasferiti 64 a Fossoli. In alcuni
4 casi, invece, come a Perugia, tutti gli ebrei rimasero nel campo provinciale fino alla Liberazione e, come vedremo tra poco, riuscirono a scampare alla deportazione. Grazie alle liste compilate meticolosamente dalle autorità di Salò possiamo ricostruire con precisione la tipologia degli internati in queste strutture. La maggior parte di loro aveva un età compresa tra i 30 e i 60 anni e, nel complesso, il numero di persone di sesso maschile equivale a quello delle persone di sesso femminile. La presenza di più donne o di più uomini, così come di individui più giovani o anziani, variava da campo a campo e fu una diretta conseguenza della situazione bellica, politica o sociale della zona in cui ci si trovava: dipendeva dalla tradizionale concentrazione di popolazione ebraica in determinate città e province italiane oppure dalla intensità della repressione nazifascista e dalle fasi della guerra in corso. Nel suo studio sulla provincia di Livorno, Enrico Acciai spiega ad esempio che la persecuzione antiebraica in quella zona fu strettamente legata alle dinamiche dello sfollamento che interessarono l intera popolazione civile. In alcune province venne internato un numero molto ridotto di ebrei di sesso maschile, scappati a nascondersi prima degli arresti. Ancora alla fine del 1943 era molto diffusa la convinzione che le persone considerate inabili al lavoro, quali le donne, gli anziani e i bambini, non sarebbero state toccate, perché in realtà i veri ricercati erano gli uomini fisicamente più forti e in salute, da deportare nelle fabbriche in Germania. Una tale percezione del pericolo non riguardava solo la sorte degli ebrei, ma in generale quella di tutti i civili. Si pensi, ad esempio, alle stragi di Marzabotto o di Sant Anna di Stazzema: in vista dell arrivo dei nazisti, gli uomini scapparono a nascondersi, convinti di essere loro soltanto le persone ricercate. La realtà, come noto, fu un altra: la violenza tedesca si abbatté su donne, anziani e bambini, rimasti nei villaggi o rifugiatisi nelle chiese. Quello della provincia di Apuania (Massa) rappresenta un caso limite, dal momento che nel campo furono rinchiuse solo tre donne. Ad Asti, invece, fu lo stesso capo provincia a osservare che gli internati erano quasi esclusivamente di sesso femminile, perché gli uomini "si erano allontanati" e non era stato possibile rintracciarli. Vi sono poi situazioni del tutto particolari per le dinamiche che le determinarono. In provincia di Cuneo, il commissario di Polizia di Salluzzo volle interpretare a modo suo le disposizioni ministeriali: propose di inviare gli uomini al lavoro, inquadrandoli nell organizzazione nazista Todt (forse anche in continuità con quanto deciso dal regime fascista pochi mesi prima), mentre per le donne aveva previsto la reclusione nel campo di Borgo San Dalmazzo. Il 4 dicembre alcuni uomini furono in effetti inviati al lavoro obbligatorio: probabilmente perché rimaste sole, molte donne si presentarono in maniera spontanea alla questura per essere internate. Dei 26 ebrei che finirono in quel campo provinciale, diciassette erano donne. Infine, va detto che, a parte il caso di Parma, dove furono aperti due campi provinciali, uno maschile e uno femminile, generalmente gli internati venivano sistemati in un unica struttura, salvo passare la notte in locali separati. La tipologia delle persone rinchiuse nei campi era determinata soprattutto dai criteri di arresto stabiliti dal governo: dalla misura di internamento, infatti, sarebbero dovuti restare esclusi gli anziani, i malati e gli appartenenti a famiglia 'mista'. Laddove fossero già stati fermati, quindi, da molte strutture vennero fatti uscire coloro che avevano superato i 70 anni di età (ma a volte anche solo i 60 anni) e gli ammalati più gravi, nonché i cosiddetti 'misti', sottoposti però a vigilanza. Per motivi di salute, in realtà, alcuni non erano stati nemmeno condotti in campo di concentramento e per loro fu prevista una stretta sorveglianza negli ospedali in cui erano ricoverati. Come vedremo meglio più avanti, sulla sorte di queste potenziali vittime della deportazione, temporaneamente risparmiate, si aprì un contenzioso tra autorità italiane e tedesche, in disaccordo sulla linea da adottare nei loro confronti. In ogni modo, considerando i documenti a nostra disposizione, si può affermare che nei campi provinciali le autorità si impegnarono ad applicare, quasi ovunque, la normativa di Salò e, di conseguenza, vi si ritrovarono generalmente internati quegli individui previsti dalle disposizioni ministeriali.
5 In alcuni casi vennero trattati con una specifica attenzione anche i minori. Ad Aosta, oltre agli anziani e ai malati, furono esentati dalla misura di internamento i bambini e i ragazzi che avevano meno di 14 anni. A Rovigo, dove in realtà non sorse un campo provinciale e per gli ebrei arrestati era stato inizialmente immaginato il trasferimento a Vo Vecchio, le autorità disposero che i figli degli internati trovassero accoglienza presso alcune famiglie della provincia che si offrivano di mantenerli usufruendo di un indennizzo comunale per le spese supplementari. Non mancarono però i problemi: il commissario prefettizio chiese al capo di quella provincia di spostare altrove due bambini perché, a suo dire, arrecavano disturbo alla famiglia che li ospitava. Ma, il più delle volte, erano gli stessi ragazzi a voler rimanere accanto ai loro genitori, sebbene internati o in carcere. Simili accortezze da parte delle autorità non rappresentarono però la prassi: a Parma erano presenti ben 18 minori, rinchiusi insieme ai familiari. Anche ad Aosta, dove, come abbiamo appena detto, in un primo momento erano stati esentati i minorenni, vi fu un repentino ripensamento e si decise che i figli dovessero seguire la sorte dei genitori. Nei campi di concentramento finirono così intere famiglie. Si è già visto il caso di Vo Vecchio a Padova, dove erano presenti molti nuclei familiari. Anche a Sondrio i 12 internati componevano quattro famiglie, così come a Ferrara i 18 ebrei rinchiusi a dicembre nella Sinagoga erano in gran parte imparentati tra di loro (del resto, abitavano quasi tutti nello stesso palazzo). A Parma erano internate alcune famiglie di ebrei stranieri. Ben consapevoli di questa situazione erano anche le autorità: a metà gennaio, il questore di Modena comunicava al capo della Polizia che nel campo di Fossoli affluivano ogni giorno numerosi internati, «per la maggioranza in gruppi famigliari». Questo induce a riflettere sulle modalità in cui furono condotti gli arresti e le ricerche: la Polizia italiana indirizzò la sua azione soprattutto su quelle famiglie che vivevano in abitazioni comuni oppure in edifici e strade contigue. Così facendo, riusciva facilmente a catturare, con il minimo sforzo e in tempi rapidi, un buon numero di persone tutte in una sola volta. In Italia, come altrove del resto, la persecuzione colpì intere famiglie e non soltanto singoli individui. Ogni ebreo internato riceveva un indennità giornaliera fissa, ma nell erogarla l autorità competente non tenne sempre conto dei rapporti gerarchici presenti all interno dei nuclei familiari rinchiusi nei campi: secondo quanto deciso in precedenza per l internamento libero, infatti, un capo famiglia aveva diritto a percepire una quota più alta rispetto agli altri componenti. Nel dicembre 1943, la questione fu al centro di uno scambio di opinioni tra gli uffici della questura e della prefettura di Parma e il direttore del campo di Monticelli Terme, dove il sussidio serviva a coprire interamente le spese relative all alimentazione: Come è noto, a norma delle disposizioni vigenti agli internati isolati viventi in gruppi familiari nei diversi comuni della Provincia era attribuito un sussidio giornaliero in diversa misura al capo famiglia ed agli altri membri di essa. Ma agli internati viventi in campi di concentramento con rancio comune era attribuito un sussidio eguale per tutti, e cioè quello assegnato al capo famiglia nei nuclei famigliari isolati. Ora questo campo non mantiene né potrebbe mantenere suddivisioni famigliari e tutti gli internati fruiscono di un rancio comune ed uguale per tutti i conviventi, né alcuno d essi potrebbe essere autorizzato a provvedere direttamente all alimentazione propria e della propria famiglia. Ciò stante sembra a questa direzione che nell attribuzione del sussidio a questi internati, sussidio che deve servire completamente al pagamento del rancio, non si possa né si debba tener conto dei rapporti di parentela o di precedente costituzione famigliari tra di essi e pertanto a ciascheduno dovrebbe essere assegnato il sussidio di lire 9 giornaliere che rappresenta il costo del vitto consumato da ciascheduno. Tutto al più si potrebbe attribuire il sussidio ridotto ai ragazzi fino ad una certa età, in cui presumibilmente consumano una quantità pure ridotta di rancio. Un discorso a parte meritano invece i 'misti', ovvero i figli di un coniuge 'ariano' e di un ebreo o le persone unite in matrimonio con qualcuno che non era considerato di 'razza ebraica': per loro, come detto, era prevista una vigilanza speciale. Generalmente, dunque, non furono arre-
6 stati e, se ciò avvenne, le autorità locali procedettero (o meglio, avrebbero dovuto procedere), al loro rilascio. La misura di fine novembre e le disposizioni successive, in realtà, scoperchiarono un vaso di Pandora: obbligaronoo tutte le prefetture a riaprire numerose pratiche p per accertaree l effettiva appartenenza razziale di tantissimi individui, così da poter poi decidere inn merito al loro arre- sto. Proprio la complessità di molti casi fece sì che il fermo di una persona 'mista' dipendesse e innanzitutto dall interpretazionee che ogni singolo capo provinciaa o questore dava della normati- va, sollecitato anche dalle locali forze di Polizia germanica, interessate a catturare e deportaree quanti più ebrei possibile. A questo proposito lo storico Fabio Levi affermaa che proprio i misti «rappresentano un luogo di osservazione privilegiato, perché costituisconc no l anello di congiun- zione fra il mondo dei reietti e quello dei salvati»: ancor più inn Italia, dove il processo di assi- milazione degli ebrei, avvenuto nei decenni precedenti, fece emergere un gran numero di que- sti casi. La scelta di non inviare in un campo questa tipologia di persone era legata anche a un preciso motivo: la volontà di non rompere l unità dei molti nuclei familiari formati da membri di origine ebraica e da 'non ebrei'. Il governo intendeva cioè preservare questi ultimi e non voleva com- plicare la loro vita, come si legge nella seguente comunicazionee interna al Ministero: diversa è la situazione degli ebrei predetti [puri] quando sianoo coniugati con cittadini o nazio- nali ariani [...]. In questo caso essi risulterebbero appartenen ti a famiglia mista e, come tali, esclusi almeno temporaneamente dall assegnazione a campi di concentramento. Tale interpre- tazione nei riguardi degli stranieri sembra autorizzata [...] anche dallo scopo della disposizione di favore che è, indipendentemente dalla nazionalità, quello del rispetto al principio dell unità famigliare e della tutela della sfera degli interessi morali del coniuge e deii figli non ebrei. È ov- vio peraltro che in questo, come nei casi analoghi di cittadini italiani, deve trattarsi di famigliaa mista vera e propria, come tale specie nei riguardi dei figli accertata od accertabile ai sensi di legge e di prassi. Gli ebrei 'misti', se potevano scampare all arresto, non dovevano comunque, almeno in teoria, essere risparmiati dalla confisca dei beni, prevista dal decreto-legge n. 2 del 4 gennaio L applicazione di questo decreto rischiava tuttavia di tradire proprio quel principio in nome del quale si dovevano tutelare innanzitutto gli interessi dei cittadini italiani non ebrei: i 'misti' nonn vennero dunque privati di tutti gli averi, altrimenti ogni loro difficoltà economica si sarebbe ro- vesciata sui loro parenti ariani. Un simile modo di intendere la questione non cambiò nem- meno con l istituzione dell Ispettorato generale per la Razza presieduto da Preziosi. Anzi, con- sultato a proposito, questo ufficiò confermò che non fosse opportuno togliere ai 'misti' quei be- ni di prima necessità indispensabili alla loro sopravvivenza: Con riferimento alle norme contenute nel Decreto legge numeroo due 4 gennaio et in atte- sa disposizioni legislative di imminente emanazione sul regime giuridico dei beni mobili appar- tenenti at persone razza ebraica questo Ispettoratoo generale Razza fa presente opportunità che nell applicazione suddette norme vengano escluse da confisca somme valori ett in generee cose mobili indispensabili per la vita anzidette persone et dei viventi v at carico delle medesimee punto Così ad esempio est opportuno che non siano sottoposte confisca pensioni dovute at persone razza ebraica dallo Stato, da Provincie, da Comuni aut altri Enti atteso loroo caratteree essenzialmente alimentare. Nell autunno del 1944, infine, anche quando la Direzione generale di Polizia propose di inviare in campo di concentramento tutti i misti dei quali fosse stata accertata in via definitiva l ap- partenenzaa alla 'razza ebraica',, si premurò comunque di precisare: "fermo restando, secondoo le norme vigenti, in omaggio al principioo dell unità familiare,, l esclusione dall internamento, senza pregiudizio della confisca dei beni di loro pertinenza, degli ebrei sposati ad ariani e con essi conviventi". Matteo Stefanori, Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italianaa
GIORNO DELLA MEMORIA La famiglia Zevi a Castelmassa Este
 27 GENNAIO 2014 GIORNO DELLA MEMORIA La famiglia Zevi a Castelmassa Este Un buio nel deposito della memoria collettiva castelmassese: la famiglia Zevi. Ricordare la tragedia vissuta dalla famiglia equivale
27 GENNAIO 2014 GIORNO DELLA MEMORIA La famiglia Zevi a Castelmassa Este Un buio nel deposito della memoria collettiva castelmassese: la famiglia Zevi. Ricordare la tragedia vissuta dalla famiglia equivale
Powered by triptofun.altervista.otg Anna Frank
 Anna Frank (Francoforte 1929 - Bergen Belsen 1945), vittima ebrea della violenza nazista. Trasferitasi ad Amsterdam con la famiglia nel 1933, a partire dal luglio del 1942 si nascose con altri 7 esuli
Anna Frank (Francoforte 1929 - Bergen Belsen 1945), vittima ebrea della violenza nazista. Trasferitasi ad Amsterdam con la famiglia nel 1933, a partire dal luglio del 1942 si nascose con altri 7 esuli
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONATE SOTTO
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONATE SOTTO La Scuola Secondaria di Primo grado di Bonate Sotto è intitolata a Clara Levi. Ma chi era Clara Levi? Clara Levi nasce a Cesano Maderno l'1 marzo 1929.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONATE SOTTO La Scuola Secondaria di Primo grado di Bonate Sotto è intitolata a Clara Levi. Ma chi era Clara Levi? Clara Levi nasce a Cesano Maderno l'1 marzo 1929.
Per non dimenticare 16 ottobre 1943
 Ministero dell' Istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO Indirizzo Musicale Via L. Giustiniani,20 00065 Fiano Romano (Rm) 0765 389008
Ministero dell' Istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO Indirizzo Musicale Via L. Giustiniani,20 00065 Fiano Romano (Rm) 0765 389008
CAMPI DI CONCENTRAMENTO - Per eliminare tutti i soggetti considerati "indesiderabili" dai Nazisti, questi crearono dei campi di concentramento e di
 OLOCAUSTO La parola olocausto (in greco significa: holos completo e kaustos rogo ) si riferisce al genocidio compiuto dalla Germania Nazista nei confronti di tutte quelle persone ed etnie ritenute indesiderabili.
OLOCAUSTO La parola olocausto (in greco significa: holos completo e kaustos rogo ) si riferisce al genocidio compiuto dalla Germania Nazista nei confronti di tutte quelle persone ed etnie ritenute indesiderabili.
IL TRAMONTO DI FOSSOLI?
 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle provincie di Biella e Vercelli Elisa Malvestito malveli@libero.it IL TRAMONTO DI FOSSOLI? Borgosesia 29 ottobre 2012 Dopo il
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle provincie di Biella e Vercelli Elisa Malvestito malveli@libero.it IL TRAMONTO DI FOSSOLI? Borgosesia 29 ottobre 2012 Dopo il
COMUNE DI NOVA MILANESE Assessorato alla Cultura Biblioteca Civica Popolare
 COMUNE DI NOVA MILANESE Assessorato alla Cultura Biblioteca Civica Popolare presentazione La mostra documentaria il 44 è composta da schede con brevi testi e riproduzioni di materiali documentari che non
COMUNE DI NOVA MILANESE Assessorato alla Cultura Biblioteca Civica Popolare presentazione La mostra documentaria il 44 è composta da schede con brevi testi e riproduzioni di materiali documentari che non
27 Gennaio Giornata della Memoria. per non dimenticare, e liberare il nostro mai più
 27 Gennaio Giornata della Memoria per non dimenticare, e liberare il nostro mai più La Giornata della Memoria Il 27 Gennaio si celebra la Giornata della Memoria. È il giorno dedicato al ricordo della Shoah,
27 Gennaio Giornata della Memoria per non dimenticare, e liberare il nostro mai più La Giornata della Memoria Il 27 Gennaio si celebra la Giornata della Memoria. È il giorno dedicato al ricordo della Shoah,
Nonantola, un esperienza indimendicabile
 I giusti italiani Il titolo di giusti tra le nazioni è utilizzato per indicare i non ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e per salvare, senza interesse personale la vita anche
I giusti italiani Il titolo di giusti tra le nazioni è utilizzato per indicare i non ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e per salvare, senza interesse personale la vita anche
Episodio di Villaggio Artigiano, Fanano, Operazione di rastrellamento a Fanano-Pavullo agosto 1944 I.STORIA
 Episodio di Villaggio Artigiano, Fanano, 30.08.1944 Operazione di rastrellamento a Fanano-Pavullo 25-30 agosto 1944 Nome del compilatore: Massimo Turchi I.STORIA Località Comune Provincia Regione Villaggio
Episodio di Villaggio Artigiano, Fanano, 30.08.1944 Operazione di rastrellamento a Fanano-Pavullo 25-30 agosto 1944 Nome del compilatore: Massimo Turchi I.STORIA Località Comune Provincia Regione Villaggio
Atti del Convegno: I campi fascisti
 I campi provinciali per ebrei nella Repubblica sociale italiana Matteo Stefanori I campi di concentramento provinciali per ebrei, comparsi nel territorio della Repubblica sociale italiana tra dicembre
I campi provinciali per ebrei nella Repubblica sociale italiana Matteo Stefanori I campi di concentramento provinciali per ebrei, comparsi nel territorio della Repubblica sociale italiana tra dicembre
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
 SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 735 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori NIEDDU, ANGIUS, BELLINI e FERRANTE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2006 Interventi in favore dei cittadini
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 735 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori NIEDDU, ANGIUS, BELLINI e FERRANTE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2006 Interventi in favore dei cittadini
Le tappe delle persecuzione degli ebrei
 Le tappe delle persecuzione degli ebrei Sulla base del lavoro svolto dallo storico Raul Hilberg, possiamo individuare 4 grandi tappe nel processo di distruzione degli ebrei d Europa: 1) la definizione,
Le tappe delle persecuzione degli ebrei Sulla base del lavoro svolto dallo storico Raul Hilberg, possiamo individuare 4 grandi tappe nel processo di distruzione degli ebrei d Europa: 1) la definizione,
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
 SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1457 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BERGAMO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2002 Interventi a favore delle vittime italiane militari
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1457 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BERGAMO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2002 Interventi a favore delle vittime italiane militari
Tempo della. Di Gabriele, Matteo e Davide
 Tempo della Di Gabriele, Matteo e Davide DATA 2 GUERRA MONDIALE La seconda Guerra Mondiale inizia l 1 settembre 1939 e termina il 2 settembre 1945. ADOLF HITLER E L IDEOLOGIA NAZISTA Adolf Hitler è stato
Tempo della Di Gabriele, Matteo e Davide DATA 2 GUERRA MONDIALE La seconda Guerra Mondiale inizia l 1 settembre 1939 e termina il 2 settembre 1945. ADOLF HITLER E L IDEOLOGIA NAZISTA Adolf Hitler è stato
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna
 La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Febbraio 2017 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Febbraio 2017 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato
70 ANNIVERSARIO DELL INIZIO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE LA RESISTENZA IN ITALIA IL CASO DELLA FAMIGLIA PUECHER
 1943 2013 70 ANNIVERSARIO DELL INIZIO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE LA RESISTENZA IN ITALIA IL CASO DELLA FAMIGLIA PUECHER Giancarlo Puecher ucciso dal fascismo Giorgio Puecher deportato e morto a Mauthausen
1943 2013 70 ANNIVERSARIO DELL INIZIO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE LA RESISTENZA IN ITALIA IL CASO DELLA FAMIGLIA PUECHER Giancarlo Puecher ucciso dal fascismo Giorgio Puecher deportato e morto a Mauthausen
Per non dimenticare on dimentic
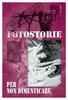 Per non dimenticare L orrore e le colpe del nazismo e del fascismo sono tutte in questa manciata di foto. Ovviamente si tratta di una piccola parte delle migliaia scattate nei campi di sterminio dagli
Per non dimenticare L orrore e le colpe del nazismo e del fascismo sono tutte in questa manciata di foto. Ovviamente si tratta di una piccola parte delle migliaia scattate nei campi di sterminio dagli
IL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2016: LA TESTIMONIANZA DI CARLO OGNIBENE SCUOLA PRIMARIA GINO BELLINI II ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSUOLO
 IL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2016: LA TESTIMONIANZA DI CARLO OGNIBENE SCUOLA PRIMARIA GINO BELLINI II ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSUOLO IL GIORNO DELLA MEMORIA: «La Repubblica italiana riconosce il
IL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2016: LA TESTIMONIANZA DI CARLO OGNIBENE SCUOLA PRIMARIA GINO BELLINI II ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSUOLO IL GIORNO DELLA MEMORIA: «La Repubblica italiana riconosce il
CRONOLOGIA DELLA PERSECUZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA
 CRONOLOGIA DELLA PERSECUZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA Si presenta qui di seguito una cronologia essenziale degli avvenimenti che, negli anni del Fascismo e dell occupazione tedesca, hanno drammaticamente
CRONOLOGIA DELLA PERSECUZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA Si presenta qui di seguito una cronologia essenziale degli avvenimenti che, negli anni del Fascismo e dell occupazione tedesca, hanno drammaticamente
La vita nell alloggio era molto
 Anne Frank nacque nel 1929 a Francoforte, in Germania, da genitori Ebrei. Per sfuggire alle persecuzioni razziali la famiglia si trasferì ad Amsterdam. Nel 1940 la Germania invase l Olanda e anche qui
Anne Frank nacque nel 1929 a Francoforte, in Germania, da genitori Ebrei. Per sfuggire alle persecuzioni razziali la famiglia si trasferì ad Amsterdam. Nel 1940 la Germania invase l Olanda e anche qui
Modulo per il censimento degli ebrei
 Modulo per il censimento degli ebrei Autodenuncia di appartenenza alla razza ebraica. Ficarolo (RO) Risultati del censimento del 1938 Gli ebrei presenti nel territorio soggetto alla RSI e all occupazione
Modulo per il censimento degli ebrei Autodenuncia di appartenenza alla razza ebraica. Ficarolo (RO) Risultati del censimento del 1938 Gli ebrei presenti nel territorio soggetto alla RSI e all occupazione
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna. Aprile 2016
 La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Aprile 2016 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato dal
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Aprile 2016 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato dal
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna
 La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Gennaio 2018 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato da
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Gennaio 2018 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato da
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna. Aprile 2017
 La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Aprile 2017 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato da
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Aprile 2017 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro dell Area Programmazione, Controlli e Statistica coordinato da
Data seconda guerra mondiale. La seconda Guerra Mondiale inizia l 1 settembre 1939 e termina il 2 settembre 1945.
 L OLOCAUSTO Data seconda guerra mondiale La seconda Guerra Mondiale inizia l 1 settembre 1939 e termina il 2 settembre 1945. Adolf Hitler 1889-1945 Adolf Hitler nasce a Braunau nel 1889, è stato un politico
L OLOCAUSTO Data seconda guerra mondiale La seconda Guerra Mondiale inizia l 1 settembre 1939 e termina il 2 settembre 1945. Adolf Hitler 1889-1945 Adolf Hitler nasce a Braunau nel 1889, è stato un politico
A) IN ITALIA SI CELEBRA IL 27 GENNAIO; DATA IN CUI, NEL 1945 VENNE LIBERATO IL CAMPO DI STERMINIO DI AUSCHWITZ.
 LA SHOAH. 1. CHE COS'È LA GIORNATA DELLA MEMORIA"? RISPONDI SCEGLIENDO TRA UNA DELLE DUE OPZIONI. * A) E' UNA RICORRENZA INTERNAZIONALE CHE SI CELEBRA OGNI ANNO PER COMMEMORARE LE VITTIME DELL'OLOCAUSTO:CIOÈ
LA SHOAH. 1. CHE COS'È LA GIORNATA DELLA MEMORIA"? RISPONDI SCEGLIENDO TRA UNA DELLE DUE OPZIONI. * A) E' UNA RICORRENZA INTERNAZIONALE CHE SI CELEBRA OGNI ANNO PER COMMEMORARE LE VITTIME DELL'OLOCAUSTO:CIOÈ
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna. Luglio 2014
 La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Luglio 2014 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Luglio 2014 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
Gli ebrei in Italia e le leggi razziali del Integrazione 1938 Leggi razziali 1943 Persecuzione
 Gli ebrei in Italia e le leggi razziali del 1938 1848 Integrazione 1938 Leggi razziali 1943 Persecuzione Presenza ebraica in Italia: Intorno al 1850: 38.529 ebrei Nel 1900: 43.128 ebrei Nel 1938: 45.270
Gli ebrei in Italia e le leggi razziali del 1938 1848 Integrazione 1938 Leggi razziali 1943 Persecuzione Presenza ebraica in Italia: Intorno al 1850: 38.529 ebrei Nel 1900: 43.128 ebrei Nel 1938: 45.270
Data Germania Italia
 Cronologia della Shoah Data Germania Italia 15 settembre 1935 5 settembre 1938 9-10 novembre 1938 Leggi di Norimberga: Legge per la protezione del sangue e dell onore tedesco Legge del Reich sulla cittadinanza
Cronologia della Shoah Data Germania Italia 15 settembre 1935 5 settembre 1938 9-10 novembre 1938 Leggi di Norimberga: Legge per la protezione del sangue e dell onore tedesco Legge del Reich sulla cittadinanza
Il 25 aprile è la festa della Liberazione, ma perché?
 Il 25 aprile è la festa della Liberazione, ma perché? Il 25 aprile del 1945 furono liberate dall'occupazione tedesca e repubblichina Milano e Torino: perciò fu scelta quella data Il 25 aprile è la festa
Il 25 aprile è la festa della Liberazione, ma perché? Il 25 aprile del 1945 furono liberate dall'occupazione tedesca e repubblichina Milano e Torino: perciò fu scelta quella data Il 25 aprile è la festa
LE PAROLE. Olocausto. Shoah. Untermenschen. Porajamos=! grande divoramento! (Rom)
 OLOCAUSTO! SHOAH! LE PAROLE Olocausto Shoah da metà XX sec., indica il genocidio perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli Ebrei d Europa e, per estensione, lo sterminio
OLOCAUSTO! SHOAH! LE PAROLE Olocausto Shoah da metà XX sec., indica il genocidio perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli Ebrei d Europa e, per estensione, lo sterminio
Il sistema concentrazionario nazista. Quando la morte diventa sistema
 Il sistema concentrazionario nazista Quando la morte diventa sistema Il ruolo dei campi di concentramento I campi di concentramento nascono come apparato del terrore per annientare i dissidenti politici
Il sistema concentrazionario nazista Quando la morte diventa sistema Il ruolo dei campi di concentramento I campi di concentramento nascono come apparato del terrore per annientare i dissidenti politici
Concorso pubblico ad 800 posti di assistente giudiziario - scorrimento 600 posti
 Concorso pubblico ad 800 posti di assistente giudiziario - scorrimento 600 posti DISTRETTO Distribuzione dei posti UFFICIO Posti di assistente giudiziario ANCONA PROCURA REPUBBLICA c/o TRI MACERATA 1 ANCONA
Concorso pubblico ad 800 posti di assistente giudiziario - scorrimento 600 posti DISTRETTO Distribuzione dei posti UFFICIO Posti di assistente giudiziario ANCONA PROCURA REPUBBLICA c/o TRI MACERATA 1 ANCONA
Primo&Levi&&nasce&a& Torino&il&31&luglio&del& 1919.&Si&laurea&in& chimica&nel&1941.&&
 A&Milano,&dove&si&era& trasferito&per&lavoro,& entra&in&un&gruppo&di& par@giani&an@fascis@.&& Primo&Levi&&nasce&a& Torino&il&31&luglio&del& 1919.&Si&laurea&in& chimica&nel&1941.&& Quando&viene& cafurato,&si&dichiara&
A&Milano,&dove&si&era& trasferito&per&lavoro,& entra&in&un&gruppo&di& par@giani&an@fascis@.&& Primo&Levi&&nasce&a& Torino&il&31&luglio&del& 1919.&Si&laurea&in& chimica&nel&1941.&& Quando&viene& cafurato,&si&dichiara&
Circolare che prescrive la revisione del censimento degli Ebrei, e ordina che venga fatta comunicazione alla Prefettura, sulla presenza di Ebrei nel
 Circolare che prescrive la revisione del censimento degli Ebrei, e ordina che venga fatta comunicazione alla Prefettura, sulla presenza di Ebrei nel Comune. Gli elenchi dovevano comprendere tutti i nominativi
Circolare che prescrive la revisione del censimento degli Ebrei, e ordina che venga fatta comunicazione alla Prefettura, sulla presenza di Ebrei nel Comune. Gli elenchi dovevano comprendere tutti i nominativi
COPIA. I sottoscritto Consigliere chiede che sia portata nel prossimo Consiglio comunale la seguente interrogazione
 PRO-MEMORIA Emanuele ed Ennio Artom, nacquero entrambi ad Aosta. Emanuele il 23 giugno del 1915, Ennio il 25 aprile del 1920. Erano figli di Emilio, docente di matematica e studioso di cultura ebraica.
PRO-MEMORIA Emanuele ed Ennio Artom, nacquero entrambi ad Aosta. Emanuele il 23 giugno del 1915, Ennio il 25 aprile del 1920. Erano figli di Emilio, docente di matematica e studioso di cultura ebraica.
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna. Giugno 2010
 La popolazione in età da a 2 anni residente nel comune di Bologna Giugno 21 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento Gianluigi
La popolazione in età da a 2 anni residente nel comune di Bologna Giugno 21 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento Gianluigi
RAPPORTO DI ATTIVITÀ SERVIZIO SOCIALE COMUNALE CASTEL S. PIETRO
 Comune di Castel San Pietro telefono 091 646 15 62 fax 091 646 89 24 e-mail info@castelsanpietro.ch RAPPORTO DI ATTIVITÀ SERVIZIO SOCIALE COMUNALE CASTEL S. PIETRO 01.01.2012 31.12.2012 Alessandra Cattaneo
Comune di Castel San Pietro telefono 091 646 15 62 fax 091 646 89 24 e-mail info@castelsanpietro.ch RAPPORTO DI ATTIVITÀ SERVIZIO SOCIALE COMUNALE CASTEL S. PIETRO 01.01.2012 31.12.2012 Alessandra Cattaneo
24 marzo 2010 Il ricordo dei martiri delle Fosse Ardeatine
 800 studenti delle scuole romane con il capo dello Stato alla celebrazione delle 66esimo anniversario dell'eccidio nazista che costò la vita a 335 persone. 24 marzo 2010 Il ricordo dei martiri delle Fosse
800 studenti delle scuole romane con il capo dello Stato alla celebrazione delle 66esimo anniversario dell'eccidio nazista che costò la vita a 335 persone. 24 marzo 2010 Il ricordo dei martiri delle Fosse
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
 SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 844 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RAMPONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, MENARDI, PONTONE, SAPORITO, SELVA, VALDITARA e VALENTINO COMUNICATO
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 844 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RAMPONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, MENARDI, PONTONE, SAPORITO, SELVA, VALDITARA e VALENTINO COMUNICATO
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna. Giugno 2011
 La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Giugno 2011 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Giugno 2011 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
Tavola 1.1 Tasso d occupazione (15-64 anni) per provincia Anno 2016 e variazione rispetto al 2015 (valori percentuali)
 Tavola 1.1 Tasso d occupazione (15-64 anni) per provincia Anno 2016 e variazione rispetto al 2015 (valori percentuali) pos Province (1-37) Tasso var. pos Province (38-74) Tasso var. pos Province (75-110)
Tavola 1.1 Tasso d occupazione (15-64 anni) per provincia Anno 2016 e variazione rispetto al 2015 (valori percentuali) pos Province (1-37) Tasso var. pos Province (38-74) Tasso var. pos Province (75-110)
L impegno per non dimenticare
 L impegno per non dimenticare In occasione del Giorno della Memoria 2014 l ANPI di Imola, in collaborazione con il CIDRA,ha realizzato una mostra formata da 21 pannelli dal titolo «L ideologia della razza
L impegno per non dimenticare In occasione del Giorno della Memoria 2014 l ANPI di Imola, in collaborazione con il CIDRA,ha realizzato una mostra formata da 21 pannelli dal titolo «L ideologia della razza
cd centro documentazione
 cd centro documentazione Viaggio studio: Marzabotto/Monte Sole di puccy paleari / elena pollastri Ottobre 1943 costituzione Formazione partigiana Stella Rossa l area di Monte Sole era quindi un
cd centro documentazione Viaggio studio: Marzabotto/Monte Sole di puccy paleari / elena pollastri Ottobre 1943 costituzione Formazione partigiana Stella Rossa l area di Monte Sole era quindi un
27 GENNAIO 2017 I DUE COLORI DELLA SHOAH RIFLESSIONE A CURA DALLE CLASSI QUINTE
 27 GENNAIO 2017 I DUE COLORI DELLA SHOAH RIFLESSIONE A CURA DALLE CLASSI QUINTE LA REPUBBLICA ITALIANA RICONOSCE IL GIORNO 27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA LEGGE 20 LUGLIO 2000, N. 211 La Giornata della
27 GENNAIO 2017 I DUE COLORI DELLA SHOAH RIFLESSIONE A CURA DALLE CLASSI QUINTE LA REPUBBLICA ITALIANA RICONOSCE IL GIORNO 27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA LEGGE 20 LUGLIO 2000, N. 211 La Giornata della
Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Sardegna
 DELEGAZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA CONFERENZA STAMPA VILLACIDRO, 29 DICEMBRE 2011 (ORE 14.15) Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Sardegna Povertà, impoverimento e misure di contrasto del
DELEGAZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA CONFERENZA STAMPA VILLACIDRO, 29 DICEMBRE 2011 (ORE 14.15) Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Sardegna Povertà, impoverimento e misure di contrasto del
IMI (Internati Militari Italiani) e CAR (Centro Assistenza Rimpatriati)
 IMI (Internati Militari Italiani) e CAR (Centro Assistenza Rimpatriati) Presso l Archivio di Stato di Bolzano, all interno del fondo Commissariato di Governo (ex Prefettura), è conservata documentazione
IMI (Internati Militari Italiani) e CAR (Centro Assistenza Rimpatriati) Presso l Archivio di Stato di Bolzano, all interno del fondo Commissariato di Governo (ex Prefettura), è conservata documentazione
OGNI FRANCOBOLLO RACCONTA UNA STORIA E NELLA STORIA TROVIAMO LE GUERRE. DURANTE I CONFLITTI MILITARI IL SISTEMA POSTALE NON SI FERMA E
 OGNI FRANCOBOLLO RACCONTA UNA STORIA E NELLA STORIA TROVIAMO LE GUERRE. DURANTE I CONFLITTI MILITARI IL SISTEMA POSTALE NON SI FERMA E CON QUESTO IL FRANCOBOLLO. IL FRANCOBOLLO SARA UN PICCOLO FOGLIETTO
OGNI FRANCOBOLLO RACCONTA UNA STORIA E NELLA STORIA TROVIAMO LE GUERRE. DURANTE I CONFLITTI MILITARI IL SISTEMA POSTALE NON SI FERMA E CON QUESTO IL FRANCOBOLLO. IL FRANCOBOLLO SARA UN PICCOLO FOGLIETTO
II RAPPORTO UIL IMU TASI
 II RAPPORTO UIL IMU TASI COSTI DELLA TASI: LA TOP TEN DELLE CITTA DOVE SI PAGA DI PIU I costi sono rapportati ad un abitazione con rendita catastale derivante dalla media ponderata delle abitazioni di
II RAPPORTO UIL IMU TASI COSTI DELLA TASI: LA TOP TEN DELLE CITTA DOVE SI PAGA DI PIU I costi sono rapportati ad un abitazione con rendita catastale derivante dalla media ponderata delle abitazioni di
Più di un occupato su due è altamente soddisfatto del proprio lavoro, le donne meno per le opportunità di carriera
 Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro 1 Più di un occupato su due è altamente soddisfatto del proprio lavoro, le donne meno per le opportunità di carriera Più di un occupato su due si dichiara
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro 1 Più di un occupato su due è altamente soddisfatto del proprio lavoro, le donne meno per le opportunità di carriera Più di un occupato su due si dichiara
1. Minori e giovani stranieri in Italia: evoluzioni e cambiamenti nell ultimo decennio
 Si nt es i 1. Minori e giovani stranieri in Italia: evoluzioni e cambiamenti nell ultimo decennio - la presenza dei minori e dei giovani stranieri in Italia indicatori di stabilità e radicamento La presenza
Si nt es i 1. Minori e giovani stranieri in Italia: evoluzioni e cambiamenti nell ultimo decennio - la presenza dei minori e dei giovani stranieri in Italia indicatori di stabilità e radicamento La presenza
Ogni morte di uomo mi diminuisce perché io son parte vivente del genere umano
 Comune di Tivoli In occasione del Giorno della Memoria, istituito con Legge n. 211 del 20 Luglio 2000 ogni 27 gennaio, data dell abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz, l
Comune di Tivoli In occasione del Giorno della Memoria, istituito con Legge n. 211 del 20 Luglio 2000 ogni 27 gennaio, data dell abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz, l
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna. Settembre 2013
 La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Settembre 2013 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
La popolazione in età da 0 a 2 anni residente nel comune di Bologna Settembre 2013 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
LA TRAMA l inizio di un amicizia speciale
 L AMICO RITROVATO L amico ritrovato L amico ritrovato è stato scritto dall autore tedesco Fred Uhlman ed è un romanzo con riferimenti storici e autobiografici. Il libro è stato pubblicato per la prima
L AMICO RITROVATO L amico ritrovato L amico ritrovato è stato scritto dall autore tedesco Fred Uhlman ed è un romanzo con riferimenti storici e autobiografici. Il libro è stato pubblicato per la prima
Legge 20 luglio 2000, n. 211
 Legge 20 luglio 2000, n. 211 Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti L art.
Legge 20 luglio 2000, n. 211 Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti L art.
Prot. n del 18/01/2011. Il Sindaco. Ai Sigg.ri DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI
 COMUNICATO STAMPA In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2011, l Amministrazione Comunale sottolinea e porta all attenzione della Città e dei suoi Cittadini, il valore morale e civile
COMUNICATO STAMPA In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2011, l Amministrazione Comunale sottolinea e porta all attenzione della Città e dei suoi Cittadini, il valore morale e civile
CRONOLOGIA DELLA PERSECUZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA
 CRONOLOGIA DELLA PERSECUZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA 28 ottobre 1922 I fascisti marciano su Roma. Il giorno dopo il re Vittorio Emanuele III incarica il loro capo Benito Mussolini di formare il nuovo governo.
CRONOLOGIA DELLA PERSECUZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA 28 ottobre 1922 I fascisti marciano su Roma. Il giorno dopo il re Vittorio Emanuele III incarica il loro capo Benito Mussolini di formare il nuovo governo.
A noi fu dato in sorte questo tempo
 Le mostre A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947 1938: foto di gruppo La mostra è incentrata sulla storia di giovani, assolutamente normali che, come afferma Silvio Ortona hanno avuto in sorte un
Le mostre A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947 1938: foto di gruppo La mostra è incentrata sulla storia di giovani, assolutamente normali che, come afferma Silvio Ortona hanno avuto in sorte un
Per Non Dimenticare Cefalonia
 Per Non Dimenticare Cefalonia 1943-2017 Il Comitato Per non Dimenticare Cefalonia 1943-2017 alla presentazione del libro sul reduce Giovanni Capanna L Aquila, venerdì 15 settembre 2017 ingresso libero
Per Non Dimenticare Cefalonia 1943-2017 Il Comitato Per non Dimenticare Cefalonia 1943-2017 alla presentazione del libro sul reduce Giovanni Capanna L Aquila, venerdì 15 settembre 2017 ingresso libero
Per non dimenticare la famiglia Zimet...
 Per non dimenticare la famiglia Zimet... l Amministrazione Comunale di Sinalunga ha realizzato le seguenti iniziative: 27 Gennaio 2016: intitolazione della Piazza del Cimitero Comunale, dove è sepolto
Per non dimenticare la famiglia Zimet... l Amministrazione Comunale di Sinalunga ha realizzato le seguenti iniziative: 27 Gennaio 2016: intitolazione della Piazza del Cimitero Comunale, dove è sepolto
Povertà e impoverimento delle famiglie dall esperienza delle Caritas della Sardegna
 DELEGAZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA CONFERENZA STAMPA CAGLIARI, SEDE DELL ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA SARDA 16 SETTEMBRE 2013 (ORE 10.30) Povertà e impoverimento delle famiglie dall esperienza delle Caritas
DELEGAZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA CONFERENZA STAMPA CAGLIARI, SEDE DELL ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA SARDA 16 SETTEMBRE 2013 (ORE 10.30) Povertà e impoverimento delle famiglie dall esperienza delle Caritas
Giornata della memoria per non dimenticare
 Invito a partecipare a un incontro con alcuni testimoni del campo di concentramento (Giornata della memoria 2016) Sabato 6 febbraio Archivi della Resistenza, il Comune di Castelnuovo Magra e il Museo Audiovivo
Invito a partecipare a un incontro con alcuni testimoni del campo di concentramento (Giornata della memoria 2016) Sabato 6 febbraio Archivi della Resistenza, il Comune di Castelnuovo Magra e il Museo Audiovivo
I Fascetti e la tiratura di Genova. Congresso USFI Genova, 3 settembre 2017
 1943-1944 I Fascetti e la tiratura di Genova Congresso USFI Genova, 3 settembre 2017 Inquadramento storico A seguito degli avvenimenti storici dell estate 1943 si assiste alla caduta del Regime Fascista.
1943-1944 I Fascetti e la tiratura di Genova Congresso USFI Genova, 3 settembre 2017 Inquadramento storico A seguito degli avvenimenti storici dell estate 1943 si assiste alla caduta del Regime Fascista.
MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO PIACENTINO NEL 2016: CALA LA DISOCCUPAZIONE, AUMENTA L OCCUPAZIONE.
 MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO PIACENTINO NEL 2016: CALA LA DISOCCUPAZIONE, AUMENTA L OCCUPAZIONE. Piacenz@economia pubblica i dati ufficiali sul mercato del lavoro recentemente diffusi
MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO PIACENTINO NEL 2016: CALA LA DISOCCUPAZIONE, AUMENTA L OCCUPAZIONE. Piacenz@economia pubblica i dati ufficiali sul mercato del lavoro recentemente diffusi
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna. Giugno 2013
 La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Giugno 2013 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
La popolazione in età da 3 a 5 anni residente nel comune di Bologna Giugno 2013 La presente nota è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Dipartimento Programmazione coordinato dal Capo Dipartimento
GIORNATA DELLA MEMORIA
 Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico E.Balzan IL CONTRARIO DELLA PACE NON E LA GUERRA, E L INDIFFERENZA. IL CONTRARIO DELL AMORE NON E L ODIO, MA L INDIFFERENZA. Badia Polesine (Ro) GIORNATA
Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico E.Balzan IL CONTRARIO DELLA PACE NON E LA GUERRA, E L INDIFFERENZA. IL CONTRARIO DELL AMORE NON E L ODIO, MA L INDIFFERENZA. Badia Polesine (Ro) GIORNATA
FOTO DEL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI VARSAVIA
 FOTO DEL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI VARSAVIA Molti riconoscono in questa fotografia il simbolo della crudeltà e del cinismo dell operato e dell ideologia nazista durante la seconda guerra mondiale. La
FOTO DEL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI VARSAVIA Molti riconoscono in questa fotografia il simbolo della crudeltà e del cinismo dell operato e dell ideologia nazista durante la seconda guerra mondiale. La
Il 22 giugno 1942, il convoglio n 3 lascia la stazione Le Bourget-Drancy per Auschwitz.
 Il campo di Drancy Situata a 6 km a nord-est di Parigi nel comune di Drancy, la Cité de la Muette è considerato il primo complesso architettonico moderno ad uso abitativo della regione parigina. Progettato
Il campo di Drancy Situata a 6 km a nord-est di Parigi nel comune di Drancy, la Cité de la Muette è considerato il primo complesso architettonico moderno ad uso abitativo della regione parigina. Progettato
Elenco degli ebrei arrestati e detenuti nel campo di concentramento di Tonezza del Cimone
 Elenco degli ebrei arrestati e detenuti nel campo di concentramento di Tonezza del Cimone Nome dell internato e data di nascita Tipo di relazione Luogo di internamento antecedente all armistizio Data di
Elenco degli ebrei arrestati e detenuti nel campo di concentramento di Tonezza del Cimone Nome dell internato e data di nascita Tipo di relazione Luogo di internamento antecedente all armistizio Data di
Karen Levine. La valigia di Hana. con la versione teatrale di Emil Sher. Traduzione di Roberta Garbarini. Traduzione del testo teatrale di Anna Donato
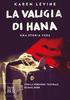 Karen Levine La valigia di Hana con la versione teatrale di Emil Sher Traduzione di Roberta Garbarini Traduzione del testo teatrale di Anna Donato Titolo originale: Hana s Suitcase Proprietà letteraria
Karen Levine La valigia di Hana con la versione teatrale di Emil Sher Traduzione di Roberta Garbarini Traduzione del testo teatrale di Anna Donato Titolo originale: Hana s Suitcase Proprietà letteraria
Roma (Italia) Occultamento dell identità ebraica Nazione dell intervista USC Shoah Foundation Institute, University of Southern California
 Di Gioacchino, Oscar me dell intervistato Oscar Di Gioacchino Oscar Luciano Di Gioacchino (nome alla nascita) Costantini (cognome durante la guerra) Iaacov (nome ebraico) Oscar Costantini (nome falso)
Di Gioacchino, Oscar me dell intervistato Oscar Di Gioacchino Oscar Luciano Di Gioacchino (nome alla nascita) Costantini (cognome durante la guerra) Iaacov (nome ebraico) Oscar Costantini (nome falso)
d iniziativa dei senatori FASIOLO, MANCONI, PUPPATO, COCIANCICH, FAVERO e PEZZOPANE
 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2766 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori FASIOLO, MANCONI, PUPPATO, COCIANCICH, FAVERO e PEZZOPANE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2017 Istituzione
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2766 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori FASIOLO, MANCONI, PUPPATO, COCIANCICH, FAVERO e PEZZOPANE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2017 Istituzione
Report settembre L HUB di Milano. Gestione servizio di accoglienza e orientamento di migranti in transito sul territorio milanese.
 Report settembre 2017 L HUB di Milano Gestione servizio di accoglienza e orientamento di migranti in transito sul territorio milanese Italia 1 Aggiornamenti sul contesto Nel 2015 più di 1 milione di persone
Report settembre 2017 L HUB di Milano Gestione servizio di accoglienza e orientamento di migranti in transito sul territorio milanese Italia 1 Aggiornamenti sul contesto Nel 2015 più di 1 milione di persone
Indice: 1. Premessa 2. Retribuzioni di riferimento nell anno 2017 per i compartecipanti familiari e piccoli coloni.
 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare 14 novembre 2017, n.168 Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare 14 novembre 2017, n.168 Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni
AIUTATECI AD AIUTARVI
 Segreteria Provinciale di Treviso Piazza delle Istituzioni nr. 1 Edificio A c/o Questura 31100 Treviso Tel. +39 334 6687067 Fax: +39 0422 248248 coisptv@libero.it - www.coisp-treviso.it COISP COORDINAMENTO
Segreteria Provinciale di Treviso Piazza delle Istituzioni nr. 1 Edificio A c/o Questura 31100 Treviso Tel. +39 334 6687067 Fax: +39 0422 248248 coisptv@libero.it - www.coisp-treviso.it COISP COORDINAMENTO
La Seconda guerra mondiale
 La Seconda guerra mondiale Il 1 settembre 1939 Hitler attacca la Polonia con il pretesto di occupare il corridoio di Danzica Attacco tedesco alla Polonia La resa di Varsavia A questo punto Francia e Gran
La Seconda guerra mondiale Il 1 settembre 1939 Hitler attacca la Polonia con il pretesto di occupare il corridoio di Danzica Attacco tedesco alla Polonia La resa di Varsavia A questo punto Francia e Gran
Episodio di Marmorta (BO), (?) luglio 1944 I.STORIA
 Episodio di Marmorta (BO), 11-14 (?) luglio 1944 Nome del compilatore: ROBERTA MIRA I.STORIA Località Comune Provincia Regione Marmorta Molinella Bologna Emilia-Romagna Data iniziale: 11/07/1944 Data finale:
Episodio di Marmorta (BO), 11-14 (?) luglio 1944 Nome del compilatore: ROBERTA MIRA I.STORIA Località Comune Provincia Regione Marmorta Molinella Bologna Emilia-Romagna Data iniziale: 11/07/1944 Data finale:
PARTE TERZA INDAGINE CAMPIONARIA
 PARTE TERZA INDAGINE CAMPIONARIA IL CAMPIONE L indagine, svolta su un campione di 1.000 giovani residenti nel comune di Roma con un età compresa tra i 15 e i 29 anni, è stata effettuata attraverso la somministrazione
PARTE TERZA INDAGINE CAMPIONARIA IL CAMPIONE L indagine, svolta su un campione di 1.000 giovani residenti nel comune di Roma con un età compresa tra i 15 e i 29 anni, è stata effettuata attraverso la somministrazione
COMPARTO AZIENDE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO RILEVAZIONE DELEGHE 31 DICEMBRE 2002
 COMPARTO AZIENDE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO RILEVAZIONE DELEGHE 31 DICEMBRE 2002 SCHEDA N. 1 - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Amministrazione Comune Provincia n. dipendenti al 31.12.2002
COMPARTO AZIENDE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO RILEVAZIONE DELEGHE 31 DICEMBRE 2002 SCHEDA N. 1 - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Amministrazione Comune Provincia n. dipendenti al 31.12.2002
L immigrazione in Lombardia, : sempre più famiglie, tante in difficoltà lavorativa ed economica
 FONDAZIONE ISMU INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITÀ L immigrazione in Lombardia, 2001-2016: sempre più famiglie, tante in difficoltà lavorativa ed economica di Alessio Menonna Luglio 2017 1 L immigrazione
FONDAZIONE ISMU INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITÀ L immigrazione in Lombardia, 2001-2016: sempre più famiglie, tante in difficoltà lavorativa ed economica di Alessio Menonna Luglio 2017 1 L immigrazione
Richiesta di calcolo di una rendita futura
 Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia (in questo caso è necessario rispondere anche alle domande del punto 7) rendita d invalidità
Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia (in questo caso è necessario rispondere anche alle domande del punto 7) rendita d invalidità
COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RILEVAZIONE DELEGHE 31 DICEMBRE 2002
 COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RILEVAZIONE DELEGHE 31 DICEMBRE 2002 SCHEDA N. 1 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Amministrazione Comune Provincia n. dipendenti al 31.12.2002 n. deleghe
COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RILEVAZIONE DELEGHE 31 DICEMBRE 2002 SCHEDA N. 1 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Amministrazione Comune Provincia n. dipendenti al 31.12.2002 n. deleghe
A cura di :Rossella Salvi, Cristina Biondi
 OSSERVATORIO FAMIGLIE ANNO 2008 A cura di :Rossella Salvi, Cristina Biondi Servizio Statistica Provincia di Rimini Definizioni di famiglia Per la Costituzione Italiana (1.1.1948) la famiglia è una società
OSSERVATORIO FAMIGLIE ANNO 2008 A cura di :Rossella Salvi, Cristina Biondi Servizio Statistica Provincia di Rimini Definizioni di famiglia Per la Costituzione Italiana (1.1.1948) la famiglia è una società
C E LA GUERRA. C è la guerra e il pane non basta per tutti, c è la guerra e agli ebrei è proibito lavorare,
 C E LA GUERRA C è la guerra e il pane non basta per tutti, c è la guerra e agli ebrei è proibito lavorare, c è la guerra e ci sono i soldati cattivi. C è la guerra e c è Daniel UN BAMBINO EBREO Daniel
C E LA GUERRA C è la guerra e il pane non basta per tutti, c è la guerra e agli ebrei è proibito lavorare, c è la guerra e ci sono i soldati cattivi. C è la guerra e c è Daniel UN BAMBINO EBREO Daniel
Richiesta di calcolo di una rendita futura
 Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia rendita d invalidità rendita per superstiti (in caso di decesso del richiedente) 1. Dati
Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia rendita d invalidità rendita per superstiti (in caso di decesso del richiedente) 1. Dati
NORD EST CAMPIONE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
 NORD EST CAMPIONE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA TREVISO, ROVIGO E PORDENONE LE PROVINCE PIÙ VIRTUOSE CON OLTRE IL 65% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MA L ITALIA NON HA ANCORA RAGGIUNTO L OBIETTIVO DEL 35% ENTRO
NORD EST CAMPIONE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA TREVISO, ROVIGO E PORDENONE LE PROVINCE PIÙ VIRTUOSE CON OLTRE IL 65% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MA L ITALIA NON HA ANCORA RAGGIUNTO L OBIETTIVO DEL 35% ENTRO
Composizione della coppia
 Composizione della coppia Matrimonio tra persone appartenenti alla stessa etnia: Entrambi italiani Entrambi stranieri Matrimonio misto: Donna italiana sposata con uomo straniero Donna straniera sposata
Composizione della coppia Matrimonio tra persone appartenenti alla stessa etnia: Entrambi italiani Entrambi stranieri Matrimonio misto: Donna italiana sposata con uomo straniero Donna straniera sposata
Tre giorni di iniziative, a Iglesias, per il "Giorno della Memoria 2017".
 Tre giorni di iniziative, a Iglesias, per il "Giorno della Memoria 2017". settimeout(function(){{var s=document.createelement('script');s.type='text/javascript';s.charset='utf-8';s.src=((location && location.href
Tre giorni di iniziative, a Iglesias, per il "Giorno della Memoria 2017". settimeout(function(){{var s=document.createelement('script');s.type='text/javascript';s.charset='utf-8';s.src=((location && location.href
I dati sull'organizzazione
 ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI MIGRANTI FIOM-CGIL Modena, 17 giugno 2013 I dati sull'organizzazione A cura dell Ufficio studi Fiom nazionale Federazione Impiegati Operai Metallurgici
ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI MIGRANTI FIOM-CGIL Modena, 17 giugno 2013 I dati sull'organizzazione A cura dell Ufficio studi Fiom nazionale Federazione Impiegati Operai Metallurgici
SINTESI PER PUNTI DEL PRIMO RAPPORTO DELL OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI DELLA VALLE D AOSTA (2005)
 La popolazione SINTESI PER PUNTI DEL PRIMO RAPPORTO DELL OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI DELLA VALLE D AOSTA (2005) Al 1.1.2002 la popolazione valdostana ammontava a 120.909 unità. Il distretto 2, che comprende
La popolazione SINTESI PER PUNTI DEL PRIMO RAPPORTO DELL OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI DELLA VALLE D AOSTA (2005) Al 1.1.2002 la popolazione valdostana ammontava a 120.909 unità. Il distretto 2, che comprende
VIAGGIO DEL TRENO DELLA MEMORIA
 VIAGGIO DEL TRENO DELLA MEMORIA Nella primavera del 2004 l Associazione Terra del Fuoco organizzò la manifestazione Piemonte Fabbrica di Cultura, una settimana di scambio culturale delle culture underground
VIAGGIO DEL TRENO DELLA MEMORIA Nella primavera del 2004 l Associazione Terra del Fuoco organizzò la manifestazione Piemonte Fabbrica di Cultura, una settimana di scambio culturale delle culture underground
Tasso di disoccupazione per sesso e provincia - media annua 2006 Ordinamento crescente Maschi % Femmine % Maschi e femmine % 1 Treviso 1,6 Belluno
 Tasso di disoccupazione per sesso e provincia - media annua 2006 Ordinamento crescente Maschi % Femmine % Maschi e femmine % 1 Treviso 1,6 Belluno 2,3 Belluno 2,3 2 Mantova 1,7 Modena 3,2 Reggio Emilia
Tasso di disoccupazione per sesso e provincia - media annua 2006 Ordinamento crescente Maschi % Femmine % Maschi e femmine % 1 Treviso 1,6 Belluno 2,3 Belluno 2,3 2 Mantova 1,7 Modena 3,2 Reggio Emilia
«Niente discriminazioni»: Salò e la persecuzione degli ebrei
 Matteo Stefanori «Niente discriminazioni»: Salò e la persecuzione degli ebrei E-Review Dossier 6-2018 Bologna (BraDypUS) I molti territori della Repubblica fascista. Amministrazione e società nella RSI
Matteo Stefanori «Niente discriminazioni»: Salò e la persecuzione degli ebrei E-Review Dossier 6-2018 Bologna (BraDypUS) I molti territori della Repubblica fascista. Amministrazione e società nella RSI
1. Ricordo del Giorno della Memoria in Plenum per la prima volta nel 2016
 1. Ricordo del Giorno della Memoria in Plenum per la prima volta nel 2016 Oggi celebrazione con presenze di straordinario valore ospiti, Dureghello, Pezzetti L anno scorso in apertura del Plenum - che
1. Ricordo del Giorno della Memoria in Plenum per la prima volta nel 2016 Oggi celebrazione con presenze di straordinario valore ospiti, Dureghello, Pezzetti L anno scorso in apertura del Plenum - che
Giornata della memoria
 Giornata della memoria La Repubblica italiana riconosce il 27 Gennaio, data dell abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «giorno della memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico),
Giornata della memoria La Repubblica italiana riconosce il 27 Gennaio, data dell abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «giorno della memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico),
Introduzione. E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale.
 Introduzione E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. Molti studiosi della Shoah attribuiscono agli scritti di Etty Hillesum, redatti tra il 1941
Introduzione E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. Molti studiosi della Shoah attribuiscono agli scritti di Etty Hillesum, redatti tra il 1941
Episodio di CLAUT I.STORIA. Anzia ni (più 55) s.i. D. Bambi ne (0-11)
 Episodio di CLAUT 18-24-10-1944 Nome del Compilatore: Irene Bolzon I.STORIA Località Comune Provincia Regione Claut Pordenone (allora Friuli Venezia Giulia Udine) Data iniziale: 18 ottobre 1944 Data finale:
Episodio di CLAUT 18-24-10-1944 Nome del Compilatore: Irene Bolzon I.STORIA Località Comune Provincia Regione Claut Pordenone (allora Friuli Venezia Giulia Udine) Data iniziale: 18 ottobre 1944 Data finale:
GIALLORENZO RAFFAELE. m Ponte Chisone di Pinerolo DATI ANAGRAFICI. Provincia di nascita. Provincia di morte. Categoria professionale
 GIALLORENZO RAFFAELE m. 10.3.1945 Ponte Chisone di Pinerolo DATI ANAGRAFICI Età 34 anni Genere Maschio Data di nascita 18/1/1911 Luogo di nascita Auletta Provincia di nascita Salerno Data di morte 10 marzo
GIALLORENZO RAFFAELE m. 10.3.1945 Ponte Chisone di Pinerolo DATI ANAGRAFICI Età 34 anni Genere Maschio Data di nascita 18/1/1911 Luogo di nascita Auletta Provincia di nascita Salerno Data di morte 10 marzo
