3 Morfologia: nozioni generali
|
|
|
- Mario Micheli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979: capp.2, 3, 5, 6, 7, Bauer 1992: capp. 2, 3, 5, 6, Haspelmath 2002: capp. 1, 2, 4, 6 (solo per quanto riguarda gli argomenti trattati)] (1) Morfologia: studio della struttura interna delle parole, e del modo in cui tale struttura varia sistematicamente in relazione alla variazione del significato (Haspelmath 2002: 1-3) (2) Italiano: amic-o / amic-i, tavol-o / tavol-i, libr-o / libr-i, ma *t-reni / f-reni (3) Casi come quelli di -o ed -i in italiano, in cui un segmento, o sequenza di suoni, è associata in maniera ricorrente allo stesso significato in contesti diversi, e non è ulteriormente scomponibili in segmenti più piccoli portatori di significato, sono esempi di morfemi, ovvero unità o combinazioni minime ricorrenti in cui sono associati suono e significato. I segmenti che veicolano concretamente il significato del morfema, ad esempio appunto -o ed -i per il singolare e plurale in italiano, prendono il nome di morfi (Haspelmath 2002: 16-7). Presente Imperfetto 1SG amo amabam 2SG amas amabas 3SG amat amabat Tabella 1: Il paradigma (parziale) del verbo latino amare amare Presente Imperfetto 1SG lego legebam 2SG legis legebas 3SG legit legebat Tabella 2: Il paradigma (parziale) del verbo latino legere leggere (4) Quali morfemi si possono individuare sulla base dei due paradigmi di amare e legere? 1
2 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a am- e leg-, rispettivamente amare e leggere, perchè si ritrovano in tutte le forme di ciascuno dei due verbi; -o 1SG.PRES, perchè viene utilizzato per entrambi i verbi solo per questo significato; -m 1SG.IMPF, perchè viene utilizzato per entrambi i verbi solo per questo significato; -s e -t, rispettivamente, per 2SG e 3SG, perchè vengono utilizzati per veicolare questi significati sia al presente sia all imperfetto per entrambi i verbi; -ba- IMPF, perchè si ritrova per entrambi i verbi in tutte le forme dell imperfetto, ma non in quelle del presente (il presente, viceversa, non è indicato da nessun morfema specifico: si parla in questi casi di morfema zero, ovvero un elemento del significato di una parola che non è indicato da nessun segmento fonetico all interno della parola). -a- per amare e -e-/-i- per legere, perchè si ritrovano in varie delle forme di ciascuno dei due verbi e sono chiaramente distinguibili dagli altri morfemi che è possibile individuare in queste forme: questi morfemi, però, non sono in realtà portatori di nessun significato specifico (se non per il fatto che distinguono la classe di coniugazione del verbo), e si parla in questo caso di morfemi vuoti, ovvero segmenti chiaramente identificabili all interno della parola che non sono però associati a nessun significato. (5) Tipi di morfemi: A. Differenza di funzione: Morfemi lessicali: hanno significato concreto, ad esempio italiano amic-, latino am- Morfemi grammaticali: hanno significato più astratto, ad esempio italiano -o SG e -i PL, latino -o 1SG.PRES B. Differenza di distribuzione: Morfemi liberi: possono occorrere autonomamente, ad esempio italiano di, il, però, lui, e, già. Morfemi legati: devono occorrere in combinazione con altri morfemi, ad esempio italiano -i, -o) SG-PL, o inglese huckle- (huckleberry, un tipo di erica). (6) Morfemi legati: 2
3 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a Base o radice: morfema legato lessicale, ad esempio italiano amic-, o in latino am- Affissi: morfemi legati grammaticali. Possono essere prefissi, collocati prima della radice ((7), (8)); suffissi, collocati dopo la radice ((9), (10)); infissi collocati all interno della radice ((11)); circumfissi, formati da due segmenti collocati uno prima e uno dopo la radice ((12)). Tagalog (austronesiano; Filippine) (7) pan-ulat STRUM-scrivere penna (Bauer 1992: 21) Swahili (nigero-congolese; Tanzania) (8) a-si-nga-li-jua 3SG-NEG-CONC-PAST-sapere se non avesse saputo (Bauer 1992: 21) Mam (maya; Guatemala) (9) txik-eenj cuocere-pat una cosa cotta (Bauer 1992: 19) Finlandese (10) talo-i-ssa-an casa-pl-in-3poss nelle loro case (Bauer 1992: 19) (11) Greco antico: [la-m-b]-an-ō prendo / e-[lab]-o-n ho preso (12) Tedesco: fragen chiedere / ge-frag-t chiesto (13) Il significato di ciascun singolo morfema non è sempre reso dagli stessi morfi: 3
4 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a Talvolta, il morfo varia a seconda dei suoni adiacenti. In italiano, ad esempio, ci sono una serie di parole in cui il morfema della radice, pur essendo scritto sempre allo stesso modo, si pronuncia diversamente (ovvero, è realizzato da morfi diversi) al singolare e al plurale, ad esempio amic-o-amic-i, grec-o-grec-i, asparag-o-asparag-i. Queste differenze di pronuncia (che si rendono in linguistica con una trascrizione speciale, che sarà trattata nei materiali n. 4: ad esempio, [a mi:ko]- [a mi:ùi], [ gre:ko]-[ greùi], [as pa:rago]-[as pa:raãi]) sono dovute a delle differenze nelle proprietà dei due suoni -o ed -i che realizzano i morfemi di singolare e plurale. In altri casi, il morfo utilizzato per realizzare un morfema dipende dagli specifici morfemi lessicali con cui il morfema in questione si combina: In inglese, il morfema di participio passato è espresso da morfi diversi a seconda del verbo, ad esempio call-ed chiamare-past.ptcpl ma eat-en mangiare-past.ptcpl. Questo significa che il morfema di participio passato ha una forma diversa a seconda del tipo di verbo. In latino, il morfema di dativo plurale è espresso da morfi diversi a seconda del nome, ad esempio ros-is rosa-dat.pl ma orator-ibus oratore-dat.pl. Quando il significato di un morfema è reso da morfi diversi, si parla di allomorfi del morfema. Gli allomorfi sono cioè segmenti diversi utilizzati in contesti diversi per esprimere il significato del morfema. (14) Alcune precisazioni sulla nozione di morfema: Talvolta, singoli morfemi contengono più di un elemento di significato. Ad esempio, in latino, -is DAT.PL veicola sia il significato di dativo sia quello di plurale. Questo si deduce dal fatto che il morfema non è utilizzato per il dativo singolare (e quindi non si può dire che veicoli il solo significato di dativo), né per altre forme di caso al plurale (e quindi non si può dire che veicoli il solo significato di plurale). I morfemi non sono sempre realizzati da stringhe di suoni contigui. Ad esempio: Alcune lingue utilizzano circumfissi (cfr. (12)), il che vuol dire che il morfema è realizzato da due elementi distinti e non adiacenti. Le lingue del gruppo semitico (ad esempio, arabo ed ebraico) utilizzano i cosiddetti morfemi a pettine : all interno della parola, una specifica combinazione di consonanti veicola le informazioni lessicali (ad esempio il significato del verbo), e diverse combinazioni di consonanti 4
5 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a che vengono di volta in volta inserite all interno di tali consonanti per veicolare diverse informazioni grammaticali (ad esempio, per i verbi, diverse forme di tempo): (15). Un fenomeno analogo è quello dell apofonia vocalica in lingue come il greco o l inglese ((16)-(17)). (15) Arabo: kataba scrivere.perf.act / kutiba scrivere.perf.pass, halaqa radersi.perf.act / huliqa radersi.perf.pass, farada decidere.perf.act / furida decidere.perf.pass (Haspelmath 2002: 23) (16) Greco antico: leíp-ein lasciare-pres, lip-eîn lasciare-aor, le-loip-énai PERF-lasciare.PERF (17) Inglese: win vincere.pres / won vincere.past, strike colpire.pres / struck colpire.past, hang appendere.pres / hung appendere.past (18) Processi di formazione delle parole (ovvero, combinazione di più morfemi): Flessione: applicazione a dei morfemi lessicali di morfemi grammaticali che esprimono categorie obbligatorie per tutte le parole che fanno parte di una determinata classe, ad esempio caso o numero per i nomi, tempo o persona per i verbi (tabelle 1, 2). Derivazione: combinazione di morfemi lessicali e morfemi lessicali che porta alla formazione di nuove parole (tabella 3). Composizione: processi che portano alla formazione di nuove parole mediante l unione di parole già esistenti. ((21)). Verbo 1SG.PRES.IND Nome SG Nome PL frullo frullatore frullatori mangio mangiatore mangiatori guido guidatore guidatori sbatto sbattitore sbattitori ricevo ricevitore ricevitori trasmetto trasmettitore trasmettitori Tabella 3: Processi di derivazione in italiano 5
6 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a (19) Quali morfemi è possibile individuare nelle forme della tabella 3? Un morfema lessicale guid-, che ricorre in guidare, guidatore, guidatori. Un morfema lessicale sbatt-, che ricorre in sbattere, sbattitore, sbattitori. Un morfema lessicale ricev-, che ricorre in ricevere, ricevitore, ricevitori. Un morfema lessicale trasmett-, che ricorre in trasmettere, trasmettitore, trasmettitori. Due morfemi grammaticali -e ed -i che ricorrono rispettivamente in tutte le forme di singolare e plurale, e veicolano pertanto, presumibilmente, questi significati: si tratta di morfemi flessivi, perchè esprimono categorie obbligatorie per tutti i nomi dell italiano, appunto il singolare e il plurale. Due morfemi vuoti -a- e -i-, che sono sempre utilizzati nelle forme nominali (cfr. frull-a-tore e ricev-i-tore), e il cui uso dipende dal tipo di verbo (si tratta di morfemi vuoti, perchè segnalano appunto solo la classe di coniugazione del verbo). Un morfema grammaticale -tor-, che ricorre in tutte le forme nominali: si tratta di un morfema derivazionale, perchè crea un nuovo nome a partire da una radice verbale. (20) Alcune differenze tra flessione e derivazione: A differenza della flessione, la derivazione non si applica obbligatoriamente a tutte le parole che fanno parte di una determinata classe (ad esempio, in italiano * dormitore, * riditore, * sorseggiatore...). La flessione, quindi, è obbligatoria per tutte le parole di una determinata classe, ovvero è sempre produttiva, mentre la derivazione può avere produttività variabile (dove per produttività si intende il numero di basi cui si può applicare un determinato morfema in una lingua). Mentre i morfemi flessivi sono associati sempre allo stesso significato, solitamente relativamente astratto (singolare, plurale, imperfetto...), quelli derivazionali sono associati a variazioni di significato a seconda della base cui vengono applicati (ad esempio guidatore persona che guida ma frullatore strumento che frulla ), e veicolano significati più concreti. (21) Alcuni esempi di composizione in cinese mandarino (Anderson 1985: 43-52): Composti modificatore-modificato: niú-ròu mucca-carne: manzo [da mangiare], fēi-chuán volare-nave: dirigibile, xuě-bái neve-bianco: bianchissimo 6
7 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a Composti verbo-oggetto: dǒng-shi controllare-cose: membro del comitato Composti soggetto-predicato: tiān-liáng giorno-illumina: alba, zuǐ-shuō bocca-parlare: promettere a parole Composti coordinati: chē-ma veicolo-cavallo: traffico, hū-xi inspirare-espirare: respirare, dá-xiǎo grande-piccolo: dimensioni, héng-shú orizzontale-verticale: comunque (22) Struttura delle parole e corrispondente tipologia morfologica (Payne 1997: 26-7): Una classificazione basata sul numero di morfemi per parola: Tipo analitico o isolante: le parole consistono normalmente di un solo morfema ((23)) Tipo sintetico: le parole consistono normalmente di più di un morfema ((24)) Tipo polisintetico: le parole possono comprendere un numero molto elevato di morfemi ((25)) Una classificazione basata sul numero di elementi di significato espressi da un singolo morfo: Tipo fusivo/flessivo: un singolo morfo può esprimere simulaneamente molti elementi di significato (ad esempio italiano parl-o parl-1sg.pres.ind ), e i morfemi presentano tipicamente numerosi allomorfi. Tipo agglutinante: un singolo morfo esprime normalmente un solo elemento di significato (tabella 4), e i fenomeni di allomorfia sono limitati. Yoruba (nigero-congolese; Nigeria) (23) Nwȯn ó maa gbà nùn wǎ loro FUT PROG ricevere pó sterlina mé dieci ló settimana sò ò sè Riceveranno dieci sterline alla settimana (Haspelmath 2002: 4) Lezgiano (caucasico; Daghestan) (24) Marf-adi pioggia-erg wiči-n stesso-gen qualin denso st al-ra-ldi goccia-pl-strum quaw tetto gata-zwa-i colpire-impf-past La pioggia colpiva il tetto con le sue dense gocce (Haspelmath 2002: 5) Groenlandese occidentale (eskimo-aleutino; Groenlandia) 7
8 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a (25) Paasi-nngil-luinnar-para capire-non-completamente-1sg.sogg.3sg.ogg.ind ilaa-juma-sutit venire-volere-2sg.ptcpl Non avevo affatto capito che volevi venire (Haspelmath 2002: 5) Singolare Plurale accusativo el-i el-ler-i genitivo el-in el-ler-in locativo el-de el-ler-de ablativo el-den el-ler-den Tabella 4: Paradigma (parziale) della parola turca EL mano (Bauer 1992: 171). Abbreviazioni IMPF imperfetto POSS possessivo ACT attivo IND indicativo PRES presente AOR aoristo NEG negazione PROG progressivo CONC concessive OGG oggetto PTCPL participio ERG ergativo PAST passato SG singolare FUT futuro PAT paziente SOGG soggetto GEN genitivo PERF perfetto STRUM strumento Riferimenti bibliografici Anderson, S. R. (1985). Typological distinctions in word formation. In T. Shopen (Ed.), Language typology and syntactic description. Vol. III. Grammatical categories and the lexicon, pp Cambridge: Cambridge University Press. Bauer, L. (1992). Introducing linguistic morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press. Haspelmath, M. (2002). Understanding Morphology. London: Arnold. Matthews, P. H. (1979). Morfologia. Bologna: Il Mulino. Payne, T. E. (1997). Describing morphosyntax. Cambridge: Cambridge University Press. 8
3 Morfologia: nozioni generali
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2016-17 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979: capp.2, 3, 5, 6, 7, Bauer 1992: capp. 2, 3, 5, 6, Haspelmath 2002:
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2016-17 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979: capp.2, 3, 5, 6, 7, Bauer 1992: capp. 2, 3, 5, 6, Haspelmath 2002:
3 Morfologia: nozioni generali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979, Bauer 1992, Haspelmath 2002 (solo per quanto riguarda gli argomenti
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979, Bauer 1992, Haspelmath 2002 (solo per quanto riguarda gli argomenti
3 Morfologia: nozioni generali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2012-13 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979: capp.2, 3, 5, 6, 7, Bauer 1992: capp. 2, 3, 5, 6, Haspelmath 2002:
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2012-13 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979: capp.2, 3, 5, 6, 7, Bauer 1992: capp. 2, 3, 5, 6, Haspelmath 2002:
3 Morfologia: nozioni generali
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979: capp.2, 3, 5, 6, 7, Bauer 1992: capp. 2, 3, 5, 6, Haspelmath 2002:
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979: capp.2, 3, 5, 6, 7, Bauer 1992: capp. 2, 3, 5, 6, Haspelmath 2002:
3 Morfologia: nozioni generali
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2008-9 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979, Bauer 1992, Haspelmath 2002 (solo per quanto riguarda gli argomenti
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2008-9 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979, Bauer 1992, Haspelmath 2002 (solo per quanto riguarda gli argomenti
3 Morfologia: nozioni generali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2011-12 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979, Bauer 1992, Haspelmath 2002 (solo per quanto riguarda gli argomenti
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2011-12 1 3 Morfologia: nozioni generali [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1979, Bauer 1992, Haspelmath 2002 (solo per quanto riguarda gli argomenti
5 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
1 Introduzione: la comparazione interlinguistica
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: la comparazione interlinguistica Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: la comparazione interlinguistica Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio
5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2014-15 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2014-15 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
3. La classificazione tipologica
 3. La classificazione tipologica Due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate
3. La classificazione tipologica Due lingue sono tipologicamente correlate se manifestano una o più caratteristiche comuni questa correlazione è indipendente dal fatto che tali lingue siano apparentate
5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2013-14 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2013-14 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
9 L origine delle categorie grammaticali: tempo e aspetto
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2008-9 1 9 L origine delle categorie grammaticali: tempo e aspetto [Manuali di riferimento per questa parte: Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: capp. 5 e 6 (le parti
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2008-9 1 9 L origine delle categorie grammaticali: tempo e aspetto [Manuali di riferimento per questa parte: Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: capp. 5 e 6 (le parti
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO. Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto. Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia
 PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO Docenti Prof. Emanuele Banfi / Prof. Ignazio Mauro Mirto Insegnamento LINGUISTICA GENERALE Modulo 1 Elementi di Fonetica e Fonologia 1.1. Alfabeti e corrispondenza biunivoca;
3 L origine delle categorie grammaticali: ancora tempo e aspetto
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 3 L origine delle categorie grammaticali: ancora tempo e aspetto (1) Alcuni tipi di nozioni di tempo e aspetto (Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: 125-;
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 3 L origine delle categorie grammaticali: ancora tempo e aspetto (1) Alcuni tipi di nozioni di tempo e aspetto (Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: 125-;
Un ulteriore fenomeno (che non si vede in (2), ma cfr. (5)):
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2011-12 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2011-12 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
6 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica
 6 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi (nonchè avverbi, adposizioni ecc.) (2) I criteri tradizionali
6 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi (nonchè avverbi, adposizioni ecc.) (2) I criteri tradizionali
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
mí 1SG ART nù acqua interno ART
 Sonia Cristofaro - Glottologia a.a. 2011-12 1 Esercizi - 4 (1) Sapendo che le lingue in (2)-(4) appartengono tutte alla stessa famiglia, e i verbi negli esempi (2) e (3) sono connessi con il morfema kè
Sonia Cristofaro - Glottologia a.a. 2011-12 1 Esercizi - 4 (1) Sapendo che le lingue in (2)-(4) appartengono tutte alla stessa famiglia, e i verbi negli esempi (2) e (3) sono connessi con il morfema kè
NUOVI ITINERARI. Sommario. Premessa
 NUOVI ITINERARI V Sommario Premessa XI Prima unità Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 3 1.1 Vocali 5 1.2 Consonanti 8 1.3 Aspirazione 10 1.4 Il sistema di accentazione 12 1.5 Proclitiche ed enclitiche.
NUOVI ITINERARI V Sommario Premessa XI Prima unità Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 3 1.1 Vocali 5 1.2 Consonanti 8 1.3 Aspirazione 10 1.4 Il sistema di accentazione 12 1.5 Proclitiche ed enclitiche.
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
376 Introduzione alla lingua di Roma nel Duecento
 INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
Indice. Introduzione. Unità I. Unità 2. Unità Unità Unità Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica
 Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
2. Fondamenta della linguistica storica. 2b. Morfologia
 2. Fondamenta della linguistica storica 2b. Morfologia Ricostruire la morfologia indoeuropea: non sempre aiutano le categorie di grammatica latina (parti del discorso, declinazioni, coniugazioni). La morfologia
2. Fondamenta della linguistica storica 2b. Morfologia Ricostruire la morfologia indoeuropea: non sempre aiutano le categorie di grammatica latina (parti del discorso, declinazioni, coniugazioni). La morfologia
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I B A S I L A R I 3
 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I B A S I L A R I 3 Introduzione: classificazione 1 2 Un primo criterio classificatorio potrebbe essere proprio quello del numero dei parlanti
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I B A S I L A R I 3 Introduzione: classificazione 1 2 Un primo criterio classificatorio potrebbe essere proprio quello del numero dei parlanti
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO CLASSE I SEZ. A. MATERIA: Lingua e cultura latina. PROF. SSA Silvia Forti
 PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017 2018 CLASSE I SEZ. A MATERIA: Lingua e PROF. SSA Silvia Forti (da allegare al registro personale) LIVELLI DI PARTENZA (Caratteristiche della classe, preparazione di
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017 2018 CLASSE I SEZ. A MATERIA: Lingua e PROF. SSA Silvia Forti (da allegare al registro personale) LIVELLI DI PARTENZA (Caratteristiche della classe, preparazione di
Livelli di analisi: Elementi di morfologia
 Livelli di analisi: Elementi di morfologia morfologia >si riferisce allo studio della forma. Biologia: lo studio di forme e strutture interne di piante e animali. MORFOLOGIA< ted. morphologie ( Goethe
Livelli di analisi: Elementi di morfologia morfologia >si riferisce allo studio della forma. Biologia: lo studio di forme e strutture interne di piante e animali. MORFOLOGIA< ted. morphologie ( Goethe
3 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2017-18 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente e motivata
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2017-18 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente e motivata
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO
 LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
LINGUA E CULTURA GRECA PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV B ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Libro di testo: P. Agazzi, M. Villardo Ellenistì, Corso di lingua e cultura greca, Manuale ed Esercizi vol.1, Zanichelli 2014,
Saussure ( ) 1913)
 Broca e Wernicke Saussure (1857-1913) 1913) Cours de linguistique générale (1916) Circuito della parola Segno linguistico Segno linguistico Segno linguistico Louis Hjelmslev (1899-1965) Funzione segnica
Broca e Wernicke Saussure (1857-1913) 1913) Cours de linguistique générale (1916) Circuito della parola Segno linguistico Segno linguistico Segno linguistico Louis Hjelmslev (1899-1965) Funzione segnica
Il verbo che cos'è. Il verbo è la parte del discorso più importante.
 IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
Categorie grammaticali = tratti morfosintattici + tratti morfosemantici + tratti morfologici
 1) Il verbo Le categorie morfologiche del verbo (categorie grammaticali, paradigmi, coniugazioni, classi regolari, sottoregolari, irregolari, allomorfie ecc.) Il verbo = la parte del discorso (estremamente)
1) Il verbo Le categorie morfologiche del verbo (categorie grammaticali, paradigmi, coniugazioni, classi regolari, sottoregolari, irregolari, allomorfie ecc.) Il verbo = la parte del discorso (estremamente)
Il verbo che cos'è. Il verbo è la parte del discorso più importante.
 IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
INDICE GENERALE Capitolo 1 - preliminari... 3 Capitolo 2 - Morfologia: preliminari... 12
 INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
Singolare Plurale. Even (ugro-finnico, Russia centrale): declinazione del nome ǰuu casa
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2013-14 1 Esercizi - 1 (1) La tabella che segue riporta alcune forme di caso per i due sostantivi pesce e donna in kayardild (australiano). Cosa si può dire circa tali
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2013-14 1 Esercizi - 1 (1) La tabella che segue riporta alcune forme di caso per i due sostantivi pesce e donna in kayardild (australiano). Cosa si può dire circa tali
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
LE CONIUGAZIONI E LE DECLINAZIONI
 LATINO LEZIONE 3 LE CONIUGAZIONI E LE DECLINAZIONI Abbiamo visto che NOMI e VERBI sono composti di 2 parti: TEMA e DESINENZA ES. LUP US MONE - O TEMA DESINENZA TEMA DESINENZA IL TEMA esprime il SIGNIFICATO
LATINO LEZIONE 3 LE CONIUGAZIONI E LE DECLINAZIONI Abbiamo visto che NOMI e VERBI sono composti di 2 parti: TEMA e DESINENZA ES. LUP US MONE - O TEMA DESINENZA TEMA DESINENZA IL TEMA esprime il SIGNIFICATO
Linguistica generale. a.a Federica Da Milano
 Linguistica generale a.a. 2014-2015 Federica Da Milano Morfologia Studio della struttura interna delle parole Definizione di parola Unità del linguaggio umano istintivamente presente alla consapevolezza
Linguistica generale a.a. 2014-2015 Federica Da Milano Morfologia Studio della struttura interna delle parole Definizione di parola Unità del linguaggio umano istintivamente presente alla consapevolezza
Criteri per la definizione della parola grammaticale
 Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
Criteri per la definizione della parola grammaticale Una parola grammaticale (morfo-sintattica, non fonologica) è definita in base alla co-occorrenza dei seguenti criteri: a) COESIONE: si definisce parola
OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO
 DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO ITALIANO CLASSE IV GINNASIALE 1. Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 2. Comprendere il senso globale di un testo narrativo poetico.
DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, LATINO E GRECO AL GINNASIO ITALIANO CLASSE IV GINNASIALE 1. Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 2. Comprendere il senso globale di un testo narrativo poetico.
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
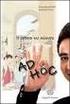 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO greco classico biennio
 OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO greco classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO greco classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
LE PARTI DEL DISCORSO =
 LATINO LEZIONE 1 LE PARTI DEL DISCORSO = LE CATEGORIE IN CUI SONO RAGGRUPPATE LE PAROLE DI UNA LINGUA SULLA BASE DI CARATTERISTICHE COMUNI (forma, funzione, posizione nella frase, significato ecc.) Confrontiamo
LATINO LEZIONE 1 LE PARTI DEL DISCORSO = LE CATEGORIE IN CUI SONO RAGGRUPPATE LE PAROLE DI UNA LINGUA SULLA BASE DI CARATTERISTICHE COMUNI (forma, funzione, posizione nella frase, significato ecc.) Confrontiamo
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO
 Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
Linguistica Generale prof. dr. Giorgio Francesco Arcodia MOCK TEST - SOLUZIONI IN FONDO 1) Definire ed illustrare con esempi la nozione di ricorsività : 2) Identificare e descrivere i morfemi contenuti
INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE
 INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
GdS Istituzioni di Linguistica MORFOLOGIA
 GdS Istituzioni di Linguistica MORFOLOGIA COSA STUDIA LA MORFOLOGIA? L'oggetto di studio della morfologia è la parola, poi ulteriormente scomposta in unità più piccole ma sempre dotate di significato.
GdS Istituzioni di Linguistica MORFOLOGIA COSA STUDIA LA MORFOLOGIA? L'oggetto di studio della morfologia è la parola, poi ulteriormente scomposta in unità più piccole ma sempre dotate di significato.
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari. Programma di Latino
 IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO MATERIA: latino ANNO SCOLASTICO 2012-2013 PROF. Maria Nivea Armellin
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO MATERIA: latino ANNO SCOLASTICO 2012-2013 PROF. Maria Nivea Armellin
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO latino classico biennio
 OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO latino classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO latino classico biennio Competenze chiave di Cittadinanza Competenze generali di Asse Linguaggi (dalle Indicazioni Nazionali e dagli Assi Culturali)
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE
 REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE e I.P.S.S.E.O.A. - CEFALU Via Maestro Vincenzo Pintorno 27 - e-mail: PAIS00200N@istruzione.it
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MANDRALISCA LICEO GINNASIO STATALE e I.P.S.S.E.O.A. - CEFALU Via Maestro Vincenzo Pintorno 27 - e-mail: PAIS00200N@istruzione.it
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica. La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio. L articolo
 Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
PIANO DI LAVORO ANNUALE
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Via Ada Negri, 14 10024 MONCALIERI (TO) Codice fiscale 84511990016 Sezione Liceale E.Majorana Sezione Tecnico Economica Scientifico - Linguistico A.Marro Via Ada
Esercizi-2. Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2013-14 1 Esercizi-2 (1) In swahili, un elevato numero di nomi forma il singolare e il plurale aggiungendo alla radice della parola, rispettivamente, i due prefissi
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2013-14 1 Esercizi-2 (1) In swahili, un elevato numero di nomi forma il singolare e il plurale aggiungendo alla radice della parola, rispettivamente, i due prefissi
Contenuti disciplinari (la scelta è in relazione ai bisogni della classe e in riferimento al documento di Dipartimento)
 Data 15-10-2015 DOCENTE: PROF: GHISELLI GUIDO CLASSE 1..SEZ ASU..LICEO: SCIENZE UMANE. DISCIPLINA: ITALIANO. Contenuti disciplinari (la scelta è in relazione ai bisogni della classe e in riferimento al
Data 15-10-2015 DOCENTE: PROF: GHISELLI GUIDO CLASSE 1..SEZ ASU..LICEO: SCIENZE UMANE. DISCIPLINA: ITALIANO. Contenuti disciplinari (la scelta è in relazione ai bisogni della classe e in riferimento al
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: LATINO Prof. SANTOMAURO TERESA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA DIDATTICHE/MODULI
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: LATINO Prof. SANTOMAURO TERESA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA DIDATTICHE/MODULI
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2012-13 1 Esercizi -1 (1) Le frasi in (2)-(6) illustrano i tipi linguistici attestati nelle lingue del mondo per cio che riguarda l accordo verbale. A partire
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2012-13 1 Esercizi -1 (1) Le frasi in (2)-(6) illustrano i tipi linguistici attestati nelle lingue del mondo per cio che riguarda l accordo verbale. A partire
5 L ordine delle parole
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 5 L ordine delle parole (1) Il punto di partenza: Le lingue del mondo presentano ordini delle parole diversi all interno di varie costruzioni (cfr.
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 5 L ordine delle parole (1) Il punto di partenza: Le lingue del mondo presentano ordini delle parole diversi all interno di varie costruzioni (cfr.
PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI LAVORO ESTIVO. a. s CLASSE: I A. Insegnante: Daniela Saracco. Disciplina: Latino
 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI LAVORO ESTIVO a. s. 2017-2018 CLASSE: I A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO 1. Segni e suoni 1.1. Vocali e dittonghi 1.2. Come si legge il latino
PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI LAVORO ESTIVO a. s. 2017-2018 CLASSE: I A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO 1. Segni e suoni 1.1. Vocali e dittonghi 1.2. Come si legge il latino
PROGRAMMA DI GRECO. ANNO SCOLASTICO
 GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
La Lingua dei Segni Italiana La comunicazione visivo-gestuale dei sordi Aspetti morfo-sintattici pp
 Tratti di morfologia lessicale e flessiva della LIS Le classi dei nomi e dei verbi Indagini su coppie nome-verbo semanticamente correlati Distinzioni tra nomi e verbi non marcate morfologicamente: - nomi
Tratti di morfologia lessicale e flessiva della LIS Le classi dei nomi e dei verbi Indagini su coppie nome-verbo semanticamente correlati Distinzioni tra nomi e verbi non marcate morfologicamente: - nomi
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
Materia: LATINO. Classe I sez. A. Liceo Scientifico. Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto
 Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSE I SEZ. A CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Prof.ssa Carmen Santarsiero SEZIONE 1 - UNITA 1 1.1 Vocali
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSE I SEZ. A CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Prof.ssa Carmen Santarsiero SEZIONE 1 - UNITA 1 1.1 Vocali
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
Percorso formativo disciplinare Disciplina: LATINO PLUS. Anno scolastico 2017/2018 Prof.ssa Ilaria Sebastiani
 Percorso formativo disciplinare Disciplina: LATINO PLUS CLASSE 1 M LICEO MUSICALE Anno scolastico 2017/2018 Prof.ssa Ilaria Sebastiani LIBRO DI TESTO Hans H. Ørberg Lingua latina per se illustrata Pars
Percorso formativo disciplinare Disciplina: LATINO PLUS CLASSE 1 M LICEO MUSICALE Anno scolastico 2017/2018 Prof.ssa Ilaria Sebastiani LIBRO DI TESTO Hans H. Ørberg Lingua latina per se illustrata Pars
Il participio. In italiano. Il participio. Il participio presente. Il participio perfetto. Verifica sommativa. Lessico
 Il participio Il participio In italiano Il participio Il participio presente Il participio perfetto Verifica sommativa Lessico In italiano Il participio è un modo indefinito e pertanto non fornisce indicazioni
Il participio Il participio In italiano Il participio Il participio presente Il participio perfetto Verifica sommativa Lessico In italiano Il participio è un modo indefinito e pertanto non fornisce indicazioni
ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1. Francesca Forza - Linguistica Generale 2
 ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE 1 Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1 Perché? Parole complesse: struttura interna. rappresentare tale struttura in modi espliciti e non ambigui. La struttura che
ANALISI DELLE PAROLE COMPLESSE 1 Q U E S T I O N I D I M E T O D O P A R T E 1 Perché? Parole complesse: struttura interna. rappresentare tale struttura in modi espliciti e non ambigui. La struttura che
6 Le relazioni grammaticali
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 6 Le relazioni grammaticali (1) Relazioni grammaticali: classe di elementi che si trovano tutti nella stessa relazione rispetto al verbo della frase e alla
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 6 Le relazioni grammaticali (1) Relazioni grammaticali: classe di elementi che si trovano tutti nella stessa relazione rispetto al verbo della frase e alla
Cenni di tipologia morfologica
 Linguistica Generale (cod. 24169), Modulo 1 - a.a. 2017-18 Materiale 3 Prof.ssa Federica Guerini Cenni di tipologia morfologica (1) Tipo morfologico nozione tradizionale elaborata nell 800; le lingue variano
Linguistica Generale (cod. 24169), Modulo 1 - a.a. 2017-18 Materiale 3 Prof.ssa Federica Guerini Cenni di tipologia morfologica (1) Tipo morfologico nozione tradizionale elaborata nell 800; le lingue variano
a. s CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013
 ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
ISIS VINCENZO MANZINI PIANO DI LAVORO ANNUALE CLASSE : 1 A LL DISCIPLINA : LATINO DOCENTE : TIZIANA COMINOTTO ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013 Situazione della classe. La classe 1^ALL è formata da 22 allievi,
4 Le relazioni grammaticali: criteri di definizione e problemi
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2009-10 1 4 Le relazioni grammaticali: criteri di definizione e problemi 4.1 Introduzione (1) La classificazione tradizionale delle relazioni grammaticali:
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2009-10 1 4 Le relazioni grammaticali: criteri di definizione e problemi 4.1 Introduzione (1) La classificazione tradizionale delle relazioni grammaticali:
Classificazione dei vrebi in base alla valenza: - avalenti o zerovalenti > nessun argomento es. piove, nevica
 I verbi Valenza verbale: indica il numero di elementi che devono obbligatoriamente accompagnare il verbo. Questi gruppi nominali sono detti argomenti. Gli altri elementi non obbligatori che occorrono in
I verbi Valenza verbale: indica il numero di elementi che devono obbligatoriamente accompagnare il verbo. Questi gruppi nominali sono detti argomenti. Gli altri elementi non obbligatori che occorrono in
Esercizi di morfologia e lessico (SOLUZIONI IN FONDO)
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2012 / 2013 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di morfologia e lessico (SOLUZIONI IN FONDO)
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2012 / 2013 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di morfologia e lessico (SOLUZIONI IN FONDO)
DIPARTIMENTO LETTERE CLASSICO LINGUISTICO DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico)
 Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico)
 3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo
3. La classificazione tipologica (la nozione di tipo linguistico) La tipologia linguistica si occupa essenzialmente dello studio della variazione interlinguistica Due condizioni: 1) le lingue del mondo
Flessione inerente: realizzazione dei valori di categorie grammaticali associate al lessema.
 Flessione inerente: realizzazione dei valori di categorie grammaticali associate al lessema. Esprime un valore di una certa categoria grammaticale senza che esso dipenda da qualcosa di esterno al lessema
Flessione inerente: realizzazione dei valori di categorie grammaticali associate al lessema. Esprime un valore di una certa categoria grammaticale senza che esso dipenda da qualcosa di esterno al lessema
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Greco Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Greco Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente, beneficiario, strumento, ecc.
 Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Indice. Premessa. Abbreviazioni
 Indice Premessa IV Abbreviazioni VI 1. Antroponimia germanica 1 1.1. Classificazione tipologica 1 1.1.1. Antroponimi composti 1 1.1.2. Antroponimi monotematici 2 1.1.3. Antroponimi derivazionali 3 1.2.
Indice Premessa IV Abbreviazioni VI 1. Antroponimia germanica 1 1.1. Classificazione tipologica 1 1.1.1. Antroponimi composti 1 1.1.2. Antroponimi monotematici 2 1.1.3. Antroponimi derivazionali 3 1.2.
Esercizi -1. Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2008-9 1 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2008-9 2 Lingua Soggetto Oggetto Roviana X X Kera X - Gallese - - Tabella 1: Distribuzione delle
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2008-9 1 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2008-9 2 Lingua Soggetto Oggetto Roviana X X Kera X - Gallese - - Tabella 1: Distribuzione delle
Domande relative a Glottologia a.a
 Prof.ssa Paola Cotticelli Domande relative a Glottologia a.a. 2005-2006 CONCETTI INTRODUTTIVI Che cosa si intende per indoeuropeo? Quali sono le concezioni interpretative relative ad esso? Quando e dove
Prof.ssa Paola Cotticelli Domande relative a Glottologia a.a. 2005-2006 CONCETTI INTRODUTTIVI Che cosa si intende per indoeuropeo? Quali sono le concezioni interpretative relative ad esso? Quando e dove
nerede? dove? Dove sono le mie due valigie? (Moravcsik 2006: xii) (b) Iki due
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2012-13 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2012-13 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE LM. Elena Nuzzo
 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE LM Elena Nuzzo Limiti delle sequenze acquisizionali Due problemi fondamentali per l insegnante: 1. Le sequenze riguardano pochi fenomeni. 2. Le esigenze didattiche possono
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE LM Elena Nuzzo Limiti delle sequenze acquisizionali Due problemi fondamentali per l insegnante: 1. Le sequenze riguardano pochi fenomeni. 2. Le esigenze didattiche possono
Esercizi di morfologia e lessico (SOLUZIONI IN FONDO)
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di morfologia e lessico (SOLUZIONI IN FONDO)
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di morfologia e lessico (SOLUZIONI IN FONDO)
Istituto Maria Agostina Scuola Primaria Parificata Paritaria
 Istituto Maria Agostina Scuola Primaria Parificata Paritaria Laboratorio di latino Classi IV A IV B V A V B ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Presentazione Il progetto-laboratorio Alla ricerca delle origini dell
Istituto Maria Agostina Scuola Primaria Parificata Paritaria Laboratorio di latino Classi IV A IV B V A V B ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Presentazione Il progetto-laboratorio Alla ricerca delle origini dell
