TELETRASPORTO QUANTISTICO. Che cosa è il Teletrasporto Quantistico? Qubit e Computer quantistici
|
|
|
- Federigo Nicola Fiori
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TELETRASPORTO QUANTISTICO Che cosa è il Teletrasporto Quantistico? Qubit e Computer quantistici
2 TAVOLA DEI CONTENUTI La teoria Introduzione al Teletrasporto Quantistico La comunicazione quantistica Storia, applicazioni, approfondimenti ritorno all introduzione
3 COSA E'IL TELETRASPORTO QUANTISTICO? Prima di dare una completa definizione è necessario sottolineare che si tratta di una tecnica di comunicazione che sfrutta alcuni aspetti peculiari della Meccanica Quantistica ossia quella teoria fisica che descrive il comportamento della radiazione elettromagnetica, della materia e delle loro interazioni, con particolare riguardo ai fenomeni che interessano le scale di lunghezze o di energie atomiche e subatomiche.
4 Sviluppo della Meccanica Quantistica Lo sviluppo della meccanica quantistica risale alla prima metà del XX secolo, data l'inconsistenza e l'impossibilità della meccanica classica di rappresentare la realtà sperimentale, con particolare riferimento alla luce e all'elettrone. Il nome Meccanica Quantistica", fu introdotto da Max Planck agli inizi del Novecento. Essa si basa sul fatto che quantità come: energia o momento angolare, di alcuni sistemi fisici, possono variare in maniera discreta ossia assumendo soltanto determinati valori detti: "QUANTI".
5 La caratteristica fondamentale che contraddistingue la meccanica quantistica dalla meccanica classica è che: in meccanica quantistica la radiazione elettromagnetica e la materia vengono entrambe descritte sia come un fenomeno ondulatorio che, allo stesso tempo, come entità particellari, al contrario della meccanica classica dove, per esempio, la luce è descritta solo come un'onda o l'elettrone solo come una particella. Questa inaspettata e contro intuitiva proprietà chiamata: dualismo onda-corpuscolo è la principale ragione del fallimento di tutte le teorie classiche sviluppate fino al XIX secolo.
6 ALCUNE SITUAZIONI SPERIMENTALI IN CUI LA FISICA CLASSICA" FALLISCE: Radiazione di corpo nero Effetto fotoelettrico Linee spettrali atomiche Proprietà ondulatorie degli elettroni LA MECCANICA QUANTISTICA FORNISCE LE SOLUZIONI CON: Teoria di Planck dell'irraggiamento di un corpo nero Spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico Modello di Bohr dell'atomo di idrogeno Lunghezza d'onda di Louis de Broglie
7 Max Planck trovò che l'energia della radiazione emessa o assorbita da un corpo nero non fosse emessa e assorbita con continuità ma in quantità discrete o quanti. Il concetto fondamentale della sua teoria si basava sul fatto che: ogni oscillatore elementare (gli elettroni all'interno dell'atomo) potesse scambiare energia con l ambiente solo in forma di pacchetti di grandezza E=hʋ dove: h = 6, J s = 6,63 x erg s ʋ è la frequenza dell'oscillatore. è la costante di Planck Albert Einstein riconobbe per primo che questa quantizzazione dell'energia della radiazione emessa o assorbita è una proprietà generale della radiazione elettromagnetica, pensando ad essa come ad un insieme di fotoni di energia E=hʋ. Niels Bohr applicò le idee di Einstein, relative alla quantizzazione dell'energia, all'energia di un atomo e propose un modello dell'atomo di idrogeno che ebbe un successo spettacolare nei calcoli delle lunghezze d'onda della radiazione emessa dall'idrogeno.
8 Dualismo onda corpuscolo NATURA ONDULATORIA E CORPUSCOLARE DELLA LUCE Schema riassuntivo La luce consiste di particelle o di onde? La risposta dipende dal tipo di fenomeno osservato.
9 I più comuni fenomeni luminosi osservati, come: riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione possono essere spiegati come fenomeni ondulatori. Tuttavia la luce, che di solito immaginiamo come un'onda, mostra anche proprietà corpuscolari quando interagisce con la materia come dimostrato da: effetto fotoelettrico e diffusione Compton. Lo stesso dualismo onda- particella vale anche per gli elettroni.
10 Dualismo onda corpuscolo NATURA ONDULATORIA DELLA MATERIA Gli elettroni (e la materia in generale), che di solito pensiamo come particelle, presentano anche le proprietà ondulatorie di interferenza e di diffrazione.
11 Fu Louis de Broglie nel 1924 a sostenere che le particelle si dovessero tutte considerare in possesso di proprietà ondulatorie. Egli giunse a suggerire che la lunghezza d onda associata all onda di materia fosse inversamente proporzionale alla massa m della particella ed alla sua velocità v, sicché: dove h è la costante di Planck. mv Il prodotto della massa per la velocità prende il nome di quantità di moto p della particella, per cui la precedente equazione si può riformulare come relazione di de Broglie nel modo seguente: h h p
12 Il carattere ondulatorio degli elettroni fu messo in evidenza dimostrando che i fasci elettronici possono essere diffratti. L esperimento fu effettuato per la prima volta nel 1925 da due scienziati americani, Clinton Davisson e Lester Germer, i quali inviarono un fascio di elettroni veloci contro un cristallo isolato di nichel. La disposizione regolare degli atomi all interno del cristallo agisce come un reticolo, capace di diffrangere le onde. Quello che si osservò fu perciò un immagine di diffrazione. G.P.Thomson, nel 1927, operando ad Aberdeen in Scozia, dimostrò che un fascio di elettroni produceva un immagine di diffrazione attraversando anche una lamina sottile d oro, come mostrato in figura:
13 Anche l'elettrone, come il fotone, rivela dunque una doppia faccia. Esso non è una tranquilla particella classica, ma può avere comportamenti ondulatori rilevabili La lunghezza d'onda ad esso associata è inversamente proporzionale alla sua quantità di moto.
14 La relazione di de Broglie è valida anche per i fotoni: λ = c/ν = hc/hν = hc/e = h/(e/c) = h/p La quantità di moto di un fotone è legata difatti alla sua energia dalla relazione: p = E/c.
15 CONCLUSIONE Si può concludere dicendo che tutti i portatori di quantità di moto e di energia: elettroni, atomi, luce, suono e così via, hanno entrambe le caratteristiche, quella corpuscolare e quella ondulatoria. ritorno alla tavola dei contenuti
16 MECCANICA CLASSICA E MECCANICA QUANTISTICA A CONFRONTO La meccanica classica è una teoria fisica di natura deterministica. Vige il principio di causalità. La meccanica quantistica è una teoria fisica di natura probabilistica. Si basa sul concetto di probabilità ed osservazione.
17 Sostanzialmente: secondo la meccanica classica, grazie alle scoperte di Newton e Galileo Galilei, se si conoscono le proprietà di un corpo (massa, forma, etc.), le sue condizioni iniziali di moto (posizione, velocità, etc.) e le condizioni esterne (campi di forze, etc.), è possibile determinare, in modo esatto, il suo comportamento istante per istante. Nell'ambito della meccanica classica vige dunque il principio di causalità, ossia in natura nulla avviene a caso, ogni evento è determinato da una causa ben precisa. La meccanica quantistica è invece di carattere indeterministico, ossia essa si basa sul concetto di probabilità ed osservazione. Se, per esempio, si vuole sapere con precisione la posizione di un elettrone in un atomo, non ne potremo mai conoscere la velocità e viceversa.
18 Il famoso esempio del gatto di Schrödinger chiarisce il carattere della meccanica quantistica.
19 In questo esempio un gatto è chiuso in una scatola, con un macchinario collegato ad una boccetta contenente del veleno. Il macchinario si avvia quando un elemento radioattivo decade, rompendo la boccetta di veleno. Dall esterno, il gatto, dentro la scatola, può essere vivo o morto, in quanto non si sa se l elemento radioattivo sia decaduto oppure no. Per la meccanica quantistica, il gatto è sia vivo che morto, si dice che è in una sovrapposizione di stati: stato vivo e stato morto. Soltanto la fase di osservazione congela lo stato del gatto, determinandone la sorte.
20 Per poter parlare di Teletrasporto Quantistico è necessario prendere in considerazione la natura ondulatoria e quella corpuscolare della radiazione elettromagnetica e della materia. Ossia far riferimento al: dualismo onda - corpuscolo sia per la luce che per la materia. A mettere in relazione la natura ondulatoria e quella corpuscolare delle particelle è il Principio di Indeterminazione di Heisenberg
21 Formulato dallo scienziato tedesco Werner Heisenberg nel 1927, tale principio asserisce che: Se l incertezza Δx sulla posizione x di una particella ha un valore molto ridotto, l incertezza Δp sulla quantità di moto p risulta elevata e viceversa. Rappresentazione del Principio di Indeterminazione di Heisenberg: a) b) a) La posizione x della particella è mal definita e ciò permette di specificare la sua quantità di moto p, rappresentata dalla freccia, con accettabile precisione. b) La posizione x della particella è ben definita e ciò impedisce di specificare con precisione la sua quantità di moto p.
22 Espressione matematica del principio: Δx Δp h/4π oppure: Δx Δp ћ/2 Secondo il Principio di Indeterminazione di Heisenberg quindi: è impossibile conoscere simultaneamente e con precisione la quantità di moto e la posizione di una particella.
23 La stessa indeterminazione lega la misura simultanea dell'energia E e del tempo t: ΔE Δt ћ/2 il che significa che: in un tempo molto breve l'energia non è definita.
24 In altre parole: il prodotto delle incertezze di due misure simultanee non può essere minore di un dato valore costante. ritorno alla tavola dei contenuti
25 Comunicazione quantistica Il teletrasporto quantistico prevede che sia possibile trasferire lo stato quantico di una particella (per esempio, lo stato di polarizzazione se si tratta di un fotone) a grandi distanze. Non è la particella in sé ad essere trasferita ma quella ricevente acquisisce esattamente lo stesso stato di polarizzazione di quella trasmittente. Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg vieta di conoscere con esattezza lo stato del fotone trasmesso, ma una proprietà detta correlazione non locale (in inglese: entanglement ) fa sì che questo non sia un problema per il teletrasporto.
26 IL TELETRASPORTO ALLA STAR TREK PREVEDE: la scomparsa di un oggetto da una posizione e la simultanea ricomparsa del medesimo oggetto in un'altra posizione dello spazio, senza dover percorrere noiosi chilometri intermedi e senza l'utilizzo di alcun veicolo.
27 Nelle storie di fantascienza Il teletrasporto consente di effettuare viaggi, senza alcun dubbio, più comodi rispetto a quelli effettuati con un ordinario veicolo spaziale, ma ciò comporta la violazione dei limiti di velocità imposti dalla teoria della relatività, secondo cui nulla può viaggiare più velocemente della luce. Nella fantascienza la procedura di teletrasporto varia da storia a storia ed in generale si svolge nel modo seguente: l'oggetto originale da teletrasportare viene sottoposto ad una scansione per estrarre le informazioni necessarie a descriverlo. Un trasmettitore trasferisce le informazioni ad una stazione ricevente che le utilizza per ottenere una replica esatta dell'originale. In alcuni casi, alla stazione ricevente, viene trasferita anche la materia che compone l'originale, sotto forma di qualche tipo di energia. In altri casi invece la replica dell'originale usa atomi e molecole già presenti nel luogo di arrivo.
28 Secondo la meccanica quantistica, un simile teletrasporto è impossibile anche in linea teorica difatti: il Principio di Indeterminazione di Heisenberg dichiara l'impossibilità di conoscere nello stesso momento, con precisione arbitraria, la posizione e la velocità di una particella. Una perfetta scansione dell'oggetto da teletrasportare implica la conoscenza, senza incertezze, della posizione e della velocità di ciascun atomo e di ciascun elettrone, quindi il teletrasporto è impossibile. Il Principio di Heisenberg inoltre si applica anche ad altre coppie di grandezze e ciò esprime l'impossibilità di misurare senza errore lo stato quantico di un oggetto. Tutte queste difficoltà, in Star Trek, sono superate dal prodigioso compensatore di Heisenberg".
29 MA Il sogno fantascientifico di proiettare oggetti da un luogo all'altro, oggi è una realtà, almeno per particelle di luce: i fotoni sebbene per gli oggetti macroscopici resti, per ora, ancora una fantasia.
30 IL TELETRASPORTO QUANTISTICO Definizione: Esso è una tecnica di comunicazione nell'ambito della Informatica Quantistica insieme di tecniche di calcolo e loro studio che utilizzano i QUANTI per memorizzare ed elaborare le informazioni. La tecnica del Teletrasporto Quantistico permette, sotto certe restrizioni, di: trasferire uno stato quantico ossia lo stato di polarizzazione dei fotoni, lo stato di spin degli elettroni o lo stato di eccitazione degli atomi, in un punto arbitrariamente lontano. L'effetto coinvolto è: L'ENTANGLEMENT QUANTISTICO
31 Si può dire che: con il Teletrasporto Quantistico non si ha un trasferimento alla Star Trek, ma è possibile, attraverso il fenomeno dell entanglement trasferire (istantaneamente) le caratteristiche (stati quantici) di fotoni, atomi, ioni, in altri fotoni, atomi, ioni posti a qualsiasi distanza.
32 L'ENTANGLEMENT QUANTISTICO L'entanglement quantistico venne ipotizzato per la prima volta nel 1926 da Erwin Schrödinger, che fu anche il primo ad introdurre nel 1935 il termine "entanglement" (letteralmente groviglio, intreccio). La correlazione quantistica o entanglement quantistico è un fenomeno quantistico, privo di analogo classico, in cui ogni stato quantico (es: polarizzazione dei fotoni, stato di spin degli elettroni) di un insieme di due o più sistemi fisici dipende dallo stato di ciascun sistema, anche se essi sono spazialmente separati. Tale fenomeno viene a volte reso in italiano con il termine "non-separabilità". Esso implica la presenza di correlazioni a distanza tra le quantità fisiche osservabili dei sistemi coinvolti, determinando il carattere non locale della teoria quantistica. Il fenomeno dell'entanglement viola dunque il principio di località per il quale ciò che accade in un luogo NON può influire immediatamente su ciò che accade in un altro. Albert Einstein, pur avendo dato importanti contributi alla teoria quantistica, non accettò mai che una particella potesse influenzarne un'altra istantaneamente. Egli pertanto cercò a lungo di dimostrare che la violazione della località fosse solo apparente, ma i suoi tentativi furono di volta in volta ribattuti dai suoi oppositori.
33 Nel 1982 il fisico Alain Aspect, con una serie di sofisticati esperimenti dimostrò l'esistenza dell entanglement e quindi l'inconsistenza della posizione di Einstein. Nell'Ottobre del 1998 il fenomeno dell entanglement fu definitivamente confermato dalla riuscita di un esperimento sul teletrasporto effettuato dall'institute of Technology (Caltech) di Pasadena, in California.
34 SAPERNE DI PIÙ SULL'ENTANGLEMENT Se due particelle interagiscono per un certo periodo di tempo e poi vengono separate, quando una delle due viene sollecitata, in modo tale da cambiare il suo stato, istantaneamente sulla seconda particella si manifesta una analoga sollecitazione, a qualunque distanza essa si trovi rispetto alla prima; in altri termini, anche la seconda particella modifica istantaneamente il suo stato. Tale fenomeno è detto "Entanglement". Un semplice esperimento sul fenomeno Entanglement : due particelle gemelle vengono lanciate in direzioni opposte. Se la particella 1, durante il suo tragitto, incontra un magnete che ne devia la direzione verso l alto, la particella 2, invece di continuare la sua traiettoria in linea retta, devia contemporaneamente la sua direzione, assumendo così un moto contrario alla sua gemella.
35 Questo esperimento dimostra che: 1. le particelle sono in grado di comunicare tra di loro trasmettendo ed elaborando informazioni. 2. la comunicazione è istantanea.
36 Il fisico Niels Bohr disse: "Tra due particelle [correlate] che si allontanano l'una dall'altra nello spazio, esiste una forma di azione - comunicazione permanente. [...] Anche se due fotoni si trovassero su due diverse galassie continuerebbero pur sempre a rimanere un unico ente..."
37 Gli esperimenti di Alain Aspect Nel 1982 Alain Aspect, con la collaborazione dei ricercatori J. Dalibard e G. Roger dell Istituto di Ottica dell Università di Parigi, dimostrò l'esistenza dell'entanglement, confermando così le ipotesi "non localistiche" della teoria quantistica. In figura è riportata una schematizzazione delle apparecchiature utilizzate da Aspect e dai suoi collaboratori durante gli esperimenti. Un atomo di calcio eccitato, al centro della figura, produce una coppia di fotoni correlati che si muovono lungo i percorsi A e B opposti:
38 lungo il percorso A viene, di tanto in tanto, inserito un cristallo birifrangente che funge da filtro. Quando il fotone interagisce con il cristallo, esso può, con una probabilità del 50 %, essere deviato oppure attraversare il cristallo proseguendo indisturbato per la sua strada. Alle estremità di ciascun tragitto, previsto per ciascun fotone, è posto un rivelatore di fotoni che ne permette la loro rilevazione. La cosa sorprendente che Aspect osservò fu che: nel momento in cui, lungo il percorso A, veniva inserito il cristallo birifrangente e si verificava una deviazione del fotone 1 verso il rivelatore c, anche il fotone 2 del percorso B (fotone separato e senza ostacoli davanti), "spontaneamente" ed istantaneamente, deviava verso il rivelatore d. Praticamente l atto di inserire il cristallo birifrangente, con la conseguente deviazione del fotone 1, faceva, istantaneamente e a distanza, deviare il fotone 2. Tutto ciò può sembrare strano, ma è quello che effettivamente accade quando si eseguono esperimenti su coppie di particelle correlate. Dunque l idea che particelle correlate, situate in luoghi distanti, rappresentino enti distinti, deve essere abbandonata.
39 In riferimento all unicità della materia che scaturisce dalla visione non localistica della teoria quantistica, così si esprime Brian Josephson, premio Nobel per la Fisica: "L universo non è una collezione di oggetti, ma una inseparabile rete di modelli di energia vibrante nei quali nessun componente ha realtà indipendente dal tutto: includendo nel tutto l osservatore".
40 RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DI UN PROCESSO DI TELETRASPORTO QUANTISTICO Fotone teletrasportato Stazione trasmittente T A C B Stazione ricevente R Fotone da teletrasportare A Fotoni entangled B Sorgente di fotoni entangled: Sorgente EPR L'entanglement è spesso indicato come "effetto EPR" dalle iniziali di Albert Einstein, Boris Podolski e Nathan Rosen, che nel 1935 ne analizzarono le conseguenze su particelle poste a grandi distanze. Le particelle coinvolte sono dette "coppie EPR.
41 BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TELETRASPORTO QUANTISTICO 1. Produzione di una coppia di fotoni A e B correlati o entangled mediante opportuno dispositivo. 2. Invio dei fotoni entangled A e B rispettivamente alla stazione trasmittente T ed alla stazione ricevente R. 3. Invio del fotone C, di cui si vuole teletrasportare lo stato di polarizzazione, alla stazione trasmittente T. 4. Interazione, alla postazione di partenza T, tra i fotoni A e C e misura sul sistema composto.
42 5. Simultaneo cambiamento, nel momento della misura, dello stato di polarizzazione del fotone B, alla stazione R. 6.Comunicazione alla stazione R, con mezzi classici (es: telefonata), del risultato della misura effettuata sul sistema composto AC. (La misura può dare uno tra quattro possibili risultati). 7.Modifica dello stato del fotone B in base alla informazione comunicata. Risultato Teletrasporto quantistico del fotone C ossia: ottenimento di un fotone con lo stesso stato di polarizzazione del fotone C senza effettuare alcuna misura su di esso.
43 Descrizione più dettagliata del processo di Teletrasporto Quantistico Amanda e Bert intendono teletrasportare il fotone C. Amanda si trova nella postazione T e Bert è nella postazione R. All inizio del processo ciascuno riceve un fotone di una coppia entangled: Amanda riceve il fotone A e Bert riceve il fotone B. Invece di effettuare una misura sui fotoni, sia Amanda che Bert conservano il proprio fotone senza disturbarne lo stato entangled. Amanda riceve un terzo fotone C che intende teletrasportare a Bert. In pratica Amanda, senza conoscere lo stato di polarizzazione del fotone C, vuole che Bert abbia un fotone con la stessa polarizzazione di C. Si badi che Amanda non può semplicemente misurare lo stato di polarizzazione del fotone C e comunicare il risultato a Bert poiché, per il principio d'indeterminazione, la misura non riprodurrebbe con esattezza lo stato originario del fotone. Per teletrasportare il fotone C, Amanda fa interagire A e C ed esegue una misura sul sistema composto, senza determinare, in termini assoluti, le singole polarizzazioni dei due fotoni. La misura può dare uno tra 4 possibili risultati.
44 In termini tecnici, una misurazione congiunta di questo tipo è chiamata misurazione dello stato di Bell ed ha un effetto particolare: induce istantaneamente un cambiamento nel fotone di Bert, correlandolo al risultato della misura effettuata da Amanda ed allo stato che il fotone C aveva originariamente. Per completare il teletrasporto, Amanda deve inviare a Bert un messaggio con metodi convenzionali (una telefonata o un appunto scritto). Dopo aver ricevuto questo messaggio, Bert, se necessario, può trasformare il suo fotone B in modo da renderlo una replica esatta del fotone C originale. La trasformazione che Bert deve applicare dipende dal risultato della misurazione di Amanda. Quale dei quattro possibili risultati ottenga Amanda è frutto del caso. Bert dunque non sa come modificare il suo fotone finché non riceve da Amanda il risultato della misurazione. Dopo questa trasformazione il fotone di Bert è nello stesso stato del fotone C.
45 Ciò che viene teletrasportato quindi non è il fotone ma il suo stato di polarizzazione o, più in generale, il suo stato quantico. Tuttavia poiché lo stato quantico è una caratteristica peculiare di una particella, teletrasportare lo stato quantico è come teletrasportare la particella stessa. E' importante osservare che: la misura che esegue Amanda accoppia il fotone A al fotone C. Il fotone C perde così tutta la "memoria" del suo stato originario. Lo stato originario del fotone C, dopo la misurazione, scompare dunque dal luogo in cui si trova Amanda. Il risultato della misura di Amanda, essendo del tutto casuale, non dice nulla sullo stato quantico. In questo modo il processo aggira il Principio di Indeterminazione di Heisenberg che non consente la completa determinazione dello stato di una particella ma permette il teletrasporto dello stato, purché non si cerchi di conoscere quale esso sia. Il trasferimento dello stato del fotone C è avvenuto senza che né Amanda né Bert sapessero nulla di esso.
46 Inoltre, l'informazione quantistica teletrasportata non viaggia materialmente. Ciò che viene trasferito, in realtà, è solo il messaggio sul risultato della misurazione di Amanda che dice a Bert come modificare il suo fotone, senza alcuna indicazione sullo stato del fotone C. In uno dei quattro casi, la misura effettuata da Amanda è fortunata ed il fotone di Bert diventa immediatamente una replica esatta del fotone originale C. In questo caso può sembrare che l'informazione viaggi istantaneamente da Amanda a Bert, infrangendo il limite imposto da Einstein. In verità, Bert non ha alcun modo di sapere che il suo fotone è già una replica dell'originale. Solo quando egli apprende il risultato della misurazione dello stato di Bell, effettuata da Amanda ed a lui trasmessa per via classica, egli può sfruttare l'informazione nello stato quantico teletrasportato.
47 CONCLUSIONI Siamo ancora lontani dal teletrasporto di un oggetto di grandi dimensioni. I problemi fondamentali sono due: occorrono due oggetti dello stesso tipo accoppiati; l'oggetto da teletrasportare e la coppia devono essere sufficientemente isolati dall'ambiente. Se una qualunque informazione viene scambiata con l'ambiente, mediante un'interazione fortuita, lo stato quantico dell'oggetto si degrada in un processo chiamato "decoerenza". E' difficile immaginare come si possa raggiungere questo assoluto isolamento per un corpo di dimensioni macroscopiche, per non parlare di un essere vivente che respira aria e scambia calore con l'esterno. Ma chi può prevedere gli sviluppi futuri? Certamente potremmo usare la tecnologia esistente per teletrasportare stati elementari, come quelli dei fotoni su distanze di pochi chilometri e forse anche fino a satelliti. La tecnologia per teletrasportare gli stati di singoli atomi è oggi alla nostra portata, come ha dimostrato il gruppo guidato da Serge Haroche dell'ecole Normale Supèrieure di Parigi realizzando l'accoppiamento di atomi. L'accoppiamento di molecole ed il loro teletrasporto possono essere ragionevolmente previsti entro il prossimo decennio. Che cosa succederà poi, nessuno lo sa. ritorno alla tavola dei contenuti
48 Il Teletrasporto Quantistico dal 1997 ad oggi I primi esperimenti di teletrasporto quantistico sono stati effettuati tra il 1993 ed il 1997, da due gruppi di ricerca internazionali, diretti rispettivamente da Francesco De Martini dell Università La Sapienza di Roma e da Anton Zeilinger dell'istituto di Fisica Sperimentale di Vienna. Essi riuscirono a teletrasportare lo stato quantico di un fotone. Nel 2004: De Martini effettuò un teletrasporto di fotoni da una parte all altra del Danubio, ricoprendo una distanza di 600 metri. due gruppi di scienziati, uno del National Institute of Standards and Technology negli Stati Uniti ed uno della Università di Innsbruck in Austria, riuscirono per la prima volta a teletrasportare alcune proprietà degli atomi. Gli Americani lavorarono con atomi di berillio mentre gli Austriaci utilizzarono atomi di calcio.
49 Nel 2006: alcuni ricercatori dell'istituto Niels Bohr di Copenhagen teletrasportarono uno stato collettivo da un gruppo di circa un trilione di atomi ad un altro. Il teletrasporto applicato agli atomi, cioè alla materia, è un processo molto fragile rispetto a quello applicato ai fotoni, a causa del processo di decoerenza che, per colpa delle interazioni con l ambiente, distrugge gli effetti quantistici, entanglement compreso. Nel 2010: in Cina, i ricercatori dell Hefei National Laboratory for Physical Sciences raggiunsero 16km nel teletrasporto di fotoni senza l aiuto di fibre ottiche.
50 Nel 2012: un gruppo di ricercatori riuscì a teletrasportare l informazione relativa ad un complesso sistema di circa 100 milioni di atomi di rubidio che aveva una grandezza di circa un millimetro. Lo studio fu condotto da Jian-Wei Pan dell Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, a cui collaborò un gruppo di ricercatori della University of Science and Technology in China e dell Università di Heidelberg. Per il teletrasporto gli scienziati prepararono in laboratorio una coppia entangled di granelli di rubidio. I granelli entangled furono posti a circa mezzo metro di distanza ed i due sistemi furono poi messi in collegamento da una fibra ottica, lunga circa 150 metri ed arrotolata su sé stessa. Prima del processo di teletrasporto quantistico, gli scienziati mapparono lo stato di eccitazione degli atomi di rubidio in un fotone che doveva viaggiare lungo la fibra ottica. Fu possibile realizzare il teletrasporto facendo interagire il fotone messaggero con un altro fotone e con il secondo sistema di atomi.
51 Nel 2012: Il team di ricercatori della University of Science and Technology of China di Shanghai, riuscì a teletrasportare più di 1100 fotoni in 4 ore, ricoprendo una distanza di 97Km di spazio libero, stabilendo così un nuovo record e superando la distanza di 16km raggiunta nel precedente esperimento del Il team di ricerca dell'optical Ground Station dell'agenzia Spaziale Europea (ESA) alle Canarie stabilì un nuovo record mondiale di distanza nel teletrasporto quantistico, riproducendo le caratteristiche di una particella di luce alla distanza di 143km (tra il Jacobus Kapteyn Telescope di La Palma e la Stazione ottica dell'esa di Tenerife)..
52 Nel 2013: Un gruppo di fisici del centro di ricerca Quantop al Niels Bohr Institute della University of Copenhagen è riuscito a teletrasportare informazioni tra due nubi di atomi di gas di cesio poste ad una distanza di mezzo metro. Il teletrasporto di informazioni da una nube all'altra è avvenuto per mezzo di luce laser, ciascuna nube è stata posta in un contenitore di vetro ed i due contenitori non sono stati in alcun modo collegati.
53 Si prevede che il prossimo esperimento di teletrasporto consisterà in un teletrasporto quantistico tra la Terra ed un satellite in orbita terrestre.
54 Applicazioni del Teletrasporto Quantistico Realizzazione di computer e reti quantistiche estremamente più potenti e più veloci degli attuali computer e reti classiche. Scambi di informazioni sicure al 100%. Difatti: fra la stazione di invio e quella di ricezione, viene scambiato solo un segnale classico che non permette ad un estraneo, che lo intercetti, di risalire all'informazione, sotto forma di stato quantico, che si sta teletrasportando. Sogno del teletrasporto alla Star Trek
55 Approfondimenti: La non separabilità quantistica Entanglement (un libro su questo misterioso fenomeno fisico) Nuova conferma per l entanglement Teletrasporto: E per saperne ancora di più: ritorno all introduzione
56 QUBIT E COMPUTER QUANTISTICI Il BIT (binary digit) è l unità di informazione classica. Il QUBIT o bit quantistico (quantum binary digit) è l unità di informazione quantistica.
57 I classici bit operano su codice binario e possono codificare solo un valore alla volta: 0 o 1. I qubit basano l elaborazione dell informazione sulle leggi della meccanica quantistica e per il principio della sovrapposizione quantistica, ovvero l idea che un oggetto possa esistere in più stati allo stesso tempo, possono assumere contemporaneamente lo stato 0 e 1.
58 In un sistema classico un bit di informazione può essere rappresentato, per esempio, dalla tensione applicata alle armature di un condensatore: il condensatore carico denota il bit 1 e quello non carico il bit 0. Quantisticamente, un bit d'informazione può essere codificato usando un sistema a due livelli, come per esempio: gli stati di spin di un elettrone, le due polarizzazioni della luce.
59 Cosa è un computer quantistico? I presupposti per la realizzazione di computer quantistici e di reti quantistiche, capaci di offrire migliori prestazioni in velocità e potenza di calcolo, sono forniti dal TELETRASPORTO QUANTISTICO ossia, il fenomeno di teletrasporto dei qubit, realizzabile tramite il fenomeno quantistico dell'entanglement.
60 In un computer quantistico le informazioni sono registrate nei qubit anziché salvate nei bit come avviene invece in un computer classico.
61 Quanta informazione può contenere un QUBIT? In pratica un Qubit non può contenere più informazione di un bit classico, poiché esso assume valore 0 o 1 nel momento in cui l informazione viene processata. Un computer quantistico, a livello di informazione immagazzinata, non presenta dunque vantaggi rispetto agli attuali computer. Il vantaggio di un computer quantistico consiste invece in un aumento esponenziale della capacità di calcolo.
62 Un processore quantistico in grado di operare su N Qubit, ha la potenza di calcolo di un processore classico che opera su 2 N bit. I computer quantistici sono dunque in grado di gestire in pochissimi minuti enormi flussi di dati.
63 DIFFICOLTÀ TECNOLOGICHE Le difficoltà tecnologiche da superare per realizzare un computer quantistico sono molte. Una di queste è la decoerenza In altri termini, l inevitabile interazione con l ambiente esterno distruggerebbe in tempi brevissimi la coerenza quantistica, cioè l informazione contenuta nel calcolatore quantistico. Allo stato attuale sono in esame proposte diverse per costruire un computer quantistico (risonanza magnetica nucleare, trappole ioniche, sistemi ottici, circuiti superconduttori etc.), ma non è ancora chiaro quale possa essere la strada con maggiori probabilità di successo.
64 Saperne di più su QUBIT e Computer Quantistici La prima memoria quantistica: QUBIT e Computers Quantistici: html ritorno all introduzione
Comunicazione quantistica
 Comunicazione quantistica Il teletrasporto quantistico prevede che sia possibile trasferire lo stato quantico di una particella (per esempio, lo stato di polarizzazione se si tratta di un fotone) a grandi
Comunicazione quantistica Il teletrasporto quantistico prevede che sia possibile trasferire lo stato quantico di una particella (per esempio, lo stato di polarizzazione se si tratta di un fotone) a grandi
Premi Nobel per la Fisica Accademia delle Scienze di Torino 10 dicembre 2012 Presentazione di Alessandro Bottino
 Premi Nobel per la Fisica 01 Serge Haroche, David J. Wineland Accademia delle Scienze di Torino 10 dicembre 01 Presentazione di Alessandro Bottino Serge Haroche Collège de France, and École Normale Supérieure,
Premi Nobel per la Fisica 01 Serge Haroche, David J. Wineland Accademia delle Scienze di Torino 10 dicembre 01 Presentazione di Alessandro Bottino Serge Haroche Collège de France, and École Normale Supérieure,
Generalità delle onde elettromagnetiche
 Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Unità 2. La teoria quantistica
 Unità 2 La teoria quantistica L'effetto fotoelettrico Nel 1902 il fisico P. Lenard studiò l'effetto fotoelettrico. Esso è l'emissione di elettroni da parte di un metallo su cui incide un'onda elettromagnetica.
Unità 2 La teoria quantistica L'effetto fotoelettrico Nel 1902 il fisico P. Lenard studiò l'effetto fotoelettrico. Esso è l'emissione di elettroni da parte di un metallo su cui incide un'onda elettromagnetica.
L'effetto Compton (1923)
 L'effetto Compton (1923) Conferma la natura quantizzata della radiazione elettromagnetica (raggi X) Conferma la natura corpuscolare dei quanti di radiazione che si comportano come particelle dotate di
L'effetto Compton (1923) Conferma la natura quantizzata della radiazione elettromagnetica (raggi X) Conferma la natura corpuscolare dei quanti di radiazione che si comportano come particelle dotate di
Teoria Atomica Moderna. Chimica generale ed Inorganica: Chimica Generale. sorgenti di emissione di luce. E = hν. νλ = c. E = mc 2
 sorgenti di emissione di luce E = hν νλ = c E = mc 2 FIGURA 9-9 Spettro atomico, o a righe, dell elio Spettri Atomici: emissione, assorbimento FIGURA 9-10 La serie di Balmer per gli atomi di idrogeno
sorgenti di emissione di luce E = hν νλ = c E = mc 2 FIGURA 9-9 Spettro atomico, o a righe, dell elio Spettri Atomici: emissione, assorbimento FIGURA 9-10 La serie di Balmer per gli atomi di idrogeno
Incontriamo la Fisica: la Meccanica Quantistica. Stefano Spagocci, GACB
 Incontriamo la Fisica: la Meccanica Quantistica Stefano Spagocci, GACB Newton e Laplace Secondo la concezione di Newton e Laplace, specificate le condizioni iniziali (posizioni e velocità), il moto di
Incontriamo la Fisica: la Meccanica Quantistica Stefano Spagocci, GACB Newton e Laplace Secondo la concezione di Newton e Laplace, specificate le condizioni iniziali (posizioni e velocità), il moto di
Introduzione alla meccanica quantistica. Vincenzo Barone
 Accademia delle Scienze di Torino 9 novembre 2017 Introduzione alla meccanica quantistica Vincenzo Barone barone@to.infn.it Parte I: Le basi della meccanica quantistica (questioni didattiche) Parte II:
Accademia delle Scienze di Torino 9 novembre 2017 Introduzione alla meccanica quantistica Vincenzo Barone barone@to.infn.it Parte I: Le basi della meccanica quantistica (questioni didattiche) Parte II:
Introduzione alla Meccanica Quantistica (MQ):
 Introduzione alla Meccanica Quantistica (MQ): 1 MECCANICA QUANTISTICA ELETTRONI MATERIA MOLECOLE ATOMI NUCLEI La nostra attuale comprensione della struttura atomica e molecolare si basa sui principi della
Introduzione alla Meccanica Quantistica (MQ): 1 MECCANICA QUANTISTICA ELETTRONI MATERIA MOLECOLE ATOMI NUCLEI La nostra attuale comprensione della struttura atomica e molecolare si basa sui principi della
Interferenza di elettroni e! Principio di Indeterminazione
 Interferenza di elettroni e! Principio di Indeterminazione Paolo Pendenza Corso PAS, 10 luglio 2014 Anche nelle scienze non si possono scoprire nuove terre se non si è pronti a lasciarsi indietro il porto
Interferenza di elettroni e! Principio di Indeterminazione Paolo Pendenza Corso PAS, 10 luglio 2014 Anche nelle scienze non si possono scoprire nuove terre se non si è pronti a lasciarsi indietro il porto
LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA
 LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA Franco Prati Università dell Insubria - Como NINDA URUK Il pane dei Sumeri Ricerca scientifica ed epistemologia 5 dicembre 2012 Congresso Internazionale dei Fisici in onore di
LA RIVOLUZIONE QUANTISTICA Franco Prati Università dell Insubria - Como NINDA URUK Il pane dei Sumeri Ricerca scientifica ed epistemologia 5 dicembre 2012 Congresso Internazionale dei Fisici in onore di
Fisica Moderna e contemporanea
 Fisica Moderna e contemporanea SSIS Puglia Prof. Luigi Schiavulli luigi.schiavulli@ba.infn.it Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin 02/02/2006 1 Sommario Quadro riassuntivo sulla Fisica
Fisica Moderna e contemporanea SSIS Puglia Prof. Luigi Schiavulli luigi.schiavulli@ba.infn.it Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin 02/02/2006 1 Sommario Quadro riassuntivo sulla Fisica
Università Primo Levi
 Università Primo Levi Primo Levi 2013 Le forze fondamentali e la fisica dei quanta INAF Osservatorio Astronomico di Bologna via Ranzani, 1 40127 - Bologna - Italia Tel, 051-2095721 Fax, 051-2095700 http://www.bo.astro.it/~bedogni/primolevi
Università Primo Levi Primo Levi 2013 Le forze fondamentali e la fisica dei quanta INAF Osservatorio Astronomico di Bologna via Ranzani, 1 40127 - Bologna - Italia Tel, 051-2095721 Fax, 051-2095700 http://www.bo.astro.it/~bedogni/primolevi
Esploriamo la chimica
 1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. L atomo di Bohr 3. Il modello atomico
1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. L atomo di Bohr 3. Il modello atomico
Teoria Atomica di Dalton
 Teoria Atomica di Dalton Il concetto moderno della materia si origina nel 1806 con la teoria atomica di John Dalton: Ogni elementoè composto di atomi. Gli atomi di un dato elemento sono uguali. Gli atomi
Teoria Atomica di Dalton Il concetto moderno della materia si origina nel 1806 con la teoria atomica di John Dalton: Ogni elementoè composto di atomi. Gli atomi di un dato elemento sono uguali. Gli atomi
Sulla nascita di questo libro. Introduzione 1
 Indice Sulla nascita di questo libro V Introduzione 1 1 Luce e materia 7 Che cos è veramente la luce? 7 Ma qui che cosa oscilla? 9 Che cosa sono la frequenza e la lunghezza d onda della luce? 11 Che cos
Indice Sulla nascita di questo libro V Introduzione 1 1 Luce e materia 7 Che cos è veramente la luce? 7 Ma qui che cosa oscilla? 9 Che cosa sono la frequenza e la lunghezza d onda della luce? 11 Che cos
NATURA DELLA LUCE. 1/4 - NATURA DELLA LUCE - C. Calì - DIEET-UNIPA (2007-rev_10/11) Pubblicato in
 NATURA DELLA LUCE Nel corso del tempo diverse sono state le teorie formulate per spiegare la luce ed il suo comportamento. La teoria corpuscolare, messa a punto da Newton, è basata sull'ipotesi che la
NATURA DELLA LUCE Nel corso del tempo diverse sono state le teorie formulate per spiegare la luce ed il suo comportamento. La teoria corpuscolare, messa a punto da Newton, è basata sull'ipotesi che la
La struttura dell atomo
 La Teoria Atomica La struttura dell atomo 10-10 m 10-14 m Proprietà delle tre particelle subatomiche fondamentali Carica Massa Nome (simbolo) relativa assoluta (C) relativa (uma)* Assoluta (g) Posizione
La Teoria Atomica La struttura dell atomo 10-10 m 10-14 m Proprietà delle tre particelle subatomiche fondamentali Carica Massa Nome (simbolo) relativa assoluta (C) relativa (uma)* Assoluta (g) Posizione
Modello atomico ad orbitali e numeri quantici
 Modello atomico ad orbitali e numeri quantici Il modello atomico di Bohr permette di scrivere correttamente la configurazione elettronica di un atomo ma ha dei limiti che sono stati superati con l introduzione
Modello atomico ad orbitali e numeri quantici Il modello atomico di Bohr permette di scrivere correttamente la configurazione elettronica di un atomo ma ha dei limiti che sono stati superati con l introduzione
Fisica Quantistica. 1. Comportamento quantistico. 2. Effetto fotoelettrico. 3. Dualismo onda-corpuscolo. 4. Principio di indeterminazione
 Fisica Quantistica by Prof.ssa Paola Giacconi 1. Comportamento quantistico 2. Effetto fotoelettrico 3. Dualismo onda-corpuscolo 4. Principio di indeterminazione 1. COMPORTAMENTO QUANTISTICO La meccanica
Fisica Quantistica by Prof.ssa Paola Giacconi 1. Comportamento quantistico 2. Effetto fotoelettrico 3. Dualismo onda-corpuscolo 4. Principio di indeterminazione 1. COMPORTAMENTO QUANTISTICO La meccanica
Lezioni di Meccanica Quantistica
 Luigi E. Picasso Lezioni di Meccanica Quantistica seconda edizione Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Luigi E. Picasso Lezioni di Meccanica Quantistica seconda edizione Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici
 Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine
STRUTTURA DELL'ATOMO
 STRUTTURA DELL'ATOMO IDROGENO 1 H ELIO He 1 2 4 Modello planetario di Rutherford -protoni e neutroni costituiscono il nucleo in cui è concentrata tutta la massa - gli elettroni ruotano attorno al nucleo
STRUTTURA DELL'ATOMO IDROGENO 1 H ELIO He 1 2 4 Modello planetario di Rutherford -protoni e neutroni costituiscono il nucleo in cui è concentrata tutta la massa - gli elettroni ruotano attorno al nucleo
Effetti relativistici e quantistici
 Effetti relativistici e quantistici Dott. Fabiano Nart Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti E. Fermi www.gdsdolomiti.org info.gdsdolomiti@gmail.com Museo Scienze Naturali Bolzano, 24/05/2016 Dott.
Effetti relativistici e quantistici Dott. Fabiano Nart Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti E. Fermi www.gdsdolomiti.org info.gdsdolomiti@gmail.com Museo Scienze Naturali Bolzano, 24/05/2016 Dott.
La nascita della fisica moderna. (un racconto di inizio 900)
 La nascita della fisica moderna (un racconto di inizio 900) Sviluppo storico della fisica tra fine 800 e il 1927 Fisica sperimentale fine 800 Fisica teorica fine 800 1900 1905 1911 1913 1916 1924 1925-1927
La nascita della fisica moderna (un racconto di inizio 900) Sviluppo storico della fisica tra fine 800 e il 1927 Fisica sperimentale fine 800 Fisica teorica fine 800 1900 1905 1911 1913 1916 1924 1925-1927
Capitolo 8 La struttura dell atomo
 Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. La «luce» degli atomi 3. L atomo di Bohr 4. La doppia natura dell elettrone 5. L elettrone e la meccanica quantistica 6. L equazione
Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. La «luce» degli atomi 3. L atomo di Bohr 4. La doppia natura dell elettrone 5. L elettrone e la meccanica quantistica 6. L equazione
1 3 STRUTTURA ATOMICA
 1 3 STRUTTURA ATOMICA COME SI SPIEGA LA STRUTTURA DELL ATOMO? Secondo il modello atomico di Rutherford e sulla base della fisica classica, gli elettroni dovrebbero collassare sul nucleo per effetto delle
1 3 STRUTTURA ATOMICA COME SI SPIEGA LA STRUTTURA DELL ATOMO? Secondo il modello atomico di Rutherford e sulla base della fisica classica, gli elettroni dovrebbero collassare sul nucleo per effetto delle
LE ONDE E I FONDAMENTI DELLA TEORIA QUANTISTICA
 LE ONDE E I FONDAMENTI DELLA TEORIA QUANTISTICA I PROBLEMI DEL MODELLO PLANETARIO F Secondo Rutherford l elettrone si muoverebbe sulla sua orbita in equilibrio tra la forza elettrica di attrazione del
LE ONDE E I FONDAMENTI DELLA TEORIA QUANTISTICA I PROBLEMI DEL MODELLO PLANETARIO F Secondo Rutherford l elettrone si muoverebbe sulla sua orbita in equilibrio tra la forza elettrica di attrazione del
catastrofe ultravioletta
 Fisica moderna Radiazione termica La radiazione termica è l insieme di onde elettromagnetiche che ogni corpo emette per effetto della sua temperatura Un corpo nero è un corpo che assorbe completamente
Fisica moderna Radiazione termica La radiazione termica è l insieme di onde elettromagnetiche che ogni corpo emette per effetto della sua temperatura Un corpo nero è un corpo che assorbe completamente
L'entanglement, da sorgente dei paradossi della meccanica quantistica a risorsa per le nascenti tecnologie quantistiche
 L'entanglement, da sorgente dei paradossi della meccanica quantistica a risorsa per le nascenti tecnologie quantistiche Il mondo classico: la nostra vita quotidiana Un pallone quantistico: il fullerene
L'entanglement, da sorgente dei paradossi della meccanica quantistica a risorsa per le nascenti tecnologie quantistiche Il mondo classico: la nostra vita quotidiana Un pallone quantistico: il fullerene
Modelli atomici Modello atomico di Rutheford Per t s d u i diare la t s rutt ttura t a omica Ruth th f or (
 Modello atomico di Rutheford Per studiare la struttura tt atomica Rutherford (1871-1937) 1937) nel 1910 bombardòb una lamina d oro con particelle a (cioè atomi di elio) Rutherford suppose che gli atomi
Modello atomico di Rutheford Per studiare la struttura tt atomica Rutherford (1871-1937) 1937) nel 1910 bombardòb una lamina d oro con particelle a (cioè atomi di elio) Rutherford suppose che gli atomi
La teoria del corpo nero
 La teoria del corpo nero Max Planck Primo Levi 2014 Roberto Bedogni INAF Osservatorio Astronomico di Bologna via Ranzani, 1 40127 - Bologna - Italia Tel, 051-2095721 Fax, 051-2095700 http://www.bo.astro.it/~bedogni/primolevi
La teoria del corpo nero Max Planck Primo Levi 2014 Roberto Bedogni INAF Osservatorio Astronomico di Bologna via Ranzani, 1 40127 - Bologna - Italia Tel, 051-2095721 Fax, 051-2095700 http://www.bo.astro.it/~bedogni/primolevi
Si arrivò a dimostrare l esistenza di una forma elementare della materia (atomo) solo nel 1803 (John Dalton)
 Atomi 16 Si arrivò a dimostrare l esistenza di una forma elementare della materia (atomo) solo nel 1803 (John Dalton) 17 Teoria atomica di Dalton Si basa sui seguenti postulati: 1. La materia è formata
Atomi 16 Si arrivò a dimostrare l esistenza di una forma elementare della materia (atomo) solo nel 1803 (John Dalton) 17 Teoria atomica di Dalton Si basa sui seguenti postulati: 1. La materia è formata
La teoria atomistica
 La teoria atomistica Joseph John Thomson Fisico britannico È noto per aver scoperto nel 1897 la particella di carica negativa: l'elettrone Ebbe come studente Rutherford Vinse il Nobel per la fisica nel
La teoria atomistica Joseph John Thomson Fisico britannico È noto per aver scoperto nel 1897 la particella di carica negativa: l'elettrone Ebbe come studente Rutherford Vinse il Nobel per la fisica nel
Verifica del Principio di Indeterminazione di Heisenberg. x v x cost
 Verifica del Principio di Indeterminazione di Heisenberg x v x cost Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg e uno dei principi su cui si fonda la Meccanica Quantistica (MQ) La MQ e la teoria che
Verifica del Principio di Indeterminazione di Heisenberg x v x cost Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg e uno dei principi su cui si fonda la Meccanica Quantistica (MQ) La MQ e la teoria che
- Dati sperimentali: interazione luce / materia spettri caratteristici
 - Thomson: evidenza sperimentale per elettrone misura e/m e - Millikan: misura la carica dell elettrone e ne ricava la massa e = 1,60 x 10-19 C - Rutherford: stima le dimensioni atomiche struttura vuota
- Thomson: evidenza sperimentale per elettrone misura e/m e - Millikan: misura la carica dell elettrone e ne ricava la massa e = 1,60 x 10-19 C - Rutherford: stima le dimensioni atomiche struttura vuota
LO SPAZIO DELLE FASI. Lezioni d'autore
 LO SPAZIO DELLE FASI Lezioni d'autore Un video : Clic Lo spazio delle fasi in meccanica classica (I) La descrizione dinamica di un punto materiale con un solo grado di libertà soggetto a forze avviene
LO SPAZIO DELLE FASI Lezioni d'autore Un video : Clic Lo spazio delle fasi in meccanica classica (I) La descrizione dinamica di un punto materiale con un solo grado di libertà soggetto a forze avviene
Come vediamo. La luce: aspetti fisici. Cos è la luce? Concetti fondamentali:
 La luce in fisica La luce: aspetti fisici Cos è la luce? Concetti fondamentali: - velocità, ampiezza, lunghezza d onda - assorbimento - riflessione -rifrazione - diffrazione - indice di rifrazione - temperatura
La luce in fisica La luce: aspetti fisici Cos è la luce? Concetti fondamentali: - velocità, ampiezza, lunghezza d onda - assorbimento - riflessione -rifrazione - diffrazione - indice di rifrazione - temperatura
COMPUTER QUANTISTICO, CRITTOGRAFIA QUANTISTICA E TELETRASPORTO
 COMPUTER QUANTISTICO, CRITTOGRAFIA QUANTISTICA E TELETRASPORTO MECCANICA QUANTISTICA E NON LOCALITÀ : L ENTANGLEMENT La Meccanica Quantistica, per particolari misurazioni eseguite su due particelle lontane,
COMPUTER QUANTISTICO, CRITTOGRAFIA QUANTISTICA E TELETRASPORTO MECCANICA QUANTISTICA E NON LOCALITÀ : L ENTANGLEMENT La Meccanica Quantistica, per particolari misurazioni eseguite su due particelle lontane,
Istituti Paritari PIO XII
 Istituti Paritari PIO XII RMTD545007 Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 00159 ROMA - via Galla Placidia, 63 RMTL395001 Costruzioni, Ambiente e territorio Tel 064381465 Fax
Istituti Paritari PIO XII RMTD545007 Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 00159 ROMA - via Galla Placidia, 63 RMTL395001 Costruzioni, Ambiente e territorio Tel 064381465 Fax
Spettro delle onde elettromagnetiche. Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione
 Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
HP Portkey: Osservazione
 HP Portkey: Osservazione domenica 21 giugno 2015 18:36 PORTKEY @ WORLD QUIDDITCH CHAMPIONSHIP https://www.youtube.com/watch?v=-4n90ipqjkc PORTKEY @ TRIWIZARD CUP https://www.youtube.com/watch?v=fyqa7ewrft8
HP Portkey: Osservazione domenica 21 giugno 2015 18:36 PORTKEY @ WORLD QUIDDITCH CHAMPIONSHIP https://www.youtube.com/watch?v=-4n90ipqjkc PORTKEY @ TRIWIZARD CUP https://www.youtube.com/watch?v=fyqa7ewrft8
LA STRUTTURA DEGLI ATOMI GLI SPETTRI ATOMICI DI EMISSIONE
 LA STRUTTURA DEGLI ATOMI GLI SPETTRI ATOMICI DI EMISSIONE LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO LA QUANTIZZAZIONE DELL
LA STRUTTURA DEGLI ATOMI GLI SPETTRI ATOMICI DI EMISSIONE LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO LA QUANTIZZAZIONE DELL
Introduzione ai fenomeni quantistici
 Introduzione ai fenomeni quantistici Tratto da: The Feynman lectures on physics, vol. 3 Marco Bonvini Nicodemo Magnoli Meccanica: Keplero (1608-1619) Galilei (1630) Newton (1687) Termodinamica: Kelvin
Introduzione ai fenomeni quantistici Tratto da: The Feynman lectures on physics, vol. 3 Marco Bonvini Nicodemo Magnoli Meccanica: Keplero (1608-1619) Galilei (1630) Newton (1687) Termodinamica: Kelvin
LA STRUTTURA DEGLI ATOMI GLI SPETTRI ATOMICI DI EMISSIONE
 LA STRUTTURA DEGLI ATOMI GLI SPETTRI ATOMICI DI EMISSIONE LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO LA QUANTIZZAZIONE DELL
LA STRUTTURA DEGLI ATOMI GLI SPETTRI ATOMICI DI EMISSIONE LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO LA QUANTIZZAZIONE DELL
Esame di stato 2010 Tema 1 1 M. Vincoli
 Esame di stato 010 Tema 1 1 M. Vincoli 1 L analisi dell effetto fotoelettrico, pubblicata da Einstein nel 1905, porta ad attribuire alla luce, al livello microscopico, una caratteristica corpuscolare,
Esame di stato 010 Tema 1 1 M. Vincoli 1 L analisi dell effetto fotoelettrico, pubblicata da Einstein nel 1905, porta ad attribuire alla luce, al livello microscopico, una caratteristica corpuscolare,
4.Semplificare e modellizzare con strumenti matematici e disciplinari situazioni reali al fine della risoluzione di semplici problemi
 MODULO : CONTINUITA 12 ore COMPETENZE: 1.Osservare, identificare ed esplorare fenomeni; 2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 3.Costruire il linguaggio della fisica classica
MODULO : CONTINUITA 12 ore COMPETENZE: 1.Osservare, identificare ed esplorare fenomeni; 2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 3.Costruire il linguaggio della fisica classica
La natura ondulatoria della materia
 La natura ondulatoria della materia 1. Dualismo onda-particella 2. Principio di indeterminazione di Heisemberg 3. Struttura del nucleo XV - 0 Dualismo onda-particella Come la radiazione presenta una doppia
La natura ondulatoria della materia 1. Dualismo onda-particella 2. Principio di indeterminazione di Heisemberg 3. Struttura del nucleo XV - 0 Dualismo onda-particella Come la radiazione presenta una doppia
LUCE E ONDE ELETTROMAGNETICHE
 LUCE E ONDE ELETTROMAGNETICHE QUASI TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SULLA STRUTTURA DELL ATOMO DERIVA DALL ANALISI DELLA LUCE EMESSA O ASSORBITA DALLE SOSTANZE CHI FU IL PRIMO AD ACCORGERSI CHE I SINGOLI ELEMENTI
LUCE E ONDE ELETTROMAGNETICHE QUASI TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SULLA STRUTTURA DELL ATOMO DERIVA DALL ANALISI DELLA LUCE EMESSA O ASSORBITA DALLE SOSTANZE CHI FU IL PRIMO AD ACCORGERSI CHE I SINGOLI ELEMENTI
LFN Incontri di Fisica anni di nonlocalità in meccanica quan;s;ca: dal paradosso EPR alle disuguaglianze di Bell, e oltre
 LFN Incontri di Fisica 2014 50 anni di nonlocalità in meccanica quan;s;ca: dal paradosso EPR alle disuguaglianze di Bell, e oltre La meccanica quantistica È la teoria che utilizziamo per descrivere atomi,
LFN Incontri di Fisica 2014 50 anni di nonlocalità in meccanica quan;s;ca: dal paradosso EPR alle disuguaglianze di Bell, e oltre La meccanica quantistica È la teoria che utilizziamo per descrivere atomi,
Università degli Studi dell Aquila Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali Corso di Fisica della Materia Prof. L.
 Università degli Studi dell Aquila Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali Corso di Fisica della Materia Prof. L. Lozzi Testi degli esercizi svolti in aula Corpo Nero 1. Il corpo
Università degli Studi dell Aquila Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali Corso di Fisica della Materia Prof. L. Lozzi Testi degli esercizi svolti in aula Corpo Nero 1. Il corpo
Risultato: ELABORAZIONE della MECCANICA QUANTISTICA e sua applicazione sistematica ai nuovi fenomeni
 Tra la fine del XIX e inizio del XX secolo una serie di fenomeni non trovano interpretazione adeguata, basata su fisica classica (meccanica, elettromagnetismo, ottica e termodinamica) Essi risultarono
Tra la fine del XIX e inizio del XX secolo una serie di fenomeni non trovano interpretazione adeguata, basata su fisica classica (meccanica, elettromagnetismo, ottica e termodinamica) Essi risultarono
Enrico Silva - diritti riservati - Non è permessa, fra l altro, l inclusione anche parziale in altre opere senza il consenso scritto dell autore
 Indeterminazione Finora si sono considerate le proprietà ondulatorie, lavorando sulla fase di una (per ora non meglio specificata) funzione. Si sono ricavate o ipotizzate relazioni per: - lunghezza d onda
Indeterminazione Finora si sono considerate le proprietà ondulatorie, lavorando sulla fase di una (per ora non meglio specificata) funzione. Si sono ricavate o ipotizzate relazioni per: - lunghezza d onda
Programma della I parte
 Programma della I parte Cenni alla meccanica quantistica: il modello dell atomo Dall atomo ai cristalli: statistica di Fermi-Dirac, il modello a bande di energia, popolazione delle bande, livello di Fermi
Programma della I parte Cenni alla meccanica quantistica: il modello dell atomo Dall atomo ai cristalli: statistica di Fermi-Dirac, il modello a bande di energia, popolazione delle bande, livello di Fermi
Atomo. Evoluzione del modello: Modello di Rutherford Modello di Bohr Modello quantomeccanico (attuale)
 Atomo Evoluzione del modello: Modello di Rutherford Modello di Bohr Modello quantomeccanico (attuale) 1 Modello di Rutherford: limiti Secondo il modello planetario di Rutherford gli elettroni orbitano
Atomo Evoluzione del modello: Modello di Rutherford Modello di Bohr Modello quantomeccanico (attuale) 1 Modello di Rutherford: limiti Secondo il modello planetario di Rutherford gli elettroni orbitano
Alle origini della fisica dei quanti: il significato della costante di Planck. Giovanni Battimelli Dipartimento di fisica, Sapienza Università, Roma
 Alle origini della fisica dei quanti: il significato della costante di Planck Giovanni Battimelli Dipartimento di fisica, Sapienza Università, Roma Roma, 30 settembre 2017 Max Planck Albert Einstein Niels
Alle origini della fisica dei quanti: il significato della costante di Planck Giovanni Battimelli Dipartimento di fisica, Sapienza Università, Roma Roma, 30 settembre 2017 Max Planck Albert Einstein Niels
CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA
 CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA Anno Accademico 007-008 CORSO di FISCA ED APPLICAZIONE DEI LASERS Questionario del Primo appello della Sessione Estiva NOME: COGNOME: MATRICOLA: VOTO: /30 COSTANTI
CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA Anno Accademico 007-008 CORSO di FISCA ED APPLICAZIONE DEI LASERS Questionario del Primo appello della Sessione Estiva NOME: COGNOME: MATRICOLA: VOTO: /30 COSTANTI
DOMANDE PER CAPIRE LA FISICA
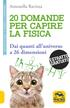 INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
ELENCO ANALITICO DEGLI ARGOMENTI
 PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
L ATOMO SECONDO LA MECCANICA ONDULATORIA IL DUALISMO ONDA-PARTICELLA. (Plank Einstein)
 L ATOMO SECONDO LA MECCANICA ONDULATORIA IL DUALISMO ONDA-PARTICELLA POSTULATO DI DE BROGLIÈ Se alla luce, che è un fenomeno ondulatorio, sono associate anche le caratteristiche corpuscolari della materia
L ATOMO SECONDO LA MECCANICA ONDULATORIA IL DUALISMO ONDA-PARTICELLA POSTULATO DI DE BROGLIÈ Se alla luce, che è un fenomeno ondulatorio, sono associate anche le caratteristiche corpuscolari della materia
MODELLO PLANETARIO ATTORNO AL NUCLEO ORBITANO GLI ELETTRONI COME PIANETI INTORNO AL SOLE TUTTAVIA
 MODELLO PLANETARIO ATTORNO AL NUCLEO ORBITANO GLI ELETTRONI COME PIANETI INTORNO AL SOLE TUTTAVIA LASCIAVA IRRISOLTI MOLTI PROBLEMI RIGUARDANTI IN PARTICOLARE LA DISPOSIZIONE DEGLI ELETTRONI INTORNO AL
MODELLO PLANETARIO ATTORNO AL NUCLEO ORBITANO GLI ELETTRONI COME PIANETI INTORNO AL SOLE TUTTAVIA LASCIAVA IRRISOLTI MOLTI PROBLEMI RIGUARDANTI IN PARTICOLARE LA DISPOSIZIONE DEGLI ELETTRONI INTORNO AL
STRUTTURA ATOMICA E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA
 pg 1 STRUTTURA ATOMICA E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA Per capire il comportamento degli atomi dobbiamo studiare il comportamento dei suoi elettroni L'atomo e le sue particelle NON sono direttamente visibili
pg 1 STRUTTURA ATOMICA E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA Per capire il comportamento degli atomi dobbiamo studiare il comportamento dei suoi elettroni L'atomo e le sue particelle NON sono direttamente visibili
Vincenzo Branchina. Rivoluzioni Scientifiche. Fisica Quantistica. Università di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Vincenzo Branchina Rivoluzioni Scientifiche Fisica Quantistica Università di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Giarre, 5 Marzo 2015 Nuova Meccanica Quantistica: Equazione di Schrodinger (1925)
Vincenzo Branchina Rivoluzioni Scientifiche Fisica Quantistica Università di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Giarre, 5 Marzo 2015 Nuova Meccanica Quantistica: Equazione di Schrodinger (1925)
Natura ondulatoria della luce. Natura corpuscolare della luce
 Natura ondulatoria della luce Data 1803 Autore Thomas Young Esperimento Un fascio di luce solare viene fatto passare da un foro e davanti a questo foro vi è un pannello con due fenditure verticali (coperte
Natura ondulatoria della luce Data 1803 Autore Thomas Young Esperimento Un fascio di luce solare viene fatto passare da un foro e davanti a questo foro vi è un pannello con due fenditure verticali (coperte
L atomo di Bohr e i raggi X
 L atomo di Bohr e i raggi X Corsi laboratorio per le scuole superiori gennaio 017 Prof. Federico Boscherini Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Bologna federico.boscherini@unibo.it www.unibo.it/docenti/federico.boscherini
L atomo di Bohr e i raggi X Corsi laboratorio per le scuole superiori gennaio 017 Prof. Federico Boscherini Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Bologna federico.boscherini@unibo.it www.unibo.it/docenti/federico.boscherini
Settimana 4 La Meccanica Quantistica Gli inizi Planck, Einstein, Bohr De Broglie: le particelle sono anche onde
 Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 4 La Meccanica Quantistica Gli inizi Planck, Einstein, Bohr De Broglie: le particelle
Relatività e Meccanica Quantistica: concetti e idee Relativity and Quantum Mechanics: concepts and ideas Settimana 4 La Meccanica Quantistica Gli inizi Planck, Einstein, Bohr De Broglie: le particelle
Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci Alunno di quarta - A.S NATURA ONDULATORIA E CORPUSCOLARE DELLA LUCE
 Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci Alunno di quarta - A.S. 2018-19 NATURA ONDULATORIA E CORPUSCOLARE DELLA LUCE Gli studi riguardo la natura della luce hanno visto nel corso dei secoli l affermarsi
Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci Alunno di quarta - A.S. 2018-19 NATURA ONDULATORIA E CORPUSCOLARE DELLA LUCE Gli studi riguardo la natura della luce hanno visto nel corso dei secoli l affermarsi
Il modello di Bohr. Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti
 Il modello di Bohr Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti VIDEO Gli spettri di emissione Nel 1859 il fisico G.R. Kirchoff scoprì che ogni elemento chimico presenta uno spettro di emissione caratteristico,
Il modello di Bohr Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti VIDEO Gli spettri di emissione Nel 1859 il fisico G.R. Kirchoff scoprì che ogni elemento chimico presenta uno spettro di emissione caratteristico,
Quanti erano e quanti sono l ABC e un po di D della Meccanica Quantistica
 Quanti erano e quanti sono l ABC e un po di D della Meccanica Quantistica Seconda e ultima parte La Torre del Sole, Brembate di Sopra (BG) - 4 Aprile 2019 Andrea Castelli, Ph.D. LOfficina del Planetario
Quanti erano e quanti sono l ABC e un po di D della Meccanica Quantistica Seconda e ultima parte La Torre del Sole, Brembate di Sopra (BG) - 4 Aprile 2019 Andrea Castelli, Ph.D. LOfficina del Planetario
La struttura degli atomi
 1 La struttura degli atomi pg. 298 27-28 31-37 43 47 51-53 55-57 61-62 67(a/h) 68(a/i) La struttura degli atomi e gli andamenti periodici pg.332 1-7 11-15 17-18 27-30 37 40-42 51 Solvay conference, 1927
1 La struttura degli atomi pg. 298 27-28 31-37 43 47 51-53 55-57 61-62 67(a/h) 68(a/i) La struttura degli atomi e gli andamenti periodici pg.332 1-7 11-15 17-18 27-30 37 40-42 51 Solvay conference, 1927
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI. Programmazione didattica annuale
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità e competenze Obiettivo
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità e competenze Obiettivo
LEZIONE N 28. Corso di Fisica II Prof. Giuseppe Ciancio
 LEZIONE N 28 1 Cenni storici atomo dal greco "atomòs" "indivisibile" Democrito In verità esistono solo atomi e il vuoto«. L uomo pensava che ogni cosa nel mondo fosse un composto dei quattro elementi:
LEZIONE N 28 1 Cenni storici atomo dal greco "atomòs" "indivisibile" Democrito In verità esistono solo atomi e il vuoto«. L uomo pensava che ogni cosa nel mondo fosse un composto dei quattro elementi:
PROFILO IN USCITA PER IL PRIM0 ANNO FISICA Sezioni internazionale ad opzione Inglese (L,M,N,O,P,Q)
 PROFILO IN USCITA PER IL PRIM0 ANNO Premessa Come stabilito dal Collegio dei docenti e conformemente con gli obiettivi della attuale sperimentazione, la programmazione seguirà, principalmente, la scansione
PROFILO IN USCITA PER IL PRIM0 ANNO Premessa Come stabilito dal Collegio dei docenti e conformemente con gli obiettivi della attuale sperimentazione, la programmazione seguirà, principalmente, la scansione
L Effetto Fotoelettrico
 L Effetto Fotoelettrico Alessio Bianchi 7 giugno 2017 Sommario Osservazione dell effetto fotoelettrico e determinazione sperimentale della costante di Planck (h). Verifica dell equipotenzialità di stopping
L Effetto Fotoelettrico Alessio Bianchi 7 giugno 2017 Sommario Osservazione dell effetto fotoelettrico e determinazione sperimentale della costante di Planck (h). Verifica dell equipotenzialità di stopping
L atomo di Bohr. Argomenti. Al tempo di Bohr. Spettri atomici 19/03/2010
 Argomenti Spettri atomici Modelli atomici Effetto Zeeman Equazione di Schrödinger L atomo di Bohr Numeri quantici Atomi con più elettroni Al tempo di Bohr Lo spettroscopio è uno strumento utilizzato per
Argomenti Spettri atomici Modelli atomici Effetto Zeeman Equazione di Schrödinger L atomo di Bohr Numeri quantici Atomi con più elettroni Al tempo di Bohr Lo spettroscopio è uno strumento utilizzato per
Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi
 Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi SEDE: Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 (Mi) - Ore 18.00-20.00 DATA: 19 ottobre
Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi SEDE: Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 (Mi) - Ore 18.00-20.00 DATA: 19 ottobre
L Universo in un lancio di dadi. Come il principio di indeterminazione di Heisenberg ha portato alla fine del determinismo scientifico
 L Universo in un lancio di dadi Come il principio di indeterminazione di Heisenberg ha portato alla fine del determinismo scientifico Abà Anna classe V BS Un precursore: David Hume «L idea di causa ed
L Universo in un lancio di dadi Come il principio di indeterminazione di Heisenberg ha portato alla fine del determinismo scientifico Abà Anna classe V BS Un precursore: David Hume «L idea di causa ed
PROGRAMMAZIONE MODULARE A.S. 2017/2018
 Liceo Scientifico Cartesio PROGRAMMAZIONE MODULARE A.S. 2017/2018 Classe V A Finalità educative: Docente: Daniele Borsatto Disciplina: Fisica Saper osservare, descrivere ed analizzare sia qualitativamente
Liceo Scientifico Cartesio PROGRAMMAZIONE MODULARE A.S. 2017/2018 Classe V A Finalità educative: Docente: Daniele Borsatto Disciplina: Fisica Saper osservare, descrivere ed analizzare sia qualitativamente
Introduzione al corso. Cenni storici ed evidenze sperimentali determinanti lo sviluppo della fisica atomica come la conosciamo ora...
 Introduzione al corso Cenni storici ed evidenze sperimentali determinanti lo sviluppo della fisica atomica come la conosciamo ora... Legge di Boyle (1662)-> La pressione di un gas cresce quando decresce
Introduzione al corso Cenni storici ed evidenze sperimentali determinanti lo sviluppo della fisica atomica come la conosciamo ora... Legge di Boyle (1662)-> La pressione di un gas cresce quando decresce
Gli acceleratori di particelle
 Gli acceleratori di particelle seconda parte Corso di valorizzazione delle eccellenze in Matematica e Fisica Liceo Statale Scientifico, Linguistico e Classico Giolitti-Gandino Come facciamo a vedere gli
Gli acceleratori di particelle seconda parte Corso di valorizzazione delle eccellenze in Matematica e Fisica Liceo Statale Scientifico, Linguistico e Classico Giolitti-Gandino Come facciamo a vedere gli
LO SPIN DELL'ELETTRONE. Lezioni d'autore
 LO SPIN DELL'ELETTRONE Lezioni d'autore VIDEO Momento magnetico e momento angolare (I) L immagine dell atomo di idrogeno, con la carica negativa in orbita chiusa intorno al protone, suggerisce l effetto
LO SPIN DELL'ELETTRONE Lezioni d'autore VIDEO Momento magnetico e momento angolare (I) L immagine dell atomo di idrogeno, con la carica negativa in orbita chiusa intorno al protone, suggerisce l effetto
I modelli atomici 10/12/2018. Thomson. Rutherford
 I modelli atomici Thomson Il primo modello atomico fu proposto nel 1904 da Joseph Thomson, lo scopritore dell elettrone. Egli immaginò che l atomo fosse una sfera omogenea all interno della quale sono
I modelli atomici Thomson Il primo modello atomico fu proposto nel 1904 da Joseph Thomson, lo scopritore dell elettrone. Egli immaginò che l atomo fosse una sfera omogenea all interno della quale sono
La Natura della Luce: dalle Scoperte alle Applicazioni
 La Natura della Luce: dalle Scoperte alle Applicazioni Luca Salasnich Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei, Università di Padova, Italy Padova, 27 Maggio 2013 Sommario L ottica geometrica
La Natura della Luce: dalle Scoperte alle Applicazioni Luca Salasnich Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei, Università di Padova, Italy Padova, 27 Maggio 2013 Sommario L ottica geometrica
L officina del Meccanico Quantistico
 L officina del Meccanico Quantistico Dal gatto di Schrödinger al Quantum Computing Fabio Chiarello Istituto di Fotonica e Nanotecnologie Consiglio Nazionale delle Ricerche Le Nanotecnologie e la Meccanica
L officina del Meccanico Quantistico Dal gatto di Schrödinger al Quantum Computing Fabio Chiarello Istituto di Fotonica e Nanotecnologie Consiglio Nazionale delle Ricerche Le Nanotecnologie e la Meccanica
CENNI DI EPISTEMOLOGIA. Giulia Cavalli
 CENNI DI EPISTEMOLOGIA Giulia Cavalli Epistemologia Concezioni sviluppate dalla scienza su come l uomo conosce (la natura, i limiti, le condizioni della conoscenza), sulle nostre rappresentazioni della
CENNI DI EPISTEMOLOGIA Giulia Cavalli Epistemologia Concezioni sviluppate dalla scienza su come l uomo conosce (la natura, i limiti, le condizioni della conoscenza), sulle nostre rappresentazioni della
Elettronica dello Stato Solido Lezione 4: L effetto fotoelettrico e il dualismo onda-particella
 Elettronica dello Stato Solido Lezione 4: L effetto fotoelettrico e il dualismo onda-particella Daniele Ielmini DEI Politecnico di Milano ielmini@elet.polimi.it D. Ielmini Elettronica dello Stato Solido
Elettronica dello Stato Solido Lezione 4: L effetto fotoelettrico e il dualismo onda-particella Daniele Ielmini DEI Politecnico di Milano ielmini@elet.polimi.it D. Ielmini Elettronica dello Stato Solido
Seconda parte Teorie atomiche. Configurazione elettronica. Il legame chimico. Prof. Stefano Piotto Università di Salerno
 Seconda parte Teorie atomiche. Configurazione elettronica. Il legame chimico Prof. Stefano Piotto Università di Salerno Seconda parte 1. Teoria atomica 2. Esperimenti di Thompson e Millikan 3. Modello
Seconda parte Teorie atomiche. Configurazione elettronica. Il legame chimico Prof. Stefano Piotto Università di Salerno Seconda parte 1. Teoria atomica 2. Esperimenti di Thompson e Millikan 3. Modello
Insegnare relatività. nel XXI secolo
 Insegnare relatività nel XXI secolo I p r i n c i p i d e l l a d i n a m i c a r e l a t i v i s t i c a Nei principi c'è poco da cambiare rispetto alla meccanica newtoniana. Il primo (inerzia) resta
Insegnare relatività nel XXI secolo I p r i n c i p i d e l l a d i n a m i c a r e l a t i v i s t i c a Nei principi c'è poco da cambiare rispetto alla meccanica newtoniana. Il primo (inerzia) resta
7 - Il dualismo onda particella e la sua indeterminazione
 7 - Il dualismo onda particella e la sua indeterminazione Se è vero che la particella in un istante, si trova in preciso punto e l istante successivo potrebbe trovarsi in un qualunque altro punto dell
7 - Il dualismo onda particella e la sua indeterminazione Se è vero che la particella in un istante, si trova in preciso punto e l istante successivo potrebbe trovarsi in un qualunque altro punto dell
Indice. Elettrostatica in presenza di dielettrici Costante dielettrica Interpretazione microscopica 119. capitolo. capitolo.
 Indice Elettrostatica nel vuoto. Campo elettrico e potenziale 1 1. Azioni elettriche 1 2. Carica elettrica e legge di Coulomb 5 3. Campo elettrico 8 4. Campo elettrostatico generato da sistemi di cariche
Indice Elettrostatica nel vuoto. Campo elettrico e potenziale 1 1. Azioni elettriche 1 2. Carica elettrica e legge di Coulomb 5 3. Campo elettrico 8 4. Campo elettrostatico generato da sistemi di cariche
Un introduzione alla Meccanica Quantistica
 Un introduzione alla Meccanica Quantistica La Teoria che nessuno capisce! Chiunque non resti sconvolto dalla teoria quantistica, sicuramente NON L HA CAPITA N. Bohr Quanto piu` la teoria dei quanti incontra
Un introduzione alla Meccanica Quantistica La Teoria che nessuno capisce! Chiunque non resti sconvolto dalla teoria quantistica, sicuramente NON L HA CAPITA N. Bohr Quanto piu` la teoria dei quanti incontra
IL LASER Come funziona un laser Le tante applicazioni dei laser
 IL LASER Come funziona un laser Le tante applicazioni dei laser Prof. Sanna Luciano 1 La radiazione elettromagnetica La luce è un onda elettromagnetica, a cui è associata una lunghezza d onda (distanza
IL LASER Come funziona un laser Le tante applicazioni dei laser Prof. Sanna Luciano 1 La radiazione elettromagnetica La luce è un onda elettromagnetica, a cui è associata una lunghezza d onda (distanza
Le Caratteristiche della Luce
 7. L Atomo Le Caratteristiche della Luce Quanti e Fotoni Spettri Atomici e Livelli Energetici L Atomo di Bohr I Modelli dell Atomo - Orbitali atomici - I numeri quantici e gli orbitali atomici - Lo spin
7. L Atomo Le Caratteristiche della Luce Quanti e Fotoni Spettri Atomici e Livelli Energetici L Atomo di Bohr I Modelli dell Atomo - Orbitali atomici - I numeri quantici e gli orbitali atomici - Lo spin
mvr = n h e 2 r = m v 2 e m r v = La configurazione elettronica r = e 2 m v 2 (1) Quantizzazione del momento angolare (2) 4 πε.
 La configurazione elettronica Modello atomico di Bohr-Sommerfeld (1913) Legge fondamentale della meccanica classica F = m a. F Coulomb = 1 4 πε. q q ' F r centrifuga = m v r ε =8.85*10-1 Fm-1 (costante
La configurazione elettronica Modello atomico di Bohr-Sommerfeld (1913) Legge fondamentale della meccanica classica F = m a. F Coulomb = 1 4 πε. q q ' F r centrifuga = m v r ε =8.85*10-1 Fm-1 (costante
FAM. Entanglement. Christian Ferrari. Liceo di Locarno
 FAM Entanglement Christian Ferrari Liceo di Locarno Spazio di Hilbert: gli stati puri 1 Lo spazio di Hilbert per modelizzare sistemi a due particelle quantistiche è H = H 1 H 2 dove H 1 e H 2 descrivono
FAM Entanglement Christian Ferrari Liceo di Locarno Spazio di Hilbert: gli stati puri 1 Lo spazio di Hilbert per modelizzare sistemi a due particelle quantistiche è H = H 1 H 2 dove H 1 e H 2 descrivono
I rivelatori. Osservare il microcosmo. EEE- Cosmic Box proff.: M.Cottino, P.Porta
 I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
