DALL ERMENEUTICA DEL SÉ ALLA POLITICA DI NOI STESSI Daniele Lorenzini
|
|
|
- Brigida Martinelli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DALL ERMENEUTICA DEL SÉ ALLA POLITICA DI NOI STESSI Daniele Lorenzini A trent anni di distanza da quando Michel Foucault lo ha pronunciato, mi pare sia fondamentale, oggi, riflettere nuovamente sul suo corso al Collège de France L herméneutique du sujet 1, anche e soprattutto perché si tratta del primo tra i corsi foucaultiani degli anni ottanta ad essere stato pubblicato, rimanendo del resto «isolato» per molto tempo (ben sette anni) in tale posizione d eccezione. Per questo, almeno inizialmente, le letture che ne sono state date hanno raramente avuto la possibilità di situarlo con precisione nel contesto degli altri corsi dello stesso periodo, in particolare dei due che lo avevano preceduto (Du gouvernement des vivants 2 e Subjectivité et vérité 3 ) e dei due che lo seguirono (Le gouvernement de soi et des autres 4 e Le courage de la vérité 5 ). La situazione, però, è molto cambiata, ora che la pubblicazione dei corsi di Foucault degli anni ottanta è quasi giunta al termine (l ultimo a dover comparire, Subjectivité et vérité, vedrà presto la luce grazie al lavoro di edizione di Frédéric Gros). Perciò, al di là della celebrazione di una ricorrenza puramente «cronologica», una riconsiderazione attenta del corso del 1982 si presenta ormai come un compito intellettualmente imprescindibile. Innanzitutto, prendendo spunto dalla posizione «strategica» del corso sull ermeneutica del soggetto, che si colloca in un certo senso esattamente a metà strada nel percorso di ricerca foucaultiano degli anni ottanta, occorrerebbe condurre un serrato confronto tra le tesi sviluppate da Foucault in questo corso e altri tre testi fondamentali e di grande attualità editoriale: in primo luogo, il corso al Collège de France del , Du gouvernement des vivants, pubblicato in Francia nel novembre del 2012 a cura di Michel Senellart; in secondo luogo, le conferenze Sull origine dell ermeneutica del sé 6, pronunciate da Foucault a Berkeley e al Dartmouth College nell autunno del 1980; infine, il corso Mal faire, dire vrai. Fonction de l aveu en justice, tenuto da Foucault a Louvain nella primavera del 1981, e pubblicato in Belgio nel settembre del 2012 a cura di Fabienne Brion e Bernard Harcourt 7. A questi testi si aggiungerà tra breve, come già accennato, il corso al Collège de France del , Subjectivité et 1 M. Foucault, L herméneutique du sujet. Cours au Collège de France , a cura di F. Gros, Seuil/Gallimard, Paris 2001, trad. it. L ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France ( ), Feltrinelli, Milano M. Foucault, Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France , a cura di M. Senellart, Seuil/Gallimard, Paris M. Foucault, Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France , inedito, consultabile presso l IMEC di Caen, Fonds Michel Foucault, C M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France , a cura di F. Gros, Seuil/Gallimard, Paris 2008, trad. it. Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France ( ), Feltrinelli, Milano M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France. 1984, a cura di F. Gros, Seuil/Gallimard, Paris 2009, trad. it. Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France (1984), Feltrinelli, Milano M. Foucault, About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth, «Political Theory», 21, 2, 1993, pp , trad. it. Sull origine dell ermeneutica del sé. Due conferenze al Dartmouth College, a cura di mf / materiali foucaultiani, Cronopio, Napoli M. Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l aveu en justice, a cura di F. Brion e B. Harcourt, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve
2 vérité. Tale confronto è fondamentale (così come lo sarebbe un secondo confronto, quello con i testi successivi al corso sull ermeneutica del soggetto) per far emergere la portata esplicitamente politica che caratterizza l impresa foucaultiana di una genealogia del soggetto moderno, una genealogia che, non a caso, dallo studio del cristianesimo dei primi secoli e delle sue tecniche ermeneutiche, Foucault ha spostato immediatamente en arrière, contrapponendo alle tecniche cristiane del sé gli esercizi ascetici della filosofia antica (greca, ellenistica e romana). Precisamente nella rottura, aperta dal lavoro genealogico, tra l arte cristiana e moderna dell interpretazione del pensiero e l arte di vivere degli Antichi, precisamente nell abisso che separa il sé cristiano (ma anche moderno, cartesiano e freudiano), considerato come un campo di dati soggettivi da interpretare, e il sé antico, che si sottopone invece alla prova di azioni possibili o reali 8 precisamente in questa rottura e in questo abisso, Foucault ha infatti individuato lo spazio di emergenza di ciò che non ha esitato a definire «uno dei principali problemi politici dei nostri giorni», ovvero «la politica di noi stessi» 9. A trent anni di distanza, è dunque essenziale tornare a riflettere e cercare di prendere sul serio questa posta in gioco esplicitamente politica che Foucault ha assegnato alle proprie analisi del pensiero antico. Posta in gioco politica, il cui valore in vista dell elaborazione di possibili strategie di resistenza, o di contro-condotta, mi pare stia progressivamente divenendo evidente anche in Italia, nonostante l influsso ancora forte e, da questo punto di vista, decisamente nefasto delle critiche di Giorgio Agamben e Roberto Esposito 10. Del resto, è proprio ne L herméneutique du sujet che Foucault afferma che la costruzione di [un etica del sé] è un compito urgente, fondamentale, politicamente indispensabile, se è vero che, dopotutto, non esiste un altro punto, originario e finale, di resistenza al potere politico, che non stia nel rapporto di sé con sé 11. Questa breve premessa era necessaria per definire l orizzonte generale dei miei interessi e del mio lavoro più recente su Foucault 12, nonché la posta in gioco del presente contributo. Tuttavia, prenderò qui in esame soltanto uno dei molti punti che meriterebbero di essere affrontati, proponendo qualche 8 Cfr. M. Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé, cit., p Ivi, p Cfr. S. Chignola, Une rencontre manquée ou seulement différée : l Italie, in Ph. Artières, J.-F. Bert, F. Gros e J. Revel (a cura di), Michel Foucault, Éditions de l Herne, Paris 2011, pp ; M. Iofrida, Foucault en Italie, in D. Lorenzini e A. Sforzini (a cura di), Michel Foucault : l Histoire de la folie, cinquante ans après, Kimé, Paris (in corso di pubblicazione). 11 M. Foucault, L ermeneutica del soggetto, cit., p Per il tentativo di sottolineare il valore politico della riflessione foucaultiana degli anni ottanta, mi sia permesso rimandare, in particolare, a D. Lorenzini, Foucault, il cristianesimo e la genealogia dei regimi di verità, «Iride. Filosofia e discussione pubblica», 25, 66, 2012, pp ; Id., Mostrar una vida. Foucault y la (bio)política de la visibilidad, in D. Fernández Agis e Á. Sierra González (a cura di), La biopolítica en el mundo actual. Reflexiones sobre el Efecto Foucault, Laertes, Barcelona 2012, pp ; Id., Para acabar con la verdad-demostración. Bachelard, Canguilhem, Foucault y la historia de los regímenes de verdad, «Revista Laguna», 26, 2010, pp
3 riflessione intorno a una questione ben delimitata: il ruolo della verità all interno delle tecniche del sé pagane e cristiane. Ciò nonostante, cercherò di collocare il più chiaramente possibile questa analisi specifica entro l orizzonte generale appena presentato. Come è noto, l interesse di Foucault per la questione della verità, o meglio della produzione della verità, è molto precoce. In un certo senso, potremmo dire che risale già a Histoire de la folie 13, che poneva appunto il problema della produzione della verità sulla follia, e del nesso che esiste, nelle nostre società occidentali, tra tale produzione e l esercizio del potere (potere di esclusione, di partage tra ragione e déraison, ecc.) 14. Sarà però solo nel corso degli anni settanta, e più compiutamente negli anni ottanta, che Foucault collocherà esplicitamente tale questione dei rapporti tra soggettività, verità ed esercizio del potere al cuore del proprio progetto genealogico. Il corso del , Du gouvernement des vivants, rappresenta senza dubbio, da questo punto di vista, lo snodo fondamentale. È in questo corso, infatti, che Foucault afferma di voler indagare «la nozione di governo degli uomini attraverso la verità» 15 o, più precisamente, la questione del «governo degli uomini attraverso la manifestazione della verità nella forma della soggettività» 16. È qui, inoltre, che Foucault definisce (o meglio ri-definisce) il concetto di «regime di verità» come «ciò che determina gli obblighi degli individui in rapporto alle procedure di manifestazione del vero» 17, e propone di studiare il cristianesimo da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei regimi di verità e, nello specifico, del regime di verità incentrato sugli atti d aveu, gli atti di confessione 18. Come sempre, tuttavia, il punto di partenza di Foucault è un problema attuale, poiché è del nostro presente che si tratta di fare la «storia». Il problema è il seguente: Come, nella nostra civiltà, si sono istituiti i rapporti tra il governo degli uomini, la manifestazione della verità nella forma della soggettività e la salvezza per tutti e per ciascuno? [ ] Perché, in quale forma, in una società come la nostra, esiste un legame tanto profondo tra l esercizio del potere e l obbligo, per gli individui, di farsi attori essenziali all interno delle procedure di manifestazione della verità, all interno delle procedure di aleturgia delle quali il potere ha bisogno? Quale relazione esiste tra il fatto di essere soggetto in una relazione di potere e soggetto attraverso il quale, per il quale e a proposito del quale si manifesta la verità? Cos è questo doppio senso del termine soggetto, 13 M. Foucault, Histoire de la folie à l âge classique, Gallimard, Paris 1972, trad. it. Storia della follia nell età classica, Rizzoli, Milano 1973 (nuova edizione: 2011). 14 Cfr. D. Defert, Volontà di verità e pratica militante in Michel Foucault, intervista a cura di O. Irrera e D. Lorenzini, «materiali foucaultiani», 1, 2, 2012 (in corso di pubblicazione). 15 M. Foucault, Du gouvernement des vivants, cit., p. 12 (quando non diversamente specificato, tutte le traduzioni dal francese o dall inglese all italiano sono mie). 16 Ivi, p Ivi, p Cfr. ivi, p
4 soggetto in una relazione di potere, soggetto in una manifestazione di verità 19? Secondo Foucault, naturalmente, questi due sensi del termine soggetto non sono disgiunti, al contrario: la manifestazione della verità di noi stessi costituisce uno dei fulcri della governamentalità contemporanea, nonché della sua capacità assoggettante (ovvero della sua capacità di costruire soggetti assoggettati). Perciò, nelle conferenze di Berkeley e Dartmouth, Foucault non esiterà a parlare del proprio progetto nei termini di una genealogia del soggetto moderno, una genealogia che non può non cimentarsi con il problema relativo al ruolo che la verità ha giocato, e gioca ancora, nei processi di soggettivazione/assoggettamento degli individui. Un simile progetto doveva quindi cominciare con l analisi del cristianesimo (in quanto esperienza di fondamentale importanza nella configurazione della soggettività occidentale) e di tutta quella serie di tecniche attraverso le quali «il cristianesimo ha legato gli individui all obbligo di manifestare la loro verità [ ] individuale». Più precisamente, si trattava per Foucault di tracciare la genealogia della pratica della confessione, per come quest ultima si è organizzata dalla fine del Medioevo: un integrale «verbalizzazione delle colpe commesse» che deve avvenire «all interno di un rapporto istituzionale con un interlocutore che è il confessore, interlocutore qualificato per ascoltare, fissare una pena [e] accordare la remissione» 20. A tale genealogia, Foucault consacra le lezioni di febbraio e marzo del corso Du gouvernement des vivants, ripercorrendo in successione alcuni dei principali «atti di confessione» che hanno caratterizzato la storia del cristianesimo: il battesimo, la penitenza, la direzione di coscienza. In particolare, è in Tertulliano che Foucault individua il momento storico e teorico d inaugurazione di una serie di fondamentali mutamenti, rispetto al cristianesimo primitivo, nel rapporto tra purificazione dell anima e accesso alla verità. Nella preparazione al battesimo e nel rituale del battesimo, spiega Foucault commentando alcuni brani di Tertulliano, l anima viene inserita «in un processo che la costituisce, certo sempre come soggetto di sapere o soggetto di conoscenza, ma ugualmente [ ] come oggetto di conoscenza» 21. È qui che comincia, «per l Occidente intero», una storia «profondamente nuova e, in ogni caso, molto complessa» dei rapporti tra soggettività e verità. Da una parte, la memoria non sarà più affare di esperienza individuale, ma di tradizione istituita, di dogma, e dall altra la scoperta della verità dell anima da parte dell anima stessa diverrà oggetto di un certo numero di procedure, di tecniche attraverso le quali all anima sarà richiesto ad ogni istante «di dire, di mostrare, di manifestare ciò che è». Foucault afferma così di voler «abbozzare i preliminari di una storia di qualcosa di cui, nella nostra società, non è mai stata fatta davvero l analisi». È la storia del «dimmi chi sei» ingiunzione fondamentale nella civiltà occidentale, che da secoli ordina 19 Ivi, pp. 74, Ivi, p Ivi, p
5 all anima di ognuno di noi: «vai verso la verità, ma non dimenticare di dirmi, nel mentre, chi sei, perché se non me lo dici non arriverai mai alla verità» 22. Questa «innovazione» (che ha radici antiche, naturalmente, ma alla quale Tertulliano e i suoi contemporanei hanno dato un nuovo contenuto) conoscerà uno sviluppo storico peculiare, e sarà rielaborata all interno delle pratiche cristiane di esame e direzione di coscienza. In tale contesto, essa si combinerà con un altra innovazione straordinaria (il cui autore, questa volta, è Cassiano), ovvero con ciò che Foucault, a Berkeley e Dartmouth, e poi anche a Louvain, descrive nei termini della «costituzione del pensiero come un campo di dati soggettivi che richiede un analisi interpretativa». L anima, già oggetto di conoscenza in Tertulliano, diviene allora, più in particolare, la sede dei logismoi, delle cogitationes, dei pensieri 23. L apertura di questo spazio dell interiorità, la trasformazione dell anima-oggetto di conoscenza nel campo delle cogitationes, nel luogo in cui risiedono i pensieri che devono essere verbalizzati per essere interpretati integralmente è in questa apertura, in questa trasformazione, in questa combinazione Tertulliano-Cassiano che va individuato il presupposto fondamentale di ciò che Foucault chiama l ermeneutica del sé, e il cui postulato, «generalmente accettato nelle società occidentali», è che «per la propria salvezza ciascuno ha bisogno di conoscere il più esattamente possibile chi è, e inoltre [ ] deve dirlo il più esplicitamente possibile ad altre persone» 24. Questo «obbligo di parlare, di dire, di dir-vero, di produrre indefinitamente un discorso vero su se stessi», secondo Foucault, «non ha mai cessato di esistere nella cultura cristiana e, verosimilmente, nelle società occidentali»: siamo ancora «obbligati a parlare di noi stessi per dirne-vero» 25. In effetti, Foucault era convinto che l «obbligo dell ermeneutica di se stessi» 26 l obbligo di praticare questa perpetua messa in discorso di se stessi, condizione necessaria per un indefinito lavoro d interpretazione, all interno di un rapporto di obbedienza assoluta all altro (il direttore spirituale, il confessore) si fosse esteso ben al di là del campo religioso, colonizzando e talvolta perfino presiedendo alla costituzione, nel corso del XVIII e del XIX secolo, di molte discipline cosiddette «scientifiche», come la pedagogia, la psichiatria, la psicanalisi, la criminologia, ecc. Il campo specifico nel quale si è prodotta tale «interferenza» tra «le procedure della confessione e la discorsività scientifica» (campo che è stato a sua volta, in un certo senso, prodotto da tale interferenza), è naturalmente quello della sessualità: i pensieri, i desideri, i piaceri individuali, sono chiamati a tenere, da allora, un discorso di verità su se stessi in vista non più della redenzione e della salvezza, ma della guarigione della conquista della salute e della «normalità». Si è costituita così questa cosa improbabile: una scienza-confessione, una scienza che si basava sui rituali della confessione e sui suoi contenuti, una scienza che 22 Ivi, pp M. Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé, cit., pp Ivi, p M. Foucault, Du gouvernement des vivants, cit., p M. Foucault, Mal faire, dire vrai, cit., p
6 presupponeva quest estorsione multiforme ed insistente, e si dava per oggetto l inconfessabile-confessato 27. Questa scienza-confessione di cui parla Foucault ne La volonté de savoir è tuttora una delle istanze principali, o forse l istanza principale, che definisce il regime di verità dominante nelle nostre società occidentali. La genealogia foucaultiana del soggetto moderno si presenta quindi, più precisamente, come una genealogia del nostro regime di verità attuale, ovvero della specifica configurazione dei rapporti tra soggettività e verità che ci caratterizza. È la forza di tale regime di verità, connessa al ruolo egemonico che in esso rivestono le scienze-confessione, a rappresentare per Foucault un problema politico estremamente urgente da affrontare, ed è questo il fondamentale legame con l attualità che intrattengono le analisi da lui svolte durante il corso del La cosa (solo apparentemente) sorprendente è che, per affrontare tale problema, Foucault abbia poi deciso di inaugurare uno studio che lo ha condotto a prendere in considerazione una serie di regimi di verità ancora più antichi di quelli elaborati nel mondo cristiano dei primi secoli regimi nei quali la questione della manifestazione della verità nella forma della soggettività, e del governo di sé e degli altri, possedeva caratteristiche molto diverse da quelle attuali 28. Nel mondo antico, infatti, l ermeneutica del sé non solo non esisteva, ma era letteralmente impensabile. Così, se nell Edipo re di Sofocle si riscontra l emergenza del tema dell autos, del «me stesso», nelle procedure di manifestazione della verità, e se in Platone si può rintracciare una teoria dell anima (in questo caso, però, ciò che si vuole conoscere non è «se stessi» come oggetto, quanto l elemento divino in sé, l elemento divino nella propria anima, la cui conoscenza consentirà al filosofo di elevarsi verso la verità), tuttavia, nel corso dell Antichità greca, ellenistica e romana, non si trova mai l idea di un interiorità psichica, della propria interiorità psichica, come campo di pensieri (o di desideri) che l individuo è chiamato a oggettivare e interpretare, verbalizzandoli a un altro, al fine di scoprire la verità di se stesso 29. Foucault, su questo, è molto chiaro. Per esempio, durante la discussione successiva alle Howison Lectures di Berkeley, il 23 ottobre 1980, risponde così a una domanda proprio su Platone: Credo che, in Platone, sia impossibile trovare un ermeneutica del sé. Si ha una teoria dell anima, ma non un ermeneutica del sé. In Platone non si trova mai qualcosa come l esame di sé, l esame del flusso dei pensieri [ ]. Il problema di Platone è l elevarsi dell anima verso la verità, e non consiste nel trovare la verità nelle profondità dell anima. Seguendo 27 M. Foucault, La volonté de savoir. Histoire de la sexualité 1, Gallimard, Paris 1976, trad. it. La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano 1978, pp Per un tentativo di ricostruire la filosofia dell «ultimo» Foucault alla luce del concetto di «regimi di verità», mi sia permesso rimandare a D. Lorenzini, «El cinismo hace de la vida una aleturgie». Apuntes para una relectura del recorrido filosófico del último Michel Foucault, «Revista Laguna», 23, 2008, pp Cfr. A.I. Davidson, Sulla fine dell ermeneutica del sé, in M. Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé, cit., pp
7 quest analisi [ ] direi, in modo molto schematico, che il conosci te stesso (gnothi seauton) non ha nulla a che fare con l ermeneutica del sé. E che la tradizione filosofica e la storia della coscienza dal conosci te stesso (gnothi seauton) fino a Descartes mi sembra un controsenso, perché non prende in considerazione l innovazione specifica che appare con la spiritualità cristiana [ ] 30. In questa sede, però, vorrei soffermarmi sull interpretazione foucaultiana del De tranquillitate animi di Seneca, per come è presentata nelle conferenze americane dell autunno del Nel quadro ben codificato di un rapporto di direzione di coscienza, Sereno scrive a Seneca per chiedergli consiglio: egli afferma allora di voler dire la verità a Seneca, di volergli descrivere, «confessare» la propria condizione di malessere, nella speranza che Seneca lo possa aiutare. Ma questa verità che Sereno confessa a Seneca non ha nulla a che vedere con peccati, colpe, pensieri segreti o desideri vergognosi 31. Sereno stila piuttosto ciò che Foucault definisce «una sorta di inventario di libertà nel quadro di un codice di azioni»: si tratta, in fondo, di un «bilancio delle dipendenze». Sereno, cioè, spiega a Seneca che la propria libertà incontra ancora degli ostacoli, che egli Sereno è ancora troppo attaccato a una serie di beni esteriori dai quali invece sa che dovrebbe distaccarsi, per raggiungere l autarchia e la tranquillità dell anima, insomma la virtù del saggio 32. Sereno, quindi, non confessa a Seneca né i propri pensieri, né i propri desideri nascosti. E Seneca, dal canto suo, che cosa fa? In quanto direttore di coscienza, anche Seneca è tenuto a dire la verità a Sereno, a dirgli una verità che, naturalmente, ha a che fare con questa condizione di dipendenza di Sereno una verità che sia dunque capace di aiutarlo. Tuttavia, anche in questo caso, la verità che Seneca dice a Sereno non è il risultato di un operazione ermeneutica, di un interpretazione dell interiorità di Sereno, dei suoi pensieri o desideri reconditi. Né corrisponde all esposizione di una teoria filosofica, o di una serie di precetti morali. Sereno, infatti, ha già dimostrato di conoscere perfettamente i grandi princìpi morali necessari a condurre una vita filosofica. Ciò di cui ha bisogno non è dunque una verità intesa come conoscenza teorica, come un aggiunta di contenuti conoscitivi, ma di quella che Foucault, a Berkeley e Dartmouth, chiama una «verità come forza». Mi sembra importante insistere su questo perché, sia nelle pagine del manoscritto preparatorio della lezione al Collège de France del 12 marzo 1980 che Foucault decide di non pronunciare 33, sia nella lezione del 29 aprile 1981 del corso di Louvain 34, nonostante Foucault analizzi il medesimo brano di Seneca, e lo faccia in un contesto teorico molto simile a quello delle conferenze americane ebbene, in nessuno di questi due casi compare l espressione «verità come forza». Un espressione che Foucault non utilizzerà nemmeno 30 M. Foucault, Discussion with philosophers, inedito, consultabile presso l IMEC di Caen, Fonds Michel Foucault, C Cfr. M. Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé, cit., p Ivi, p Cfr. M. Foucault, Du gouvernement des vivants, cit., p Cfr. M. Foucault, Mal faire, dire vrai, cit., pp
8 commentando il De tranquillitate animi durante la lezione del 27 gennaio 1982 del corso sull ermeneutica del soggetto 35, dove però, molto significativamente, egli introdurrà la nozione di parrhesia, il cui nesso con il concetto di «verità come forza» credo sia superfluo esplicitare. Per tornare alle conferenze di Berkeley e Dartmouth, ciò di cui Sereno ha bisogno non è quindi una verità intesa come un aggiunta di contenuti conoscitivi, quanto piuttosto una verità che sia in grado di trasformare ciò che già si conosce in un modo di vita effettivo. Si tratta esattamente del passaggio dal logos all ethos che Foucault, nella lezione del 3 marzo 1982 de L herméneutique du sujet, descriverà nei termini di una «soggettivazione del discorso vero» 36. È precisamente questa verità come forza etica che Seneca cerca di fornire a Sereno, utilizzando una serie di argomenti persuasivi, di dimostrazioni, di esempi, non con l obiettivo di scoprire una verità nascosta nel profondo dell anima di Sereno, non con l obiettivo di svelare la sua vera «natura», né con l obiettivo di insegnargli altri (ulteriori) princìpi teorici, ma al fine di trasformare le verità che Sereno già conosce in verità pratiche, in ethos modo di vivere 37. Il processo di «soggettivazione della verità» di cui Foucault parla a proposito dello stoicismo consiste dunque nella costituzione di un soggetto che è «al tempo stesso, e senza discontinuità, soggetto di conoscenza e soggetto di volontà». Un soggetto che potrebbe quindi essere definito «gnomico», se per gnome si intende designare l unità della forza della verità e della forma della volontà 38. Come già accennato, è senza dubbio qui che andrebbero rintracciate le radici dell interesse foucaultiano per un discorso «vero» nel quale, tuttavia, la verità è una forza etico-politica che non ha nulla a che vedere con la verità nel senso logico o epistemologico del termine. Spingendo indietro nel tempo la propria genealogia del soggetto moderno, e del regime di verità nel quale tale soggetto, nel quale noi siamo inseriti, Foucault si proponeva quindi di interrogare il luogo di nascita di alcuni temi che, dopo essersi trasformati e aver assunto un significato differente, sono poi confluiti nel nostro regime di verità attuale. Tuttavia, egli intendeva anche mettere questo regime di verità «in prospettiva», mostrandoci non soltanto la sua storicità e la sua non-necessità, ma suggerendoci inoltre che esso non è il solo concepibile. Al contrario, è già stato possibile configurare altrimenti il rapporto tra soggettività e verità, è già stato possibile (e dunque lo è ancora) concepire la verità e il soggetto, e la loro relazione, in modo diverso da quello che la confessione cristiana prima, e il discorso della scienza poi, ci hanno suggerito e imposto configurando un regime di verità nel quale il soggetto prende la forma di quello che Foucault chiama, non a caso, «sé gnoseologico» 39, ovvero un sé essenzialmente identificato con il campo del proprio pensiero, concepito a sua volta come insieme di dati soggettivi da interpretare. 35 Cfr. M. Foucault, L ermeneutica del soggetto, cit., pp Ivi, pp Cfr. M. Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé, cit., p Ivi, pp Ivi, p
9 Da questo punto di vista, non c è dubbio che lo scopo principale delle analisi foucaultiane degli anni ottanta, come Foucault afferma esplicitamente a Berkeley e Dartmouth, fosse quello di farci provare l urgente necessità di sbarazzarci sia dell ermeneutica cristiana del sé, sia dell ermeneutica scientifica dell «uomo». Di sbarazzarci, in altri termini, sia dell ingiunzione cristiana secondo la quale dobbiamo scoprire la verità di noi stessi al fine di rifiutarla secondo la quale, cioè, siamo chiamati a scoprire la verità di noi stessi in funzione del sacrificio di noi stessi, dato che tale verità è in realtà il male, è l Altro in noi, è Satana che si è insediato nella nostra natura in seguito al peccato originale 40 ; sia dell invenzione moderna dell «uomo» come correlato essenziale e fondamento positivo delle operazioni ermeneutiche inscritte nel cuore delle scienze umane un invenzione, questa, che in tempi più recenti ha assunto la forma dell ingiunzione all autenticità, secondo la quale la scoperta della verità di noi stessi è necessaria per la nostra «realizzazione» (e dunque, lungi dal rinunciare a tale verità, saremmo invece chiamati a identificarci completamente con essa, ad aderire a essa senza residui) 41. Eppure, secondo Foucault, queste due ingiunzioni sono solo apparentemente antitetiche; o meglio, pur essendo l una il rovescio dell altra, scaturiscono in realtà da due regimi di verità basati entrambi essenzialmente sul principio dell ermeneutica del sé. È questo principio che, attraverso una serie di analisi storiche, Foucault intende mettere radicalmente in discussione, come afferma nel corso di una conversazione con Hubert Dreyfus, svoltasi a Berkeley il 24 ottobre del 1980: [L ermeneutica del sé] consiste nello scoprire, nel cercare, a partire da sé e a partire dalla propria esperienza in quanto esperienza soggettiva, qualcosa che si possa dare universalmente come conoscenza oggettiva dell essere umano. Bene, allora è questo che voglio criticare 42. Ma criticare questo principio dell ermeneutica del sé significa, necessariamente, cercare di sbarazzarsi una volta per tutte dei regimi di verità che su di esso sono stati e sono ancora fondati. Perciò, come già più volte ricordato, Foucault conclude le conferenze di Berkeley e Dartmouth affermando che [f]orse il nostro problema, oggi, è scoprire che il sé non è nient altro che il correlato storico delle tecnologie che abbiamo costruito nella nostra storia. Forse il problema, oggi, è cambiare queste tecnologie, o sbarazzarcene, sbarazzandoci così del sacrificio ad esse connesso. In questo caso, uno dei principali problemi politici dei nostri giorni sarebbe, alla lettera, la politica di noi stessi Cfr. M. Foucault, Du gouvernement des vivants, cit., pp Cfr. Ch. Taylor, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1992, pp M. Foucault, Discussion about books, inedito, consultabile presso l IMEC di Caen, Fonds Michel Foucault, C M. Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé, cit., p
10 È questa prospettiva che connette essenzialmente l etica (il «noi stessi», il nostro rapporto con noi stessi) alla politica che occorre sempre tenere a mente quando si legge e si discute dell «ultimo» Foucault una prospettiva che, del resto, a trent anni dalla pubblicazione de L herméneutique du sujet, mi sembra ancora più attuale che mai. 10
Foucault, il cristianesimo e la genealogia dei regimi di
 Foucault, il cristianesimo e la genealogia dei regimi di verità Daniele Lorenzini To cite this version: Daniele Lorenzini. Foucault, il cristianesimo e la genealogia dei regimi di verità. Iride, Società
Foucault, il cristianesimo e la genealogia dei regimi di verità Daniele Lorenzini To cite this version: Daniele Lorenzini. Foucault, il cristianesimo e la genealogia dei regimi di verità. Iride, Società
Michel Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé. Due conferenze al Dartmouth College, Cronopio, 2012, pp. 114, ISBN
 Michel Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé. Due conferenze al Dartmouth College, Cronopio, 2012, pp. 114, 12.50 ISBN 9788889446751 Claudio Cavallari, Università degli Studi di Padova La pubblicazione
Michel Foucault, Sull origine dell ermeneutica del sé. Due conferenze al Dartmouth College, Cronopio, 2012, pp. 114, 12.50 ISBN 9788889446751 Claudio Cavallari, Università degli Studi di Padova La pubblicazione
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE
 FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
Classe III Sezione D
 Programmazione Individuale a.s. 2018-2019 DISCIPLINA Filosofia LIBRO DI TESTO IO Penso DOCENTE Roberta Maltese Classe III Sezione D Liceo SCIENZE UMANE 1 A.s. Classe Indirizzo Disciplina Prof. 2018/2019
Programmazione Individuale a.s. 2018-2019 DISCIPLINA Filosofia LIBRO DI TESTO IO Penso DOCENTE Roberta Maltese Classe III Sezione D Liceo SCIENZE UMANE 1 A.s. Classe Indirizzo Disciplina Prof. 2018/2019
Filosofia del diritto
 A12 26 Teresa Serra Appunti di Filosofia del diritto a cura di Mario Sirimarco Copyright MMIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133 a/b 00173
A12 26 Teresa Serra Appunti di Filosofia del diritto a cura di Mario Sirimarco Copyright MMIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133 a/b 00173
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO DOTTORATO DI RICERCA IN SOCIOLOGIA, ANALISI SOCIALE, POLITICHE PUBBLICHE X CICLO NUOVA SERIE (A.A. 2009/2010-2011/2012) Abstract I PERCORSI TEORICI DELLA GOVERNAMENTALITÁ.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO DOTTORATO DI RICERCA IN SOCIOLOGIA, ANALISI SOCIALE, POLITICHE PUBBLICHE X CICLO NUOVA SERIE (A.A. 2009/2010-2011/2012) Abstract I PERCORSI TEORICI DELLA GOVERNAMENTALITÁ.
Domenica, 17 dicembre Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano
 Domenica, 17 dicembre 2017 Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano Silvana Borutti Wittgenstein: la filosofia come compito e come risveglio Ora avrei la possibilità di essere una persona
Domenica, 17 dicembre 2017 Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano Silvana Borutti Wittgenstein: la filosofia come compito e come risveglio Ora avrei la possibilità di essere una persona
«L E S S E N Z A D E L L
 Università degli Studi di Roma La Sapienza «L E S S E N Z A D E L L E S S E N Z A D E L L E S S E R E U M A N O N O N E S I S T E» P E R U N A P R E S E N T A Z I O N E D E L L A N A L O G I A S U B J
Università degli Studi di Roma La Sapienza «L E S S E N Z A D E L L E S S E N Z A D E L L E S S E R E U M A N O N O N E S I S T E» P E R U N A P R E S E N T A Z I O N E D E L L A N A L O G I A S U B J
"Il velo di Maya Verità e illusione tra Oriente e Occidente
 "Il velo di Maya Verità e illusione tra Oriente e Occidente Può il pensiero sgombrare la mente dai fantasmi e dalle apparenze e giungere ad una visione nitida delle cose? [PP.1] Bruno Bonandi [PP.2] [PP.3]
"Il velo di Maya Verità e illusione tra Oriente e Occidente Può il pensiero sgombrare la mente dai fantasmi e dalle apparenze e giungere ad una visione nitida delle cose? [PP.1] Bruno Bonandi [PP.2] [PP.3]
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
TEOLOGIA E POSTCRISTIANESIMO
 Carmelo Dotolo TEOLOGIA E POSTCRISTIANESIMO Un percorso interdisciplinare QUERINIANA INDICE GENERALE Introduzione.... 5 1. Verso un mutamento di paradigma? Il cammino interdisciplinare della teologia dopo
Carmelo Dotolo TEOLOGIA E POSTCRISTIANESIMO Un percorso interdisciplinare QUERINIANA INDICE GENERALE Introduzione.... 5 1. Verso un mutamento di paradigma? Il cammino interdisciplinare della teologia dopo
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
> NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
G.W.F. Hegel. Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia
 G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
DISCIPLINA Filosofia LIBRO DI TESTO La meraviglia delle idee DOCENTE Roberta Maltese Classe 3 Sezione I
 DISCIPLINA Filosofia LIBRO DI TESTO La meraviglia delle idee DOCENTE Roberta Maltese Classe 3 Sezione I Indirizzo Liceo Linguistico A.s. Classe Indirizzo Disciplina Prof. 2016/2017 III I Liceo Linguistico
DISCIPLINA Filosofia LIBRO DI TESTO La meraviglia delle idee DOCENTE Roberta Maltese Classe 3 Sezione I Indirizzo Liceo Linguistico A.s. Classe Indirizzo Disciplina Prof. 2016/2017 III I Liceo Linguistico
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA. ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B
 PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
I.C. Don Milani Prato Curricolo verticale di STORIA
 GRIGLIA N 1 Competenza di base a conclusione dell obbligo di istruzione Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in
GRIGLIA N 1 Competenza di base a conclusione dell obbligo di istruzione Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in
PEDAGOGIA DEL CONFLITTO E DELLA MEDIAZIONE. Prof. Andrea Potestio
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PEDAGOGIA DEL CONFLITTO E DELLA MEDIAZIONE (A.A. 2017/2018) Prof. Andrea Potestio Il diritto di punire P. Ricoeur Corso di Pedagogia del conflitto e della mediazione anno
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PEDAGOGIA DEL CONFLITTO E DELLA MEDIAZIONE (A.A. 2017/2018) Prof. Andrea Potestio Il diritto di punire P. Ricoeur Corso di Pedagogia del conflitto e della mediazione anno
Sesso, desiderio e verità in Grecia e a Roma
 Sesso, desiderio e verità in Grecia e a Roma Su Subjectivité et vérité di Michel Foucault di ORAZIO IRRERA e DANIELE LORENZINI Pubblicato in occasione del trentennale della morte di Michel Foucault, il
Sesso, desiderio e verità in Grecia e a Roma Su Subjectivité et vérité di Michel Foucault di ORAZIO IRRERA e DANIELE LORENZINI Pubblicato in occasione del trentennale della morte di Michel Foucault, il
INTRODUZIONE Lorenzo Bernini
 INTRODUZIONE Lorenzo Bernini Senza ombra di dubbio, Michel Foucault può essere annoverato tra quei grandi autori del Novecento che esercitano un ampia influenza sulla riflessione filosofica e politica
INTRODUZIONE Lorenzo Bernini Senza ombra di dubbio, Michel Foucault può essere annoverato tra quei grandi autori del Novecento che esercitano un ampia influenza sulla riflessione filosofica e politica
CONSIGLIO. consigliare ed ascoltare col cuore
 CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
LICEO SCIENTIFICO STATALE GUIDO CASTELNUOVO PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE IV I ANNO SCOLASTICO
 LICEO SCIENTIFICO STATALE GUIDO CASTELNUOVO PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE IV I ANNO SCOLASTICO 2013-2014 Da La filosofia volume 1B N. Abbagnano, G. Fornero, Paravia Unità 5 Capitolo 2: Lo stoicismo 1.
LICEO SCIENTIFICO STATALE GUIDO CASTELNUOVO PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE IV I ANNO SCOLASTICO 2013-2014 Da La filosofia volume 1B N. Abbagnano, G. Fornero, Paravia Unità 5 Capitolo 2: Lo stoicismo 1.
FACOLTÀ DI FILOSOFIA IN FILOSOFIA
 FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea IN FILOSOFIA PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
PROPOSTE FORMATIVE PER L ANNO SCOLASTICO
 PROPOSTE FORMATIVE PER L ANNO SCOLASTICO 2018-2019 Gentile dirigente, gentile docente, in allegato trova le proposte formative che anche quest anno il Premio ITAS propone ai docenti e agli studenti dagli
PROPOSTE FORMATIVE PER L ANNO SCOLASTICO 2018-2019 Gentile dirigente, gentile docente, in allegato trova le proposte formative che anche quest anno il Premio ITAS propone ai docenti e agli studenti dagli
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A
 HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
Gotthard Fuchs TOCCATI DAL DIVINO. Per una mistica della quotidianità. Queriniana
 Gotthard Fuchs TOCCATI DAL DIVINO Per una mistica della quotidianità Queriniana Prefazione «Dal connubio di desiderio e disperazione nasce la mistica». Questa massima del tardo Nietzsche, ormai molto citata,
Gotthard Fuchs TOCCATI DAL DIVINO Per una mistica della quotidianità Queriniana Prefazione «Dal connubio di desiderio e disperazione nasce la mistica». Questa massima del tardo Nietzsche, ormai molto citata,
2. ERMENEUTICA FILOSOFICA
 2. ERMENEUTICA FILOSOFICA 2.1. LA OGGETTIVAZIONE «L uomo non può vivere la sua vita senza compiere al tempo stesso sforzi continui per esprimerla. Le maniere di questa espressione sono molteplici e mutevoli.
2. ERMENEUTICA FILOSOFICA 2.1. LA OGGETTIVAZIONE «L uomo non può vivere la sua vita senza compiere al tempo stesso sforzi continui per esprimerla. Le maniere di questa espressione sono molteplici e mutevoli.
ETICA GENERALE ETICA
 ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
Conversazioni su una Regola Familiare /10
 Conversazioni su una Regola Familiare /10 DECIMA CONVERSAZIONE Un vastissimo programma di educazione di Don Massimo Lapponi OSB La quarta lezione, Un immensa opera educativa, può essere considerata, in
Conversazioni su una Regola Familiare /10 DECIMA CONVERSAZIONE Un vastissimo programma di educazione di Don Massimo Lapponi OSB La quarta lezione, Un immensa opera educativa, può essere considerata, in
6 Fiducia uno perde la fiducia, con che cosa potrà ancora salvarsi?» e ancora: «La fiducia è comunque sempre necessaria, anche quando essa ti ha abban
 Prefazione Nel i secolo a.c. viveva a Roma un liberto di nome Publilio Siro. Era originario della Siria ed era stato deportato a Roma come schiavo. Grazie alla sua intelligenza e alla sua arguzia fu dichiarato
Prefazione Nel i secolo a.c. viveva a Roma un liberto di nome Publilio Siro. Era originario della Siria ed era stato deportato a Roma come schiavo. Grazie alla sua intelligenza e alla sua arguzia fu dichiarato
Le ideologie. dal Novecento al Postmoderno
 Le ideologie dal Novecento al Postmoderno 1. Definizione L ideologia è un sistema di pensiero volto a interpretare e/o governare la realtà. Si tratta, cioè, di un insieme di ideali etici, princìpi, dottrine
Le ideologie dal Novecento al Postmoderno 1. Definizione L ideologia è un sistema di pensiero volto a interpretare e/o governare la realtà. Si tratta, cioè, di un insieme di ideali etici, princìpi, dottrine
Cambia il lavoro cambia il sindacato
 Sandro Antoniazzi Cambia il lavoro cambia il sindacato Venticinque anni dopo Lettera alla classe operaia BiblioLavoro ISBN 978-88-95660-17-2 2011, BiblioLavoro Viale Fulvio Testi, 42 20099 Sesto San Giovanni
Sandro Antoniazzi Cambia il lavoro cambia il sindacato Venticinque anni dopo Lettera alla classe operaia BiblioLavoro ISBN 978-88-95660-17-2 2011, BiblioLavoro Viale Fulvio Testi, 42 20099 Sesto San Giovanni
introduzione :10 Pagina 11 PREFAZIONE
 introduzione 22-12-2008 17:10 Pagina 11 PREFAZIONE In questo libro Laura Cremonesi propone una delle prime sintesi complete sullo spazio e sull importanza della filosofia antica nell opera di Michel Foucault.
introduzione 22-12-2008 17:10 Pagina 11 PREFAZIONE In questo libro Laura Cremonesi propone una delle prime sintesi complete sullo spazio e sull importanza della filosofia antica nell opera di Michel Foucault.
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
Esperimento maieutico di Socrate. Liberamente tratto dal Menone di Platone. Testi di Bruno Jannamorelli Disegni di Silvia Di Loreto
 Esperimento maieutico di Socrate Liberamente tratto dal Menone di Platone Testi di Bruno Jannamorelli Disegni di Silvia Di Loreto 0 Dimmi Dimmi un po, un po, ragazzo, ragazzo, sai sai cheche questa questa
Esperimento maieutico di Socrate Liberamente tratto dal Menone di Platone Testi di Bruno Jannamorelli Disegni di Silvia Di Loreto 0 Dimmi Dimmi un po, un po, ragazzo, ragazzo, sai sai cheche questa questa
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE ISTITUTI TECNICI
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE ISTITUTI TECNICI STORIA OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PRIMO BIENNIO Il docente di Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE ISTITUTI TECNICI STORIA OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PRIMO BIENNIO Il docente di Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati
Filosofia o. Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia
 Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere
Pubblicato per. da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN
 Pubblicato per da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-09823-6 Prima edizione: febbraio 2018 Realizzazione editoriale: Studio Editoriale
Pubblicato per da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-09823-6 Prima edizione: febbraio 2018 Realizzazione editoriale: Studio Editoriale
Il cammino del discernimento nella Comunità Capi
 Il cammino del discernimento nella Comunità Capi l Assistente Ecclesiastico che accompagna P. ROBERTO DEL RICCIO SJ 6 FEBBRAIO 2018 Accompagnare Il compito del presbitero «[ ] spetta ai sacerdoti, [ ]
Il cammino del discernimento nella Comunità Capi l Assistente Ecclesiastico che accompagna P. ROBERTO DEL RICCIO SJ 6 FEBBRAIO 2018 Accompagnare Il compito del presbitero «[ ] spetta ai sacerdoti, [ ]
SIGMUND FREUD ( )
 1. Che cos è la psicoanalisi - La psicoanalisi è al tempo stesso un metodo di cura per le malattie mentali e una teoria di indagine della psiche umana in tutta la sua complessità. - Essa prende le mosse
1. Che cos è la psicoanalisi - La psicoanalisi è al tempo stesso un metodo di cura per le malattie mentali e una teoria di indagine della psiche umana in tutta la sua complessità. - Essa prende le mosse
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Socrate. Atene a.c.
 Socrate Atene 470-399 a.c. La sofistica Movimento filosofico, e più ampiamente etico e culturale, affermatosi nella Grecia antica, e soprattutto in Atene, tra il 5 e il 4 sec. a.c. L insegnamento sofistico
Socrate Atene 470-399 a.c. La sofistica Movimento filosofico, e più ampiamente etico e culturale, affermatosi nella Grecia antica, e soprattutto in Atene, tra il 5 e il 4 sec. a.c. L insegnamento sofistico
KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico
 Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
Kierkegaard l esistenza come possibilità e fede
 l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
UN MOMENTO DI SILENZIO IN CUI QUALCOSA VACILLA *
 UN MOMENTO DI SILENZIO IN CUI QUALCOSA VACILLA * Moustapha Safouan * Un moment de silence où quelque chose vacille, in Sophie Piérac-Daoud e Dominique Platier-Zeitoun, Silences. Paroles de psychanalystes,
UN MOMENTO DI SILENZIO IN CUI QUALCOSA VACILLA * Moustapha Safouan * Un moment de silence où quelque chose vacille, in Sophie Piérac-Daoud e Dominique Platier-Zeitoun, Silences. Paroles de psychanalystes,
EVENTI JESOLO Metodo per essere felici. Io sono una Missione. Festa dei Giovani. di Marco Gallo 1. #Perlavitadeglialtri
 EVENTI JESOLO 2019 Metodo per essere felici 10 Festa dei Giovani 03 di Marco Gallo 1 Io sono una Missione #Perlavitadeglialtri tratto dal libro Marco Gallo: Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare
EVENTI JESOLO 2019 Metodo per essere felici 10 Festa dei Giovani 03 di Marco Gallo 1 Io sono una Missione #Perlavitadeglialtri tratto dal libro Marco Gallo: Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare
1. Agire con le parole 2. Cittadini del conoscere 3. Per una cittadinanza planetaria, attiva,
 Educare alla cittadinanza partecipata 1. 2. Cittadini del conoscere 3. Per una cittadinanza planetaria, attiva, interculturale 4. La partecipazione fra teoria e pratica: nodi metodologici, sfide e scenari
Educare alla cittadinanza partecipata 1. 2. Cittadini del conoscere 3. Per una cittadinanza planetaria, attiva, interculturale 4. La partecipazione fra teoria e pratica: nodi metodologici, sfide e scenari
Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I
 CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
FACOLTÀ DI FILOSOFIA FILOSOFICHE
 FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario
FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario
LA NARRAZIONE TRA MEDICINA E
 LA NARRAZIONE TRA MEDICINA E BIBBIA: UNA PROSPETTIVA DI SENSO. 1 Sr Carla Corbella s.a. 10 giugno 2013 La prospettiva narrativa come una prospettiva di senso rileggere i fatti dell esistenza nell ordine
LA NARRAZIONE TRA MEDICINA E BIBBIA: UNA PROSPETTIVA DI SENSO. 1 Sr Carla Corbella s.a. 10 giugno 2013 La prospettiva narrativa come una prospettiva di senso rileggere i fatti dell esistenza nell ordine
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Senso religioso Qualcuno più grande di noi Religioni primitive Religioni dell antichità Religioni abramitiche La e altre Come si usa
CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Senso religioso Qualcuno più grande di noi Religioni primitive Religioni dell antichità Religioni abramitiche La e altre Come si usa
PRIMO BIENNIO Primo anno. Competenze Abilità Conoscenze Tempi. religioso, in particolare quello cristianocattolico,
 DIPARTIMENTO DI I.R.C. Superare una concezione infantile e preconcetta del sentimento religioso. Individuare la specificità del fenomeno religioso e del suo linguaggio. PRIMO BIENNIO Primo anno Riconoscere
DIPARTIMENTO DI I.R.C. Superare una concezione infantile e preconcetta del sentimento religioso. Individuare la specificità del fenomeno religioso e del suo linguaggio. PRIMO BIENNIO Primo anno Riconoscere
FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q 10 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALBERTO ANDRONICO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q 10 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALBERTO ANDRONICO
Organizzazione delle informazioni Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
 COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI Orientarsi nel tempo e nello spazio, utilizzando gli indicatori spazio/ temporali per riferire esperienze. Osservare e descrivere cambiamenti prodotti su persone, altri
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI Orientarsi nel tempo e nello spazio, utilizzando gli indicatori spazio/ temporali per riferire esperienze. Osservare e descrivere cambiamenti prodotti su persone, altri
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE LINEE GUIDA - II BIENNIO LICEO SCIENZE APPLICATE
 Progetto esecutivo MOD 7.3_2 Pag. 1 /n9 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE LINEE GUIDA - II BIENNIO LICEO SCIENZE APPLICATE ISTITUTO : INDIRIZZO: ARTICOLAZIONE: OPZIONE: ISTITUTO
Progetto esecutivo MOD 7.3_2 Pag. 1 /n9 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE LINEE GUIDA - II BIENNIO LICEO SCIENZE APPLICATE ISTITUTO : INDIRIZZO: ARTICOLAZIONE: OPZIONE: ISTITUTO
filosofia minima conoscenza, etica, estetica
 filosofia minima 2014 2015 conoscenza, etica, estetica KANT Immanuel 1724-1804 KANT indagine preliminare delle forme delle facoltà umane e delle loro possibilità 1. il sentire etico dell Illuminismo: un
filosofia minima 2014 2015 conoscenza, etica, estetica KANT Immanuel 1724-1804 KANT indagine preliminare delle forme delle facoltà umane e delle loro possibilità 1. il sentire etico dell Illuminismo: un
ISTITUTO COMPRENSIVO BRA
 ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 1 Via Vittorio Emanuele, 200-12042 BRA (Cuneo) 0172 412438 C.F.90054270047 Cod. meccanografico: CNIC86400t E-mail: cnic86400t@istruzione.it PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 1 Via Vittorio Emanuele, 200-12042 BRA (Cuneo) 0172 412438 C.F.90054270047 Cod. meccanografico: CNIC86400t E-mail: cnic86400t@istruzione.it PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE
L oggettività dell astrazione. Riflessioni storiche sulla natura della matematica
 L oggettività dell astrazione Riflessioni storiche sulla natura della matematica IL SOGNO DELLA CULTURA SCIENTIFICA DI INIZIO 900 FISICA Problemi aperti per la fisica classica 1865 Maxwell - teoria elettromagnetismo
L oggettività dell astrazione Riflessioni storiche sulla natura della matematica IL SOGNO DELLA CULTURA SCIENTIFICA DI INIZIO 900 FISICA Problemi aperti per la fisica classica 1865 Maxwell - teoria elettromagnetismo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER UN ETICA DELL OSPITALITA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di laurea in Filosofia Elaborato finale PER UN ETICA DELL OSPITALITA ACCOGLIERE LO STRANIERO Relatore: Prof. ANTONIO DA RE Laureando:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di laurea in Filosofia Elaborato finale PER UN ETICA DELL OSPITALITA ACCOGLIERE LO STRANIERO Relatore: Prof. ANTONIO DA RE Laureando:
Perché scegliere il liceo A. B. Sabin?
 Perché scegliere il liceo A. B. Sabin? I nostri indirizzi Liceo Scientifico e relativi indirizzi: Scienze Applicate, Sportivo Potenziamento di fisica sperimentale con laboratorio digitale in una sez. di
Perché scegliere il liceo A. B. Sabin? I nostri indirizzi Liceo Scientifico e relativi indirizzi: Scienze Applicate, Sportivo Potenziamento di fisica sperimentale con laboratorio digitale in una sez. di
Composizione del Dipartimento
 LICEO CLASSICO STATALE GALILEO Via Martelli, 9-50129 FIRENZE Tel. 055216882 - e-mail: FIPC030003@istruzione.it REGISTRO Dipartimento disciplinare Percorso di condivisione didattica per competenze ANNO
LICEO CLASSICO STATALE GALILEO Via Martelli, 9-50129 FIRENZE Tel. 055216882 - e-mail: FIPC030003@istruzione.it REGISTRO Dipartimento disciplinare Percorso di condivisione didattica per competenze ANNO
I SOFISTI E SOCRATE LA PEDAGOGIA NELLA GRECIA CLASSICA CLEMENTE DANIELI «LA MENTE E L ALBERO»
 I SOFISTI E SOCRATE LA PEDAGOGIA NELLA GRECIA CLASSICA CLEMENTE DANIELI «LA MENTE E L ALBERO» LA STORIA IN BREVE 499-479 GUERRE PERSIANE CON LA VITTORIA DELLA GRECIA E IL PERIODO DI MASSIMO SPLENDORE DI
I SOFISTI E SOCRATE LA PEDAGOGIA NELLA GRECIA CLASSICA CLEMENTE DANIELI «LA MENTE E L ALBERO» LA STORIA IN BREVE 499-479 GUERRE PERSIANE CON LA VITTORIA DELLA GRECIA E IL PERIODO DI MASSIMO SPLENDORE DI
Ordinamento didattico (Classe 5) del Corso di Laurea triennale in LETTERE
 5 Ordinamento didattico (Classe 5) del Corso di Laurea triennale in LETTERE Obiettivi formativi CARATTERISTICHE DEL CORSO. Il Corso di Laurea triennale in Lettere (Classe 5) si propone di formare laureati
5 Ordinamento didattico (Classe 5) del Corso di Laurea triennale in LETTERE Obiettivi formativi CARATTERISTICHE DEL CORSO. Il Corso di Laurea triennale in Lettere (Classe 5) si propone di formare laureati
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
CONOSCENZA ED ESPERIENZA
 CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
Introduzione alla storia lezione n. 2. Prof. Marco Bartoli
 Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO
 LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO Argomenti Una definizione di FILOSOFIA Dal mito al logos Le peculiarità della società greca UNA DEFINIZIONE FILOSOFIA: RICERCA RAZIONALE SUI FONDAMENTI DELL ESSERE, DEL
LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO Argomenti Una definizione di FILOSOFIA Dal mito al logos Le peculiarità della società greca UNA DEFINIZIONE FILOSOFIA: RICERCA RAZIONALE SUI FONDAMENTI DELL ESSERE, DEL
LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA
 JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
PASSI BIBLICI DIFFICILI
 Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F
 A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F DUALISMO Ma che cos è il dualismo? Il termine dualismo definisce, in generale, ogni dottrina
A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F DUALISMO Ma che cos è il dualismo? Il termine dualismo definisce, in generale, ogni dottrina
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE
 FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
In I A, di questo percorso, ci vogliamo tenere in mente
 In I A, di questo percorso, ci vogliamo tenere in mente la bellezza di descrivere l oggetto che ci rappresenta e scoprire cosa significa per l altro il suo oggetto. x che è stato bello! Ho capito più cose
In I A, di questo percorso, ci vogliamo tenere in mente la bellezza di descrivere l oggetto che ci rappresenta e scoprire cosa significa per l altro il suo oggetto. x che è stato bello! Ho capito più cose
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE ANNO SCOLASTICO 2018 /19 CLASSE IV B - E Liceo Scientifico
 LICEO A. VOLTA SEZIONI SCIENTIFICO E CLASSICO COLLE DI VAL D ELSA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE ANNO SCOLASTICO 2018 /19 CLASSE IV B - E Liceo Scientifico FINALITA L IRC inserendosi a pieno titolo
LICEO A. VOLTA SEZIONI SCIENTIFICO E CLASSICO COLLE DI VAL D ELSA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE ANNO SCOLASTICO 2018 /19 CLASSE IV B - E Liceo Scientifico FINALITA L IRC inserendosi a pieno titolo
massimo rizzante cornelius castoriadis homo poeticus, homo politicus archivio di saggi 15
 massimo rizzante cornelius castoriadis homo poeticus, homo politicus archivio di saggi 15 CORNELIUS CASTORIADIS HOMO POETICUS, HOMO POLITICUS 2014 Massimo Rizzante Mi chiedo: che cosa significa oggi cercare
massimo rizzante cornelius castoriadis homo poeticus, homo politicus archivio di saggi 15 CORNELIUS CASTORIADIS HOMO POETICUS, HOMO POLITICUS 2014 Massimo Rizzante Mi chiedo: che cosa significa oggi cercare
Programmazione di Circolo RELIGIONE CATTOLICA. Anno Scolastico
 Programmazione di Circolo Anno Scolastico 2014 2015 PREMESSA La Religione Cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico e umano della società italiana, pertanto offre una prima conoscenza
Programmazione di Circolo Anno Scolastico 2014 2015 PREMESSA La Religione Cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico e umano della società italiana, pertanto offre una prima conoscenza
L indagine sulla natura: il pensiero presocratico
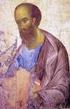 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale
 Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
2 Timoteo 2: 2 Siamo capaci
 2 Timoteo 2: 2 Siamo capaci Spesso la riunione della domenica ci dice il Cosa, ma non il Come, quindi spesso ci si sente impotenti di cambiare e frustrati e alcuni per tali motivi si allontanano dalla
2 Timoteo 2: 2 Siamo capaci Spesso la riunione della domenica ci dice il Cosa, ma non il Come, quindi spesso ci si sente impotenti di cambiare e frustrati e alcuni per tali motivi si allontanano dalla
Istituto per il LogoCounseling 2013 PaoloGiovanni Monformoso
 Istituto per il LogoCounseling 2013 PaoloGiovanni Monformoso L uomo è libero perché l inconscio spirituale costituisce il suo io più profondo, ma l essere dell uomo non si risolve in esso, perché l uomo,
Istituto per il LogoCounseling 2013 PaoloGiovanni Monformoso L uomo è libero perché l inconscio spirituale costituisce il suo io più profondo, ma l essere dell uomo non si risolve in esso, perché l uomo,
Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L-36)
 Insegnamento Livello e corso di studio Settore scientifico disciplinare (SSD) Filosofia politica Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L-36) SPS/01 Anno
Insegnamento Livello e corso di studio Settore scientifico disciplinare (SSD) Filosofia politica Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L-36) SPS/01 Anno
caratteristiche principali dell IRC e ne sa cogliere la valenza. che l uomo si pone e dare risposte motivate
 RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: IMPARARE A IMPARARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: IMPARARE A IMPARARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: STORIA classe Prima
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.P.S.S.C. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel:035 250547 035 253492 Fax:035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.P.S.S.C. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel:035 250547 035 253492 Fax:035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Indice. 1 Pedagogia di Giovanni Gentile
 INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA LEZIONE III GIOVANNI GENTILE PROF. CARMINE PISCOPO Indice 1 Pedagogia di Giovanni Gentile-------------------------------------------------------------------------3
INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA LEZIONE III GIOVANNI GENTILE PROF. CARMINE PISCOPO Indice 1 Pedagogia di Giovanni Gentile-------------------------------------------------------------------------3
L insegnamento del diritto romano nel Belgio nel 2010
 L insegnamentodeldirittoromanonelbelgionel2010 Come conviene insegnare il diritto romano oggi? Ecco la domanda che ci è stata propostadagiannisantucci,l organizzatorediquestoseminario.ledomandedidattiche
L insegnamentodeldirittoromanonelbelgionel2010 Come conviene insegnare il diritto romano oggi? Ecco la domanda che ci è stata propostadagiannisantucci,l organizzatorediquestoseminario.ledomandedidattiche
Schopenhauer Le radici del sistema
 Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale
Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
Corso di Storia della Psicologia
 Corso di Storia della Psicologia Anno accademico 2017/18 Turno 1 Prof. Mauro Antonelli Presentazione del corso Ø Finalità del corso Ø Argomenti del corso Ø Bibliografia Ø Modalità d esame Finalità del
Corso di Storia della Psicologia Anno accademico 2017/18 Turno 1 Prof. Mauro Antonelli Presentazione del corso Ø Finalità del corso Ø Argomenti del corso Ø Bibliografia Ø Modalità d esame Finalità del
LA PROSPETTIVA DEL SÉ
 LA PROSPETTIVA DEL SÉ Ha origine da analisi speculative che si sono sviluppate in ambito filosofico e religioso sin dall antichità classica. In questi ambiti ha avuto origine la concezione unitaria del
LA PROSPETTIVA DEL SÉ Ha origine da analisi speculative che si sono sviluppate in ambito filosofico e religioso sin dall antichità classica. In questi ambiti ha avuto origine la concezione unitaria del
Analisi dei media. Parte seconda - Come studiare i media: alcune prospettive di analisi. La prospettiva ermeneutica. (Selezione di diapositive)
 Analisi dei media Parte seconda - Come studiare i media: alcune prospettive di analisi. La prospettiva ermeneutica. (Selezione di diapositive) Mezzi di comunicazione e modernità Introduzione: J. Thompson,
Analisi dei media Parte seconda - Come studiare i media: alcune prospettive di analisi. La prospettiva ermeneutica. (Selezione di diapositive) Mezzi di comunicazione e modernità Introduzione: J. Thompson,
L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi
 Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Cosa desideri per essere felice? Guida per l insegnante
 ? Guida per l insegnante Obiettivi educativi generali Compito di esplorazione - Comprendere la molteplicità dei punti di vista. - Dare risposte originali. - Essere capace di produrre molte idee. - Diventare
? Guida per l insegnante Obiettivi educativi generali Compito di esplorazione - Comprendere la molteplicità dei punti di vista. - Dare risposte originali. - Essere capace di produrre molte idee. - Diventare
