19. Strutture e oggetti per la preparazione del cibo nell'abitato dell'età del Bronzo di Mursia, Pantelleria (TP).
|
|
|
- Bernadetta Di Stefano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 19. Strutture e oggetti per la preparazione del cibo nell'abitato dell'età del Bronzo di Mursia, Pantelleria (TP). MAURIZIO CATTANI (1), FLORENCIA DEBANDI (2), SEBASTIANO TUSA (3) In questo contributo si vuole focalizzare l'attenzione sul contesto dell'abitato dell'età del Bronzo di Mursia, nell'isola di Pantelleria, eccezionale per conservazione e per articolazione delle strutture. Il rinvenimento di contesti stratigrafici connessi alla produzione, conservazione e consumo di beni ci riporta allo spazio abitato e alle dinamiche che lo caratterizzano sia come organizzazione spaziale, sia come evoluzione cronologica del villaggio abitato almeno per tre secoli. Ricostruire le attività domestiche all'interno di un abitato dell'età del Bronzo è un obiettivo che supera la normale classificazione di strutture e reperti messi in luce in uno scavo archeologico. Struttura sociale, abitudini collettive, esigenze di sussistenza primaria, strategie volte a garantire una continuità di vita sono alla base dei processi che lasciano spesso scarse tracce nella documentazione archeologica. Ci si sofferma in questo breve lavoro sulle tipologie e sulla distribuzione delle strutture connesse alle produzioni alimentari, ma l'obiettivo successivo sarà la comprensione dei significati più strutturali dello spazio abitato, l'organizzazione della struttura sociale e i rapporti tra queste e la produzione e trasformazione delle risorse. L abitato dell'età del Bronzo di Mursia è da diversi anni oggetto di scavo, diretto da S. Tusa, con la partecipazione dell'università di Bologna e dell'università di Napoli Suor Orsola Benincasa, che rispettivamente curano le ricerche nelle aree a monte (settori B, C, E, F) e verso mare (settori A, D) separati dalla moderna strada perimetrale. L'abitato, che si colloca cronologicamente tra il XVIII e il XV sec.a.c., è affacciato sul mare nel lato ovest e delimitato da un imponente muro difensivo nel lato verso terra. All'interno sono state riconosciute numerose capanne, prevalentemente di forma ovale, distribuite in diverse fasi senza tuttavia segnare vere e proprie cesure nella vita del villaggio. Per un inquadramento del sito e dei risultati delle campagne di scavo si rimanda alle precedenti pubblicazioni (Tusa, Marazzi 2005, Ardesia et al 2006, Cattani et al 2012, Cattani et al 2014). Pag.1 L'articolazione interna delle capanne comprende diverse strutture che permettono talvolta di identificare la destinazione d'uso. Nella maggior parte dei casi si può affermare che le capanne abbiano avuto una funzione domestica, in cui sono riconoscibili le attività di preparazione (1) Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, Bologna; maurizio.cattani@unibo.it (2) Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, Bologna; florencia.debandi3@unibo.it (3) Soprintendenza del Mare, Regione Siciliana, Via Lungarini 9, 90133, Palermo; sebtusa@archeosicilia.it
2 degli alimenti. L'elemento più caratterizzante, presente nella maggior parte delle capanne è il focolare strutturato a cista litica (Fig. 1), formato da quattro o più lastre in pietra infisse in verticale nel pavimento, generalmente all'interno di una fossa appositamente realizzata con una inzeppatura di piccole pietre attorno. Di dimensioni variabili (tra 25 e 40 cm di lato), le ciste litiche sembrano identificare la modalità principale di gestire il fuoco, testimoniata dagli strati di riempimento delle strutture, costituiti da cenere e carbone e soprattutto dalle evidenti azioni di rubefazione, che talvolta interessano in modo consistente l'area circostante. Nelle capanne sono presenti almeno una e talvolta due o tre ciste litiche: in alcuni casi è evidente che la diversa disposizione delle ciste è il risultato di modificazioni o sostituzioni nel corso delle fasi di vita, ma in altri è accertata la contemporaneità di almeno due ciste, talvolta appaiate una a fianco dell'altra come nel caso della capanna B15. Le ciste litiche sono presenti fin dalle prime fasi degli ambienti: nella capanna B1 una prima cista litica realizzata in corrispondenza del primo piano pavimentale viene abbandonata, parzialmente smantellata rimuovendo una delle quattro lastre e poi ricoperta dal muretto divisorio che caratterizzerà la capanna fino alle fasi più avanzate, mentre una seconda cista litica viene realizzata nella parte settentrionale della struttura, venendo così a sostituire la precedente. Nella capanna B2 sono presenti allo stesso livello pavimentale due ciste, poco distanti tra loro. Nelle capanne dove non sono state individuate ciste litiche sorge il dubbio che possano essere state rimosse per un riutilizzo delle lastre. Ad es. nella capanna B4, in corrispondenza del primo pavimento è presente un focolare a fossa non strutturato, apparentemente con uno stato di conservazione molto compromesso, al contrario di tutte le altre evidenze riscontrate nella stessa fase. Non è improbabile che il focolare possa essere interpretato come cista litica smantellata. Ben conservata è invece la cista litica installata nella capanna B14 nella fase più antica in corrispondenza dell abside Sud. La cista litica, una struttura a cassetta (US 1046) costituita da 4 lastre posizionate verticalmente con la sommità sporgente sul livello pavimentale era posta all'interno di una fossa che ha tagliato il primo battuto e solidamente fissata grazie ad una inzeppatura di piccole pietre. All'interno della cista è stato rinvenuto un sedimento sciolto di colore nero, ricco di frustoli di carbone e qualche frammento di ossa bruciate. L'utilizzo della cista litica persiste per un lungo periodo, confermata dai successivi battuti che gli si appoggiano, lasciando sempre esposti i bordi superiori. La cista litica sembra essere una struttura ottimale per la gestione del fuoco vivo, potendo controllare la combustione ed evitare che possa espandersi. Quando è presente l'associazione con una piastra di cottura, si può ipotizzare che il fuoco vivo venga accesso all'interno della cista e che solo i carboni ardenti vengano trasferiti sulla piastra per le vere e proprie fasi di cottura degli alimenti. E' interessante notare che in molti casi non si trova attorno o dentro alla cista una gran quantità di terra combusta o carbone, facendo supporre la continua rimozione dei residui di combustione verso aree esterne all'ambiente. Le ciste litiche utilizzate come focolare sembrano essere una peculiarità del sito di Mursia: trovano pochi confronti collocati solo nelle Eolie, a S. Vincenzo di Stromboli (Martinelli 2013, Di Renzoni et al 2014), Capo Graziano a Filicudi (Bernabò Brea, Cavalier 1991, p.98, capanna 3; capanna 5 e capanna 8) dove sono tuttavia interpretate come ripostigli e non come focolari, così come a Panarea, (Bernabò Brea, Cavalier 1968) nella capanna XVI è presente una struttura composta da due lastre parallele infisse nel suolo. La struttura a cassetta litica è ancora più rara in altri contesti siciliani o peninsulari dove raramente si fa riferimento all'uso come focolare domestico (cfr. Coppa Nevigata, Cazzella Moscoloni 1999, pp , fig. 3). Pag.2
3 Fig. 1. Mursia. Ciste litiche. 1. B15 (UUSS1010,1009); 2. B14 (US1046); 3. C1 (UUSS1010, 1009); 4. B14 (US1096); 5. B3. (US809); 6. C4 (US1069). Pag.3 Nell'abitato di Mursia sono presenti anche altre tipologie di focolare, costituite da piccole fosse non strutturate, poste direttamente sul pavimento, o più frequentemente utilizzate in corrispondenza degli strati di abbandono delle strutture e rappresentative di attività presumibilmente non quotidiane e ripetute. Talvolta sono presenti anche piccoli focolari strutturati, delimitati da piccole pietre e ritenuti accessori rispetto alle modalità descritte in precedenza. Molto caratterizzanti le fasi di cottura dei cibi sono invece le strutture a "piastra di cottura" di cui sono state riconosciute almeno tre tipologie definite dalle modalità costruttive e ipoteticamente da una successione cronologica. Possono essere realizzate direttamente sul pavimento in argilla, riconoscibile per l'area di combustione e in un solo caso segnato con un solco che le separa dal resto del piano, oppure con una lastra di pietra posta sul piano pavimentale o infine con una costruzione in rilievo formata da un vespaio di ciottoli o di frr. di ceramica ricoperto da un piano di argilla ben lisciato in superficie. Nel settore D sono frequenti le piastre focolare realizzate sul piano pavimentale (capanne D1, D7 primo livello, D10, D11 primo livello, D14, D16). Nella capanna D7, appartenente alla prima fase del impianto, ha restituito, al centro dell abside Nord, una piastra di cottura
4 quadrangolare ricavata nel battuto pavimentale mediante una profonda incisione al perimetro, larga e profonda 3 cm scavata quando il conglomerato era ancora fresco. Tra le piastre di cottura più antiche rientrano quelle costruite con la lastra in pietra inglobata nel piano pavimentale e ricoperta da uno strato di argilla. Nella capanna B14 in corrispondenza della prima fase di vita, sono state allestite due lastre di pietra collocate rispettivamente nelle metà a Nord e a Sud della struttura, rispettivamente di forma quadrangolare e circolare US 1192 e US 1197 sovrapposte al rifacimento del primo pavimento. Entrambe presentano tracce di rubefazione sulla superficie e nelle aree immediatamente adiacenti, testimoniando un'attività intensa e ripetuta nel tempo. La lastra collocata nell'abside Nord di forma sub-quadrangolare misura 0,63 x 0,70 m per lato e 3 cm di spessore. La lastra collocata nell'abside Sud è molto danneggiata e sembra avere una forma circolare con i bordi più arrotondati. Il diametro è di circa 0,94 m e lo spessore varia tra i 2,5 e 3 cm. La capanna B15 ha restituito una lastra in pietra (US 951), senza rivestimento in argilla, che considerando la rubefazione in superficie e l'associazione con strati carboniosi può essere considerata come piano di focolare. Anche la capanna C4, accanto alla cista litica aveva due lastre in pietra adiacenti ed una terza lastra collocata poco distante (Fig. 2). Pag.4 Fig. 2. Mursia. Piastre realizzate con lastre in pietra. 1. C4: tre lastre a fianco della cista litica (US1069); 2. B14 (US1192); 3. B14 (US 1197) Focolari costituiti da lastricati di pietra sono documentati in altri contesti coevi, nelle Isole Eolie, a partire dalle fasi iniziali del bronzo Antico come testimoniato a Filicudi nello scavo di casa Lopez e nella capanna D (Bernabò Brea, Cavalier 1991), fino al Bronzo Medio (Portella di Salina, Milazzese a Panarea (Bernabò Brea, Cavalier 1968) e al Bronzo Recente (acropoli di Lipari capanne dell insula IV (Bernabò Brea, Cavalier 1980). In una fase successiva, con l'intensificarsi nelle fasi finali vengono realizzate le piastre di cottura in argilla rialzate rispetto al pavimento fino a 10 cm con una base in ciottoli e frr. di ceramica, generalmente di forma circolare od ovale, con una dimensione che varia tra ca. 50 e
5 120 cm di diametro. L apprestamento di queste piastre prevede la stesura di uno spesso strato di argilla con la superficie ben lisciata, piana o leggermente concava, con bordi solitamente arrotondati e molto ben curati. Nel settore B dello scavo di Mursia sono attestate più frequentemente nelle fasi avanzate e non sembrano essere mai abbinate alle ciste litiche. Possono essere collocate in vari punti all interno degli ambienti, ma più frequentemente sono addossate ai muri perimetrali. Nel settore B nella capanna B10 è stata rinvenuta una piastra in argilla di forma perfettamente circolare addossata al muro perimetrale nel lato nord, costruita con una base di ciottoli e ceramica (Ardesia et alii 2006, pp ). Nella capanna B12 sono due le piastre di cottura rinvenute pertinenti a due diverse fasi di vita: la prima di forma circolare (diametro 1 m) si trovava al centro dell area settentrionale; la seconda di forma meno regolare è addossata al muro Est della capanna, all'angolo con un altro muro che divide la struttura. Entrambe sono allettate su un vespaio di piccoli ciottoli e di frr. di ceramica. Nella capanna D7, negli strati relativi ad una fase avanzata, è presente la piastra di cottura circolare in argilla che va a sostituire la precedente costruito sul piano pavimentale. Nella capanna D10 la piastra di cottura (US254) era collocata nella zona centrale del lato Nord addossata al muro. Composta da argilla cotta e lisciata allettata su di un vespaio di ciottoli di circa 1 m di diametro che si innalzava 10 cm dal battuto. Le piastre sono avvicinabili ai focolari in rilievo diffusi in ambito egeo e in Anatolia dal Calcolitico all'età del Bronzo. Sono ben documentati all'interno dell'architettura palaziale, ma un riscontro nella vasta bibliografia ha messo in evidenza anche la loro presenza in contesti domestici. Nell'ambito della Sicilia e delle altre isole è spesso difficile poter fare precisi confronti per la documentazione soprattutto grafica e fotografica carente. Sono presenti nelle Eolie a Lipari, capanna β V (Bernabò Brea, Cavalier 1980, tav. XXXVIII) e nell insediamento di Filo Braccio nell isola di Filicudi dove al centro dello lo spazio all aperto L, è documentata una grande piastra di cottura (Martinelli et alii 2010, pp ). Altri confronti in ambito peninsulare si possono proporre con l'abitato di Porto Perone (Lo Porto 1963) e di Tufariello (Holloway 1975, fig. 60). La documentazione di Pantelleria mostra una possibile evoluzione cronologica dei focolari a piastra circolare: al modello che si colloca nel piano pavimentale e che è identificabile come area di attività per l'arrossamento circolare, o segnata semplicemente da un solco perimetrale, si affianca un modello che utilizza una base litica, costituita da una o più lastre ricoperte talvolta in argilla, fino ad adottare la piastra in argilla in rilievo, realizzata con molta cura e particolarmente rifinita sul bordo. L'evoluzione tecnologica prosegue con l'adozione di una piastra fittile appositamente preparata a quattro settori, ben testimoniata nei siti di Bronzo Medio, come ad Ustica (Holloway, Lukesh 2001, figg e 2.18), e che non è attestata nel sito di Mursia. Non si esclude che il modello più semplice continui ad essere realizzato in tutte le fasi. Particolarmente interessante risulta l'ambiente B5, relativo alla fase finale dell'abitato di Mursia, che ci permette di ricostruire le attività domestiche connesse alla preparazione dei cibi (Ardesia et al 2006, pp ). La struttura, a pianta rettangolare, di piccole dimensioni (12 mq), è anomala rispetto alla norma delle capanne di uso residenziale. I reperti rinvenuti indicano attività di trasformazione di prodotti vegetali, presumibilmente cereali, tramite macine (quattro integre) e un mortaio interrato ed inglobato nel pavimento e attività di cottura dei cibi all'interno di grandi olle (sei integre) e scodelloni (tre integri). Il sistema di cottura prevedeva l'uso di due piastre di cottura, una di forma circolare (US 57) ed un'altra Pag.5
6 ellittica (US84) entrambe rialzate di ca. 10 cm sul piano del pavimento e ottenute con la posa di piccoli ciottoli, rivestiti di uno strato di argilla con superficie lisciata e bordi ben rifiniti. La prima piastra, addossata al muro Sud dell'ambiente, ha un diametro di circa 95 cm, mentre la seconda, che si colloca all'angolo Nord-Ovest misura 75 cm circa. Lo spessore varia tra i 3-5 cm. In prossimità alla piastra centrale (US 57) erano collocati due alari ginecomorfi in terracotta. Pag.6 Fig. 3. Mursia. Piastre focolare con rivestimento in argilla. 1. B5 (US57); 2. B10 (US483); 3. B12 (US866) Gli alari sono gli strumenti mobili connessi alla cottura degli alimenti. A Mursia il tipo di alare frequente è quello ginecomorfo e laddove è stati rinvenuto integro o abbastanza integro è sempre in stretto rapporto con le piastre di cottura. Sono stati rinvenuti negli scavi di Tozzi nel settore A e recentemente nel settore D. La capanna D6 al di sopra di una piastra (US180) aveva un alare e la D7 sempre in fase con una piastra (US 343) ne ha restituito altre due (Ardesia et alii, p ). Una recente conferma è stato il rinvenimento di due alari in prossimità di una piastra nella capanna 1 del settore E, insieme ad una coppa di cottura. La presenza di alari al di sopra delle piastre, insieme a frammenti di olle e grandi scodelloni,
7 contribuisce a ipotizzare una gestione della preparazione degli alimenti utilizzando questi recipienti posti sollevati rispetto al fuoco o ai carboni ardenti tramite gli alari (Fig. 4.1). Completa il quadro sulla preparazione degli alimenti l'uso delle coppe di cottura (Fig. 4.2), che costituiscono una sorta di fornetto rimovibile sotto al quale cuocere svariati alimenti. Sono poste direttamente sul piano della piastra e coperte dalle braci o dal fuoco vivo generando una cottura come in un piccolo forno. Gli alimenti possono essere posti direttamente sul piano della piastra o all'interno di piccoli contenitori come le teglie. A Mursia, sono state individuate strutture che per la loro forma e caratteristiche potrebbero essere confrontabili con i forni di uso alimentare. Nel settore B, in un'area probabilmente a cielo aperto e non più occupata da strutture residenziali al di sopra della capanna B15, sono stati messi in luce una piastra di cottura di forma circolare in argilla (US 866) ed un forno circolare seminterrato del diametro di 1,20 m (Fig. 4.3), costruito con una serie di pietre infisse verticalmente nel terreno per una profondità di circa 30 cm (US868). Il fondo piano, fatto di lastrine di pietra frammiste ad argilla indurita, mostra chiare evidenze di arrossamento, così come le superfici interne delle lastre verticali. Non sono state documentate tracce di una eventuale copertura, ma si ritiene probabile interpretare questa struttura come forno. Una struttura simile, anche se di dimensioni minori è presente tra le capanne B3 e B12 (US 1073). Nell'ambito di attività domestiche rientrano altre tipologie di strutture rinvenute all'interno delle capanne, non connesse con le attività di combustione, ma probabilmente con la conservazione di beni alimentari. Rientrano in questa tipologia strutture in pietra a pianta circolare elevate di ca. 20 cm rispetto al piano pavimentale come nella B14 (Cattani et al 2014, fig. 1), spazi delimitati da lastre infisse verticalmente che si configurano come possibili ripostigli come nella B4 (Ardesia et al 2006, fig. 3). Sempre come contenitori sono documentate nicchie inserite nel muro come mostrano i casi delle capanne B4 e B14. Pag.7 Fig. 4. Mursia. 1. Ricostruzione dell'uso degli alari a sostegno di uno scodellone; 2. Coppa di
8 cottura; 3. Forno (US868). Numerosi sono gli elementi mobili riconducibili ad attività connesse con la preparazione dei cibi: oltre ai vasi in ceramica 1, strumenti in osso, schegge e lame in ossidiana, lamette in selce e qualche sporadico frammento in metallo, sono molto differenziati gli strumenti litici, costituiti prevalentemente da macine, macinelli e mortai (talvolta inseriti nel battuto pavimentale). Meritano un breve approfondimento i cd. vasi litici, interpretabili come strumenti più adatti a pestare dei prodotti piuttosto che a contenerli. Sono ricavati da grosse pietre di trachite o basalto in cui è stata scavata una concavità conica. Quando si ritrovano in contesto primario sono generalmente incassati nel battuto, spesso con l'imboccatura al livello del pavimento. Molti di questi presentano un foro in corrispondenza del fondo che non sembra intenzionale, ma al momento non si può escludere 2 e in alcuni casi oltre il foro era posizionata una pietra che suggerisce una chiusura della perforazione al momento dell'utilizzo. Ad esempio nella capanna B14 incassato nello stesso battuto in cui troviamo le piastre litiche, nella zona centrale della capanna, è stato trovato un mortaio in pietra (US 1238) di 32 cm di diametro esterno e 23 cm interno con concavità conica e fondo forato. Lo strato di riempimento del mortaio conteneva alcuni frammenti di ceramica e ossa inframmezzate a piccole pietre, mentre una pietra a modo di chiusura era collocata nel fondo al di sotto del foro del mortaio. Vicino al mortaio è stato rinvenuto un'altro strumento in pietra di dimensioni minori (16 cm diametro) con un piccolo foro nel centro. Accanto al mortaio era presente una fossa (US 1235) di forma circolare di 50 cm di diametro rivestita di argilla, molto lisciata con l'imboccatura al livello del pavimento. I tre elementi sopra descritti identificano un'area di attività che potrebbe essere connessa alla pressatura o macinatura di prodotti e ipoteticamente immagazzinati all'interno della fossa in argilla. Anche la capanna D7, sulla fine della banchina nell'abside Nord e infisso nel battuto, presentava un vaso litico con foro passante al fondo. Altri casi come l'ambiente C4, presenta sullo stesso pavimento in cui era inserita la cista litica (US 1056) di forma rettangolare un mortaio (reperto: C14001) di forma ovale allungato (52 x 32 cm) con una vasca ben conservata e a poca distanza, frammisto alle pietre del crollo un piccolo mortaio (reperto: C14018) di forma più arrotondata (29 x 23 cm). La presenza di macinelli nelle vicinanze fanno immaginare il loro utilizzo per la macinatura dei cereali. Tra le altre tipologie di strutture rinvenute all'interno degli ambienti si segnala il caso particolare, per ora risultato unico, di impianti interpretati come palmenti nella capanna B6, per cui si è ipotizzata la produzione di olio. Per questo contesto si rimanda alle descrizioni di strutture e materiali già editi (Marcucci 2008, Ardesia et al 2012). Pag.8 Conclusioni Una ricostruzione delle operazioni connesse alla preparazione del cibo nell'abitato dell'età del Bronzo di Mursia è ancora difficile. L'ottimo stato di conservazione dei contesti ci suggerisce che potessero essere tante le modalità applicate ed è probabile che le strutture di combustione avessero un ruolo polifunzionale, con differenti modalità di funzionamento connesse con attività non solo di preparazione alimentare. Lo studio dei resti archeobotanici e archeozoologici ci permette di integrare la catena alimentare fondata sui prodotti a base ceralicola, integrata da una fortissima disponibilità di proteine evidenziata dal consumo di animali domestici in alcuni casi macellati a pochi mesi di vita. 1 2 Per la discussione sull'uso dei recipienti ceramici si rimanda alla comunicazione di Magrì, Cattani, Tusa. Macine e macinelli richiedono uno studio più approfondito da quanto si presenta in questo contributo.
9 Lo studio delle strutture di combustione mostra procedure differenziate volte alla cottura di prodotti macinati e di impasti farinacei collocati direttamente sulle piastre utilizzando teglie e coppe di cottura. Le stesse piastre di cottura sono ottimali anche per altri scopi come la tostatura dei cereali o la preparazione delle carni. Fig. 5. Mursia. Mortai o cd. vasi litici. 1. B13 ; 2 B7 (US718).; 3. B13 ; 4. B6 (US616); 5. A5; 6.C4 (rep.c14001). Questa particolarità ci permette di ipotizzare una trasformazione nelle abitudini di utilizzo delle piastre, in cui da una prima fase che prevede il contatto diretto con il presumibile utilizzo di braci ardenti poste sulla superficie ampiamente riscaldata che ne garantivano la diffusione uniforme del calore, si passa ad un utilizzo del fuoco più diretto, agevolato dall'uso degli alari. Le prime piastre in pietra (rivestite o no in argilla) si riscaldano molto velocemente e richiedono l'aggiunta di braci prodotte all'interno delle ciste litiche. Le piastre in argilla richiedono un tempo maggiore per il riscaldamento, ma mantengono a lungo il calore accumulato, ipoteticamente anche per 2 o 3 ore soprattutto se sostenuto da fiamma viva. Pag.9 Bibliografia: ARDESIA V., CATTANI M., MARAZZI M., NICOLETTI F., SECONDO M., TUSA S. 2006, Gli scavi nell abitato dell età del Bronzo di Mursia, Pantelleria (TP). Relazione preliminare delle campagne , RSP, vol. LVI, pp ARDESIA V., CATTANI M., MARCUCCI S., PETRINELLI PANNOCCHIA C., SECONDO M. 2012, Le strutture produttive della capanna B6 di Mursia, Atti XLI RSIIPP, Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica, San Cipirello novembre 2006, Firenze, pp BERNABÒ BREA L., CAVALIER M. 1968, Stazioni preistoriche delle isole Panarea, Salina e Stromboli, Meligunìs Lipára III Flaccovio: Palermo.
10 BERNABÒ BREA L., CAVALIER M. 1980, L'acropoli di Lipari nella preistoria, Meligunìs Lipára IV Flaccovio: Palermo. BERNABÒ BREA L., CAVALIER M. 1991, Filicudi: insediamenti dell età del bronzo, Meligunìs Lipára VI Flaccovio: Palermo. CATTANI M., NICOLETTI F., TUSA S. 2012, Resoconto preliminare degli scavi dell insediamento di Mursia (Pantelleria), Atti XLI RSIIPP, Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica, San Cipirello novembre 2006, Firenze, pp CATTANI M., DEBANDI F. MAGRÌ A, PEINETTI A., TUSA S. 2014, Mursia, Pantelleria (TP), Notiziario di Preistoria e Protostoria, IV. Neolitico ed età dei Metalli Sardegna e Sicilia, pp DOLFINI A. 2005, Lo spazio abitativo come spazio sociale: le case di Sorgenti della Nova nel quadro della protostoria italiana, in P. ATTEMA, A. NIJBOER AND A. ZIFFERERO (eds.), Papers in Italian Archaeology VI: Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period. British Archaeological Reports, International Series 1452(1), Oxford: Archaeopress, pp CAZZELLA, A., RECCHIA, G. 2008, A fuoco lento: strutture di combustione nell'abitato dell'età del Bronzo di Coppa Nevigata (Manfredonia - FG), in III International Meeting of Anthracology, BAR Int. S. 1807, Oxford, pp DI RENZONI A., BETTELLI M., CANNAVÒ V., FERRANTI F., LEVI S.T., MARTINELLI M.C. 2014, San Vincenzo, Isola di Stromboli (Lipari, Prov. di Messina) -Campagna 2013, Notiziario di Preistoria e Protostoria, IV. Neolitico ed età dei Metalli Sardegna e Sicilia, pp GIANNITRAPANI E., GRILLO F. M., SPECIALE C., 2014, Household archaeology nella preistoria siciliana in Agathòn RFCA &RCAPIA PhD Journal. Recupero dei Contesti Antichi e Processi Innovativi nell'architettura, ARACNE editrice, Palermo, pp HOLLOWAY R. R. 1975, Buccino: the Early Bronze Age village of Tufariello, Journal of Field Archaeology, 2, pp HOLLOWAY R. R., LUKESH S.S. 2001, Ustica II, Archeologia Transatlantica XIX. JONGSMA T., GREENFIELD H. J. 2002, The household as behaviour: an anthropological perspective in NIKOLOVA L., a cura di, Material evidence and cultural pattern in prehistory contributions to the theory and history of the household and burial customs. International Institute of Anthropology Prehistory Foundation, Salt Lake City, Sofia, Karlovo. LO PORTO F. G., 1963, Leporano (Taranto). La stazione protostorica di Porto Perone, in NSc, serie ottava, vol. XVII, pp LO PORTO F. G., 1970, L attività archeologica in Puglia, in Atti del nono convegno di studi sulla Magna Grecia, Napoli, 1970, pp MARAZZI M., TUSA S. 2005a, Egei in occidente. Le più antiche vie marittime alla luce dei nuovi scavi sull isola di Pantelleria, in Emporia, pp MARCUCCI S. 2008, La capanna B6 dell abitato dell Antica Età del Bronzo di Mursia (Pantelleria TP) e le strutture produttive domestiche, Ipotesi di Preistoria, vol. 1, 1, pp MARTINELLI M.C., et alii. 2010, Nuove ricerche nell insediamento sull istmo di Filo Braccio a Filicudi. Nota preliminare sugli scavi ORIGINI XXXII, Nuova Serie IV,. pp MARTINELLI M.C., LEVI S.T. 2013, Eolie, un'età dell'oro, Archeo XXIX, 11 Novembre 2013, pp NICOLETTI F., TROJSI G., TUSA S. 2012, Analisi tipologiche e mineralogico-petrografiche sui conglomerati architettonici delle capanne dell età del Bronzo di Mursia (Pantelleria) in Atti XLI RSIIPP, Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica, San Cipirello novembre 2006, Firenze, pp Pag.10 RIASSUNTO - STRUTTURE E OGGETTI PER LA PREPARAZIONE DEL CIBO NELL'ABITATO DELL ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA, PANTELLERIA (TP) - Le capanne di Mursia sono frequentemente caratterizzate da strutture domestiche connesse con le produzioni alimentari. Il contributo prende in esame le strutture di combustione costituite da ciste litiche, focolari semplici e strutturati e le piastre di cottura cercando di ricostruire la sequenza di azioni che si svolgevano quotidianamente per la preparazione dei cibi. La ricca documentazione delle strutture in ottimo stato di conservazione permettono di approfondire le tematiche di gestione del fuoco e di cottura degli alimenti con una proposta di modifiche diacroniche che portano all'adozione degli alari e delle coppe di cottura combinate alle piastre in argilla come soluzione adottata nelle fasi avanzate dell'abitato.
11 Completa il quadro una breve considerazione degli strumenti accessori utilizzati per la trasformazione dei beni, con particolare riferimento alla macinatura e pressatura di prodotti vegetali. SUMMARY - FEATURES AND FINDS FOR FOOD CONSUMPTION AT THE BRONZE AGE SETTLEMENT OF MURSIA, PANTELLERIA (TP) - The dwellings at the settlement of Mursia are characterized by several domestic features linked with the preparation of food. This paper deals with the fire structures, square features made of lithic slabs, hearths and cooking platforms made of stone or clay, trying to reconstruct the daily operational actions. The good state of preservation and the richness of available documentation allow to go in depth with the use of fire and with the cooking systems. A further proposal suggests a diachronic evolution that ends with the choice of use of andirons and cooking mugs above clay platforms in the later phases of the settlement. A short presentation of stone tools (querns, grinders and mortars) used next to the cooking features, completes the procedures of preparation of food in the phases of grinding and pressing vegetal products. Pag.11
NOTIZIARIO. San Vincenzo - Stromboli. Campagna 2012
 NOTIZIARIO San Vincenzo - Stromboli. Campagna 2012 Le campagne di scavo di giugno e ottobre 2012 nel sito di San Vincenzo sull'isola di Stromboli (Bettelli et al. 2010; 2011; Levi et al. 2011), hanno avuto
NOTIZIARIO San Vincenzo - Stromboli. Campagna 2012 Le campagne di scavo di giugno e ottobre 2012 nel sito di San Vincenzo sull'isola di Stromboli (Bettelli et al. 2010; 2011; Levi et al. 2011), hanno avuto
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
LA CAPANNA B14 DELL'ABITATO DELL'ETA' DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA)
 VOL. 7 2015 PP. 71-136 ISSN 1974-7985 LA CAPANNA B14 DELL'ABITATO DELL'ETA' DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA) Florencia Debandi 1 PAROLE CHIAVE Abitato; Mursia; Pantelleria; età del Bronzo; capanna; cista
VOL. 7 2015 PP. 71-136 ISSN 1974-7985 LA CAPANNA B14 DELL'ABITATO DELL'ETA' DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA) Florencia Debandi 1 PAROLE CHIAVE Abitato; Mursia; Pantelleria; età del Bronzo; capanna; cista
Fig. 51 Campioni delle tecniche murarie riconosciute nel palazzo.
 LE TECNICHE MURARIE Presentiamo in questa sede i primi risultati del lavoro di ricerca e documentazione sulle tecniche murarie in S. Giovanni Valdarno, relativamente al Palazzo d'arnolfo. Tutte le murature
LE TECNICHE MURARIE Presentiamo in questa sede i primi risultati del lavoro di ricerca e documentazione sulle tecniche murarie in S. Giovanni Valdarno, relativamente al Palazzo d'arnolfo. Tutte le murature
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO A VAGNARI. (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO-AGOSTO 2015 RAPPORTO PRELIMINARE
 LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO-AGOSTO 2015 RAPPORTO PRELIMINARE Prof.ssa Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO-AGOSTO 2015 RAPPORTO PRELIMINARE Prof.ssa Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
L analisi stratigrafica delle murature in elevato
 Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia
 Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO (VICUS) A VAGNARI. (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO 2012 RAPPORTO PRELIMINARE
 LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO (VICUS) A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO 2012 RAPPORTO PRELIMINARE Dr. Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street Sheffield,
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO (VICUS) A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO 2012 RAPPORTO PRELIMINARE Dr. Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street Sheffield,
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
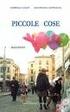 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
4000 anni fa sotto il vulcano. Il villaggio protostorico di San Vincenzo a Stromboli
 4000 anni fa sotto il vulcano Il villaggio protostorico di San Vincenzo a Stromboli Direzione Maria Clara Martinelli Sara Levi Marco Bettelli Vice-direzione Andrea Di Renzoni Francesca Ferranti Collaborazioni
4000 anni fa sotto il vulcano Il villaggio protostorico di San Vincenzo a Stromboli Direzione Maria Clara Martinelli Sara Levi Marco Bettelli Vice-direzione Andrea Di Renzoni Francesca Ferranti Collaborazioni
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO Centro Studi di Preistoria e Archeologia
 PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO 2015 Centro Studi di Preistoria e Archeologia Direttore Scientifico Nuccia Negroni Catacchio: Università degli studi di Milano e Centro studi di Preistoria
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO 2015 Centro Studi di Preistoria e Archeologia Direttore Scientifico Nuccia Negroni Catacchio: Università degli studi di Milano e Centro studi di Preistoria
LA FASE TARDA DELL'ABITATO DI MURSIA NELL'AREA NORD-OVEST DEL SETTORE B
 VOL. 7 2015 PP. 137-264 ISSN 1974-7985 LA FASE TARDA DELL'ABITATO DI MURSIA NELL'AREA NORD-OVEST DEL SETTORE B Alessandra Magrì 1 PAROLE CHIAVE: Abitato, Mursia, Pantelleria, età del Bronzo, capanne, ceramica.
VOL. 7 2015 PP. 137-264 ISSN 1974-7985 LA FASE TARDA DELL'ABITATO DI MURSIA NELL'AREA NORD-OVEST DEL SETTORE B Alessandra Magrì 1 PAROLE CHIAVE: Abitato, Mursia, Pantelleria, età del Bronzo, capanne, ceramica.
Un viaggio nell età del Bronzo. Proposta didattica
 Un viaggio nell età del Bronzo. Proposta didattica Il Comune di Solarolo propone alle scuole un offerta didattica da svolgere all aperto presso il sito archeologico di via Ordiere, un villaggio di 3500
Un viaggio nell età del Bronzo. Proposta didattica Il Comune di Solarolo propone alle scuole un offerta didattica da svolgere all aperto presso il sito archeologico di via Ordiere, un villaggio di 3500
GLI SCAVI NEL SETTORE B DELL'ABITATO DELL'ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA)
 VOL. 7 2015,1 PP. 1-16 ISSN 1974-7985 GLI SCAVI NEL SETTORE B DELL'ABITATO DELL'ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA) Maurizio Cattani 1 PAROLE CHIAVE Abitato, Mursia, Pantelleria, età del Bronzo, stratigrafia,
VOL. 7 2015,1 PP. 1-16 ISSN 1974-7985 GLI SCAVI NEL SETTORE B DELL'ABITATO DELL'ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA) Maurizio Cattani 1 PAROLE CHIAVE Abitato, Mursia, Pantelleria, età del Bronzo, stratigrafia,
01. Metodi e strategie
 01. Metodi e strategie dello scavo stratigrafico Metodi e strategie Metodi di scavo: arbitrario o stratigrafico Strategie: per trincee, per quadrati, per grandi aree ecc. Metodi arbitrari Rimozione sommaria
01. Metodi e strategie dello scavo stratigrafico Metodi e strategie Metodi di scavo: arbitrario o stratigrafico Strategie: per trincee, per quadrati, per grandi aree ecc. Metodi arbitrari Rimozione sommaria
Tre finestre rettangolari, decorate con vetri multicolore raffiguranti S. Pietro, S. Paolo e Gesù Cristo, illuminano la cantoria e la navata centrale
 Descrizione Oggetto Esterno La Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo presenta una tipica facciata a capanna (fotografia 1). Il portale principale (fotografia 2), recante il simbolo del Giubileo del 2000 (fotografia
Descrizione Oggetto Esterno La Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo presenta una tipica facciata a capanna (fotografia 1). Il portale principale (fotografia 2), recante il simbolo del Giubileo del 2000 (fotografia
REGIONE SICILIANA. Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana.
 REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento
REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento
CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 4/2011 TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. LIQUIDAZIONE DEI BENI OFFERTI ALLA MASSA DEI CREDITORI DELLA ELDO ITALIA SPA
 CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 4/2011 TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. LIQUIDAZIONE DEI BENI OFFERTI ALLA MASSA DEI CREDITORI DELLA ELDO ITALIA SPA IMMOBILI OGGETTO DI CESSIONE IMMOBILE COMMERCIALE VIA PONTEGRADELLA,
CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 4/2011 TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. LIQUIDAZIONE DEI BENI OFFERTI ALLA MASSA DEI CREDITORI DELLA ELDO ITALIA SPA IMMOBILI OGGETTO DI CESSIONE IMMOBILE COMMERCIALE VIA PONTEGRADELLA,
Il Forno del Nonno ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI FORNI LINEA PROFESSIONALE (P120, P140, P140L)
 Il Forno del Nonno ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI FORNI LINEA PROFESSIONALE (P10, P140, P140L) PREPARAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO E POSIZIONAMENTO: I FORNI PROFESSIONALI SONO COSTRUITI SU UNA BASE DI CALCESTRUZZO
Il Forno del Nonno ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI FORNI LINEA PROFESSIONALE (P10, P140, P140L) PREPARAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO E POSIZIONAMENTO: I FORNI PROFESSIONALI SONO COSTRUITI SU UNA BASE DI CALCESTRUZZO
Fondamenti di Archeologia Archeologia e contesti archeologici
 Fondamenti di Archeologia Archeologia e contesti archeologici L archeologia è una disciplina che cerca di ricostruire i processi storici a partire dagli oggetti Fuori contesto? Recupero di oggetti da
Fondamenti di Archeologia Archeologia e contesti archeologici L archeologia è una disciplina che cerca di ricostruire i processi storici a partire dagli oggetti Fuori contesto? Recupero di oggetti da
Premio Bandiera 2012 Gubbio
 Premio Bandiera 2012 Gubbio Comunicato stampa scavi a Col di Marzo (PG) campagna 2013 L alimentazione degli Etruschi La valle dominata dall abbazia di Montelabate si arricchisce di nuova storia, anzi
Premio Bandiera 2012 Gubbio Comunicato stampa scavi a Col di Marzo (PG) campagna 2013 L alimentazione degli Etruschi La valle dominata dall abbazia di Montelabate si arricchisce di nuova storia, anzi
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA
 DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
Descrizione generale della proprietà
 Descrizione generale della proprietà La proprietà si estende su una superficie di 1523m2 in Via al Piano 6 nel Comune di Sementina, ai margini della zona agricola del Piano di Magadino, in un quartiere
Descrizione generale della proprietà La proprietà si estende su una superficie di 1523m2 in Via al Piano 6 nel Comune di Sementina, ai margini della zona agricola del Piano di Magadino, in un quartiere
Introduzione all archeologia percorso per le classi terze della scuola primaria
 Introduzione all archeologia percorso per le classi terze della scuola primaria SINTESI DELL INCONTRO SUGLI SCAVI DI ANZOLA E LE TERREMARE La storia delle ricerche archeologiche relative all Età del Bronzo,
Introduzione all archeologia percorso per le classi terze della scuola primaria SINTESI DELL INCONTRO SUGLI SCAVI DI ANZOLA E LE TERREMARE La storia delle ricerche archeologiche relative all Età del Bronzo,
Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia
 Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia Rapporto sulla campagna 2010 (Michael Heinzelmann Manuel Buess) Dal 26/7 al 31/8/2010 l Istituto Archeologico dell
Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia Rapporto sulla campagna 2010 (Michael Heinzelmann Manuel Buess) Dal 26/7 al 31/8/2010 l Istituto Archeologico dell
I CONTENITORI PER GRANO DESTINATI ALL'AMMASSO PUBBLICO DELLA "TERRA NUOVA"
 I CONTENITORI PER GRANO DESTINATI ALL'AMMASSO PUBBLICO DELLA "TERRA NUOVA" Nell'area esterna al palazzo, delimitata dal porticato più recente, sono stati individuati 18 silos per granaglie (1), quasi tutti
I CONTENITORI PER GRANO DESTINATI ALL'AMMASSO PUBBLICO DELLA "TERRA NUOVA" Nell'area esterna al palazzo, delimitata dal porticato più recente, sono stati individuati 18 silos per granaglie (1), quasi tutti
Dati generali. Villa Vergani - Bonora. n/r. edificio residenziale unifamiliare. privata. utilizzato parzialmente utilizzato non utilizzato
 Dati generali Denominazione Villa Vergani - Bonora Localizzazione via Pordenone 60-64, angolo via S. Vito Datazione fra il 1913 ed il 1928 Autore Oggetto edificio residenziale unifamiliare Proprietà privata
Dati generali Denominazione Villa Vergani - Bonora Localizzazione via Pordenone 60-64, angolo via S. Vito Datazione fra il 1913 ed il 1928 Autore Oggetto edificio residenziale unifamiliare Proprietà privata
Tarquinia, complesso monumentale : ceramica depurata acroma e a bande
 XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
NOTA SU ALCUNI MATERIALI LITICI DELL AMBIENTE B13 NELL'ABITATO DELL'ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA)
 VOL. 7 2015,1 PP. 265-271 ISSN 1974-7985 NOTA SU ALCUNI MATERIALI LITICI DELL AMBIENTE B13 NELL'ABITATO DELL'ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA) Davide Mengoli 1 PAROLE CHIAVE Abitato, Mursia, Pantelleria,
VOL. 7 2015,1 PP. 265-271 ISSN 1974-7985 NOTA SU ALCUNI MATERIALI LITICI DELL AMBIENTE B13 NELL'ABITATO DELL'ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA) Davide Mengoli 1 PAROLE CHIAVE Abitato, Mursia, Pantelleria,
SITI DELL ETÀ MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB)
 SITI DELL ETÀ del BRONZO NEL MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB) L e ricerche archeologiche in due siti interni del Molise riferibili all età del Bronzo, condotte
SITI DELL ETÀ del BRONZO NEL MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB) L e ricerche archeologiche in due siti interni del Molise riferibili all età del Bronzo, condotte
PROGRAMMA/ORDINE DELLE DEMOLIZIONI (Art. 151 del Testo Unico della sicurezza D.Lgs 81/08) E DICHIARAZIONE DI IDONEITA STATICA
 PROGRAMMA/ORDINE DELLE DEMOLIZIONI (Art. 151 del Testo Unico della sicurezza D.Lgs 81/08) E DICHIARAZIONE DI IDONEITA STATICA DESCRIZIONE DELL AREA DI CANTIERE Il cantiere confina con le seguenti vie:
PROGRAMMA/ORDINE DELLE DEMOLIZIONI (Art. 151 del Testo Unico della sicurezza D.Lgs 81/08) E DICHIARAZIONE DI IDONEITA STATICA DESCRIZIONE DELL AREA DI CANTIERE Il cantiere confina con le seguenti vie:
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CLAUDIO NEGRELLI. Castelli tardoantichi 2
 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 2014-2015 CLAUDIO NEGRELLI Castelli tardoantichi 2 I castelli bizantini della Liguria Il problema dei castelli altomedievali in Liguria viene trattato per la prima volta da D. Bullough,
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 2014-2015 CLAUDIO NEGRELLI Castelli tardoantichi 2 I castelli bizantini della Liguria Il problema dei castelli altomedievali in Liguria viene trattato per la prima volta da D. Bullough,
SCHEDA RIVESTIMENTO NO.1
 SCHEDA RIVESTIMENTO NO.1 Locale 50 m, attività sportiva per mezzo di pistola. Rivestimento Fonoassorbente speciale, utilizzato in ambiti con esigenze elevate come uno Stand di Tiro o una camera per registrazioni
SCHEDA RIVESTIMENTO NO.1 Locale 50 m, attività sportiva per mezzo di pistola. Rivestimento Fonoassorbente speciale, utilizzato in ambiti con esigenze elevate come uno Stand di Tiro o una camera per registrazioni
III. I VETRI. BAUMGARTNER, KRUEGER 1988, p
 III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
Manciano. Sito Complesso Architettonico 1. Francesca Cheli. Corpo di Fabbrica 1. Piano 1. Piano 2
 Manciano Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 325, n. 27.1; COLLAVINI 1998, pp. 199n, 323-24, 363, 375n, 377n, 409, 561; CORRIDORI 2004, p. 409-415; MACCARI, NOCCIOLI 1995; Repertorio
Manciano Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 325, n. 27.1; COLLAVINI 1998, pp. 199n, 323-24, 363, 375n, 377n, 409, 561; CORRIDORI 2004, p. 409-415; MACCARI, NOCCIOLI 1995; Repertorio
Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive
 Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive L attività di ricerca archeologica nelle due Università sarde, nel settore della Preistoria e della Protostoria, si
Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive L attività di ricerca archeologica nelle due Università sarde, nel settore della Preistoria e della Protostoria, si
FORNO CON PAVIMENTO GIREVOLE PER ESTERNO CON MAIOLICHE Forno con pavimento girevole realizzato con materiali idonei per essere collocato esternamente
 FORNO CON PAVIMENTO GIREVOLE PER ESTERNO CON MAIOLICHE Forno con pavimento girevole realizzato con materiali idonei per essere collocato esternamente senza necessità di copertura e fornito di tappo parapioggia.
FORNO CON PAVIMENTO GIREVOLE PER ESTERNO CON MAIOLICHE Forno con pavimento girevole realizzato con materiali idonei per essere collocato esternamente senza necessità di copertura e fornito di tappo parapioggia.
Parco Archeologico del Forcello Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)
 Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) Recapiti Pro Loco Bagnolo tel 348 0394636, fax 0376 415446 Comune di Bagnolo San Vito tel. 0376.413317, fax 0376.415387 info@parcoarcheologicoforcello.it
Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) Recapiti Pro Loco Bagnolo tel 348 0394636, fax 0376 415446 Comune di Bagnolo San Vito tel. 0376.413317, fax 0376.415387 info@parcoarcheologicoforcello.it
ISOLAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PER UFFICI IN ROMAGNANO AL MONTE (SA)
 Luigi Iannone (luigi.iannone@hotmail.com), M.Gabriella Castellano (maria.gabriella.castellano@fip-group.it) SOMMARIO ISOLAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PER UFFICI IN ROMAGNANO AL MONTE (SA) L edificio per
Luigi Iannone (luigi.iannone@hotmail.com), M.Gabriella Castellano (maria.gabriella.castellano@fip-group.it) SOMMARIO ISOLAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PER UFFICI IN ROMAGNANO AL MONTE (SA) L edificio per
Prot. n Del 16/12/2015
 COMUNE DI Cavallino - Treporti (Provincia di Venezia) Servizio Urbanistica Prot. n. 50804 Del 16/12/2015 OGGETTO: Variante non sostanziale al Piano degli Interventi ai sensi dell art. 107 delle NTO. Modifica
COMUNE DI Cavallino - Treporti (Provincia di Venezia) Servizio Urbanistica Prot. n. 50804 Del 16/12/2015 OGGETTO: Variante non sostanziale al Piano degli Interventi ai sensi dell art. 107 delle NTO. Modifica
PROTOCOLLO D INTESA CAI-FEDERPARCHI
 PROTOCOLLO D INTESA CAI-FEDERPARCHI ABACO DELLA SEGNALETICA Allegato A SEGNALETICA DEI SENTIERI La Legge 24 dicembre 1985, n. 776, all art. 2 lettera b), stabilisce che il CAI provvede al tracciamento,
PROTOCOLLO D INTESA CAI-FEDERPARCHI ABACO DELLA SEGNALETICA Allegato A SEGNALETICA DEI SENTIERI La Legge 24 dicembre 1985, n. 776, all art. 2 lettera b), stabilisce che il CAI provvede al tracciamento,
HAMEAU CHEZ-LES-BLANC-DESSOUS
 SCHEDE DEGLI EDIFICI COMUNE DI ETROUBLES HAMEAU CHEZ-LES-BLANC-DESSOUS U Scheda N : COMUNE DI ETROUBLES 1 Epoca di costruzione: antecedente il 1900 Stato di conservazione: discreto Stato del fabbricato:
SCHEDE DEGLI EDIFICI COMUNE DI ETROUBLES HAMEAU CHEZ-LES-BLANC-DESSOUS U Scheda N : COMUNE DI ETROUBLES 1 Epoca di costruzione: antecedente il 1900 Stato di conservazione: discreto Stato del fabbricato:
Piano di Recupero Compendio Forte Marghera. Base per monumento dopo il 1941
 ELEMENTI DI ANALISI DELL EDIFICIO VALUTAZIONE DEL GRADO DI TRASFORMABILITA DELL EDIFICIO Destinazione di P.R.G.: Zone per attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico territoriale VUA - Verde urbano
ELEMENTI DI ANALISI DELL EDIFICIO VALUTAZIONE DEL GRADO DI TRASFORMABILITA DELL EDIFICIO Destinazione di P.R.G.: Zone per attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico territoriale VUA - Verde urbano
La Calabria tirrenica nell antichità. Maria Clara Martinelli. Rubbettino. Nuovi documenti e problematiche storiche
 cop_estratti_de_sensi:cop_estratti_de_sensi 25-02-2009 14:25 Pagina 6 IRACEB - ISTITUTO REGIONALE PER LE ANTICHITÀ CALABRESI CLASSICHE E BIZANTINE - ROSSANO Maria Clara Martinelli I rapporti tra le isole
cop_estratti_de_sensi:cop_estratti_de_sensi 25-02-2009 14:25 Pagina 6 IRACEB - ISTITUTO REGIONALE PER LE ANTICHITÀ CALABRESI CLASSICHE E BIZANTINE - ROSSANO Maria Clara Martinelli I rapporti tra le isole
Sferracavallo. Storia di Sferracavallo
 Sferracavallo Sferracavallo è una località marittima del capoluogo siciliano, Palermo, appartenente alla VII circoscrizione. È un piccolo borgo che si estende attorno al piccolo porto ai piedi di Capo
Sferracavallo Sferracavallo è una località marittima del capoluogo siciliano, Palermo, appartenente alla VII circoscrizione. È un piccolo borgo che si estende attorno al piccolo porto ai piedi di Capo
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
 FRANTOIO E PALMENTO DI CALA ZIMMARI - PANAREA (Edificio di interesse storico e demo-etno-antropologico vincolato ai sensi della L.1089/39 così come modificata dal testo unico D.Lgs 490/99) PROGETTO DI
FRANTOIO E PALMENTO DI CALA ZIMMARI - PANAREA (Edificio di interesse storico e demo-etno-antropologico vincolato ai sensi della L.1089/39 così come modificata dal testo unico D.Lgs 490/99) PROGETTO DI
RILIEVO SAGGI STRATIGRAFICI DEI PAVIMENTI
 Monastero di Santa Clara Campagna di rilievo dell Ala Nord, Ala Ovest e parte dell Ala Sud RILIEVO SAGGI STRATIGRAFICI DEI PAVIMENTI Livello : PT Unità : T35 Elemento : SAGGIO N.8 Foglio n. POSIZIONE DEL
Monastero di Santa Clara Campagna di rilievo dell Ala Nord, Ala Ovest e parte dell Ala Sud RILIEVO SAGGI STRATIGRAFICI DEI PAVIMENTI Livello : PT Unità : T35 Elemento : SAGGIO N.8 Foglio n. POSIZIONE DEL
LA CAPANNA B6 DELL ABITATO DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA TP) E LE STRUTTURE PRODUTTIVE
 VOL. 1 2008 PP. 125-199 ISSN 1974-7985 LA CAPANNA B6 DELL ABITATO DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA TP) E LE STRUTTURE PRODUTTIVE DOMESTICHE 1 Serena Marcucci 2 Parole chiave: Pantelleria,
VOL. 1 2008 PP. 125-199 ISSN 1974-7985 LA CAPANNA B6 DELL ABITATO DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DI MURSIA (PANTELLERIA TP) E LE STRUTTURE PRODUTTIVE DOMESTICHE 1 Serena Marcucci 2 Parole chiave: Pantelleria,
Relatore: Fabio Mantovani Correlatore: Riccardo Salvini. Tesista : Nadia Bianconi
 Ricostruzione del percorso dell acquedotto romano di Firenze rinvenuto presso il torrente Zambra (Comune di Sesto Fiorentino - FI) attraverso misure di resistività elettrica Relatore: Fabio Mantovani Correlatore:
Ricostruzione del percorso dell acquedotto romano di Firenze rinvenuto presso il torrente Zambra (Comune di Sesto Fiorentino - FI) attraverso misure di resistività elettrica Relatore: Fabio Mantovani Correlatore:
21) FLAVIO ANDO (chalet)
 21) FLAVIO ANDO (chalet) QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico
21) FLAVIO ANDO (chalet) QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico
Configurazione della bocca di porto di Lido con le opere di difesa. In giallo, i cantieri in corso, in arancione, quelli ultimati.
 BOCCA DI PORTO DI LIDO Configurazione della bocca di porto di Lido con le opere di difesa. In giallo, i cantieri in corso, in arancione, quelli ultimati. INTERVENTI IN CORSO: PORTO RIFUGIO 1. bacino lato
BOCCA DI PORTO DI LIDO Configurazione della bocca di porto di Lido con le opere di difesa. In giallo, i cantieri in corso, in arancione, quelli ultimati. INTERVENTI IN CORSO: PORTO RIFUGIO 1. bacino lato
Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
 Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
Tunnel Solare nel centro storico
 Tunnel Solare nel centro storico Una forma di luce integrativa per i locali non illuminati in maniera adeguata Indice 2 Il contesto storico 3 L utilità del Tunnel Solare 4 Un illuminamento adeguato 5 La
Tunnel Solare nel centro storico Una forma di luce integrativa per i locali non illuminati in maniera adeguata Indice 2 Il contesto storico 3 L utilità del Tunnel Solare 4 Un illuminamento adeguato 5 La
Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
Tribunale di Firenze Esecuzioni Immobiliari Rg. 270/00 Giudice Delegato Dott. D.Ammirati
 Pergolato Tribunale di Firenze Esecuzioni Immobiliari Rg. 270/00 Giudice Delegato Dott. D.Ammirati Forno Depositi Pollaio Deposito Legnaia Lastrico e deposito DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Immobile: Unità
Pergolato Tribunale di Firenze Esecuzioni Immobiliari Rg. 270/00 Giudice Delegato Dott. D.Ammirati Forno Depositi Pollaio Deposito Legnaia Lastrico e deposito DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Immobile: Unità
Relazione paesaggistica
 COMUNE DI PISA PIANO ATTUATIVO SCHEDA NORMA 39.1 TIRRENIA VIA DELLE GIUNCHIGLIE Relazione paesaggistica Richiedente: Baldereschi R. sas Via Flavio Andò, 5/D Marina di Pisa 1. Tipologia di intervento L
COMUNE DI PISA PIANO ATTUATIVO SCHEDA NORMA 39.1 TIRRENIA VIA DELLE GIUNCHIGLIE Relazione paesaggistica Richiedente: Baldereschi R. sas Via Flavio Andò, 5/D Marina di Pisa 1. Tipologia di intervento L
Relazione Tecnica Progetto UWC Via Dei Serragli. 1. Premessa Descrizione generica della tecnologia di intervento... 2
 Indice 1. Premessa... 2 2. Descrizione generica della tecnologia di intervento... 2 3. DESCRIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI... 3 A. Postazione n.1 (Via Dei Serragli angolo Via S. Maria)... 3 B. Postazione
Indice 1. Premessa... 2 2. Descrizione generica della tecnologia di intervento... 2 3. DESCRIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI... 3 A. Postazione n.1 (Via Dei Serragli angolo Via S. Maria)... 3 B. Postazione
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO
 CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
La stratigrafia archeologica
 La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
ARCHEOLOGIA Finalità e Ordinamento
 Lettere e Filosofia ARCHEOLOGIA Finalità e Ordinamento La Scuola, articolata negli indirizzi di Archeologia preistorica, Archeologia classica, Archeologia post-classica, ha lo scopo di approfondire la
Lettere e Filosofia ARCHEOLOGIA Finalità e Ordinamento La Scuola, articolata negli indirizzi di Archeologia preistorica, Archeologia classica, Archeologia post-classica, ha lo scopo di approfondire la
POLITECNICO DI TORINO II FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea Magistrale in Architettura (ambiente e paesaggio) Tesi meritevoli di pubblicazione
 POLITECNICO DI TORINO II FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea Magistrale in Architettura (ambiente e paesaggio) Tesi meritevoli di pubblicazione Lettura e rappresentazione della città antica di Aquileia
POLITECNICO DI TORINO II FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea Magistrale in Architettura (ambiente e paesaggio) Tesi meritevoli di pubblicazione Lettura e rappresentazione della città antica di Aquileia
Cana. Sito Complesso Architettonico 1. Corpo di Fabbrica 1. Riccardo Bargiacchi
 Cana Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.3; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364, 460; CORRIDORI 2004, p. 268-270; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148; Repetti
Cana Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.3; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364, 460; CORRIDORI 2004, p. 268-270; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148; Repetti
Documento di Valutazione Archeologica Preventiva. Cascina Cadrega Costa Masnaga -LC
 AR.PA. Ricerche Committente EUSIDER Immobiliare Documento di Valutazione Archeologica Preventiva Cascina Cadrega Costa Masnaga -LC 2013 AR.PA. Ricerche - Via Strada della Piazza, 13-23821 Abbadia Lariana
AR.PA. Ricerche Committente EUSIDER Immobiliare Documento di Valutazione Archeologica Preventiva Cascina Cadrega Costa Masnaga -LC 2013 AR.PA. Ricerche - Via Strada della Piazza, 13-23821 Abbadia Lariana
IL MUSEO DELLA CERAMICA A. TAFURI a cura di Irma Pastore
 IL MUSEO DELLA CERAMICA A. TAFURI a cura di Irma Pastore Nel centro storico di Salerno, poco distante dal Duomo, nel caratteristico Largo Casavecchia, troviamo il museo della ceramica Alfonso Tafuri. Il
IL MUSEO DELLA CERAMICA A. TAFURI a cura di Irma Pastore Nel centro storico di Salerno, poco distante dal Duomo, nel caratteristico Largo Casavecchia, troviamo il museo della ceramica Alfonso Tafuri. Il
COMPLESSO TURISTICO-SPORTIVO BAGNI CLODIA Come rendere percepibile dall esterno la reale funzione di ogni singolo spazio
 COMPLESSO TURISTICO-SPORTIVO BAGNI CLODIA Come rendere percepibile dall esterno la reale funzione di ogni singolo spazio Il complesso turistico-sportivo Bagni Clodia si colloca fra la grande spiaggia di
COMPLESSO TURISTICO-SPORTIVO BAGNI CLODIA Come rendere percepibile dall esterno la reale funzione di ogni singolo spazio Il complesso turistico-sportivo Bagni Clodia si colloca fra la grande spiaggia di
(I II sec d. C.) Prof. Zaccaria MARI Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
 SCAVO DI DUE TOMBE ALLA CAPPUCCINA (I II sec d. C.) Prof. Zaccaria MARI Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio CINETO ROMANO (Roma) Loc. Torrente Ferrata 27-29 aprile
SCAVO DI DUE TOMBE ALLA CAPPUCCINA (I II sec d. C.) Prof. Zaccaria MARI Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio CINETO ROMANO (Roma) Loc. Torrente Ferrata 27-29 aprile
DPIA redatta secondo DGR n. 673/2004 Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 Legge 26 ottobre 1995, n. 447
 DPIA redatta secondo DGR n. 673/2004 Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 PROCEDURA SEMPLIFICATA (ai sensi dell art. 4 LR n.15/2001) INTEGRAZIONE 0.1!!" # $ $ Comune di Ferrara
DPIA redatta secondo DGR n. 673/2004 Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 PROCEDURA SEMPLIFICATA (ai sensi dell art. 4 LR n.15/2001) INTEGRAZIONE 0.1!!" # $ $ Comune di Ferrara
CRISPIANO (TA) LOC. CACCIAGUALANI PROPRIETA ZACCARIA RELAZIONE SCIENTIFICA DI SCAVO ARCHEOLOGICO
 1 of 24 CRISPIANO (TA) LOC. CACCIAGUALANI PROPRIETA ZACCARIA RELAZIONE SCIENTIFICA DI SCAVO ARCHEOLOGICO 2 of 24 L intervento in oggetto si è svolto in agro di Crispiano (Loc. Cacciagualani) all interno
1 of 24 CRISPIANO (TA) LOC. CACCIAGUALANI PROPRIETA ZACCARIA RELAZIONE SCIENTIFICA DI SCAVO ARCHEOLOGICO 2 of 24 L intervento in oggetto si è svolto in agro di Crispiano (Loc. Cacciagualani) all interno
COMUNE DI BUCCINO Provincia di Salerno
 Pagina 1 SCHEDA UNITA IMMOBILIARE Pianta stato di fatto Localizzazione Comune: BUCCINO c.a.p : 84021 Provincia: Salerno Zona: Centro storico denominazione stradale: Via Sant Orsola n civico: 31 Superficie
Pagina 1 SCHEDA UNITA IMMOBILIARE Pianta stato di fatto Localizzazione Comune: BUCCINO c.a.p : 84021 Provincia: Salerno Zona: Centro storico denominazione stradale: Via Sant Orsola n civico: 31 Superficie
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA
 CONCORSO PER L AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE: strutture della società, insediamenti ed organizzazione del territorio, attività produttive ELENCO TEMI XIV CICLO Tema
CONCORSO PER L AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE: strutture della società, insediamenti ed organizzazione del territorio, attività produttive ELENCO TEMI XIV CICLO Tema
UNA LETTURA DEL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
 UNA LETTURA DEL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI a cura del Centro Studi sull Economia Immobiliare - CSEI Tecnoborsa Tecnoborsa torna ad affrontare i temi dell ultimo Censimento
UNA LETTURA DEL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI a cura del Centro Studi sull Economia Immobiliare - CSEI Tecnoborsa Tecnoborsa torna ad affrontare i temi dell ultimo Censimento
ISTITUTO ALBERGHIERO P. ARTUSI - RIOLO TERME, RAVENNA
 ISTITUTO ALBERGHIERO P. ARTUSI - RIOLO TERME, RAVENNA Lavori di ampliamento, adeguamento normativo e funzionale dell Istituto Professionale Alberghiero P. Artusi di Riolo Terme (RA). Committente: Provincia
ISTITUTO ALBERGHIERO P. ARTUSI - RIOLO TERME, RAVENNA Lavori di ampliamento, adeguamento normativo e funzionale dell Istituto Professionale Alberghiero P. Artusi di Riolo Terme (RA). Committente: Provincia
USO ATTUALE. Part. 391 restaurata, studio di progettazione. La part. 506 con la primitiva calcara, di proprietà del Comune di Solagna, è in rovina.
 4.2 - Comune di Solagna, Solagna. Calcara. LUOGO. Comune di Solagna, Solagna, località Fossà. OGGETTO. Calcara, poi ex Fornace da calce. CATASTO. F. XII (1929), part. 506,391, 491. CRONOLOGIA. Part. 506
4.2 - Comune di Solagna, Solagna. Calcara. LUOGO. Comune di Solagna, Solagna, località Fossà. OGGETTO. Calcara, poi ex Fornace da calce. CATASTO. F. XII (1929), part. 506,391, 491. CRONOLOGIA. Part. 506
DATI AMMINISTRATIVI Comune: Como Localizzazione: Attuale Villa Stampa ed ex convento di S.Croce RIFERIMENTI CARTOGRAFICI CTR: B4A5. Scala: 1:10.
 CODICE ID SITO/RINVENIMENTO: COCE148 Provincia: Tipo settore: urbano DATI AMMINISTRATIVI Comune: Frazione: Localizzazione: Attuale Villa Stampa ed ex convento di S.Croce Località: Via Zezio RIFERIMENTI
CODICE ID SITO/RINVENIMENTO: COCE148 Provincia: Tipo settore: urbano DATI AMMINISTRATIVI Comune: Frazione: Localizzazione: Attuale Villa Stampa ed ex convento di S.Croce Località: Via Zezio RIFERIMENTI
Arcipelaghi e isole d Italia
 L Isola di Vulcano, in primo piano, nelle Eolie. La penisola italiana è circondata, oltre che dalla Sicilia e dalla Sardegna, che sono le isole più grandi del Mediterraneo, anche da numerosi arcipelaghi
L Isola di Vulcano, in primo piano, nelle Eolie. La penisola italiana è circondata, oltre che dalla Sicilia e dalla Sardegna, che sono le isole più grandi del Mediterraneo, anche da numerosi arcipelaghi
Indagini nell'area del Foro di Grumentum
 The Journal of Fasti Online Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica Piazza San Marco, 49 I-00186 Roma Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org
The Journal of Fasti Online Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica Piazza San Marco, 49 I-00186 Roma Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org
CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 4/2011 TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. LIQUIDAZIONE DEI BENI OFFERTI ALLA MASSA DEI CREDITORI DELLA ELDO ITALIA SPA
 CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 4/2011 TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. LIQUIDAZIONE DEI BENI OFFERTI ALLA MASSA DEI CREDITORI DELLA ELDO ITALIA SPA IMMOBILI OGGETTO DI CESSIONE PIATTAFORMA DISTRIBUTIVIA
CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 4/2011 TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. LIQUIDAZIONE DEI BENI OFFERTI ALLA MASSA DEI CREDITORI DELLA ELDO ITALIA SPA IMMOBILI OGGETTO DI CESSIONE PIATTAFORMA DISTRIBUTIVIA
Solaio contro terra. lezione 6. sicuro. non cedevole. non sdrucciolevole. deve isolare dall umidità ed evitare le dispersioni di calore
 Solaio contro terra lezione 6 1 Solaio contro terra: requisiti sicuro non cedevole non sdrucciolevole deve isolare dall umidità ed evitare le dispersioni di calore 2 1 Strati che compongono il solaio Strato
Solaio contro terra lezione 6 1 Solaio contro terra: requisiti sicuro non cedevole non sdrucciolevole deve isolare dall umidità ed evitare le dispersioni di calore 2 1 Strati che compongono il solaio Strato
POLITECNICO DI TORINO FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea in Architettura Tesi meritevoli di pubblicazione
 POLITECNICO DI TORINO FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea in Architettura Tesi meritevoli di pubblicazione L architettura dell industria molitoria tra conoscenza e conservazione : il Mulino Nuovo
POLITECNICO DI TORINO FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea in Architettura Tesi meritevoli di pubblicazione L architettura dell industria molitoria tra conoscenza e conservazione : il Mulino Nuovo
Toscana Vendita Appartamenti in villa storica Toscana Arezzo vendita appartamenti in villa storica
 Ville@Casali Real Estate s.r.l. Telefono: 800 984 481 Email: info@villeecasalinetwork.com Toscana Vendita Appartamenti in villa storica Toscana Arezzo vendita appartamenti in villa storica Arezzo, IT Descrizione
Ville@Casali Real Estate s.r.l. Telefono: 800 984 481 Email: info@villeecasalinetwork.com Toscana Vendita Appartamenti in villa storica Toscana Arezzo vendita appartamenti in villa storica Arezzo, IT Descrizione
Dati generali. Villino. n/r. edificio residenziale bifamiliare. privata. utilizzato parzialmente utilizzato non utilizzato. Riferimenti archivistici
 Dati generali Denominazione Villino Localizzazione via Gorizia 5 Datazione fra il 1913 ed il 1928 Autore Oggetto Proprietà edificio residenziale bifamiliare privata Proprietari Grado di Utilizzo utilizzato
Dati generali Denominazione Villino Localizzazione via Gorizia 5 Datazione fra il 1913 ed il 1928 Autore Oggetto Proprietà edificio residenziale bifamiliare privata Proprietari Grado di Utilizzo utilizzato
ALTRI DOCUMENTI SULL 'ANTICA STORIA DEI VENETI
 ALTRI DOCUMENTI SULL 'ANTICA STORIA DEI VENETI In Boemia nel 1800 a.c. circa si affermó la florida Cultura d'aunjetitz, che si propagherá in tutta la Cechia, la Slovacchia, la Polonia, la Germania, l'ungheria,
ALTRI DOCUMENTI SULL 'ANTICA STORIA DEI VENETI In Boemia nel 1800 a.c. circa si affermó la florida Cultura d'aunjetitz, che si propagherá in tutta la Cechia, la Slovacchia, la Polonia, la Germania, l'ungheria,
Destinatari: classi III - IV e V della Scuola Primaria adattabile anche alla scuola secondaria di I grado
 l osservazione diretta e l analisi dell ambiente e della flora presente oggi al Lavagnone. A questo punto si lascia il sito archeologico. 2) Attività presso il Museo Rambotti. I ragazzi effettuano l attività
l osservazione diretta e l analisi dell ambiente e della flora presente oggi al Lavagnone. A questo punto si lascia il sito archeologico. 2) Attività presso il Museo Rambotti. I ragazzi effettuano l attività
10. Lo studio palinostratigrafico e archeobotanico dei depositi archeologici e delle attività dell uomo
 Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
Il MUSEO PER LA SCUOLA
 Il MUSEO PER LA SCUOLA Educatori ed insegnanti potranno scegliere, spaziando fra una vasta gamma di proposte che vanno da una prima conoscenza generale del museo ad approfondimenti mirati per tematiche
Il MUSEO PER LA SCUOLA Educatori ed insegnanti potranno scegliere, spaziando fra una vasta gamma di proposte che vanno da una prima conoscenza generale del museo ad approfondimenti mirati per tematiche
CHIOSTRO CAPITOLARE INDAGINI PRELIMINARI
 CHIOSTRO CAPITOLARE INDAGINI PRELIMINARI I resti dell archeggiatura del lato orientale del chiostro, ancora imprigionati in un muro di recinzione, in una foto dei primi del Novecento. L area del chiostro,
CHIOSTRO CAPITOLARE INDAGINI PRELIMINARI I resti dell archeggiatura del lato orientale del chiostro, ancora imprigionati in un muro di recinzione, in una foto dei primi del Novecento. L area del chiostro,
CATALOGO DELLE TRACCE. Foto 1
 CATALOGO DELLE TRACCE Foto 1 ID_ANOMALIA: 5500 COMUNE: GROSSETO LOCALITA: Poggio Lecci X: 1671516,61734 Y: 4722855,75235 USO DEL SUOLO: Zone boscate TIPO DI TRACCIA: Crescita anomala di piante ad alto
CATALOGO DELLE TRACCE Foto 1 ID_ANOMALIA: 5500 COMUNE: GROSSETO LOCALITA: Poggio Lecci X: 1671516,61734 Y: 4722855,75235 USO DEL SUOLO: Zone boscate TIPO DI TRACCIA: Crescita anomala di piante ad alto
SICILIA MARINA. b 3) La geografia
 b 3) La geografia SICILIA MARINA La Sicilia è la maggiore isola del Mediterraneo; misura infatti 25.708 Kmq., includendo le isole di Ustica e Pantelleria e gli arcipelaghi delle: - Eolie comprendenti le
b 3) La geografia SICILIA MARINA La Sicilia è la maggiore isola del Mediterraneo; misura infatti 25.708 Kmq., includendo le isole di Ustica e Pantelleria e gli arcipelaghi delle: - Eolie comprendenti le
COMUNE DI SESSA CILENTO RECUPERO DI UN ANTICA CALCARA NELLA FRAZIONE CASIGLIANO
 COMUNE DI SESSA CILENTO RECUPERO DI UN ANTICA CALCARA NELLA FRAZIONE CASIGLIANO La calcara e la produzione della calce La Calcara è una fornace costruita in pietra a secco destinata alla produzione della
COMUNE DI SESSA CILENTO RECUPERO DI UN ANTICA CALCARA NELLA FRAZIONE CASIGLIANO La calcara e la produzione della calce La Calcara è una fornace costruita in pietra a secco destinata alla produzione della
RIVIVERE LA PREISTORIA
 RIVIVERE LA PREISTORIA Il progetto Rivivere la Preistoria nasce dalla volontà di far conoscere la preistoria del territorio di Montelupo, coinvolgendo le classi III della primaria dell'ist. Com. Baccio
RIVIVERE LA PREISTORIA Il progetto Rivivere la Preistoria nasce dalla volontà di far conoscere la preistoria del territorio di Montelupo, coinvolgendo le classi III della primaria dell'ist. Com. Baccio
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Resti del III-IV secolo a Solaro (MI)
 The Journal of Fasti Online Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica Piazza San Marco, 49 I-00186 Roma Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org
The Journal of Fasti Online Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica Piazza San Marco, 49 I-00186 Roma Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org
1- ARCHIVIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
 1- ARCHIVIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 1.1 Descrizione dell archivio L archivio della Cassa di Risparmio di Ravenna costituisce un complesso documentario assai interessante per lo studio della
1- ARCHIVIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 1.1 Descrizione dell archivio L archivio della Cassa di Risparmio di Ravenna costituisce un complesso documentario assai interessante per lo studio della
Ambito antropico. a. L area di indagine
 Ambito antropico Questo primo rapporto relativo all analisi socio-economica dell area su cui insiste il Parco nazionale del Vesuvio intende fornire un primo inquadramento di carattere generale sulle caratteristiche
Ambito antropico Questo primo rapporto relativo all analisi socio-economica dell area su cui insiste il Parco nazionale del Vesuvio intende fornire un primo inquadramento di carattere generale sulle caratteristiche
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO Via Trinchese 61/D Galleria LECCE tel fax
 AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO Via Trinchese 61/D Galleria 73100 LECCE tel. 0832 446111 fax 0832 315034 PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO Via Trinchese 61/D Galleria 73100 LECCE tel. 0832 446111 fax 0832 315034 PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI
IL SISTEMA AMBIENTALE IL SISTEMA TECNOLOGICO. 2 La scomposizione del Sistema Edilizio
 La scomposizione del Sistema Edilizio IL SISTEMA AMBIENTALE IL SISTEMA TECNOLOGICO Tadao Ando, Conference pavilion, @ VITRA Weil am Rhein, Germany 1993 NORMA Definizione STRUMENTALE Secondo la Direttiva
La scomposizione del Sistema Edilizio IL SISTEMA AMBIENTALE IL SISTEMA TECNOLOGICO Tadao Ando, Conference pavilion, @ VITRA Weil am Rhein, Germany 1993 NORMA Definizione STRUMENTALE Secondo la Direttiva
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO
 REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
