U. IRTI (*) LA CERAMICA A SQUAME NEL FUCINO
|
|
|
- Tito Corradi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 97 (1990) pagg , figg. 4 U. IRTI (*) LA CERAMICA A SQUAME NEL FUCINO Riassunto - L'autore dà notizia della scoperta di alcuni insediamenti con ceramica a squame, posti intorno allago del Fucino. Descrive il materiale raccolto in superficie, ascrivibile ad una fase finale dell'eneolitico. Abstract - Rusticated poltery in the lake Fucino area. The author presents the discovery of some settlements with rusticated pottery in the lake Fucino area. The material collected from the surface can be adscribed to the fina I peri od of Eneolithic Age. Key words - Fucino (Abruzzo), Eneolithic Age, rusticated pottery. Le ricerche di superficie svolte dall'autore nella conca del Fucino hanno portato, negli anni , alla scoperta di alcuni insediamenti all'aperto con ceramica a squame. Durante le ricognizioni degli anni precedenti non era stata mai individuata questa classe ceramica, non solo perché in generale poco studiata, ma soprattutto perché i relativi materiali erano inseriti in contesti caratterizzati con assoluta prevalenza da ceramica di aspetto molto scadente, con superficie poco lisciata e non lucidata, che sfuggiva ad una precisa collocazione cronologica, senza stimolare indagini più attente. Le ultime prospezioni hanno invece rivelato un orizzonte culturale ben attestato, con una serie di insediamenti perilacustri posti sui terrazzi che bordano l'alveo prosciugato del Fucino o sulle falde dei monti vicini (IRTI, in corso di stampa). DATI DI CARATTERE TOPOGRAFICO Come è noto, la conca del Fucino è una depressione tettonica at- (*) Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
2 204 IRTI U. tualmente occupata dalla pianura risultante dalla bonifica del 1875, bordata da terrazzi e depositi di varia origine, risalenti al Pleistocene Superiore e all'olocene, che si estendono fino alle falde dei rilievi montuosi (GIRAUDI, 1988). Gli insediamenti perilacustri finora scoperti attraverso le ricognizioni di superficie appartengono al Neolitico, all'eneolitico ed all'età del Bronzo, e risultano distribuiti secondo una doppia serie: alcuni sono posti nella piana del Fucino e sono quindi sorti su porzioni di territorio emerse durante fasi di abbassamento del livello lacustre; altri si trovano fuori della piana, sui terrazzi e sui rilievi che la circondano, e corrispondono invece (almeno in gran parte) a fasi di maggiore livello delle acque (IRTI, 1986, 1988). A questa seconda serie appartengono i cinque insediamenti con ceramica a squame, tutti ubicati ben al di fuori della piana, soprattutto intorno alla quota di m. Elenchiamo qui di seguito gli insediamenti, indicando il comune o la frazione in cui sono posti ed il relativo toponimo: 1. AVEZZANO-LE MOLE 1, LG.M. Avezzano, F.145, II, So., quota SAN PELINO-MASCIARELLI, LG.M. Celano Sud, F.146, III, SO, quota VENERE e ORTUCCHIO-LE COSTE, LG.M. Gioia dei Marsi, F.152, IV, quota ORTUCCHIO-COLLE S. STEFANO, LG.M. Gioia dei Marsi, IV, NE, quota LUCO-VILLINO SOR PAOLO, LG.M. Trasacco, F.152, IV, NO, quota 673. I MATERIALI RECUPERA TI Il dato più significativo, comune ai cinque insediamenti, è quello della presenza di ceramica a squame, decorazione ottenuta con riporti di argilla più o meno schiacciati, e in parte sovrapposti, che conferiscono un aspetto embricato alla superficie esterna. I frammenti decorati a squame sono piuttosto piccoli, per cui non è possibile riconoscere completamente la sintassi decorativa. In alcuni frammenti, peraltro, sembra che le squame siano disposte in modo irregolare, senza un preciso ordine, mentre in altri è possibile cogliere un prevalente orientamento su linee orizzontali oppure oblique. Gli altri elementi comuni riscontrati nei cinque insediamenti sono i seguenti: ceramica dura e compatta, realizzata a cercine, con superfi-
3 LA CERAMICA A SQUAME NEL FUCINO 205 cie, in assoluta prevalenza, di colore rossiccio o bruno, non lucidata, scabra e con segni più o meno marcati di steccature; anse a nastro piatto, con attacchi e tappo, a volte con margini ben rilevati o con steccature che formano lievi scanalature verticali (Fig. 1, nn. 12, 13); prese a linguetta e frammenti di parete con piccole bugne (Fig. 1, nn. 7-9); fondi a tacco più o meno pronunciato, frammenti di orlo con decorazione a tacche sul labbro; frammenti di parete con cordoni decorati a impressioni. Sono altresì presenti fuseruole fittili di varie forme (discoidali, lenticolari, globulari, biconiche), a volte di dimensioni piuttosto grandi. L'industria litica è generalmente rappresentata da schegge di selce e frammenti di macinelli. Non sono stati recuperati frammenti decorati con veri e propri listelli applicati e sovrapposti, né con superficie trattata a spazzola. Nella ceramica di S. Pelino-Masciarelli la decorazione sembra limitata ad una fascia lungo l'estremità superiore dell'orlo, con applicazioni di argilla schiacciate e allineate in modo da formare un cordone orizzontale, a volte a mo' di festone (Fig. 2, nn. 1-6), secondo una sintassi che trova confronti nella facies del Gaudo (HOLLOWAY, 1973) e nella Grotta dell'orso di Sarteano (CREMONESI, 1968a), ma che è stata ritenuta estranea alla tipica ceramica a squame, intesa nella sua definizione più restrittiva (BAGOLINI e CREMONESI, 1988). Da questo stesso sito proviene un frammento di ansa a nastro verticale, con profonda insellatura nel punto di attacco e quindi con margini molto rilevati (Fig. 2, n. lo). In alcuni frammenti più grandi, presenti ad Avezzano, S. Pelino ed a Luco dei Marsi, si hanno riporti di argilla poco pronunciati, ottenuti con lunghe steccature oblique all'orlo, secondo linee subparallele che danno alla superficie un aspetto ondulato (Figg. 1, n. lo; 2, nn. 8, 9; 4, nn. 5-8). Fra i materiali di Luco dei Marsi sono presenti due frammenti di parete decorati con sottili incisioni subparallele (Fig. 4, nn. lo, 11) ed un probabile elemento di presa, sul quale è applicata una piccola bugna a cavità centrale (Fig. 4, n. 9). Pasticche a cavità centrale e frammenti con incisioni risultano associati anche nel livello eneolitico con ceramica a squame del Riparo dell'ambra, strato 13 (D. COCCHI GENICK, 1986, Figg. 8,5 e 10,5). Sempre a Luco sono stati rinvenuti alcuni nuclei e lamette di ossi diana. Anche ad Avezzano-Le Mole è stato recuperato un frammento di parete con piccola bugna a cavità centrale (Fig. 1, n. 11), frammenti con una o più bugnette applicate (Fig. 1, nn. 7-9), nonché due fuseruole, di
4 Fig. 1 - Avezzano-Le Mole: frammé"nti ceramici decorati ;'squame (1-6, lo), con bugnette (7, 8, 9), con pasticca cava (11); anse a nastro con scanalature verticali (12) e con attacco a tappo (13) (grand. nal).
5 Fig. 2 - S. Pelino-Masciarelli: frammenti ceramici decorati a squame (1-9, grand. nat.); ansa a nastro con forte insellatura nel punto di attacco (lo, 3/4 grand. nat.). 10
6 208 IRTI U. cui una piccola di forma ellissoidale e l'altra molto grande di forma globulare (diametro cm. 6). Altre due fuseruole sono presenti a Paterno Masciarelli, una cilindrica e l'altra più grande, a probabile sezione biconica. Una vasta area insediativa si estende per almeno 1 km ai piedi del Colle delle Cerese, in località Le Coste, in territorio di Vene re e di Ortucchio, a quote comprese tra i 680 e i 700 m; in questa zona l'apertura di tre cave per l'estrazione di inerti ha portato alla luce altrettanti depositi di terreno fortemente antropizzato, nei quali si potevano individuare resti di focolari e alcuni fondi di capanna con battuto di argilla. Tra i pochi materiali recuperati vanno segnalati: un frammento di grande vaso decorato con due file verticali di unghiate fortemente impresse, una grossa macina ed un macinello in pietra calcarea, una cuspide di freccia a triangolo isoscele e pochi altri frammenti ceramici, di cui uno con squame ben marcate, che si estendono fino all'orlo (Fig. 3, n. 1), ed un altro con riporti di argilla ben sovrapposti e con profonde impressioni digitali (Fig. 3, n. 2). Da uno dei tre siti sconvolti dai lavori di estrazione proviene un interessante vaso biconico monoansato, con collo troncoconico distinto, tipo Gaudo, che riconduce ad una sfera culturale finora mai riscontrata nel Fucino (Orante Ventura, com. pers.). A Colle s. Stefano di Ortucchio un'aratura particolarmente profonda ha messo in luce numerosi frammenti di intonaco, molto friabile, con impronte ben marcate di rami, oltre a frammenti vascolari nei quali le squame sembrano interessare l'intera superficie (Fig. 3). OSSERV AZIONI La scoperta di questi siti assume particolare importanza, dal momento che l'interesse degli studiosi si è negli ultimi tempi fortemente incentrato sui problemi connessi a tale classe ceramica, in passato molto trascurata (CREMONESI, 1989). Come è noto, si tratta di ceramica quasi sempre di uso domestico (in alcuni contesti associata a quella con superficie a striature), pressoché esclusiva degli insediamenti all'aperto, rivelatasi ampiamente diffusa in tutta la Penisola nell'ambito di cerchie culturali tra loro anche molto distanti, da quella di Spilamberto dell'area emiliana (dove è presente anche in alcuni sepolcreti) a quelle centro-meridionali del Gaudo e di Laterza. Nel Fucino, prima dei nuovi rinvenimenti, la ceramica a squame,
7 7 Fig. 3 - Vene re-le Coste: frammenti ceramici decorati a squame (1-3); Ortucchio-Colle S. Stefano: frammenti ceramici decorati a squame (4-11) (grand. nat.).
8 210 IRTI U. a parte un isolato frammento recuperato nel villaggio di Ortucchio Strada 28 (RADMILLI, 1977; RADI, 1988, Fig. 18,5), era stata recuperata soltanto in alcune grotte scavate da Antonio Mario Radmilli e da altri archeologi della scuola pisana. Frammenti sporadici provenivano dalla Grotta la Cava (TOZZI, 1962) e dai Grottoni di Balzone (RADMILLI, 1965, Fig. 4,1), entrambi presso Ortucchio, nonché dalla Grotta Di Ciccio Felice (RADMILLI, 1956), mentre una più precisa collocazione stratigrafica avevano i frammenti a squame delle grotte Maritza (tagli 16-14: GRIFONI e RADMILLI, 1954) e La Punta (CREMONESI, 1968), dove risultavano presenti in livelli superiori a quelli della cultura di Ortucchio. Più recentemente frammenti di ceramica a squame sono stati rinvenuti nella Grotta Continenza di Trasacco, insieme a pesi da rete ed asce litiche, ma in livelli risultati sconvolti (BARRA e GRIFONI CREMONE SI, in corso di stampa). In Abruzzo questo tipo di ceramica, oltre che in alcune grotte, come la Grotta S. Angelo (GRIFONI CREMONESI e DI FRAIA, in corso di stampa) e la Grotta delle Marmitte di Ofena (GRIFONI CREMONESI, 1969), è stato rinvenuto soprattutto negli insediamenti all'aperto, prima nella Valle della Vibrata (COLINI, 1907, tavv. X nn. 2,6; XIII n. 9; p. 206), poi a Fonte D'Amore (TOZZI, 1968; MATTIOCCO, 1981), a Pennapiedimonte (D'ERCOLE, 1982), a Castel di Ieri, località Le Castagne (D'ERCOLE, 1984; 1988), ed in buon numero sull'altopiano di Navelli (MATTIOCCO, 1986, pp e Fig. 17). Sul piano cronologico, la ceramica a squame dell'italia peninsulare sembra avere una lunga durata e manifestarsi soprattutto in una fase avanzata e finale dell'eneolitico, con attardamenti in alcune facies della prima età del Bronzo (come quella di Cellino San Marco: CREMO NESI, 1989, p. 92), fino ad esaurirsi completamente con l'avvento del protoappenninico, momento che segna la vera cesura tra le due fasi culturali (CREMONESI e VIGLIARDI, 1988, p. 311). E proprio per una corretta collocazione cronologica, decisivo rilievo si è attribuito, tra gli altri, ai dati stratigrafici della grotta n. 3 di Latronico (CREMONESI, 1978, 1989), dove il livello con ceramica a squame (str. 10) chiudeva il deposito, senza essere seguito, come nelle altre grotte di Latronico, dai livelli del protoappenninico e dell'appenninico. In Calabria, nella Grotta S. Angelo III di Cassano Ionio, la ceramica a squame compare nei livelli tardo eneolitici e della prima età del Bronzo (TINÉ, 1964); anche nelle grotte di Praia a Mare è presente in una fase avanzata della cultura del Gaudo, che si estende agli inizi dell'età del Bronzo (CREMONESI, 1989, p. 94).
9 Fig. 4 0_. L~co dei Marsi-Villino Sor Paolo: frammenti ceramici decorati a squame (1-8) e con incisioni (lo, Il); probabile presa orizzontale, con pasticca cava sulla faccia superiore (9) (grand. nat.).
10 212 IRTI U. In Campania, nell'insediamento di S. Mauro del Buccino, la ceramica a squame è ugualmente presente nella seconda fase del Gaudo, anche se ridotta ad una fascia orizzontale di due o tre file sovrapposte, subito al di sotto dell'orlo (HOLLOWAY, 1973; CREMONESI, 1989, p. 96). Nel territorio di Roma numerosi siti che hanno restituito ceramica «a scaglie» sono stati ascritti «all'eneolitico-i Età del Bronzo» (EIETTI SESTIERI e GIANNI, 1988a); in altri sono presenti materiali con decorazione plastica a «barbotine», riferiti all'eneolitico recente, secondo la classificazione proposta da A. Cazzella, cioè all'antica età del Bronzo di Peroni (PERONI, 1971; CAZZELLA, 1972; Bietti Sestieri, 1984; BIETTI SE STIERI e GIANNI, 1988). Nel resto della regione laziale ceramica a squame è segnalata nei siti di Torre Crognola, Diga, Cuccumelletta, Tufarelle e Cecio, ma senza alcuna indicazione cronologica (DI GENNARO e PENNACCHIONI, 1988). Nelle Marche questo tipo di ceramica viene inquadrato tra «le fasi finali dell'eneolitico e l'inizio dell'antica Età del Bronzo» (LOLLINI et alii, 1988), e tenuto distinto da quello a listelli sovrapposti, attribuito invece a momenti più antichi, come la facies di Attiggio IV ed i livelli inferiori del fossato di Conelle (CAZZELLA e MOSCOLONI, 1988). Nella medesima linea si pongono i dati provenienti dalla sequenza del Riparo dell'ambra, in Toscana, dove la ceramica a squame (str. lo) precede distinti livelli (str. 8-9) con reperti del «Bronzo antico» (COCCHI GENICK, 1986). Tornando al Fucino, è bene sottolineare che nelle grotte La Punta e Maritza la ceramica a squame si trovava al di sopra dei livelli attribuiti alla cultura di Ortucchio (datata con il C14, in cronologia non calibrata, a 2356 ± 105 a.c. nella Grotta dei Piccioni, ed a 2120 ± 180 a.c. nel villaggio della piana), per cui sembrerebbe confermata l'appartenenza di questa classe ceramica ad una fase avanzata e finale dell'eneolitico. In base ai primi dati raccolti riesce tuttavia difficile operare un più preciso inquadramento cronologico rispetto alle culture già attestate nel Fucino e soprattutto a quella di Ortucchio, e quindi stabilire i modi e tempi di penetrazione e diffusione di questo nuovo aspetto culturale e le caratteristiche dei relativi contesti. Un contributo alla soluzione di tale problema può essere offerto da alcuni elementi, che indichiamo in rapida sintesi: a) si è già detto che in altre zone della Penisola la vera e propria ceramica a squame si afferma in una fase avanzata e finale dell'eneolitico, ed anche nel Fucino le stratigrafie delle grotte la vedono sovrapposta e distinta da quella di Ortucchio;
11 LA CERAMICA A SQUAME NEL FUCINO 213 b) ad Ortucchio-Strada 28, nel pur abbondante materiale, è stato rinvenuto un solo frammento di ceramica a squame; c) nei nuovi stanziamenti con ceramica a squame mancano completamente i materiali tipici della cultura di Ortucchio, l'unica generica analogia consistendo nella presenza di ceramica grossolana con superficie rozzamente lisciata e non lucidata; d) negli insediamenti della cultura di Ortucchio (Ortucchio-Strada 28 e Ortucchio-Balzane 1) sono presenti i tipici pesi da rete cilindrici, mentre negli insediamenti con ceramica a squame, ancorché posti in ambiente perilacustre, sono del tutto assenti; e) anche sotto il profilo topografico, sussiste una netta distinzione tra gli insediamenti della cultura di Ortucchio e quelli con ceramica a squame: i primi sono stati finora individuati nella piana (IRTI, 1988), mentre gli altri si trovano tutti sui terrazzi e sulle alture, a quote superiori ai 674 m. e pertanto sembrano corrispondere ad un altro periodo, caratterizzato da altre condizioni ambientali; tale diversa situazione potrebbe corrispondere a quella determinata dalla variazione climatica avvenuta nella fase iniziale del II millennio a.c., in senso umido, con diminuzione della temperatura, avanzata dei ghiacciai, aumento della piovosità e quindi del livello lacustre (PINNA, 1984, p. 117); f) negli insediamenti con ceramica a squame sono presenti alcune fuseruole fittili di notevoli dimensioni, che ricordano tipi ampiamente diffusi anche in livelli attribuiti al «Bronza antico» (COCCHI GENICK, 1986, Fig. 29,9). Muovendo da tali elementi, ed in attesa di acquisire dati stratigrafici attraverso campagne di scavo, è possibile per ora concludere affermando che gli abitati con ceramica a squame documentano apporti culturali nuovi e ben attestati nel Fucino, forse riferibili all'arco di tempo che abbraccia la fine del III e i primi secoli del II millennio a.c., tra le ultime fasi della cultura di Ortucchio e l'avvento del protoappenninico. Questa ipotesi non sembra contrastata dal rinvenimento del vaso tipo Gaudo, facies che altrove, e soprattutto in Campania, si manifesta durante «l'eneolitico II» e persiste fino alla prima età del Bronza (BAl LO MODESTI, 1988). I pochi dati disponibili non offrono alcun contributo utile per conoscere l'economia propria degli insediamenti con ceramica a squame. Certo è che in questi siti non sono più presenti i pesi da rete cilindrici, il che induce a supporre l'uso di una diversa tecnica di pesca o il mancato esercizio di tale attività. Si può comunque osservare che i siti in esame, al pari di quelli neo-
12 214 IRTI U. litici, risultano distribuiti sui terrazzi e le alture prossime allago, sicché è da ritenere che il loro impianto sia stato dettato dalla medesima strategia insediativa, incentrata sulla necessità di trarre dal lago ogni possibile utilità. Questa cospicua presenza abitativa, ben concentrata sulle sponde del lago, sembra anche confermare che si trattava di gruppi insediati stabilmente. È da notare, infine, che i cinque insediamenti con ceramica a squame costituiscono una presenza davvero notevole, ove si consideri che la loro scoperta è avvenuta nel corso di ricognizioni compiute in due sole stagioni invernali e in tempi abbastanza limitati: ciò induce a far ritenere che la generale scarsità di abitati eneolitici riscontrata nella Penisola (CREMONESI e VIGLIARDI, 1988) dipenda solo dalla loro mancata individuazione, in assenza di ricerche capillari e sistematiche. RINGRAZIAMENTI Ringrazio il Prof. Giuliano Cremonesi per avermi segnalato l'opportunità di redigere questo lavoro specifico sui primi siti con ceramica a squame scoperti nel Fucino; il sig. Orante Ventura per avermi indicato i siti di Venere-Le Coste e di Ortucchio-Colle S. Stefano; la Soprintendenza Archeologica d'abruzzo per aver consentito la pubblicazione dei materiali. BIBLIOGRAFIA BAGOLINI B., CREMONESI G. (1988) - La distribuzione della ceramica a squame. Atti Congresso «L'età del rame in Europa». Rass. Arch., 7, BAlLO MODESTI G. (1988) - L'eneolitico in Campania e la facies del Gaudo. Atti Congresso «L'età del rame in Europa». Rass. Arch., 7, BARRA A., GRIFONI CREMONESI R. (in corso di stampa) - Gli scavi nella Grotta Continenza di Trasacco. Atti Convegno,<Il Fucino e le aree limitrofe nell'antichità», Avezzano. BIETTI SESTIERI A.M. (1984) - L'insediamento eneolitico di Piscina di Torre Spaccata. In: Preistoria e Protostoria del territorio di Roma. Roma, BIETTI SESTIERI A.M., GIANNI A. (1988a) - L'eneolitico recente - I. Età del Bronzo nel territorio di Roma. Atti Congresso «L'età del rame in Europa». Rass. Arch., 7, BIETTI SESTlERI A.M., GIANNI A. (1988b) - L'insediamento eneolitico di Piscina di Torre Spaccata (Roma). Atti Congresso «L'età del rame in Europa». Rass. Arch., 7, CAZZELLA A. (1972) - Considerazioni su alcuni aspetti eneolitici dell'italia meridionale e della Sicilia. Origini, 6, CAZZELLA A., MOSCOLONI M. (1988) - Le facies eneolitiche delle Marche. Atti Congresso «L'età del rame in Europa». Rass. AI ch., 7,
13 LA CERAMICA A SQUAME NEL FUCINO 215 COCCHI GENICK D. (1986) - Il Riparo dell'ambra - Una successione stratigrafica dal neolitico tardo al bronzo finale. Viareggio. COLINI G.A. (1907) - Le scoperte archeologiche del Dott. C. Rosa nella valle della Vibrata e la civiltà primitiva degli Abruzzi e delle Marche. BuI/. Pale/o l/al., 33, CREMONESI G. (1968a) - La Grotta dell'orso di Sarteano. I livelli dell'età dei metalli. Origini, 2, l. CREMONESI G. (1968b) - Contributo alla conoscenza della preistoria del Fucino. La Grotta di Ortucchio e la Grotta La Punta. Riv. SCo Preis/., 33, CREMONESI G. (1978) - Gli scavi nella Grotta n. 3 di Latronico (nota preliminare). Atti XX Riun. Sco 1.1.P.P., Firenze, CREMONESI G. (1989) - Il problema della ceramica a squame nell'italia centromeridionale in relazione alla Daunia. Atti 7 0 Conv. Preist. Protost. Storia della Daunia, Sansevero, 89-10l. CREMONESI G., VIGLIARDI A. (1988) - L'età del rame nell'italia peninsulare: problemi generali. Atti Congresso "L'età del rame in Europa. Rass. Arch., 7, D'ERCOLE V. (1982) - Pennapiedimonte. Riv. Soc. Preis/., 37, Notiz., 320. D'ERCOLE V. (1984) - Le Castagne-Castel di Ieri. Riv. Soc. Preis/., 39, Notiz., D'ERCOLE V. (1988) - L'età del rame in Abruzzo: nuovi contributi. Atti Congresso "L'età del rame in Europa. Rass. Arch., 7, DI GENNARO F., PENNACCHIONI M. (1988) - Aspetti insediativi dell'età del Rame nel Lazio Settentrionale. Atti Congresso «L'età del rame in Europa. Rass. Arch., 7, GIRAVOI C. (1988) - Evoluzione geologica della piana del Fucino (Abruzzo) negli ultimi anni. Il Qua/emario, l, GRIFONI R., RADMILLI A.M. (1964) - La Grotta Maritza e il Fucino prima dell'età romana. Riv. Soc. Preis/., 19, GRIFONI CREMONESI R. (1969) - La Grotta cultuale delle «Marmitte presso Ofena (L'Aquila). Alli Soc. Tosc. Sco Na/., Mem., SeI'. A, 76, GRIFONI CREMONESI R., DI FRA la T. (in corso di stampa) - La Grotta S. Angelo a Civitella del Tronto, luogo di culto dal neolitico ad oggi. HOLLOWAY R. (1973) - Buccino. The eneolithic Necropolis of S. Antonio and other discoveries made in 1968 and 1969 by the Brown University. Roma. IRTI U. (1986) - Gli insediamenti dell'età dei metalli nel bacino del Fucino: ricognizioni di superficie. Alli Soc. Tosc. SCo Na/., Mem., SeI'. A, 93, IRTI U. (1988) - Testimonianze preistoriche e protostoriche nell'area pre-parco della Marsica. Ricognizioni di superficie. Atti IO Convegno Nazionale di Archeologia «Il territorio del Parco Nazionale d'abruzzo nell'antichità, IRTI U. (in corso di stampa) - Gli insediamenti all'aperto del neolitico e dell'età dei metalli. Atti Convegno «Il Fucino e le aree limitrofe nell'antichità, Avezzano. LOLLINI D., BALDELLI D., LANDOLFI M., LUCENTINI N., SILVESTRINI M. (1988) - La ceramica a squame nelle Marche. Atti Congresso «L'età del rame in Europa. Rass. Arch., 7, MATTIOCCO E. (1981) - Centri fortificati preromani nella Conca di Sulmona. Pescara. MATTIOCCO E. (1986) - Centri fortificati vestini. Teramo.
14 216 IRTI U. PERONI R. (1971) - L'età del bronzo nella penisola italiana. VoI. I. L'antica età del bronzo. Firenze. PINNA M. (1984) - La storia del clima. Roma. RADI G. (1988) - L'eneolitico in Abruzzo. Atti Congresso «L'età del rame in Europa». Rass. Arch., 7, RADMILLI A.M. (1956) - Preistoria e Protostoria marsicana: gli scavi nella Grotta di Ciccio Felice. Riv. Sco Preist., 11, RADMILLI A.M. (1965) - Considerazioni sull'età del bronzo in Abruzzo. Abruzzo, 2, RADMILLI A.M. (1977) - Storia dell'abruzzo dalle origini all'età del Bronzo. Pisa. TINÉ S. (1964) - La Grotta di S. Angelo III a Cassano Ionio. Atti e Mem. Soc. Magna Grecia, 5, TozzI C. (1962) - Resti neolitici e sepolture nella Grotta La Cava (Bacino del Fucino). Atti Soc. Tose. Se. Nat., Mem., Ser. A, 69, 1-8. TozzI C. (1968) - Insediamento con resti piceni nella Conca Peligna (Sulmona). Atti Soc. Tosc. Sco Nat., Mem., Ser. A, 75, (ms. presentato il 14 dicembre 1990; ult. bozze il 28 dicembre 1990)
UN INSEDIAMENTO NEOLITICO CON CERAMICA IMPRESSA A PASSO CORDONE DI LORETO APRUTINO (PESCARA)
 Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Me",., Serie A, 101 (1994) pagg. 51-57, fìgg. 3 M. MAGGIORI UN INSEDIAMENTO NEOLITICO CON CERAMICA IMPRESSA A PASSO CORDONE DI LORETO APRUTINO (PESCARA) Riassunto - Si dà notizia
Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Me",., Serie A, 101 (1994) pagg. 51-57, fìgg. 3 M. MAGGIORI UN INSEDIAMENTO NEOLITICO CON CERAMICA IMPRESSA A PASSO CORDONE DI LORETO APRUTINO (PESCARA) Riassunto - Si dà notizia
U. IRTI PRIME TESTIMONIANZE DI UN INSEDIAMENTO DELL'ETA' DEL BRONZO A VENERE (FUCINO)
 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 89 (1982) pagg. 163-172, ff. 2. U. IRTI PRIME TESTIMONIANZE DI UN INSEDIAMENTO DELL'ETA' DEL BRONZO A VENERE (FUCINO) Riassunto - L'Autore dà notizia della scoperta
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 89 (1982) pagg. 163-172, ff. 2. U. IRTI PRIME TESTIMONIANZE DI UN INSEDIAMENTO DELL'ETA' DEL BRONZO A VENERE (FUCINO) Riassunto - L'Autore dà notizia della scoperta
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
NUOVO SITO A CERAMICA IMPRESSA NEL FUCINO (L'AQUILA)
 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 100 (1993) pagg. 4549, fig. 1 G. RADI (*), O. VENTURA (**) NUOVO SITO A CERAMICA IMPRESSA NEL FUCINO (L'AQUILA) Riassunto - Si dà notizia del rinvenimento nel
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 100 (1993) pagg. 4549, fig. 1 G. RADI (*), O. VENTURA (**) NUOVO SITO A CERAMICA IMPRESSA NEL FUCINO (L'AQUILA) Riassunto - Si dà notizia del rinvenimento nel
Acquarossa: tramonto.
 La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
III. I VETRI. BAUMGARTNER, KRUEGER 1988, p
 III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
MANUFATTI IN PIETRA LEVIGATA IN LOCALITÀ LA PADULA E PARRANA (LIVORNO)
 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Me m., Serie A, 91 (1984) pagg. 363 367, fi gg. 2. A. SART (*), P. STODUT (*) MANUFATT N PETRA LEVGATA N LOCALTÀ LA PADULA E PARRANA (LVORNO) Riassunto - Gli Autori descrivono
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Me m., Serie A, 91 (1984) pagg. 363 367, fi gg. 2. A. SART (*), P. STODUT (*) MANUFATT N PETRA LEVGATA N LOCALTÀ LA PADULA E PARRANA (LVORNO) Riassunto - Gli Autori descrivono
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4
 Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
Villaggio romano a Colamarina (Sant'Angelo d'ischia)
 Villaggio romano a Colamarina (Sant'Angelo d'ischia) Nella seconda metà del VI sec. a. C. l antico villaggio greco viene abbandonato, forse a causa di accumuli di piogge cineriti e di materiali alluvionali
Villaggio romano a Colamarina (Sant'Angelo d'ischia) Nella seconda metà del VI sec. a. C. l antico villaggio greco viene abbandonato, forse a causa di accumuli di piogge cineriti e di materiali alluvionali
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche
 Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
 EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
GRADUS RIVISTA DI ARCHEOLOGIA E DI RESTAURO ANNO 10 N. 1
 GRADUS RIVISTA DI ARCHEOLOGIA E DI RESTAURO 2015 - ANNO 10 N. 1 Domenico Barreca, Dalla produzione all'esportazione: il lungo viaggio delle salse di pesce tra il I e il IV secolo d.c.; Gloriana Pace, Barbara
GRADUS RIVISTA DI ARCHEOLOGIA E DI RESTAURO 2015 - ANNO 10 N. 1 Domenico Barreca, Dalla produzione all'esportazione: il lungo viaggio delle salse di pesce tra il I e il IV secolo d.c.; Gloriana Pace, Barbara
QUINTA CAMPAGNA DI SCAVO NELLA STAZIONE DEL PALEOLITICO INFERIORE A CASTEL DI GUIDO PRESSO ROMA
 .Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 91 (1984) pagg. 369-375, fig g. 3. A.M. RADMILLI (*) QUINTA CAMPAGNA DI SCAVO NELLA STAZIONE DEL PALEOLITICO INFERIORE A CASTEL DI GUIDO PRESSO ROMA Riassunto
.Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 91 (1984) pagg. 369-375, fig g. 3. A.M. RADMILLI (*) QUINTA CAMPAGNA DI SCAVO NELLA STAZIONE DEL PALEOLITICO INFERIORE A CASTEL DI GUIDO PRESSO ROMA Riassunto
Parco Archeologico del Forcello Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)
 Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) Recapiti Pro Loco Bagnolo tel 348 0394636, fax 0376 415446 Comune di Bagnolo San Vito tel. 0376.413317, fax 0376.415387 info@parcoarcheologicoforcello.it
Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) Recapiti Pro Loco Bagnolo tel 348 0394636, fax 0376 415446 Comune di Bagnolo San Vito tel. 0376.413317, fax 0376.415387 info@parcoarcheologicoforcello.it
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
La stratigrafia archeologica
 La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
REPORT METEOROLOGICO DEL MESE DI GENNAIO 2017 NELLA REGIONE ABRUZZO.
 Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo Ufficio Coordinamento Servizi vivaistici e Agrometeo Scerni(Ch) REPORT METEOROLOGICO DEL MESE DI GENNAIO 217 NELLA REGIONE ABRUZZO. Bruno Di Lena
Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo Ufficio Coordinamento Servizi vivaistici e Agrometeo Scerni(Ch) REPORT METEOROLOGICO DEL MESE DI GENNAIO 217 NELLA REGIONE ABRUZZO. Bruno Di Lena
La ceramica decorata appenninica: un network peninsulare della media Età del Bronzo
 La ceramica decorata appenninica: un network peninsulare della media Età del Bronzo Benito Alberto Ricciardi 1, Mariele Proietti 2, Alessandro Guidi 1, Federico Nomi 1 1 Università Roma Tre, Roma, Italia
La ceramica decorata appenninica: un network peninsulare della media Età del Bronzo Benito Alberto Ricciardi 1, Mariele Proietti 2, Alessandro Guidi 1, Federico Nomi 1 1 Università Roma Tre, Roma, Italia
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
L Eneolitico. Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, Introduzione allo studio della ceramica in archeologia. Siena 2007,
 L Eneolitico Valentina Leonini L Italia settentrionale Non è ancora possibile definire precise articolazioni cronologiche e culturali dell Eneolitico in Italia settentrionale. Lo studio si scontra infatti
L Eneolitico Valentina Leonini L Italia settentrionale Non è ancora possibile definire precise articolazioni cronologiche e culturali dell Eneolitico in Italia settentrionale. Lo studio si scontra infatti
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia
 Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2009 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
PADOVA, 5-9 NOVEMBRE 2013
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA XLVIII Riunione Scientifica PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL VENETO DEDICATA A GIULIA FOGOLARI E PIERO LEONARDI PADOVA, 5-9 NOVEMBRE 2013 Sedi della Riunione Aula
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA XLVIII Riunione Scientifica PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL VENETO DEDICATA A GIULIA FOGOLARI E PIERO LEONARDI PADOVA, 5-9 NOVEMBRE 2013 Sedi della Riunione Aula
OGGETTO : RECUPERO, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CASALE MONFERRATO - 5/8 LOTTO DI LAVORI
 MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
Documento digitalizzato dallo Staff di UnissResearch
 Melis, Maria Grazia (2000) La Domus de janas n. 3 di Iloi-Sedilo (OR). In: L'ipogeismo nel Mediterraneo: origini, sviluppo, quadri culturali: atti del Congresso internazionale, 23-28 maggio 1994, Sassari-Oristano,
Melis, Maria Grazia (2000) La Domus de janas n. 3 di Iloi-Sedilo (OR). In: L'ipogeismo nel Mediterraneo: origini, sviluppo, quadri culturali: atti del Congresso internazionale, 23-28 maggio 1994, Sassari-Oristano,
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO
 CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012
 Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Pericolosità sismica: l Abruzzo seconda regione italiana per superficie e terza per popolazione ed edifici residenziali in zona sismica 1
 L Aquila, 5 gennaio 2017 Pericolosità sismica: l Abruzzo seconda regione italiana per superficie e terza per popolazione ed edifici residenziali in zona sismica 1 È classificato in zona sismica 1 1, quella
L Aquila, 5 gennaio 2017 Pericolosità sismica: l Abruzzo seconda regione italiana per superficie e terza per popolazione ed edifici residenziali in zona sismica 1 È classificato in zona sismica 1 1, quella
TESTIMONIANZE DELL'ETA' DEL BRONZO AD ORTUCCHIO (FUCINO)
 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 88 (1981) pagg. 261-286, ff. 6. U. IRTI TESTIMONIANZE DELL'ETA' DEL BRONZO AD ORTUCCHIO (FUCINO) Riassunto - L'A. descrive il materiale dell'età del Bronzo raccolto
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 88 (1981) pagg. 261-286, ff. 6. U. IRTI TESTIMONIANZE DELL'ETA' DEL BRONZO AD ORTUCCHIO (FUCINO) Riassunto - L'A. descrive il materiale dell'età del Bronzo raccolto
OPERATIVI: L 6. I 7. I 8. I 9. I 10. I
 GEOGRAFIA INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla comprensione dell idea di spazio, partendo dalla conoscenza dello spazio vicino e vissuto, ampliando poi l orizzonte geografico verso altri ambienti per stabilire
GEOGRAFIA INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla comprensione dell idea di spazio, partendo dalla conoscenza dello spazio vicino e vissuto, ampliando poi l orizzonte geografico verso altri ambienti per stabilire
L analisi stratigrafica delle murature in elevato
 Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
1970 Santa Maria Capua Vetere (antica Capua). Necropoli delle Fornaci. Soprintendenza archeologica delle Province di Napoli e Caserta.
 1968 Alba - La Romaine (Francia). Università Claude Bernard (Lyon).. 1969 Ampurias (Spagna). Istituto di Studi Liguri. Albintimillium Ventimiglia. Istituto di Studi Liguri. Albenga. Relitto repubblicano.
1968 Alba - La Romaine (Francia). Università Claude Bernard (Lyon).. 1969 Ampurias (Spagna). Istituto di Studi Liguri. Albintimillium Ventimiglia. Istituto di Studi Liguri. Albenga. Relitto repubblicano.
Siti Archeologici L Aquila
 Siti Archeologici L Aquila Agellum Comune: Aielli Come arrivare: http://g.co/maps/3jgw3 Info: Municipio tel. 0863-78119 Alba Fucens Comune: Massa D'Albe Frazione: Albe Come arrivare: http://g.co/maps/nh6sm
Siti Archeologici L Aquila Agellum Comune: Aielli Come arrivare: http://g.co/maps/3jgw3 Info: Municipio tel. 0863-78119 Alba Fucens Comune: Massa D'Albe Frazione: Albe Come arrivare: http://g.co/maps/nh6sm
LUOGO E STATO DI CONSERVAZIONE DEPOSITO S. MARIA IN PADOVETERE COMACCHIO INTEGRO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FERRARA PARZIALMENTE RICOMPONIBILE
 N. INV. DESCRIZIONE DA REGISTRO INVENTARIALE E DIMENSIONI PROVENIENZA LUOGO E STATO DI CONSERVAZIONE VALORI PATRIMONIALI IN EURO RIVALUTATI SECONDO I COEFFICIENTI ISTAT 2015 E ARROTONDATI FOTO 46 75763
N. INV. DESCRIZIONE DA REGISTRO INVENTARIALE E DIMENSIONI PROVENIENZA LUOGO E STATO DI CONSERVAZIONE VALORI PATRIMONIALI IN EURO RIVALUTATI SECONDO I COEFFICIENTI ISTAT 2015 E ARROTONDATI FOTO 46 75763
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
IL MUSEO DELLA CERAMICA A. TAFURI a cura di Irma Pastore
 IL MUSEO DELLA CERAMICA A. TAFURI a cura di Irma Pastore Nel centro storico di Salerno, poco distante dal Duomo, nel caratteristico Largo Casavecchia, troviamo il museo della ceramica Alfonso Tafuri. Il
IL MUSEO DELLA CERAMICA A. TAFURI a cura di Irma Pastore Nel centro storico di Salerno, poco distante dal Duomo, nel caratteristico Largo Casavecchia, troviamo il museo della ceramica Alfonso Tafuri. Il
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
Le pianure. Mondadori Education
 Le pianure La pianura italiana più vasta e fertile è la Pianura Padana, che si estende da ovest verso est ai piedi delle Alpi. È una pianura di origine alluvionale, cioè si è formata in seguito al deposito
Le pianure La pianura italiana più vasta e fertile è la Pianura Padana, che si estende da ovest verso est ai piedi delle Alpi. È una pianura di origine alluvionale, cioè si è formata in seguito al deposito
DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA
 DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito ricade all interno della Riserva Naturale Selva del Lamone in zona La Roccaccia, nel comune
DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito ricade all interno della Riserva Naturale Selva del Lamone in zona La Roccaccia, nel comune
Rinvenimenti dell'eneolitico e del bronzo antico a Casalecchio di Reno (Bologna)
 Preistoria Alpina - Museo Tridentino di Scienze Naturali pagg. 147-154 Trento 1984 G. STEFFÈ Rinvenimenti dell'eneolitico e del bronzo antico a Casalecchio di Reno (Bologna) ABSTRACT Aeneolithic and Bronze
Preistoria Alpina - Museo Tridentino di Scienze Naturali pagg. 147-154 Trento 1984 G. STEFFÈ Rinvenimenti dell'eneolitico e del bronzo antico a Casalecchio di Reno (Bologna) ABSTRACT Aeneolithic and Bronze
Tipologia delle Forme vascolari. Claudio Giardino
 Tipologia delle Forme vascolari Claudio Giardino CATEGORIA Categorie sistematiche (spada, pugnale, ascia, brocca, urna) CLASSE (spada a lingua da presa, ascia ad alette, brocca, urna a collo) FORMA (spada
Tipologia delle Forme vascolari Claudio Giardino CATEGORIA Categorie sistematiche (spada, pugnale, ascia, brocca, urna) CLASSE (spada a lingua da presa, ascia ad alette, brocca, urna a collo) FORMA (spada
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA
 DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
Arte della preistoria in Calabria. Papasidero, Grotta di Romito
 Arte della preistoria in Calabria In epoca preistorica, gli abitanti della Calabria espressero in diversi modi il loro amore per l'arte. Tra le numerosissime manifestazioni artistiche dobbiamo ricordare:
Arte della preistoria in Calabria In epoca preistorica, gli abitanti della Calabria espressero in diversi modi il loro amore per l'arte. Tra le numerosissime manifestazioni artistiche dobbiamo ricordare:
POLITECNICO DI TORINO II FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea Magistrale in Architettura (ambiente e paesaggio) Tesi meritevoli di pubblicazione
 POLITECNICO DI TORINO II FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea Magistrale in Architettura (ambiente e paesaggio) Tesi meritevoli di pubblicazione Lettura e rappresentazione della città antica di Aquileia
POLITECNICO DI TORINO II FACOLTA' DI ARCHITETTURA Corso di Laurea Magistrale in Architettura (ambiente e paesaggio) Tesi meritevoli di pubblicazione Lettura e rappresentazione della città antica di Aquileia
La Valle d Aosta. il... (4 476 m). Il capoluogo di regione è...
 La Valle d Aosta La Valle d Aosta confina a nord con la......, a est e a sud con il..., a ovest con la... È una regione completamente...... Le sue cime principali sono: il...... (4 810 m), il...... (4
La Valle d Aosta La Valle d Aosta confina a nord con la......, a est e a sud con il..., a ovest con la... È una regione completamente...... Le sue cime principali sono: il...... (4 810 m), il...... (4
UNIVERSITÀ DI PISA. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
 UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
Prospetto 4.1. Pesi per unità di volume dei principali materiali strutturali
 4.PESI PROPRI DEI MATERIALI STRUTTURALI. I pesi per unità di volume dei più comuni materiali, per la determinazione dei pesi propri. strutturali, possono essere assunti pari a quelli riportati nel prospetto
4.PESI PROPRI DEI MATERIALI STRUTTURALI. I pesi per unità di volume dei più comuni materiali, per la determinazione dei pesi propri. strutturali, possono essere assunti pari a quelli riportati nel prospetto
Recupero di un passato scomparso
 Recupero di un passato scomparso Museo Civico Archeologico di anzio 22 dicembre 2013 19 gennaio 2014 Città di Anzio Museo Civico Archeologico Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio Comando Carabinieri
Recupero di un passato scomparso Museo Civico Archeologico di anzio 22 dicembre 2013 19 gennaio 2014 Città di Anzio Museo Civico Archeologico Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio Comando Carabinieri
Nota preliminare sul rinvenimento di materiale dell'età del Bronzo a Torrechiara (Parma)
 Preistoria Alpina - Museo Tridentino di Scienze Naturali I VoI. 18 I Pagg. 157-162 1 Trento 1982 I s. BONARDI M. BERNABÒ BREA Nota preliminare sul rinvenimento di materiale dell'età del Bronzo a Torrechiara
Preistoria Alpina - Museo Tridentino di Scienze Naturali I VoI. 18 I Pagg. 157-162 1 Trento 1982 I s. BONARDI M. BERNABÒ BREA Nota preliminare sul rinvenimento di materiale dell'età del Bronzo a Torrechiara
LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
 Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
LA PUGLIA LA PUGLIA È LA REGIONE PIÙ A EST DELLA PENISOLA E PER LA SUA POSIZIONE È ANCHE DETTA TACCO D'ITALIA
 LA PUGLIA LA PUGLIA È LA REGIONE PIÙ A EST DELLA PENISOLA E PER LA SUA POSIZIONE È ANCHE DETTA TACCO D'ITALIA I CONFINI E LE PROVINCE La regione confina a nord-ovest con il Molise, a ovest con la Campania,
LA PUGLIA LA PUGLIA È LA REGIONE PIÙ A EST DELLA PENISOLA E PER LA SUA POSIZIONE È ANCHE DETTA TACCO D'ITALIA I CONFINI E LE PROVINCE La regione confina a nord-ovest con il Molise, a ovest con la Campania,
Allevamenti. Consistenza
 Consistenza Distribuzione percentuale delle aziende con allevamenti % di aziende con allevamenti sul totale delle aziende % aziende con bovini sul totale aziende con allevamenti % aziende con ovini sul
Consistenza Distribuzione percentuale delle aziende con allevamenti % di aziende con allevamenti sul totale delle aziende % aziende con bovini sul totale aziende con allevamenti % aziende con ovini sul
ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA
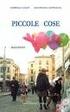 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA ATTI DELLA XLI RIUNIONE SCIENTIFICA DAI CICLOPI AGLI ECISTI SOCIETÀ E TERRITORIO NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA San Cipirello (PA), 16-19 novembre
Tarquinia, complesso monumentale : ceramica depurata etrusco-geometrica
 XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
climaticamente questa vasta area ed eventualmente verificare se sono stati registrati cambiamenti significativi degli stessi
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE UMIDE CON ESTATE CALDA Introduzione Con questo articolo inauguriamo una rassegna sui climi italiani iniziando da quelli identificati, nella convenzione internazionale,
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE UMIDE CON ESTATE CALDA Introduzione Con questo articolo inauguriamo una rassegna sui climi italiani iniziando da quelli identificati, nella convenzione internazionale,
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE MEDITERRANEE SECCHE TENDENTI ALLO STEPPICO
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE MEDITERRANEE SECCHE TENDENTI ALLO STEPPICO Introduzione Terminiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi delle aree caratterizzate da clima mediterraneo tendente
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE MEDITERRANEE SECCHE TENDENTI ALLO STEPPICO Introduzione Terminiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi delle aree caratterizzate da clima mediterraneo tendente
TERREMOTO CENTRO ITALIA Di.Coma.C Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione. Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016
 Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESISTICA E AMBIENTALE AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA)
 AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
Sabetta Ciani. MINERVA E L ARCANGELO A MINERVINO MURGE Itinerari di storia e di fede
 Sabetta Ciani MINERVA E L ARCANGELO A MINERVINO MURGE Itinerari di storia e di fede Il libro è una ricerca storica sulle origini di Minervino e insieme un cammino di fede che risponde ad una profonda devozione
Sabetta Ciani MINERVA E L ARCANGELO A MINERVINO MURGE Itinerari di storia e di fede Il libro è una ricerca storica sulle origini di Minervino e insieme un cammino di fede che risponde ad una profonda devozione
Spesso la pianura è attraversata da corsi d'acqua e per questo è un ambiente favorevole a molte attività umane e soprattutto all'agricoltura.
 LA PIANURA La pianura ha un'altitudine inferiore a 200 metri. In pianura non ci sono i rilievi. Le strade sono comode, molto trafficate, poco tortuose e prive ripide salite e discese. Ci sono autostrade,
LA PIANURA La pianura ha un'altitudine inferiore a 200 metri. In pianura non ci sono i rilievi. Le strade sono comode, molto trafficate, poco tortuose e prive ripide salite e discese. Ci sono autostrade,
Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
Veduta aerea del settore settentrionale di Pisa: localizzazione delle necropoli etrusca e romana di Via Marche
 Veduta aerea del settore settentrionale di Pisa: localizzazione delle necropoli etrusca e romana di Via Marche Progetto Antica Gente di Pisa L obiettivo è completare l indagine archeologia eseguita sul
Veduta aerea del settore settentrionale di Pisa: localizzazione delle necropoli etrusca e romana di Via Marche Progetto Antica Gente di Pisa L obiettivo è completare l indagine archeologia eseguita sul
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA --- COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC)
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO --- COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) PIANA DI SAN MARTINO SITO TARDO ANTICO ALTOMEDIEVALE INDAGINI ARCHEOLOGICHE L'area di scavo della Piana di San Martino,
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO --- COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) PIANA DI SAN MARTINO SITO TARDO ANTICO ALTOMEDIEVALE INDAGINI ARCHEOLOGICHE L'area di scavo della Piana di San Martino,
Elaborazione ERSAL CREMA ( )
 . INQUADRAMENTO CLIMATICO In generale, l area oggetto di studio è caratterizzata da un regime di tipo continentale sublitoraneo, tipico della Pianura Padana, con inverni rigidi ed estati relativamente
. INQUADRAMENTO CLIMATICO In generale, l area oggetto di studio è caratterizzata da un regime di tipo continentale sublitoraneo, tipico della Pianura Padana, con inverni rigidi ed estati relativamente
21) FLAVIO ANDO (chalet)
 21) FLAVIO ANDO (chalet) QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico
21) FLAVIO ANDO (chalet) QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione...2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e depurazione...7 Clima acustico
ALTRI DOCUMENTI SULL 'ANTICA STORIA DEI VENETI
 ALTRI DOCUMENTI SULL 'ANTICA STORIA DEI VENETI In Boemia nel 1800 a.c. circa si affermó la florida Cultura d'aunjetitz, che si propagherá in tutta la Cechia, la Slovacchia, la Polonia, la Germania, l'ungheria,
ALTRI DOCUMENTI SULL 'ANTICA STORIA DEI VENETI In Boemia nel 1800 a.c. circa si affermó la florida Cultura d'aunjetitz, che si propagherá in tutta la Cechia, la Slovacchia, la Polonia, la Germania, l'ungheria,
Parco Archeologico di Fregellae
 Parco Archeologico di Fregellae Fregellae Parco Archeologico Offerta formativa per l anno scolastico 2014/2015 Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova Museo Antropologico Gente di
Parco Archeologico di Fregellae Fregellae Parco Archeologico Offerta formativa per l anno scolastico 2014/2015 Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova Museo Antropologico Gente di
OGGETTO PROGETTAZIONE. U.T. Consorzio A.S.I. Arch. Alberto CANNAVALE ELABORATO PD_RS.01. Relazione indagine archeologica R.U.P. Geom.
 OGGETTO Riproduzione del modello "Rustici industriali" nell'agglomerato industriale di San Nicola Manfredi - San Giorgio del Sannio PROGETTO DEFINITIVO PROGETTAZIONE U.T. Consorzio A.S.I. Ing. Luigi TRAVAGLIONE
OGGETTO Riproduzione del modello "Rustici industriali" nell'agglomerato industriale di San Nicola Manfredi - San Giorgio del Sannio PROGETTO DEFINITIVO PROGETTAZIONE U.T. Consorzio A.S.I. Ing. Luigi TRAVAGLIONE
SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI. Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze. Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella
 SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella I bambini delle classi terze della Scuola Primaria Mascagni hanno svolto durante l anno scolastico
SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella I bambini delle classi terze della Scuola Primaria Mascagni hanno svolto durante l anno scolastico
Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2)
 Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2) In particolare i valori di piezometria sono risultati più bassi rispetto a quelli del
Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2) In particolare i valori di piezometria sono risultati più bassi rispetto a quelli del
LA PROVINCIA DELL AQUILA 1 DATI GENERALI
 LA PROVINCIA DELL AQUILA 1 DATI GENERALI 4 1 La presente sezione generale è estratta dal Primo Rapporto Sui Rifiuti anno 2002. 2 La provincia dell Aquila occupa un territorio di 5.034 Kmq su una superficie
LA PROVINCIA DELL AQUILA 1 DATI GENERALI 4 1 La presente sezione generale è estratta dal Primo Rapporto Sui Rifiuti anno 2002. 2 La provincia dell Aquila occupa un territorio di 5.034 Kmq su una superficie
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: STORIA (ST) N.B. L'ordine delle competenze non è tassonomico, ma è da considerare secondo una mappa concettuale.
 Pag. 1 di 11 DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: STORIA (ST) N.B. L'ordine delle competenze non è tassonomico, ma è da considerare secondo una mappa concettuale. COMPETENZA FUNZIONI COINVOLTE NUCLEI FONDANTI A
Pag. 1 di 11 DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: STORIA (ST) N.B. L'ordine delle competenze non è tassonomico, ma è da considerare secondo una mappa concettuale. COMPETENZA FUNZIONI COINVOLTE NUCLEI FONDANTI A
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
 DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il presente elaborato di valutazione del rischio archeologico, redatto in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109\2005 artt.2ter
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il presente elaborato di valutazione del rischio archeologico, redatto in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109\2005 artt.2ter
La montagna. Ghiacciai. Clima e vegetazione
 La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA
 CONCORSO PER L AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE: strutture della società, insediamenti ed organizzazione del territorio, attività produttive ELENCO TEMI XIV CICLO Tema
CONCORSO PER L AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE: strutture della società, insediamenti ed organizzazione del territorio, attività produttive ELENCO TEMI XIV CICLO Tema
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Gli Appennini. Piani di Castelluccio, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Umbria.
 Piani di Castelluccio, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Umbria. Gli Appennini sono un sistema montuoso collegato a nord-ovest alle Alpi e che si estende fino al di là dello Stretto di Messina,
Piani di Castelluccio, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Umbria. Gli Appennini sono un sistema montuoso collegato a nord-ovest alle Alpi e che si estende fino al di là dello Stretto di Messina,
Ideazione - Alessandro Maria Barelli. Fotografie - Massimo Del Citto, Alessandro Maria Barelli. Testi - Luca Tredicucci
 NUOVA EDIZIONE AMPLIATA Anno IV N 13 La Città Silente Registrata al Tribunale di Viterbo - n. 509 il 31.10.2002 Anno IV Periodico culturale Ideazione - Alessandro Maria Barelli Fotografie - Massimo Del
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA Anno IV N 13 La Città Silente Registrata al Tribunale di Viterbo - n. 509 il 31.10.2002 Anno IV Periodico culturale Ideazione - Alessandro Maria Barelli Fotografie - Massimo Del
Giardin Grande. Colle del Castello. Udine
 Giardin Grande Colle del Castello UD Udine TS G E O S I TO Colle di Udine Corrado Venturini C è un Grande Indiziato (secondo la Giuria Popolare) il Colle di Udine 26 m Attila COSA SI DICE luglio 452 d.c.
Giardin Grande Colle del Castello UD Udine TS G E O S I TO Colle di Udine Corrado Venturini C è un Grande Indiziato (secondo la Giuria Popolare) il Colle di Udine 26 m Attila COSA SI DICE luglio 452 d.c.
PU_959. Grotta di Parabita (grotta delle Veneri) sovrintendenza ai beni culturali GRUPPO SPELEOLOGICO LECCESE NDRONICO
 Lecce parco archeologico parabita strada tuglie/collepasso X X sovrintendenza ai beni culturali Pagina 1 di 12 Scheda aggiornata al 16-03-17 22:25:20 0-0-0 X 0-0-0 1 prendere la ss101 lecce-gallipoli.
Lecce parco archeologico parabita strada tuglie/collepasso X X sovrintendenza ai beni culturali Pagina 1 di 12 Scheda aggiornata al 16-03-17 22:25:20 0-0-0 X 0-0-0 1 prendere la ss101 lecce-gallipoli.
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO
 CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Per l anno scolastico 2015-2016 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Per l anno scolastico 2015-2016 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1
 COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1 1. INQUADRAMENTO Comune di: Civitella di Romagna. Località: S. Martino in Varolo. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav.
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1 1. INQUADRAMENTO Comune di: Civitella di Romagna. Località: S. Martino in Varolo. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav.
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
GLI INSEDIAMENTI TURISTICI DI MARILLEVA: ANALISI DELLA
 GLI INSEDIAMENTI TURISTICI DI MARILLEVA: ANALISI DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA E DELLA SITUAZIONE PROPRIETARIA LA RICETTIVITÀ TURISTICA NEL COMUNE DI MEZZANA Gli insediamenti turistici di Marilleva 1400
GLI INSEDIAMENTI TURISTICI DI MARILLEVA: ANALISI DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA E DELLA SITUAZIONE PROPRIETARIA LA RICETTIVITÀ TURISTICA NEL COMUNE DI MEZZANA Gli insediamenti turistici di Marilleva 1400
Indice. 1. Descrizione generale dei tratti autostradali e caratterizzazione dell area. 2. Programmi di contenimento del rumore - Tratto Toscano
 Indice 1. Descrizione generale dei tratti autostradali e caratterizzazione dell area 2. Programmi di contenimento del rumore - Tratto Toscano 3. Popolazione esposta 4. Superficie esposta - pag. 1 di 6
Indice 1. Descrizione generale dei tratti autostradali e caratterizzazione dell area 2. Programmi di contenimento del rumore - Tratto Toscano 3. Popolazione esposta 4. Superficie esposta - pag. 1 di 6
LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE
 Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
OBIETTIVO GENERALE: promuovere la conoscenza degli elementi significativi del trascorrere del tempo cogliendone le trasformazioni
 CURRICOLO DI STORIA CLASSE PRIMA OBIETTIVO GENERALE: promuovere la conoscenza degli elementi significativi del trascorrere del tempo cogliendone le trasformazioni Sa cogliere il concetto di tempo cronologico,
CURRICOLO DI STORIA CLASSE PRIMA OBIETTIVO GENERALE: promuovere la conoscenza degli elementi significativi del trascorrere del tempo cogliendone le trasformazioni Sa cogliere il concetto di tempo cronologico,
Capitolo 6 Rilevamento geologico
 Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
BORS, UNA VALLE MINERARIA
 BORS, UNA VALLE MINERARIA Alagna ha antiche tradizioni minerarie con miniere di oro, argento, ferro, rame, manganese e, stando a quanto rilevato su un antica carta [Senex 1721]. anche di cristalli (Mine
BORS, UNA VALLE MINERARIA Alagna ha antiche tradizioni minerarie con miniere di oro, argento, ferro, rame, manganese e, stando a quanto rilevato su un antica carta [Senex 1721]. anche di cristalli (Mine
Edilizia rurale 1. Il caso della pianura padana (da Bacchetta 2003)
 Edilizia rurale 1 Il caso della pianura padana (da Bacchetta 2003) Critica della tradizione Lugli Visione esclusiva dell aspetto monumentale Lettura talvolta strumentale della fonte antica Assillo della
Edilizia rurale 1 Il caso della pianura padana (da Bacchetta 2003) Critica della tradizione Lugli Visione esclusiva dell aspetto monumentale Lettura talvolta strumentale della fonte antica Assillo della
GEO-ARCHEOLOGIA SEZIONE TOSCANA
 SEZIONE TOSCANA Le vie cave : straordinari monumenti da salvare Le vie cave costituiscono un grande patrimonio storicoarcheologico, culturale e paesaggistico pressoché unico, e sono tra i principali aspetti
SEZIONE TOSCANA Le vie cave : straordinari monumenti da salvare Le vie cave costituiscono un grande patrimonio storicoarcheologico, culturale e paesaggistico pressoché unico, e sono tra i principali aspetti
10. Lo studio palinostratigrafico e archeobotanico dei depositi archeologici e delle attività dell uomo
 Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
 F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome DE ASCENTIS MASSIMO Indirizzo 01, VIA VOLTURNO, 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI - AQ Telefono 329 4615048 Fax --- E-mail massimodeascentis@yahoo.it
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome DE ASCENTIS MASSIMO Indirizzo 01, VIA VOLTURNO, 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI - AQ Telefono 329 4615048 Fax --- E-mail massimodeascentis@yahoo.it
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE)
 Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
