Newsletter del CeMAV Anno 3 - N novembre 2010 Comune di Pavia. Centro Regionale Educazione Ambientale
|
|
|
- Jacopo Spinelli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Newsletter del CeMAV Anno 3 - N novembre 2010 Comune di Pavia Università di Pavia Centro Regionale Educazione Ambientale Assessorato Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Sanità Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia Dipartimento di Ecologia del Territorio Sezione di Ecologia Centro di Monitoraggio Ambientale della roggia Vernavola responsabile scientifico: Renato Sconfietti comitato di coordinamento: Massimo Valdati, Guido Corsato, Bruno Iofrida, Pinuccia Spadaro, Italo Venzaghi IL BILANCIO DEL TERZO ANNO Il 5 novembre presso la sede del CeMAV si è riunito il comitato di coordinamento - nel quale è entrato anche il dott. Guido Corsato, dirigente del Servizio Ecologia - per discutere i risultati del terzo anno di monitoraggio e decidere il destino del Centro nell immediato futuro: ha senso proseguire solo se si riesce ad avere dei riscontri collaborativi e, almeno in parte, risolutivi. L assessore Valdati e i suoi collaboratori hanno preso atto della situazione negativa sostanzialmente immutata che si registra all ingresso nord del Parco, a Montemaino, in relazione agli scarichi provenienti da San Genesio, e si impegnano a smuovere in tempi brevi la situazione intervenendo con maggiore fermezza. Viene segnalata anche una situazione negativa nel territorio del Comune di Pavia, evidenziata dai nuovi dati di monitoraggio acquisiti quest anno con l aggiunta di un ulteriore stazione di campionamento all altezza di Viale Cremona, dove si registra un nuovo picco di colibatteri. Insieme si decide, allora, di convocare un tavolo tecnico per il 23 novembre, chiedendo l intervento di ASM-Pavia e Pavia-Acque e invitando il prof. Sergio Papiri, direttore del Centro di Ricerca sulle Acque dell Università di Pavia, che ha competenza ed esperienza specifica in materia. Nel frattempo il Comune di San Genesio ci comunica di aver attivato alcune indagini mirate alla soluzione del problema da noi segnalato ben due anni fa (!); viene, quindi, invitato al tavolo tecnico. Nel corso della riunione sono state affrontate e discusse tutte le problematiche presentate; l apporto sinergico di competenze e conoscenze specifiche ha consentito di chiarire molti aspetti tecnici e di orientare le prossime azioni. Adesso ci aspettiamo che in tempi brevi il Comune di San Genesio ci comunichi quanto emerso dalle indagini conoscitive in corso e le strategie che saranno adottate per risolvere i problemi ben noti. Per la situazione a Pavia, le cui origini sono state abbastanza circoscritte (si veda p. 8-9), l assessore si impegna ad affrontare con urgenza il problema. Da parte mia, come responsabile scientifico, mi impegno a monitorare l evoluzione della vicenda e a sollecitarne una soluzione positiva. Renato Sconfietti, responsabile scientifico stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia 1
2 Comune di Pavia - CREA Dip. Ecologia del Territorio, Università di Pavia METODI DI INDAGINE PER IL MONITORAGGIO SINTESI Scelta delle stazioni Alle tre stazioni sinora indagate, a partire dalla prima campagna 2010 il monitoraggio si è aggiunta una quarta stazione, st. 7, collocata circa a metà tra la st. 5 e la st. 8, mantenendo il riferimento alla numerazione utilizzata nel primo anno di indagine (2007). La prima stazione di campionamento è all ingresso del parco a Mirabello: st. 1; la seconda nel tratto rettilineo poco dopo l ingresso nel parco dalla strada Vigentina: st. 5; la terza nel punto di attraversamento di viale Cremona. st. 7; la quarta al ponte di strada Scagliona, vicino all omonima cascina, nel tratto a valle: st. 8. V5 V1 Qualità biologica Si utilizza il metodo IBE (Indice Biotico Esteso) seguendo il protocollo riportato nel manuale APAT del 2001; il metodo prevede l utilizzo dei macroinvertebrati bentonici come bioindicatori. V7 V8 Dal valore IBE si risale alla classe di qualità biologica (C.Q.) e al relativo giudizio di qualità. I.B.E C.Q. I II III IV V Livello Inquinamento da Macrodescrittori È stato preso come riferimento il modello analitico suggerito dalla Tabella 7 del DLgs n. 152/1999, che consente di definire l indice LIM utilizzando come macrodescrittori sette parametri chimici e microbiologici essenziali, riferiti al bilancio dell ossigeno nell acqua, ai nutrienti (azoto e fosforo) e alla presenza del colibatterio Escherichia coli, tracciante di inquinamento da reflui urbani. I valori identificati in laboratorio per ciascun parametro portano all assegnazione di un punteggio, la cui sommatoria consente di definire il Livello di Inquinamento. Le analisi sono eseguite dal prof. Italo Venzaghi. Parametro liv. 1 liv. 2 liv. 3 liv. 4 liv OD > 50 (% sat) BOD 5 2, > 15 (O 2 mg/l) COD (O 2 mg/l) < > 25 NH 4 < 0,03 0,10 0,50 1,50 > 1,50 (N mg/l) NO 3 (N mg/l) < 0,3 1,5 5,0 10,0 > 10,0 Fosforo tot. < 0,07 0,15 0,30 0,60 > 0,60 (P mg/l) E. coli UFC/ 100 ml < *10 4 >2*10 4 punteggio Livello di Inquinamento (sommatoria) < 60 Per i dettagli sui metodi analitici si rimanda alla Newsletter n. 0 del gennaio stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia
3 Newsletter del CeMAV Anno 3 - N novembre 2010 Dopo la prima Newsletter del febbraio 2010 non sono stati resi pubblici i dati delle campagne di monitoraggio. Provvediamo, quindi, a presentare i risultati delle campagne di aprile, luglio e ottobre. CAMPAGNA 26 APRILE 2010 QUALITÀ BIOLOGICA (IBE) dati st. 1 st. 5 st.7 st. 8 U.S IBE CQ V IV IV IV STATO ECOLOGICO (SECA) st. 1 st. 5 st.7 st. 8 classe qualità V IV IV IV LIVELLO DI INQUINAMENTO (LIM) Parametro st. 1 st. 5 st.7 st OD (% sat) BOD 5 (O 2 mg/l) 3,7 1,8 2,8 1,9 COD (O 2 mg/l) 14,6 7,1 10,9 9,6 NH 4 (N mg/l) 0,61 0,14 0,22 0,19 NO 3 (N mg/l) 1,5 1,6 2,0 1,2 Fosforo tot. (P mg/l) 0,15 0,10 0,11 0,11 E. coli (UFC/100 ml) livello III II III II CAMPAGNA 16 LUGLIO 2010 QUALITÀ BIOLOGICA (IBE) dati st. 1 st. 5 st.7 st. 8 U.S IBE CQ IV III IV-III III STATO ECOLOGICO (SECA) st. 1 st. 5 st.7 st. 8 classe qualità IV III IV-III III LIVELLO DI INQUINAMENTO (LIM) Parametro st. 1 st. 5 st.7 st OD (% sat) BOD 5 (O 2 mg/l) 1,8 1,7 2,6 1,6 COD (O 2 mg/l) 14,9 12,4 14,9 9,6 NH 4 (N mg/l) 0,46 0,12 0,27 0,10 NO 3 (N mg/l) 2,3 1,8 1,8 2,6 Fosforo tot. (P mg/l) 0,18 0,32 0,15 0,21 E. coli (UFC/100 ml) livello III III III II CAMPAGNA 19 OTTOBRE 2010 QUALITÀ BIOLOGICA (IBE) dati st. 1 st. 5 st.7 st. 8 U.S IBE CQ IV-III III IV IV STATO ECOLOGICO (SECA) st. 1 st. 5 st.7 st. 8 classe qualità IV III IV-III III LIVELLO DI INQUINAMENTO (LIM) Parametro st. 1 st. 5 st.7 st OD (% sat) BOD 5 (O 2 mg/l) 1,6 1,3 2,0 1,8 COD (O 2 mg/l) 10,5 6,3 10,1 7,2 NH 4 (N mg/l) 0,57 0,17 0,38 0,11 NO 3 (N mg/l) 2,8 1,3 2,0 1,9 Fosforo tot. (P mg/l) 0,15 0,08 0,14 0,12 E. coli (UFC/100 ml) livello III III II II stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia 3
4 Comune di Pavia - CREA Dip. Ecologia del Territorio, Università di Pavia APPLICAZIONE DELL INDICE DIATOMICO Nell ambito delle indagini che il nostro laboratorio continua a svolgere sulla Vernavola in occasione dell ultima campagna di indagini è stato applicato anche un indice di qualità delle acque basato sullo studio delle Diatomee bentoniche, alghe unicellulari che ricoprono le superfici immerse in acqua dolce e sono utilizzate come indicatori biologici. LE DIATOMEE Le Diatomee sono alghe brune, unicellulari, generalmente delle dimensioni di pochi µm, che possono vivere isolate o formare colonie. Caratteristica peculiare è la parete cellulare composta principalmente da silice, detta frustulo, che racchiude la cellula come una scatola: il coperchio detto epivalva e il fondo detto ipovalva. Nei corsi d acqua le Diatomee vanno a costituire, assieme a batteri, funghi, protozoi ed altri organismi fotosintetici, la comunità del periphyton. Per le Diatomee bentoniche il tipo di substrato al quale aderiscono è una caratteristica molto importante, che ne controlla la distribuzione delle specie. In base al substrato su cui sono adese, le comunità diatomiche sono distinte in: -) epifitiche, quando si sviluppano sulla superficie di altri vegetali, quali macroalghe, muschi e piante acquatiche; -) epilitiche, se invece, aderiscono a substrati duri naturali o artificiali (per es. ciottoli, rocce, pilastri di ponti). Le Diatomee epilitiche sono considerate lo strumento migliore per il monitoraggio fluviale; essendo organismi vegetali, le Diatomee sono influenzate da numerose variabili ambientali come la luce, la temperatura, il ph, la salinità, la velocità di corrente, la concentrazioni di ossigeno, sostanza organica, nutrienti ed eventualmente metalli pesanti. Le comunità sono quindi capaci di rispondere efficacemente alle variazioni di questi fattori, variando le specie che le compongono. LE DIATOMEE COME INDICATORI BIOLOGICI Le Diatomee presentano caratteristiche bioecologiche che le rendono sicuramente dei buoni indicatori della qualità ambientale: -) sono organismi vegetali ubiquitari, presenti durante tutto l anno con un elevato numero di specie; -) sono alla base della rete trofica e quindi sensibili alle variazioni dei parametri chimici e fisici delle acque; -) molte specie presentano una auto-ecologia ben definita. L utilizzo delle Diatomee come indicatori presenta, però, anche alcuni svantaggi: infatti la difficoltà nella identificazione delle singole specie, dovuta all assenza di chiavi dicotomiche, richiede una formazione specifica e mirata dell operatore. Nonostante tale difficoltà, l efficacia delle Diatomee come bio-indicatori è comunque confermata dal loro ampio utilizzo nella valutazione della qualità delle acque in tutta Europa. Inoltre i risultati ottenuti dallo studio delle comunità diatomiche forniscono informazioni peculiari, che possono integrare il giudizio di qualità espresso dall analisi della componente macrobentonica. ATTIVITA DI CAMPO Il successo dell utilizzo della comunità diatomica come indicatore biologico è dovuto soprattutto alla rapidità ed economicità del campionamento. Il campionamento delle diatomee epilitiche viene effettuato attraverso la spazzolatura di 4 o 5 massi o ciottoli nella zona centrale dell alveo, avendo cura di escludere le zone in cui la corrente lenta (es. pozze laterali) potrebbe favorire il proliferare di alghe filamentose. Il campione viene quindi fissato con alcool al 90% e trasportato in laboratorio. ATTIVITA DI LABORATORIO In laboratorio per prima cosa è necessario eliminare la sostanza organica presente nel campione. Per 4 stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia
5 Newsletter del CeMAV Anno 3 - N novembre 2010 fare questo sono noti da bibliografia alcuni metodi tra cui quello dell incenerimento tramite muffola a 500 C. Una volta eliminata la sostanza organica è necessario allestire un vetrino permanente, utilizzando una resina ad elevato indice di rifrazione, per consentire il lavoro al microscopio. Il campione viene poi analizzato al microscopio con un ingrandimento 100x ad immersione. Per l applicazione degli indici diatomici per ogni campione devono essere contati almeno 400 individui, i- dentificati tramite la morfologia dei frustoli a livello di specie. L INDICE DIATOMICO DI EUTROFIZZAZIONE (EPI-D) L Indice Diatomico di Eutrofizzazione/Polluzione o EPI-D è un indice integrato, basato sulla sensibilità della comunità diatomica ai nutrienti e alla sostanza organica di un corpo idrico. Il risultato fornito dall indice EPI-D è un valore compreso tra 0 e 4, dove i valori prossimi allo 0 indicano acque pulite, mentre quelli vicino a 4 stanno a significare acque molto compromesse. Allo scopo di mettere in relazione i risultati forniti dall indice EPI-D con quelli derivanti da altri indici biotici (es. IBE), è stata costruita una tabella di conversione dei punteggi in cinque classi di qualità. In molti paesi d Europa vengono utilizzati indici diatomici diversi per la valutazione della qualità biologica degli ambienti d acqua corrente., per i quali sono utilizzate scale differenti; al fine di uniformare e poter facilmente confrontare i risultati da essi forniti, anche l indice EPI-D è stato ricondotto ad una scala 1-20, dove valori prossimi a 20 significano acque pulite mentre i valori prossimi a 1 segnalano ambienti gravemente compromessi; l interpretazione dei valori si inverte rispetto a quella che si ottiene con l EPI-D in scala 0-4, pur rimanendo invariato il giudizio finale. I RISULTATI PER LA VERNAVOLA Le stazioni indagate risultano nella Classe di Qualità (CQ) III, tranne la st. V7, in Viale Cremona, che si trova in CQ IV. I risultati, seppure non pienamente sovrapponibili a quelli dell IBE, registrano comunque una situazione ambientale di sofferenza EPI-D EPI-D CQ CQ Un campione di diatomee al microscopio V1 V5 V7 V8 dott. Daniele Paganelli, PhD Dip. Ecologia del Territorio Università di Pavia stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia 5
6 Comune di Pavia - CREA Dip. Ecologia del Territorio, Università di Pavia STATO DELL AMBIENTE 2010 I.B.E. medio 8 7 III valori I.B.E st. 1 st. 5 st. 7 st. 8 IV V La qualità biologica su scala annuale mostra un quadro sostanzialmente immutato rispetto alle indagini precedenti, e l aggiunta della st. 7 non porta variazioni particolari. Si oscilla tra la III e la IV classe, con la st. 5 che mediamente ha valori di poco più elevati rispetto alle altre, e sufficienti ad assegnare una CQ III come qualità media. Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori indica una condizione stabilmente peggiore nella stazione più a monte, determinato soprattutto dai valori elevati di Escherichia coli e ioni ammonio (si veda in dettaglio nella pagine precedente), indicatori di reflui fognari. Tendenzialmente la stazione più a valle, st. 8, presenta una situazione lievemente migliore, probabilmente dovuta anche a fattori diluitivi L.I.M st. 1 st. 5 st. 7 st. 8 I.B.E. febbr apr lugl ott In ogni caso resta una situazione mediamente critica, che può essere rimediata solo in parte perchè legata alla condizione particolare della roggia, di fatto praticamente urbana e a bassa capacità autodepurativa intrinseca. Sarebbe, comunque, un risultato soddisfacente riuscire a portare la qualità media su valori a cavallo fra la classe III e la classe II, con valori di IBE tra 7 e 8 anzichè 5-6. Questo traguardo potrebbe essere raggiunto I attuando le strategie che emergeranno dal tavolo tecnico, che si riunirà a breve II su convocazione del nostro assessore all ambiente. III febbr apr lugl ott IV V India Pesci, Italo Venzaghi, Renato Sconfietti st. 1 st. 5 st. 7 st. 8 6 stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia
7 Newsletter del CeMAV Anno 3 - N novembre 2010 LA SITUAZIONE DEI COLIBATTERI UFC Escherichia coli febbr apr lugl ott st. 1 st. 5 st. 7 st. 8 I colibatteri, e qui in particolare l Escherichia coli, sono batteri simbionti presenti nel nostro intestino, cioè batteri che con-vivono con noi traendone un vantaggio (si cibano di una piccolissima frazione di quanto ingeriamo) e fornendoci un vantaggio, in quanto ci aiutano nell ottimizzare i processi digestivi attraverso la produzione di particolari enzimi. Vengono espulsi con le feci, e in questo modo si rinnova la popolazione batterica intestinale. Se nell intestino la loro presenza è indubbiamente preziosa, in altri apparati possono diventare, invece, parassiti patogeni: molte infezioni urinarie hanno come responsabili proprio questi batteri. Come tutti i simbionti (o parassiti, secondo le situazioni) obbligati per svolgere il loro ciclo vitale, o addirittura semplicemente per sopravvivere, hanno necessariamente bisogno di un ospite. Pertanto la loro vita al di fuori dell ospite è molto precaria e di breve durata. Vista la loro provenienza, la presenza nelle acque è un inequivocabile indicatore di apporti fecali, umani o di altri grandi mammiferi, come bovini o suini. Se ciò avviene, normalmente si registrano anche valori elevati di azoto, soprattutto ammoniacale, sotto forma di ione ammonio NH 4 +. Può succedere anche che ci sia immissione di colibatteri in assenza di elevati carichi di azoto, come in uscita da impianti di depurazione dove manca la disinfezione finale; nel fiume Ticino, per esempio, la non-balneabilità è legata al superamento della soglia considerata critica per i colibatteri, soprattutto in uscita dai depuratori a valle di Vigevano, compreso quello di Pavia. In acqua i colibatteri, fuori dal loro microambiente specifico (l intestino) hanno scarsa sopravvivenza. Nella roggia Vernavola la diminuzione di colibatteri che si registra a valle delle stazioni con i valori più elevati è dovuta sia all aumento di portata, che porta ad una riduzione della concentrazione, sia al naturale decadimento della carica batterica. Un nuovo picco segnala una nuova immissione. La comparazione dei tre anni di monitoraggio mostra un picco iniziale sempre presente, dovuto alle immissioni a monte della st. 1, all inizio del parco (San Genesio). Le osservazioni eseguite nel 2010 hanno confermato, però, la presenza di un altra immissione, non meno importante, localizzabile tra la st. 5 (ingresso parco Strada Vigentina) e la st. 7 (Viale Cremona), nel tratto del doppio corso Vernavola-Vernavolino. Vista la persistenza dei picchi nelle st. 1 e 7 si può immaginare che non si tratti di eventi sporadici, ma che piuttosto ci si trovi in presenza di immissioni non autorizzate o, comunque, dirette di reflui fognari, non adeguatamente indirizzati verso la rete di collettamento. India Pesci e Renato Sconfietti stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia 7
8 Comune di Pavia - CREA Dip. Ecologia del Territorio, Università di Pavia TAVOLO TECNICO DEL CEMAV - 23 NOVEMBRE Il 23 novembre scorso presso la sede del CREA, che ospita il CeMAV, si è tenuta la riunione tecnica decisa il 5 novembre dal Comitato di Coordinamento. Erano presenti il comitato del CeMAV, al completo, il prof. Sergio Papiri del Dip. di Ingegneria idraulica e ambientale dell Università di Pavia che si ringrazia per la disponibilità - il sig. Giampaolo Roscio di ASM-Pavia, e l ing. Carlo Cassani, incaricato una settimana prima dal Comune di San Genesio di studiare il problema degli scarichi di acque reflue in Vernavola. Erano assenti l ing. Carlo Mascheroni di PaviaAcque, per un impegno improrogabile, e i responsabili del Comune di San Genesio, che hanno delegato la loro presenza al consulente. Per la situazione di San Genesio una breve discussione tecnica ha messo a fuoco il problema, identificandone le cause peraltro già segnalate in dettaglio nella nostra Newsletter 1-4 del 2008 e nuovamente sollecitate nella Newsletter 2-4 del e avanzando anche qualche proposta di soluzione, che comunque dovrà essere valutata dal consulente ing. Cassani e trasmessa al Comune. Considerata la difficoltà di collaborazione sinora riscontrata, sarà fondamentale seguire da vicino l evolversi della situazione, allo scopo di sollecitarne una rapida soluzione. Zone critiche a San Genesio ed Unitii: 1 reflui diretti; 2 scaricatore di piena quasi sempre attivo. 2 Per la criticità segnalata a Pavia all altezza di Viale Cremona, e quindi localizzata fra la Torretta, dove 1 è fissata una stazione CeMAV, e la stazione successiva in viale Cremona sono state localizzate cinque possibili fonti di reflui fognari, riportate nella CTR alla pagina successiva, che spesso scaricano nella fogna senza che questa sia, in realtà, allacciata al collettore. Talvolta si tratta, invece, di scaricatori di piena che non funzionano bene e, quindi, si trovano a sversare i loro reflui nei corpi idrici identificati come recettori. Le zone critiche, elencate da monte a valle, sono: 1 via Poma, a ridosso dell area dell ex riseria Scotti, dove alcuni edifici sversano nella condotta emissaria di uno scaricatore di piena, che a sua volta scarica nella Vernavola; 2 via S. Spirito, nei pressi del Mulino S. Giacomo non molto a valle della derivazione del Vernavolino, dove probabilmente si trova uno scaricatore poco efficiente; 3 strada Cascina Spelta, a monte di Viale Lodi; 4 Villa Serafina, poco a valle di Viale Lodi; 5 via Baldo degli Ubaldi, vicino a Viale Cremona. Poichè le situazioni emerse non sono per lo più inadempienze di soggetti privati, allacciati regolarmente alla rete fognaria, la soluzione del problema è a carico dei soggetti pubblici coinvolti, nello specifico PaviaAcque e Comune di Pavia. La segnalazione di tali criticità era già stata puntualizzata qualche anno fa da ASM in un rapporto depositato al Comune di Pavia, ma l avvicendarsi degli amministratori e l evoluzione del ruolo della stessa ASM, allo stato attuale solo gestore delle acque reflue, hanno fatto in modo che il problema non venisse affrontato. E volontà dell Amministrazione comunale, espressa dall ass. Valdati, di trovare idonee soluzioni per evitare gli impatti cronici e garantire, per quanto possibile, la salvaguardia della roggia Vernavola. Il team dell assessorato si è impegnato a contattare immediatamente PaviaAcque per segnalare quanto emerso e acquisire informazioni in proposito. Occorrerà, poi, eseguire sopralluoghi mirati per chiarire alcuni aspetti. Autonomamente il CeMAV effettuerà almeno una campagna di campionamento per la misura della carica di colibatteri in tutti i punti critici segnalati nel tratto interessato. Renato Sconfietti e Giuseppina Spadaro 8 stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia
9 Newsletter del CeMAV Anno 3 - N novembre Localizzazione delle criticità individuate nel tratto Torretta-viale Cremona (riunione tavolo tecnico 23 novembre 2010) 1 via Poma; 2 via S. Spirito; 3 strada Cascina Spelta; 4 Villa Serafina; 5 via Baldo degli Ubaldi. stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia 9
10 Comune di Pavia - CREA Dip. Ecologia del Territorio, Università di Pavia SEDE e CONTATTI Centro Regionale Educazione Ambientale via Case Basse Torretta 11/13 tel. n fax creapv@comune.pv.it renato.sconfietti@unipv.it Responsabile scientifico: Renato Sconfietti, professore aggregato di Ecologia, Dip. Ecologia del Territorio, Univ. di Pavia Comitato di coordinamento Massimo Valdati, assessore all Ambiente, Sviluppo sostenibile, Sanità Guido Corsato, Dirigente Servizio Ecologia Bruno Iofrida, funzionario Ufficio Ecologia Pinuccia Spadaro, responsabile CREA Italo Venzaghi, formatore per l area chimica dei progetti CREA, professore a contratto di Analisi chimicotossicologiche, Fac. di Farmacia, Univ. statale di Milano E possibile richiedere copia elettronica del notiziario o essere inseriti nella mailing list. Il notiziario è scaricabile dal sito 10 stampato dal Centro Stampa del Comune di Pavia
Newsletter del CeMAV Anno XI - N. 1 - marzo 2018 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno XI - N. 1 - marzo 2018 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia - Energia - Agenda 21, Sviluppo sostenibile Settore Mobilità e Tutela
Newsletter del CeMAV Anno XI - N. 1 - marzo 2018 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia - Energia - Agenda 21, Sviluppo sostenibile Settore Mobilità e Tutela
Newsletter del CeMAV Anno IX - N novembre 2016 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno IX - N. 3-4 - novembre 2016 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia, Sviluppo Sostenibile e Urbanistica Settore Mobilità, Sport
Newsletter del CeMAV Anno IX - N. 3-4 - novembre 2016 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia, Sviluppo Sostenibile e Urbanistica Settore Mobilità, Sport
Newsletter del CeMAV Anno 4 - N luglio 2011 Comune di Pavia. Centro Regionale Educazione Ambientale
 Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 2-3 - luglio 2011 Comune di Pavia Università di Pavia Centro Regionale Educazione Ambientale Assessorato Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Sanità Settore Ambiente e Territorio
Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 2-3 - luglio 2011 Comune di Pavia Università di Pavia Centro Regionale Educazione Ambientale Assessorato Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Sanità Settore Ambiente e Territorio
Newsletter del CeMAV Anno X - N. 1 - febbraio 2017 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno X - N. 1 - febbraio 2017 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia, Sviluppo Sostenibile e Urbanistica Settore Mobilità, Sport e
Newsletter del CeMAV Anno X - N. 1 - febbraio 2017 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia, Sviluppo Sostenibile e Urbanistica Settore Mobilità, Sport e
Newsletter del CeMAV Anno VII - N. 4 - novembre 2014 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno VII - N. 4 - novembre 2014 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia e Sviluppo sostenibile Settore Tutela ambientale Servizio Ecologia
Newsletter del CeMAV Anno VII - N. 4 - novembre 2014 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia e Sviluppo sostenibile Settore Tutela ambientale Servizio Ecologia
Newsletter del CeMAV Anno VI - N. 1 - marzo 2013 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno VI - N. 1 - marzo 2013 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno VI - N. 1 - marzo 2013 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 1 - marzo 2011 Comune di Pavia. Centro Regionale Educazione Ambientale
 Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 1 - marzo 2011 Comune di Pavia Università di Pavia Centro Regionale Educazione Ambientale Assessorato Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Sanità Settore Ambiente e Territorio
Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 1 - marzo 2011 Comune di Pavia Università di Pavia Centro Regionale Educazione Ambientale Assessorato Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Sanità Settore Ambiente e Territorio
Newsletter del CeMAV Anno X - N. 2 - maggio 2017 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno X - N. 2 - maggio 2017 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia, Sviluppo Sostenibile e Urbanistica Settore Mobilità, Sport e Tutela
Newsletter del CeMAV Anno X - N. 2 - maggio 2017 C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Comune di Pavia Assessorato Ecologia, Sviluppo Sostenibile e Urbanistica Settore Mobilità, Sport e Tutela
Newsletter del CeMAV Anno V - N. 2 - maggio 2012 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno V - N. 2 - maggio 2012 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno V - N. 2 - maggio 2012 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno V - N. 3 - luglio 2012 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno V - N. 3 - luglio 2012 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno V - N. 3 - luglio 2012 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 4 - novembre 2011 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 4 - novembre 2011 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno 4 - N. 4 - novembre 2011 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
ARPA Sezione di Rimini
 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Il L.I.M. risulta di Livello 3 (punteggio complessivo 180) e pur risultando superiore rispetto ai valori degli ultimi due anni, si può comunque considerare in
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Il L.I.M. risulta di Livello 3 (punteggio complessivo 180) e pur risultando superiore rispetto ai valori degli ultimi due anni, si può comunque considerare in
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci
 Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
10 IL BACINO DEL TORRENTE TAVOLLO
 10 IL BACINO DEL TORRENTE TAVOLLO Pagina 94 10.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Tavollo è incuneato fra quelli del Ventena e del Foglia. Il bacino del torrente Tavollo ha una superficie complessiva
10 IL BACINO DEL TORRENTE TAVOLLO Pagina 94 10.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Tavollo è incuneato fra quelli del Ventena e del Foglia. Il bacino del torrente Tavollo ha una superficie complessiva
Newsletter del CeMav Anno 1 - N. 0 - Gennaio 2008 Comune di Pavia. Centro Regionale Educazione Ambientale
 Newsletter del CeMav Anno 1 - N. 0 - Gennaio 2008 Comune di Pavia Università di Pavia Centro Regionale Educazione Ambientale Assessorato Sviluppo Sostenibile -Ambiente Settore Ambiente e Territorio Dipartimento
Newsletter del CeMav Anno 1 - N. 0 - Gennaio 2008 Comune di Pavia Università di Pavia Centro Regionale Educazione Ambientale Assessorato Sviluppo Sostenibile -Ambiente Settore Ambiente e Territorio Dipartimento
MACROINVERTEBRATI BENTONICI E QUALITÀ DELLE ACQUE. Isola della Cona, Riserva Naturale Regionale della Foce dell Isonzo, Staranzano (GO)
 MACROINVERTEBRATI BENTONICI E QUALITÀ DELLE ACQUE 25 maggio 2016 Marco Bertoli Isola della Cona, Riserva Naturale Regionale della Foce dell Isonzo, Staranzano (GO) I macroinvertebrati bentonici Alcune
MACROINVERTEBRATI BENTONICI E QUALITÀ DELLE ACQUE 25 maggio 2016 Marco Bertoli Isola della Cona, Riserva Naturale Regionale della Foce dell Isonzo, Staranzano (GO) I macroinvertebrati bentonici Alcune
5 IL BACINO DEL FIUME USO
 5 IL BACINO DEL FIUME USO Pagina 39 5.1 GENERALITÀ Il bacino idrografico del fiume Uso è costituito da una superficie, stretta e lunga, di 141 km 2 compresa tra i bacini idrografici dei fiumi Savio, Rubicone
5 IL BACINO DEL FIUME USO Pagina 39 5.1 GENERALITÀ Il bacino idrografico del fiume Uso è costituito da una superficie, stretta e lunga, di 141 km 2 compresa tra i bacini idrografici dei fiumi Savio, Rubicone
13 dicembre Descrizione dell attività didattica
 13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
I RISULTATI WQI 1) BOD
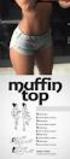 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
Newsletter del CeMAV Anno V - N. 1 - febbraio 2012 C.R.E.A.
 Newsletter del CeMAV Anno V - N. 1 - febbraio 2012 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
Newsletter del CeMAV Anno V - N. 1 - febbraio 2012 Comune di Pavia Assessorato Istruzione-Ecologia Settore Ambiente e Territorio Servizio Ecologia C.R.E.A. Centro Regionale di Educazione Ambientale Università
9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA
 9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA Pagina 83 9.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Ventena confina in sinistra idrografica con il bacino del Conca ed in destra con i bacini del Foglia e del Tavollo. Il bacino
9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA Pagina 83 9.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Ventena confina in sinistra idrografica con il bacino del Conca ed in destra con i bacini del Foglia e del Tavollo. Il bacino
Indicatore Trofico Fiumi
 Indicatore Trofico Fiumi 2010-2017 Contesto di riferimento Il territorio regionale del Lazio contiene un ampia e diversificata varietà di ambienti fluviali, che spaziano dai territori degli apparati vulcanici
Indicatore Trofico Fiumi 2010-2017 Contesto di riferimento Il territorio regionale del Lazio contiene un ampia e diversificata varietà di ambienti fluviali, che spaziano dai territori degli apparati vulcanici
corso d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce,
 Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI
 IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
BACINO DEI FIUMI UNITI
 11 - BACINO DEI FIUMI UNITI 1 CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO E IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ANTROPICA Superficie del bacino Portata media alla foce Carico generato nel bacino Carichi sversati nei corpi
11 - BACINO DEI FIUMI UNITI 1 CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO E IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ANTROPICA Superficie del bacino Portata media alla foce Carico generato nel bacino Carichi sversati nei corpi
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
ARPATnews RISORSE IDRICHE
 n. 095-2008 Mercoledì 18 giugno 2008 Newsletter sulle tematiche ambientali ARPATnews RISORSE IDRICHE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DELL ARNO E DEI SUOI PRINCIPALI AFFLUENTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE Sintesi
n. 095-2008 Mercoledì 18 giugno 2008 Newsletter sulle tematiche ambientali ARPATnews RISORSE IDRICHE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DELL ARNO E DEI SUOI PRINCIPALI AFFLUENTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE Sintesi
Qualità delle acque di balneazione del Fiume Ticino a nord ovest di Milano
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Qualità delle acque di balneazione del Fiume Ticino a nord ovest di Milano Premessa Quando si parla di qualità delle acque destinate alla
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Qualità delle acque di balneazione del Fiume Ticino a nord ovest di Milano Premessa Quando si parla di qualità delle acque destinate alla
Centrale termoelettrica. di Porto Tolle. Allegato /II
 Allegato 2.1.3.1/II LA PRIMA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA DEI CORSI D ACQUA DEL VENETO (abstract) ANNO 2002, 2001 E BIENNIO 2001-2002 ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. approvata dalla Regione Veneto
Allegato 2.1.3.1/II LA PRIMA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA DEI CORSI D ACQUA DEL VENETO (abstract) ANNO 2002, 2001 E BIENNIO 2001-2002 ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. approvata dalla Regione Veneto
MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO
 MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO Gennaio Dicembre 2016 Monitoraggio Laguna di Capo Peloro La Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro, istituita con Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO Gennaio Dicembre 2016 Monitoraggio Laguna di Capo Peloro La Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro, istituita con Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
7 IL BACINO DEL FIUME MARANO
 7 IL BACINO DEL FIUME MARANO Pagina 61 7.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Marano sfocia nel Mare Adriatico al confine fra i comuni di Rimini e Riccione, ed è compreso fra i bacini del Melo, del Conca
7 IL BACINO DEL FIUME MARANO Pagina 61 7.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Marano sfocia nel Mare Adriatico al confine fra i comuni di Rimini e Riccione, ed è compreso fra i bacini del Melo, del Conca
GLI ECOSISTEMI ACQUATICI DEL PARCO PINETA ~ Gestione e Riqualificazione delle Aree Umide ~ Laura Sartori
 GLI ECOSISTEMI ACQUATICI DEL PARCO PINETA ~ Gestione e Riqualificazione delle Aree Umide ~ Laura Sartori Dip. di Scienze dell Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT). Università degli
GLI ECOSISTEMI ACQUATICI DEL PARCO PINETA ~ Gestione e Riqualificazione delle Aree Umide ~ Laura Sartori Dip. di Scienze dell Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT). Università degli
Nome indicatore DPSIR Fonte dati Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Disponibilità dati *** R
 ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2015 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2015 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
Lucca, Autorità di Bacino del fiume Serchio
 Sperimentazione sugli effetti dei rilasci dagli sbarramenti Enel Lucca, Autorità di Bacino del fiume Serchio 30.04.2009 2 Presentazione Mario Lagorio URS Italia S.p.A. Società multinazionale di consulenza
Sperimentazione sugli effetti dei rilasci dagli sbarramenti Enel Lucca, Autorità di Bacino del fiume Serchio 30.04.2009 2 Presentazione Mario Lagorio URS Italia S.p.A. Società multinazionale di consulenza
Contenuti del Piano di Gestione. ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Aggiornamento stato qualitativo acque superficiali: ai sensi del D.
 Aggiornamento stato qualitativo acque superficiali: ai sensi del D.Lgs 152/99 LIM Esprime lo stato di qualità dei corsi d acqua principalmente dal punto di vista chimico Fiume Serchio: Livello 1 Livello
Aggiornamento stato qualitativo acque superficiali: ai sensi del D.Lgs 152/99 LIM Esprime lo stato di qualità dei corsi d acqua principalmente dal punto di vista chimico Fiume Serchio: Livello 1 Livello
Wew32q4e2. Monitoraggio Diga del Pertusillo
 Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese GIUGNO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese GIUGNO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
La qualità e la classificazione delle acque di balneazione del Piemonte
 La qualità e la classificazione delle acque di balneazione del Piemonte Francesca Vietti Arpa Piemonte Viverone, 20 luglio 2016 IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE Parametri microbiologici Aliquota
La qualità e la classificazione delle acque di balneazione del Piemonte Francesca Vietti Arpa Piemonte Viverone, 20 luglio 2016 IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE Parametri microbiologici Aliquota
8 IL BACINO DEL FIUME CONCA
 8 IL BACINO DEL FIUME CONCA Pagina 72 8.1 GENERALITÀ Il fiume Conca nasce in provincia di Pesaro-Urbino, dalle pendici del monte Carpegna a 1415 metri sul livello medio del mare, e sfocia nei pressi di
8 IL BACINO DEL FIUME CONCA Pagina 72 8.1 GENERALITÀ Il fiume Conca nasce in provincia di Pesaro-Urbino, dalle pendici del monte Carpegna a 1415 metri sul livello medio del mare, e sfocia nei pressi di
Il lago di Cavazzo (lago dei Tre Comuni): i monitoraggi di Arpa FVG
 Il lago di Cavazzo (lago dei Tre Comuni): i monitoraggi di Arpa FVG Acque destinate alla balneazione Anno 2018 Delibera di Giunta Regionale n.2441 del 07 dicembre 2017 La Regione FVG, in accordo con Arpa
Il lago di Cavazzo (lago dei Tre Comuni): i monitoraggi di Arpa FVG Acque destinate alla balneazione Anno 2018 Delibera di Giunta Regionale n.2441 del 07 dicembre 2017 La Regione FVG, in accordo con Arpa
Il metodo di calcolo del DMV proposto dall Autorità di Bacino Regionale è il seguente:
 Calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) Per la valutazione della portata istantanea derivabile dal fiume Cesano alla sezione di interesse risulta indispensabile la preliminare valutazione della portata
Calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) Per la valutazione della portata istantanea derivabile dal fiume Cesano alla sezione di interesse risulta indispensabile la preliminare valutazione della portata
Caratterizzazione della qualità ambientale di acque superficiali: il fiume Sabato
 ISTITUTO PROFESSIONALE IPIA A. AMATUCCI COD. AUT. NAZIONALE F-2-FSE-2011-12 Caratterizzazione della qualità ambientale di acque superficiali: il fiume Sabato Dott. ing. Sabino DE GISI Avellino - Giovedi
ISTITUTO PROFESSIONALE IPIA A. AMATUCCI COD. AUT. NAZIONALE F-2-FSE-2011-12 Caratterizzazione della qualità ambientale di acque superficiali: il fiume Sabato Dott. ing. Sabino DE GISI Avellino - Giovedi
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEI SISTEMI DI FOGNATURA. Sergio Papiri
 CORSO DI FORMAZIONE CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEI SISTEMI DI FOGNATURA Sergio Papiri Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Università degli
CORSO DI FORMAZIONE CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEI SISTEMI DI FOGNATURA Sergio Papiri Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Università degli
6 METODOLOGIA qualità chimico-fisica
 6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
La qualità ambientale del Canale Navile
 La qualità ambientale del Canale Navile A seguito della richiesta, pervenuta ad ARPA nel 2010, dei Sindaci dei Comuni di Malabergo, Bentivoglio, Castel Maggiore (prot. N 15598/10 del Comune di Malalbergo)
La qualità ambientale del Canale Navile A seguito della richiesta, pervenuta ad ARPA nel 2010, dei Sindaci dei Comuni di Malabergo, Bentivoglio, Castel Maggiore (prot. N 15598/10 del Comune di Malalbergo)
L attività di monitoraggio delle acque di balneazione di Arpa Piemonte. Quali opportunità?
 L attività di monitoraggio delle acque di balneazione di Arpa Piemonte. Quali opportunità? Angelo Robotto Francesca Vietti Arpa Piemonte MAPPA DELLE ZONE BALNEABILI 93 zone controllate localizzate sui
L attività di monitoraggio delle acque di balneazione di Arpa Piemonte. Quali opportunità? Angelo Robotto Francesca Vietti Arpa Piemonte MAPPA DELLE ZONE BALNEABILI 93 zone controllate localizzate sui
Centro di Educazione Ambientale L'ACQUA SOSTENIBILE
 Centro di Educazione Ambientale L'ACQUA SOSTENIBILE ACQUA ED ECOSISTEMI Biomonitoraggio dei torrenti BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE Bios = vita controllo della vita Gli esseri viventi sono adattati a vivere
Centro di Educazione Ambientale L'ACQUA SOSTENIBILE ACQUA ED ECOSISTEMI Biomonitoraggio dei torrenti BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE Bios = vita controllo della vita Gli esseri viventi sono adattati a vivere
Progetto Strategia Marina
 AMBIENTE MARINO-COSTIERO Progetto Strategia Marina Dott. Massimo Petrini ARTA Abruzzo - Distretto di Pescara D.Lgs 190/2010 - MARINE STRATEGY - Strategie comuni con gli Stati membri per il raggiungimento
AMBIENTE MARINO-COSTIERO Progetto Strategia Marina Dott. Massimo Petrini ARTA Abruzzo - Distretto di Pescara D.Lgs 190/2010 - MARINE STRATEGY - Strategie comuni con gli Stati membri per il raggiungimento
Strategie per lo studio, la salvaguardia e il recupero dell'ambiente fluviale del Fiume Serio
 Strategie per lo studio, la salvaguardia e il recupero dell'ambiente fluviale del Fiume Serio PROVINCIA DI BERGAMO Protocollo d Intesad Intesa per la comprensione condivisa di una risorsa Seriate,, 13
Strategie per lo studio, la salvaguardia e il recupero dell'ambiente fluviale del Fiume Serio PROVINCIA DI BERGAMO Protocollo d Intesad Intesa per la comprensione condivisa di una risorsa Seriate,, 13
6 IL BACINO DEL FIUME MARECCHIA
 6 IL BACINO DEL FIUME MARECCHIA Pagina 50 6.1 GENERALITÀ La collocazione geografica del bacino del Marecchia viene individuata tramite la descrizione dei bacini ad esso limitrofi. Tali bacini sono: per
6 IL BACINO DEL FIUME MARECCHIA Pagina 50 6.1 GENERALITÀ La collocazione geografica del bacino del Marecchia viene individuata tramite la descrizione dei bacini ad esso limitrofi. Tali bacini sono: per
BMI.
 Esercizio.2 E stato effettuata uno studio relativo all indice di massa corporea BMI ( peso kg /statura 2 m) ed al test WKS (distanza percorsa per 6 minuti in m) in un campione di 0 individui femmina con
Esercizio.2 E stato effettuata uno studio relativo all indice di massa corporea BMI ( peso kg /statura 2 m) ed al test WKS (distanza percorsa per 6 minuti in m) in un campione di 0 individui femmina con
La situazione del Lambro. Luca Bonomo
 La situazione del Lambro Luca Bonomo Inquadramento Geografico Alps F. Ticino Milano F. Adda Mare Adriatico F. Po Lambro-Seveso Seveso-Olona La Lombardia è la più popolosa regione d Italia: 9 milioni di
La situazione del Lambro Luca Bonomo Inquadramento Geografico Alps F. Ticino Milano F. Adda Mare Adriatico F. Po Lambro-Seveso Seveso-Olona La Lombardia è la più popolosa regione d Italia: 9 milioni di
ISTRUTTORIA TECNICA. Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI. Risultati Monitoraggio Corso d Opera.
 SUPPORTO TECNICO ALL OSSERVATORIO AMBIENTALE CASCINA MERLATA ISTRUTTORIA TECNICA Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI Risultati Monitoraggio Corso d Opera 3 Trimestre 2015
SUPPORTO TECNICO ALL OSSERVATORIO AMBIENTALE CASCINA MERLATA ISTRUTTORIA TECNICA Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI Risultati Monitoraggio Corso d Opera 3 Trimestre 2015
PATOGENI ENTERICI: PRESSIONI E IMPATTI SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE. ROBERTA DE ANGELIS,
 PATOGENI ENTERICI: PRESSIONI E IMPATTI SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE ROBERTA DE ANGELIS, roberta.deangelis@isprambiente.it INTRODUZIONE Il rischio più facilmente associabile all uso di acqua da parte dell
PATOGENI ENTERICI: PRESSIONI E IMPATTI SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE ROBERTA DE ANGELIS, roberta.deangelis@isprambiente.it INTRODUZIONE Il rischio più facilmente associabile all uso di acqua da parte dell
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 01_MOR
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) 0700800801 Confine stato (Comune Ventimiglia) Punta della Rocca (Comune Ventimiglia) 7,9 * Il codice è costruito con
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) 0700800801 Confine stato (Comune Ventimiglia) Punta della Rocca (Comune Ventimiglia) 7,9 * Il codice è costruito con
I fiumi. La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia
 I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
1.1 Dati identificativi. 2.1 Descrizione dell'area di balneazione
 1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione Arenile Lido di Staranzano 4 Categoria acque marino costiere 5 Regione Friuli Venezia Giulia 6 Provincia Gorizia 7 Comune Staranzano 8 Corpo
1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione Arenile Lido di Staranzano 4 Categoria acque marino costiere 5 Regione Friuli Venezia Giulia 6 Provincia Gorizia 7 Comune Staranzano 8 Corpo
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/2010.
 Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI (art. 85 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ANNO 2017
 SINTESI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA TA DEI PESCI (art. 85 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ANNO 2017 Il individua, tra le acque superficiali a specifica destinazione funzionale, le
SINTESI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA TA DEI PESCI (art. 85 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ANNO 2017 Il individua, tra le acque superficiali a specifica destinazione funzionale, le
Cos è un "acqua di balneazione"? Cosa sono gli Enterococchi intestinali? Cosa sono gli Escherichia coli?
 Cos è un "acqua di balneazione"? L acqua di balneazione è un acqua superficiale o parte di essa nella quale l autorità competente prevede venga praticata la balneazione e nella quale non ha imposto un
Cos è un "acqua di balneazione"? L acqua di balneazione è un acqua superficiale o parte di essa nella quale l autorità competente prevede venga praticata la balneazione e nella quale non ha imposto un
CONVENZIONE QUADRO TRA CONSORZIO PLEMMIRIO E ARPA SICILIA TRIENNIO
 CONVENZIONE QUADRO TRA CONSORZIO PLEMMIRIO E ARPA SICILIA TRIENNIO 2014-2016 RELAZIONE SULL ATTIVITA SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO SETTEMBRE 2015 Premessa Le attività condotte durante il secondo anno della
CONVENZIONE QUADRO TRA CONSORZIO PLEMMIRIO E ARPA SICILIA TRIENNIO 2014-2016 RELAZIONE SULL ATTIVITA SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO SETTEMBRE 2015 Premessa Le attività condotte durante il secondo anno della
Acqua Aspetti qualitativi della risorsa acqua: applicazione in Italia della Direttiva WFD 2000/60CE.
 Aspetti qualitativi della risorsa acqua: applicazione in Italia della Direttiva WFD 2000/60CE. In questi ultimi 30 anni la normativa italiana sulla risorsa idrica ha subito una progressiva evoluzione passando
Aspetti qualitativi della risorsa acqua: applicazione in Italia della Direttiva WFD 2000/60CE. In questi ultimi 30 anni la normativa italiana sulla risorsa idrica ha subito una progressiva evoluzione passando
LA QUALITA' DELLE ACQUE DEL CAVO TRESINARO
 LA QUALITA' DELLE ACQUE DEL CAVO TRESINARO 1999-2005 A cura di: Dott. ssa Silvia Franceschini Dott. ssa Silvia Messori, Area Ecosistemi Idrici Interni ARPA Sezione provinciale di Reggio Emilia Sede legale:
LA QUALITA' DELLE ACQUE DEL CAVO TRESINARO 1999-2005 A cura di: Dott. ssa Silvia Franceschini Dott. ssa Silvia Messori, Area Ecosistemi Idrici Interni ARPA Sezione provinciale di Reggio Emilia Sede legale:
Monitoraggio Cova acque superficiali e sedimenti fluviali anno 2012
 UFFICIO RISORSE IDRICHE DIPARTIMENTO PROVINCIALE (PZ)) Monitoraggio Cova acque superficiali e sedimenti fluviali anno 2012 In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n 627 del 4 maggio 2011,
UFFICIO RISORSE IDRICHE DIPARTIMENTO PROVINCIALE (PZ)) Monitoraggio Cova acque superficiali e sedimenti fluviali anno 2012 In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n 627 del 4 maggio 2011,
PROVINCIA DI GORIZIA
 PROVINCIA DI GORIZIA 34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/385277 - FAX 0481/385251 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTE Servizio Tutela del Territorio e Ambiente
PROVINCIA DI GORIZIA 34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/385277 - FAX 0481/385251 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTE Servizio Tutela del Territorio e Ambiente
LA VALLE STURA E IL SUO FIUME. note sparse di ecologia
 LA VALLE STURA E IL SUO FIUME note sparse di ecologia NEL NOVEMBRE 1992 LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (C.I.PR.A.), NEL RAPPORTO INTITOLATO "GLI ULTIMI FIUMI NATURALI DELLE
LA VALLE STURA E IL SUO FIUME note sparse di ecologia NEL NOVEMBRE 1992 LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (C.I.PR.A.), NEL RAPPORTO INTITOLATO "GLI ULTIMI FIUMI NATURALI DELLE
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali
 A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali RELAZIONE ANNUALE SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DELLE ACQUE NEL COMUNE DI BELLUNO (ANNO 2010) 2 INDICE Premessa 5 1. Introduzione
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali RELAZIONE ANNUALE SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DELLE ACQUE NEL COMUNE DI BELLUNO (ANNO 2010) 2 INDICE Premessa 5 1. Introduzione
I LAGHI DEL PIEMONTE. Le acque di balneazione del Piemonte La stagione 2018 e proposte per la stagione 2019
 Le acque di balneazione del Piemonte La stagione 2018 e proposte per la stagione 2019 Francesca Vietti Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Il monitoraggio delle Acque di Balneazione in Piemonte
Le acque di balneazione del Piemonte La stagione 2018 e proposte per la stagione 2019 Francesca Vietti Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Il monitoraggio delle Acque di Balneazione in Piemonte
ACQUE SUPERFICIALI PROGETTO BALNEABILITA F. TREBBIA HIDROSOURCE 2005
 CODICE: 15_HS_B DATI BACINO Nome bacino: TREBBIA Nome corso d acqua: F. TREBBIA Sup. bacino (km 2 ): 1085 Lungh. corso d acqua (km): 119.98 Ordine corso d acqua: 2 DATI STAZIONE Provincia: PIACENZA Comune:
CODICE: 15_HS_B DATI BACINO Nome bacino: TREBBIA Nome corso d acqua: F. TREBBIA Sup. bacino (km 2 ): 1085 Lungh. corso d acqua (km): 119.98 Ordine corso d acqua: 2 DATI STAZIONE Provincia: PIACENZA Comune:
3.4 Livello di funzionalità ecologica (IFF), Giugno 2000
 3.4 Livello di funzionalità ecologica (IFF), Giugno 2000 L ecosistema fluviale dell alto Sangro (S1-S2) denota un livello di funzionalità fluviale giudicabile buono ottimo, che diviene ottimo all altezza
3.4 Livello di funzionalità ecologica (IFF), Giugno 2000 L ecosistema fluviale dell alto Sangro (S1-S2) denota un livello di funzionalità fluviale giudicabile buono ottimo, che diviene ottimo all altezza
Il Monitoraggio Marino Costiero nelle Marche: norme e programmi d attuazioned
 Le MARCHE e la qualità del mare Il Monitoraggio Marino Costiero nelle Marche: norme e programmi d attuazioned WORKSHOP Ancona 18 Luglio 2006 Luigi Bolognini Servizio Ambiente e Difesa del Suolo PF Difesa
Le MARCHE e la qualità del mare Il Monitoraggio Marino Costiero nelle Marche: norme e programmi d attuazioned WORKSHOP Ancona 18 Luglio 2006 Luigi Bolognini Servizio Ambiente e Difesa del Suolo PF Difesa
Casetta dell acqua di Città Studi: Aspetti microbiologici
 29 maggio 2018 Festival dello Sviluppo Sostenibile Casetta dell acqua di Città Studi: Aspetti microbiologici Inquadramento normativo Aspetti microbiologici Risultati delle analisi microbiologiche sulle
29 maggio 2018 Festival dello Sviluppo Sostenibile Casetta dell acqua di Città Studi: Aspetti microbiologici Inquadramento normativo Aspetti microbiologici Risultati delle analisi microbiologiche sulle
Strumenti per una difesa sostenibile delle piante
 Strumenti per una difesa sostenibile delle piante A. Vercesi, DiSAA, Università di Milano Agricoltura sostenibile sicurezza alimentare salvaguardia dell ambiente e delle risorse naturali uso efficiente
Strumenti per una difesa sostenibile delle piante A. Vercesi, DiSAA, Università di Milano Agricoltura sostenibile sicurezza alimentare salvaguardia dell ambiente e delle risorse naturali uso efficiente
CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DI AGGLOMERATI A.E.
 CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DI AGGLOMERATI 2.000 A.E. ANNO 2017 (I SEMESTRE) CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DI AGGLOMERATI
CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DI AGGLOMERATI 2.000 A.E. ANNO 2017 (I SEMESTRE) CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DI AGGLOMERATI
SIA CAVONE - APPENDICE 2
 SIA CAVONE - APPENDICE 2 ATTIVITA DI MONITORAGGIO (Elaborato redatto dalla CIIP spa Area Gestione Servizio Lavori) Durante le operazioni di ricognizione dei luoghi, necessarie per la redazione degli apporti
SIA CAVONE - APPENDICE 2 ATTIVITA DI MONITORAGGIO (Elaborato redatto dalla CIIP spa Area Gestione Servizio Lavori) Durante le operazioni di ricognizione dei luoghi, necessarie per la redazione degli apporti
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali
 A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali RELAZIONE ANNUALE SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DELLE ACQUE NEL COMUNE DI BELLUNO - ANNO 2011 - ARPAV Agenzia Regionale per la
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali RELAZIONE ANNUALE SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DELLE ACQUE NEL COMUNE DI BELLUNO - ANNO 2011 - ARPAV Agenzia Regionale per la
Studio di Ingegneria Ferrari e Giraudo Corso Nizza 67/A 12100 CUNEO PREMESSA... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE... 2
 Sommario PREMESSA... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI ESERCIZIO... 4 MONITORAGGIO CHIMICO... 4 MONITORAGGIO BIOLOGICO... 5 MONITORAGGIO IDROMORFOLOGICO... 7 Piano di monitoraggio
Sommario PREMESSA... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE... 2 MONITORAGGIO IN FASE DI ESERCIZIO... 4 MONITORAGGIO CHIMICO... 4 MONITORAGGIO BIOLOGICO... 5 MONITORAGGIO IDROMORFOLOGICO... 7 Piano di monitoraggio
ISTRUTTORIA TECNICA. Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI. Risultati Monitoraggio Corso d Opera.
 SUPPORTO TECNICO ALL OSSERVATORIO AMBIENTALE CASCINA MERLATA ISTRUTTORIA TECNICA Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI Risultati Monitoraggio Corso d Opera 4 Trimestre 2015
SUPPORTO TECNICO ALL OSSERVATORIO AMBIENTALE CASCINA MERLATA ISTRUTTORIA TECNICA Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI Risultati Monitoraggio Corso d Opera 4 Trimestre 2015
MONITORAGGIO DEI CONTAMINANTI EMERGENTI NELLE ACQUE REFLUE IL CASO DELL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCAFATI
 Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO MONITORAGGIO DEI CONTAMINANTI EMERGENTI
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO MONITORAGGIO DEI CONTAMINANTI EMERGENTI
Esercizio 1.2. n BMI WKS
 Esercizio. E stato effettuata uno studio relativo all indice di massa corporea BMI ( peso kg /statura m) ed al test WKS (distanza percorsa per 6 minuti in m) in un campione di 0 individui femmina con problemi
Esercizio. E stato effettuata uno studio relativo all indice di massa corporea BMI ( peso kg /statura m) ed al test WKS (distanza percorsa per 6 minuti in m) in un campione di 0 individui femmina con problemi
Annuario dei dat ambientali della Toscana. Firenze, 13 settembre 2018
 Annuario 2018 dei dat ambientali della Toscana Firenze, 13 settembre 2018 1 Lo stato dell ambiente toscano attraverso l analisi di 70 indicatori, classificati secondo i 5 elementi del modello DPSIR e suddivisi
Annuario 2018 dei dat ambientali della Toscana Firenze, 13 settembre 2018 1 Lo stato dell ambiente toscano attraverso l analisi di 70 indicatori, classificati secondo i 5 elementi del modello DPSIR e suddivisi
Wew32q4e2. Monitoraggio Diga del Pertusillo
 Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
ANALISI AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DELLO STORIONE COBICE
 ANALISI AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DELLO STORIONE COBICE Carlo Lombardi FIUMI INDAGATI PO (a valle del confine provinciale PC-PV) ADDA (tratto sublacuale) OGLIO (tratto sublacuale) MINCIO (tratto
ANALISI AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DELLO STORIONE COBICE Carlo Lombardi FIUMI INDAGATI PO (a valle del confine provinciale PC-PV) ADDA (tratto sublacuale) OGLIO (tratto sublacuale) MINCIO (tratto
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO SINTESI DELL ELABORATO DI TESI VALUTAZIONE DEI TREND DEI NITRATI IN CAMPANIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO SINTESI DELL ELABORATO DI TESI VALUTAZIONE DEI TREND DEI NITRATI IN CAMPANIA
Indagini sullo stato trofico dello stagno del Calich
 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Dipartimento Provinciale di Sassari Indagini sullo stato trofico dello stagno del Calich Agosto 2009 Indagini sullo stato trofico
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Dipartimento Provinciale di Sassari Indagini sullo stato trofico dello stagno del Calich Agosto 2009 Indagini sullo stato trofico
Monitoraggio di ambienti acquatici. Renato Sconfietti
 Monitoraggio di ambienti acquatici Renato Sconfietti tipologia ambienti acquatici acque lotiche corsi d acquad acque lentiche laghi, stagni, pozze (aree umide canneti, torbiere, ecc.) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Monitoraggio di ambienti acquatici Renato Sconfietti tipologia ambienti acquatici acque lotiche corsi d acquad acque lentiche laghi, stagni, pozze (aree umide canneti, torbiere, ecc.) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Scheda Informativa Balneazione
 Scheda Informativa 2017 Balneazione Indice Balneabilità e qualità delle acque - pag. 3 La definizione delle acque di balneazione - pag. 4 Dove è vietata la balneazione - pag. 5 Come si controllano le acque
Scheda Informativa 2017 Balneazione Indice Balneabilità e qualità delle acque - pag. 3 La definizione delle acque di balneazione - pag. 4 Dove è vietata la balneazione - pag. 5 Come si controllano le acque
Dov o e v e s ia i mo m INDECAST srl
 Dove siamo INDECAST srl La nostra storia 1982 Nasce Int.Dep.Cast. S.r.l. 1985 In funzione la prima linea di trattamento biologico 1987 Raddoppia la sezione di ossidazione biologica e disidratazione fanghi,
Dove siamo INDECAST srl La nostra storia 1982 Nasce Int.Dep.Cast. S.r.l. 1985 In funzione la prima linea di trattamento biologico 1987 Raddoppia la sezione di ossidazione biologica e disidratazione fanghi,
Scheda Informativa Balneazione
 Scheda Informativa 2018 Balneazione Indice Balneabilità e qualità delle acque - pag. 3 La definizione delle acque di balneazione - pag. 4 Dove è vietata la balneazione - pag. 5 Come si controllano le acque
Scheda Informativa 2018 Balneazione Indice Balneabilità e qualità delle acque - pag. 3 La definizione delle acque di balneazione - pag. 4 Dove è vietata la balneazione - pag. 5 Come si controllano le acque
Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante le comunità diatomiche: prime esperienze di classificazione
 Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante le comunità diatomiche: prime esperienze di classificazione Catia Monauni, Raffaella Canepel, Chiara Defrancesco www.appa.provincia.tn.it
Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante le comunità diatomiche: prime esperienze di classificazione Catia Monauni, Raffaella Canepel, Chiara Defrancesco www.appa.provincia.tn.it
I parametri di qualità chimica e microbiologica per la caratterizzazione delle acque
 Parte 3. I parametri di qualità chimica e microbiologica per la caratterizzazione delle acque Corso di Competitività e Sostenibilità A.A. 2014/2015 Massimo Raboni. PhD mraboni@liuc.it Parametri chimici
Parte 3. I parametri di qualità chimica e microbiologica per la caratterizzazione delle acque Corso di Competitività e Sostenibilità A.A. 2014/2015 Massimo Raboni. PhD mraboni@liuc.it Parametri chimici
Fiume ADDA. Cornate d Adda. Dati biologici. Dati generali. Caratteristiche ambientali. Stato biologico. Tendenza
 Fiume ADDA Cornate d Adda Periodo di campionamento: - Numero campionamenti: Numero dati : POADCN Cornate d Adda Frazione Porto d Adda m km Caratteristiche ambientali Il territorio circostante è coperto
Fiume ADDA Cornate d Adda Periodo di campionamento: - Numero campionamenti: Numero dati : POADCN Cornate d Adda Frazione Porto d Adda m km Caratteristiche ambientali Il territorio circostante è coperto
«11/11/'11» un giorno unico per numeri uno "SQE Summit MILANO 2011 SINTESI INTERVENTO VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI
 gli amici dell aria e dell acqua per un mondo più pulito! «11/11/'11» un giorno unico per numeri uno "SQE Summit MILANO 2011 SINTESI INTERVENTO VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI Relatori:
gli amici dell aria e dell acqua per un mondo più pulito! «11/11/'11» un giorno unico per numeri uno "SQE Summit MILANO 2011 SINTESI INTERVENTO VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI Relatori:
CONVEGNO SISTEMI IDRAULICI URBANI: TRA SOSTENIBILITA AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI IMPATTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO SUI RICETTORI FLUENTI
 CONVEGNO SISTEMI IDRAULICI URBANI: TRA SOSTENIBILITA AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI IMPATTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO SUI RICETTORI FLUENTI Sergio Papiri Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
CONVEGNO SISTEMI IDRAULICI URBANI: TRA SOSTENIBILITA AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI IMPATTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO SUI RICETTORI FLUENTI Sergio Papiri Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Acque superficiali: Campionamento analisi chimiche Relatore: Dr. Ferdinando De Rosa
 Acque superficiali: Campionamento analisi chimiche Relatore: Dr. Ferdinando De Rosa salute e il tempo libero Riferimenti normativi D.Lgs 152 dell 11 maggio 1999 modificata e integrata con il D.Lgs 258
Acque superficiali: Campionamento analisi chimiche Relatore: Dr. Ferdinando De Rosa salute e il tempo libero Riferimenti normativi D.Lgs 152 dell 11 maggio 1999 modificata e integrata con il D.Lgs 258
La qualità ambientale del Canale Navile
 La qualità ambientale del Canale Navile A seguito della richiesta, pervenuta ad ARPA nel 2010, dei Sindaci dei Comuni di Malabergo, Bentivoglio e Castel Maggiore (prot. N 15598/10 del Comune di Malalbergo)
La qualità ambientale del Canale Navile A seguito della richiesta, pervenuta ad ARPA nel 2010, dei Sindaci dei Comuni di Malabergo, Bentivoglio e Castel Maggiore (prot. N 15598/10 del Comune di Malalbergo)
IL FIUME: solo acqua che scorre?????
 RIFLESSIONI SULLA QUALITA AMBIENTALE DEI FIUMI MISA E NEVOLA CONTRATTO DIFIUME Senigallia 20 marzo 2017 IL FIUME: solo acqua che scorre????? Il FIUME è ACQUA in movimento.....ma la CORRENTE che alimenta
RIFLESSIONI SULLA QUALITA AMBIENTALE DEI FIUMI MISA E NEVOLA CONTRATTO DIFIUME Senigallia 20 marzo 2017 IL FIUME: solo acqua che scorre????? Il FIUME è ACQUA in movimento.....ma la CORRENTE che alimenta
Parco del Molgora Tavolo tecnico
 24 febbraio 2016 Parco del Molgora Tavolo tecnico Molgora a Trucazzano Molgora a Carnate Molgoretta a Lomagna Valeria Marchesi, Pietro Genoni, Alberto Pagani, Mattia Frigerio, Paola Ferrè, Vittorio Casiraghi
24 febbraio 2016 Parco del Molgora Tavolo tecnico Molgora a Trucazzano Molgora a Carnate Molgoretta a Lomagna Valeria Marchesi, Pietro Genoni, Alberto Pagani, Mattia Frigerio, Paola Ferrè, Vittorio Casiraghi
