Analisi delle Istituzioni Politiche. Lez. 7: Istituzioni e organizzazioni
|
|
|
- Livia Piccinini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Analisi delle Istituzioni Politiche Lez. 7: Istituzioni e organizzazioni
2 DdP e beni collettivi La reciproca convenienza non è sufficiente a garantire a un gruppo sociale di raggiungere il bene collettivo Vari autori suggeriscono diversi modi per ottenere l ottimalità paretiana attraverso la cooperazione Incentivi selettivi per i beni pubblici (Olson) Intervento dell autorità per eliminare i beni comuni (Hardin) Autorganizzazione (Ostrom) Sono tutti modi per creare aspettative reciproche sui comportamenti dei membri del gruppo => Ridurre l incertezza dei membri del gruppo circa i comportamenti degli altri, producendo fiducia che le regole del gioco stabilite saranno rispettate 2
3 Istituzioni Un istituzione è un qualunque sistema di regole che consente a un gruppo di individui di prendere decisioni collettive Le istituzioni indirizzano i comportamenti segnalando agli attori sociali quanto nelle diverse situazioni è lecito o doveroso fare, e quanto invece non è consentito riducendo l incertezza intorno ai comportamenti degli altri, da cui in generale ci si aspetta che rispetteranno le regole stabilite creando aspettative comuni di regolarità nell azione dei singoli e consentendo di fare previsioni attendibili sull evoluzione degli eventi collettivi 3
4 Organizzazioni Sono tutti i gruppi che adottano una procedura interna per determinare le scelte collettive del gruppo un organizzazione è un attore (collettivo) che agisce per uno scopo (razionale): ad es. un partito, un assemblea elettiva, un ministero, un governo, ecc. Le procedure interne di un organizzazione costituiscono il sistema delle istituzioni vigenti tra i membri di quella organizzazione Organizzazioni complesse sono quelle che hanno organizzazioni tra i loro membri; ad es. un sistema di partiti I rapporti tra organizzazioni sono regolati da istituzioni relative a sistemi organizzativi complessi 4
5 Una distinzione importante (D. North) Le istituzioni regolano l attività delle organizzazioni Istituzioni: regole del gioco Organizzazioni: giocatori Come nascono le istituzioni e come operano entro le organizzazioni; due fasi Fase costituente : le regole dell organizzazione emergono in modo endogeno dal gruppo non ancora regolato Fase post-costituente: le regole statuite nella fase costituente devono essere rispettate per il funzionamento dell organizzazione secondo i criteri fissati nella fase costituente 5
6 Cambiamento istituzionale Distinguere tra organizzazioni e istituzioni consente di apprezzare se e perché le istituzioni sono adatte a una data organizzazione Le istituzioni definiscono la struttura degli incentivi che motivano all azione i membri dell organizzazione I cambiamenti istituzionali modificano la struttura degli incentivi e possono determinare il successo o l insuccesso delle organizzazioni (la conquista o meno del bene collettivo) 6
7 Il mercato e la sua regolazione La teoria economica neoclassica e la naturalizzazione del mercato (le leggi del mercato come leggi di natura) Mercato composto da un gran numero di produttori che offrono una piccola parte della quantità del bene prodotta complessivamente a un grande numero di consumatori che ne domandano una piccola parte. Il mercato funziona in base al prezzo di equilibrio che si stabilisce tra domanda e offerta. La competizione tra molti produttori garantisce l efficienza del mercato, mantenendo il prezzo di equilibrio al livello più basso possibile data la tecnologia disponibile. Naturalizzazione del mercato: gli scambi basati sul prezzo sono una sfera a parte delle relazioni umane che si sviluppa spontaneamente, retta da leggi di natura immutabile che vanno rispettate. Concezione priva di fondamento storico 7
8 Il mercato e la sua regolazione La storia economica e la regolazione autoritativa del mercato al fine di facilitare gli scambi L insorgenza e la stabilizzazione di una attività di scambi avviene solo attraverso qualche forma di regolazione autoritativa in grado di ridurre il potenziale opportunismo: unità di misura moneta sistema legale La realtà attuale delle agenzie pubbliche per il controllo dei mercati contenimento delle posizioni di monopolio tutela dei brevetti regolazione del credito ecc. Storicamente il mercato si è sviluppato grazie alla politica, e a sua volta i benefici del mercato hanno rafforzato e legittimato la politica 8
9 Mercato come istituzione L autorità politica istituisce e regola il mercato Stabilendo cosa può essere oggetto di scambio Assegnando e proteggendo per tali beni e servizi i relativi diritti di proprietà Fissando le modalità che rendono legittimi i trasferimenti di proprietà connessi con gli scambi Sanzionando chi non rispetta tali modalità Il mercato è un istituzione della politica 9
10 Mercato come bene pubblico Entro i limiti che lo regolano: Il mercato assegna a tutti il diritto di partecipare agli scambi: non escludibile l opportunità di scambiare che il mercato offre a qualcuno non diminuisce la stessa opportunità offerta ad altri non rivale Il mercato è un bene pubblico Tutte le istituzioni sono beni pubblici (per la collettività di riferimento) La legge, le norme morali, la regola della maggioranza, le convenzioni sociali, ecc. Hanno la funzione di creare una struttura di incentivi per gli individui che operano attraverso di esse 10
11 Impresa L impresa è un organizzazione che opera entro l istituzione mercato Entro l impresa il mercato sparisce come istituzione, per essere sostituito da una gerarchia La gerarchia non funziona per mezzo di scambi regolati da prezzi, ma attraverso ordini trasmessi alle varie parti della struttura organizzativa Nella prospettiva razionale ciò avviene quando la gerarchia è più efficiente del mercato come istituzione per la produzione di beni Infatti il mercato implica dei costi trascurati dalla prima rivoluzione neoclassica della teoria economica 11
12 Costi di transazione Sono quelli che le parti devono sopportare per concludere gli accordi contrattuali che portano agli scambi entro il mercato; due tipi: 1. per la perlustrazione delle opportunità offerte dal mercato e dei relativi prezzi 2. per la negoziazione dei contratti di compravendita, e il controllo che gli accordi contrattuali siano rispettati 12
13 Mercati, costi di transazione, gerarchia dell impresa L impresa si costituisce come una gerarchia per cercare di contenere i costi di transazione che si svilupperebbero al suo interno se funzionasse come un mercato L economia neoclassica nella sua prima formulazione ha nascosto i costi di transazione e l analisi dell impresa sotto la finzione della perfetta informazione degli attori entro il mercato 13
14 Mercato e impresa Domanda: dati i costi di transazione, perché il mercato non si trasforma in un unica grande impresa? Risposta: anche l organizzazione gerarchica dell impresa presenta costi I costi di transazione del mercato vanno comparati con i costi interni dell organizzazione gerarchica dell impresa 14
15 Dimensioni dell impresa Il confronto tra produrre al proprio interno o acquistare sul mercato è un confronto tra i costi della gerarchia e i costi del mercato I limiti dell integrazione verticale ( fare o comprare ) C A (costi interni dell impresa A) C B (costi interni dell impresa B) CT AB (costi di transazione tra le due imprese) A può trovare conveniente assorbire B solo se C A C B + CT AB Quanto maggiori i CT AB tanto più inefficiente lo scambio tra A e B rispetto al controllo gerarchico e tanto più probabile l assorbimento di B in A Nascita dell impresa come caso di cambiamento istituzionale basato sul calcolo comparato dei costi 15
16 Nascita contrattuale dell impresa (1) Perché l impresa? Problema di azione collettiva: trasformare un collettivo in un organizzazione che funziona sulla base di un sistema istituzionale che consenta di raggiungere determinati obiettivi. Modello del lavoro di squadra e soluzione contrattuale al problema dell opportunismo. 16
17 Nascita contrattuale dell impresa (2) Consideriamo un gruppo di lavoratori indipendenti Difficoltà dell azione collettiva nel lavoro di squadra Manca il coordinamento Si perdono i vantaggi della specializzazione Il problema della misurazione della produttività marginale (stabilita a priori una remunerazione eguale per tutti) Il calcolo del singolo e il bene collettivo =>il vantaggio di scansare la fatica : cooperando si accolla il costo della fatica del suo contributo alla produzione complessiva, e ottiene la remunerazione prestabilita; non cooperando riduce la produzione e rinuncia alla parte di remunerazione che non può essere distribuita=> accolla al resto della squadra il costo collettivo della sua mancata cooperazione situazione analoga al dilemma del prigioniero mutua non cooperazione 17
18 Nascita contrattuale dell impresa (3) Per risolvere il DdP della squadra occorre un cambiamento istituzionale per compensare ciascuno in base a quanto ha contribuito (produttività marginale) Introdurre la regola di sorvegliare il lavoro di ciascuno. Ma in che modo? Ciascuno sorveglia a turno? (perdita del beneficio della specializzazione) Assumere un sorvegliante? (Rischio di collusione) Come compensarlo? Il concetto di residuo (compenso in base alla produzione complessiva che riesce a realizzare spronando la produttività marginale di ciascun lavoratore) Il sorvegliante è l imprenditore e la squadra diventa l impresa L impresa si afferma consensualmente al posto del mercato perché distribuisce ai lavoratori più di quanto otterrebbero se fossero indipendenti 18
Modelli e tecniche di frazionamento del processo produttivo: spunti per un analisi organizzativa
 Modelli e tecniche di frazionamento del processo produttivo: spunti per un analisi organizzativa Luigi Golzio Dipartimento di Economia Marco Biagi Fondazione Marco Biagi LUIGI ENRICO GOLZIO 1 INDICE. Convegno
Modelli e tecniche di frazionamento del processo produttivo: spunti per un analisi organizzativa Luigi Golzio Dipartimento di Economia Marco Biagi Fondazione Marco Biagi LUIGI ENRICO GOLZIO 1 INDICE. Convegno
Analisi delle istituzioni politiche
 Analisi delle istituzioni politiche Lez. 10 Lo stato Formula dell equilibrio di Nash B b 1 b 2 b j a 1 u A (a 1,b 1 ), u B (a 1,b 1 ) u A (a 1,b 2 ), u B (a 1,b 2 ) u A (a 1,b j ), u B (a 1,b j ) A a 2
Analisi delle istituzioni politiche Lez. 10 Lo stato Formula dell equilibrio di Nash B b 1 b 2 b j a 1 u A (a 1,b 1 ), u B (a 1,b 1 ) u A (a 1,b 2 ), u B (a 1,b 2 ) u A (a 1,b j ), u B (a 1,b j ) A a 2
Economia (Sanna Randaccio) Lezione n 20 Il Monopolio II. Monopolio Naturale
 Economia (Sanna Randaccio) Lezione n 20 Il Monopolio II Monopolio Naturale Una singola impresa è in grado di produrre la quantità che può venire assorbita dal mercato ad un costo totale inferiore rispetto
Economia (Sanna Randaccio) Lezione n 20 Il Monopolio II Monopolio Naturale Una singola impresa è in grado di produrre la quantità che può venire assorbita dal mercato ad un costo totale inferiore rispetto
Il Dilemma del Prigioniero
 TEORIA DEI GIOCHI La teoria dei giochi studia come gli individui si comportano in situazioni strategiche. Le decisioni strategiche implicano il tenere conto di come il comportamento degli altri possa influire
TEORIA DEI GIOCHI La teoria dei giochi studia come gli individui si comportano in situazioni strategiche. Le decisioni strategiche implicano il tenere conto di come il comportamento degli altri possa influire
Professionisti e professioni: collaborazione e/o competizione. Sonia Bertolini Università di Torino
 Professionisti e professioni: collaborazione e/o competizione Sonia Bertolini Università di Torino sonia.bertolini@unito.it TEORIA DEI GIOCHI La situazione che si viene a creare tra collaborazione e competizione
Professionisti e professioni: collaborazione e/o competizione Sonia Bertolini Università di Torino sonia.bertolini@unito.it TEORIA DEI GIOCHI La situazione che si viene a creare tra collaborazione e competizione
CAPITOLO CAPIT Organizzazioni e Teoria ganizzazioni e T Organizzativa
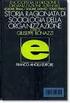 CAPITOLO 1 Organizzazioni e Teoria Organizzativa Agenda Cos è un organizzazione Le dimensioni organizzative La struttura organizzativa Le parti di un organizzazione Valutare un organizzazione Evoluzione
CAPITOLO 1 Organizzazioni e Teoria Organizzativa Agenda Cos è un organizzazione Le dimensioni organizzative La struttura organizzativa Le parti di un organizzazione Valutare un organizzazione Evoluzione
ECONOMIA APPLICATA. Corso di Laurea triennale in ecologia sperimentale ed applicata Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 ECONOMIA APPLICATA Corso di Laurea triennale in ecologia sperimentale ed applicata Università degli Studi di Roma Tor Vergata Alessandra Bianchi alessandra.bianchi@uniroma2.it Elementi di Economia del
ECONOMIA APPLICATA Corso di Laurea triennale in ecologia sperimentale ed applicata Università degli Studi di Roma Tor Vergata Alessandra Bianchi alessandra.bianchi@uniroma2.it Elementi di Economia del
La regolamentazione: un introduzione
 La regolamentazione: Definizione Regolamentazione: misura di controllo diretto con la quale lo Stato, o altro ente pubblico disciplina il comportamento degli operatori sui mercati 1 La regolamentazione:
La regolamentazione: Definizione Regolamentazione: misura di controllo diretto con la quale lo Stato, o altro ente pubblico disciplina il comportamento degli operatori sui mercati 1 La regolamentazione:
Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2011/2012 L OLIGOPOLIO.
 Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA : MICROECONOMIA A.A. 2011/2012 L Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@unimc.it Web: http://docenti.unimc.it/docenti/fabio-clementi
Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA : MICROECONOMIA A.A. 2011/2012 L Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@unimc.it Web: http://docenti.unimc.it/docenti/fabio-clementi
Politica economica (A-D) Sapienza Università di Rome. Efficienza ed equità. Giovanni Di Bartolomeo Sapienza Università di Roma
 Politica economica (A-D) Sapienza Università di Rome Efficienza ed equità Giovanni Di Bartolomeo Sapienza Università di Roma In prima approssimazione Possiamo dire che è soddisfatta l efficienza se gli
Politica economica (A-D) Sapienza Università di Rome Efficienza ed equità Giovanni Di Bartolomeo Sapienza Università di Roma In prima approssimazione Possiamo dire che è soddisfatta l efficienza se gli
ESEMPI DI DOMANDE per la prova scritta dell esame di Istituzioni di Economia.
 ESEMPI DI DOMANDE per la prova scritta dell esame di Istituzioni di Economia. La prova scritta consta di dodici domande, formulate come test a risposta multipla. Una sola delle cinque risposte fornite
ESEMPI DI DOMANDE per la prova scritta dell esame di Istituzioni di Economia. La prova scritta consta di dodici domande, formulate come test a risposta multipla. Una sola delle cinque risposte fornite
ECONOMIA URBANA. Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre. Contatti:
 ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
ECONOMIA URBANA Valeria Costantini Facoltà di Architettura, Università Roma Tre Contatti: costanti@uniroma3.it LA MICROECONOMIA LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI AGENTI IN UN SISTEMA ECONOMICO Economia
Lezioni di Economia Politica
 Università degli Studi ROMA TRE Facoltà di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica I principi fondamentali dell economia e gli strumenti per lo studio Giovanni Nicola De Vito - 2010 Microeconomia area
Università degli Studi ROMA TRE Facoltà di Giurisprudenza Lezioni di Economia Politica I principi fondamentali dell economia e gli strumenti per lo studio Giovanni Nicola De Vito - 2010 Microeconomia area
Capitolo 4 Gli strumenti dell analisi normativa
 Capitolo 4 Gli strumenti dell analisi normativa 1 Obiettivi di apprendimento Cosa si intende per economia del benessere Confronto di allocazioni alternative tramite lo strumento analitico della scatola
Capitolo 4 Gli strumenti dell analisi normativa 1 Obiettivi di apprendimento Cosa si intende per economia del benessere Confronto di allocazioni alternative tramite lo strumento analitico della scatola
Oligopolio. Data la simmetria della struttura dei costi delle due imprese, la funzione di reazione dell impresa 2
 Oligopolio Esercizio 1 Si consideri un duopolio in cui le imprese sono caratterizzate dalla seguente funzione di costo totale (identica per entrambe) = 0. Esse offrono un prodotto omogeneo su un mercato
Oligopolio Esercizio 1 Si consideri un duopolio in cui le imprese sono caratterizzate dalla seguente funzione di costo totale (identica per entrambe) = 0. Esse offrono un prodotto omogeneo su un mercato
Proposte di lavoro pluridisciplinari 1 di 8 MODULO 1. Proposte di lavoro pluridisciplinari con Economia politica
 Proposte di lavoro pluridisciplinari 1 di 8 MODULO 1 Proposte di lavoro pluridisciplinari con Economia politica 1. Leggi i brani di seguito proposti tratti da L. Guatri e S. Vicari, Sistemi d impresa e
Proposte di lavoro pluridisciplinari 1 di 8 MODULO 1 Proposte di lavoro pluridisciplinari con Economia politica 1. Leggi i brani di seguito proposti tratti da L. Guatri e S. Vicari, Sistemi d impresa e
Introduzione. L oggetto di studio dell Economia sanitaria. Quadro teorico di riferimento. Le peculiarità del mercato delle prestazioni sanitarie
 Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro di testo
Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente al libro di testo
Teoria dell impresa cooperativa (Iª parte)
 Teoria dell impresa cooperativa (Iª parte) Per dare ai soci più sicurezza e benessere la Società [Equitable Pionieer of Rochdale] ] comprerà o prenderà in affitto una terra che sarà coltivata dai soci
Teoria dell impresa cooperativa (Iª parte) Per dare ai soci più sicurezza e benessere la Società [Equitable Pionieer of Rochdale] ] comprerà o prenderà in affitto una terra che sarà coltivata dai soci
Economia delle Imprese Multinazionali
 Economia delle Imprese Multinazionali Lezione su Costi di transazione e internalizzazione! Davide Castellani Università di Perugia Dipartimento di Economia davide.castellani@unipg.it Perché esistono le
Economia delle Imprese Multinazionali Lezione su Costi di transazione e internalizzazione! Davide Castellani Università di Perugia Dipartimento di Economia davide.castellani@unipg.it Perché esistono le
Giustificazione dell intervento pubblico
 Giustificazione dell intervento pubblico Giustificazione dell intervento pubblico Oggetto: Analizzare i contributi della teoria economica per spiegare gli interventi pubblici a livello microeconomico Giustificazione
Giustificazione dell intervento pubblico Giustificazione dell intervento pubblico Oggetto: Analizzare i contributi della teoria economica per spiegare gli interventi pubblici a livello microeconomico Giustificazione
Indice. Presentazione. Capitolo 1
 Presentazione XIII Capitolo 1 Capitolo 2 Il sistema economico: i soggetti e le interdipendenze 1 1. Il sistema economico 1 2. La teoria economica 3 3. Un modello economico disaggregato: i comportamenti
Presentazione XIII Capitolo 1 Capitolo 2 Il sistema economico: i soggetti e le interdipendenze 1 1. Il sistema economico 1 2. La teoria economica 3 3. Un modello economico disaggregato: i comportamenti
La teoria dell offerta
 La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
La teoria dell offerta Tecnologia e costi di produzione In questa lezione approfondiamo l analisi del comportamento delle imprese e quindi delle determinanti dell offerta. In particolare: è possibile individuare
La grande frontiera dell utilità nell economia del benessere
 Seminario di Scienza delle Finanze Marco Passarella La grande frontiera dell utilità nell economia del benessere Martedì 3 maggio 2011 Legenda: Parti trattate in Bosi (2006, cap. 1.2-1.3) Parti non trattate
Seminario di Scienza delle Finanze Marco Passarella La grande frontiera dell utilità nell economia del benessere Martedì 3 maggio 2011 Legenda: Parti trattate in Bosi (2006, cap. 1.2-1.3) Parti non trattate
Curva di indifferenza
 Curva di indifferenza Individua le combinazioni di consumo che offrono al consumatore il medesimo livello di soddisfazione La pendenza della curva di indifferenza in qualsiasi punto corrisponde al rapporto
Curva di indifferenza Individua le combinazioni di consumo che offrono al consumatore il medesimo livello di soddisfazione La pendenza della curva di indifferenza in qualsiasi punto corrisponde al rapporto
divisione del lavoro interdipendenze coordinamento a cura di G. Masino
 a cura di G. Masino masino@economia.unife.it 1 Da dove nasce l esigenza di coordinamento? Perche il coordinamento e un problema? Quali sono le modalita tipiche di coordinamento (e di decisione collettiva
a cura di G. Masino masino@economia.unife.it 1 Da dove nasce l esigenza di coordinamento? Perche il coordinamento e un problema? Quali sono le modalita tipiche di coordinamento (e di decisione collettiva
Le origini della VIA. il sistema economico neoclassico e il fallimento del mercato
 Le origini della VIA il sistema economico neoclassico e il fallimento del mercato Il modello del flusso circolare domanda di beni e servizi offerta di beni e servizi spese per consumi mercato dei prodotti
Le origini della VIA il sistema economico neoclassico e il fallimento del mercato Il modello del flusso circolare domanda di beni e servizi offerta di beni e servizi spese per consumi mercato dei prodotti
Economia Politica. Appunti delle lezioni Massimo Carboni. Le esternalità
 Economia Politica Appunti delle lezioni Massimo Carboni Le esternalità Inquadramento generale In alcuni casi il libero mercato non è in grado di allocare le risorse in modo efficiente e quindi garantire
Economia Politica Appunti delle lezioni Massimo Carboni Le esternalità Inquadramento generale In alcuni casi il libero mercato non è in grado di allocare le risorse in modo efficiente e quindi garantire
Programma dell insegnamento di. Microeconomia. Prof.ssa Rosanna Nisticò. Corso di Laurea in Economia A.A Microeconomia SECS-P/01
 Programma dell insegnamento di Microeconomia Prof.ssa Rosanna Nisticò Corso di Laurea in Economia A.A. 2007-08 Disciplina Settore Disciplinare Microeconomia SECS-P/01 Il corso affronta lo studio della
Programma dell insegnamento di Microeconomia Prof.ssa Rosanna Nisticò Corso di Laurea in Economia A.A. 2007-08 Disciplina Settore Disciplinare Microeconomia SECS-P/01 Il corso affronta lo studio della
 Facoltà di Scienze Politiche Corso di Economia Politica Esercitazione di Microeconomia sui capitoli da 1 a 4 Integrazione Domanda 1 La frontiera delle possibilità di produzione si sposta verso destra a
Facoltà di Scienze Politiche Corso di Economia Politica Esercitazione di Microeconomia sui capitoli da 1 a 4 Integrazione Domanda 1 La frontiera delle possibilità di produzione si sposta verso destra a
Capitale sociale e autogoverno
 Capitale sociale e autogoverno Carlo Borzaga e Jacopo Sforzi Trento, 8 luglio 2017 Capitale Sociale Il capitale sociale è un concetto multidimensionaleed è per sua natura legato a qualcosa di estremamente
Capitale sociale e autogoverno Carlo Borzaga e Jacopo Sforzi Trento, 8 luglio 2017 Capitale Sociale Il capitale sociale è un concetto multidimensionaleed è per sua natura legato a qualcosa di estremamente
Esercitazione 10 maggio 2016 (Viki Nellas)
 Esercitazione 10 maggio 2016 (Viki Nellas) Esercizio 1 Si consideri un duopolio in cui le imprese sono caratterizzate dalla seguente funzione di costo totale (identica per entrambe) Esse offrono un prodotto
Esercitazione 10 maggio 2016 (Viki Nellas) Esercizio 1 Si consideri un duopolio in cui le imprese sono caratterizzate dalla seguente funzione di costo totale (identica per entrambe) Esse offrono un prodotto
Il problema organizzativo E. Bracci Economia e Gestione di Impresa
 CdL Informatica Economia e gestione di impresa Docente: Enrico Bracci Il problema organizzativo Obiettivi del modulo 1. Come nasce il problema organizzativo 2. Un modello di analisi dell organizzazione
CdL Informatica Economia e gestione di impresa Docente: Enrico Bracci Il problema organizzativo Obiettivi del modulo 1. Come nasce il problema organizzativo 2. Un modello di analisi dell organizzazione
Esercitazione 3 Aprile 2017
 Esercitazione 3 Aprile 2017 Domanda e Offerta La domanda di computer è D=15 2P, dove P è il prezzo dei computer. Inizialmente, l offerta dei computer è S = P: Trovate il prezzo e la quantita di equilibrio
Esercitazione 3 Aprile 2017 Domanda e Offerta La domanda di computer è D=15 2P, dove P è il prezzo dei computer. Inizialmente, l offerta dei computer è S = P: Trovate il prezzo e la quantita di equilibrio
Indice. Presentazione dell edizione italiana Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura
 Indice Presentazione dell edizione italiana Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura PARTE I Concetti di base XI XII XIII 1 Le basi dell economia 1 1.1 Introduzione 1 1.1.1 Scarsità ed efficienza:
Indice Presentazione dell edizione italiana Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura PARTE I Concetti di base XI XII XIII 1 Le basi dell economia 1 1.1 Introduzione 1 1.1.1 Scarsità ed efficienza:
Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico
 Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico La legislazione antimonopolista Gli strumenti di politica economica: protezioni, sussidi, diritti esclusivi, salvataggi, svalutazioni
Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico La legislazione antimonopolista Gli strumenti di politica economica: protezioni, sussidi, diritti esclusivi, salvataggi, svalutazioni
7. EFFICIENZA DEL MERCATO CONCORRENZIALE: IL MODELLO DELL EQUILIBRIO CONCORRENZIALE
 7. EFFICIENZA DEL MERCATO CONCORRENZIALE: IL MODELLO DELL EQUILIBRIO CONCORRENZIALE Edi Defrancesco Dip. Territorio e sistemi agroforestali Università di Padova e-mail edi.defrancesco@unipd.it Defrancesco
7. EFFICIENZA DEL MERCATO CONCORRENZIALE: IL MODELLO DELL EQUILIBRIO CONCORRENZIALE Edi Defrancesco Dip. Territorio e sistemi agroforestali Università di Padova e-mail edi.defrancesco@unipd.it Defrancesco
Progettazione della microstruttura (seconda parte)
 Progettazione della microstruttura (seconda parte) Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 4 del testo «La progettazione organizzativa» (a cura di Franco Isotta) Progettazione delle mansioni
Progettazione della microstruttura (seconda parte) Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 4 del testo «La progettazione organizzativa» (a cura di Franco Isotta) Progettazione delle mansioni
Lezione 10. Problemi di coordinamento nelle attività agro-industriali (II). Organizzazioni dei Produttori come forme ibride: economia e gestione
 Lezione 10 Problemi di coordinamento nelle attività agro-industriali (II). Organizzazioni dei Produttori come forme ibride: economia e gestione 1 Attributi distintivi delle forme di governo Attributi Strutture
Lezione 10 Problemi di coordinamento nelle attività agro-industriali (II). Organizzazioni dei Produttori come forme ibride: economia e gestione 1 Attributi distintivi delle forme di governo Attributi Strutture
Economia Politica. Cap L economia del settore pubblico. Appunti delle lezioni Raffaele Paci
 Economia Politica Appunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 10-11 L economia del settore pubblico Inquadramento generale In alcuni
Economia Politica Appunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 10-11 L economia del settore pubblico Inquadramento generale In alcuni
Analisi delle Istituzioni Politiche. Lez. 8: Istituzioni e organizzazioni
 Analisi delle Istituzioni Politiche Lez. 8: Istituzioni e organizzazioni I costi del mercato in generale Anche l impresa ha costi di funzionamento, dovuti alla sua struttura gerarchica Questi costi devono
Analisi delle Istituzioni Politiche Lez. 8: Istituzioni e organizzazioni I costi del mercato in generale Anche l impresa ha costi di funzionamento, dovuti alla sua struttura gerarchica Questi costi devono
Economia Politica. Appunti delle lezioni Massimo Carboni. L equilibrio di un impresa nel mercato concorrenziale
 Economia olitica Appunti delle lezioni Massimo Carboni L equilibrio di un impresa nel mercato concorrenziale Inquadramento generale L obiettivo di questo capitolo è quello di esaminare come le imprese
Economia olitica Appunti delle lezioni Massimo Carboni L equilibrio di un impresa nel mercato concorrenziale Inquadramento generale L obiettivo di questo capitolo è quello di esaminare come le imprese
ECONOMIA DELL INFORMAZIONE E DEI MERCATI FINANZIARI
 ECONOMIA DELL INFORMAZIONE E DEI MERCATI FINANZIARI C.d.L. in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (8 CFU) C.d.L. in Statistica per le decisioni Finanziarie e attuariali (6 CFU) a.a. 2012-13
ECONOMIA DELL INFORMAZIONE E DEI MERCATI FINANZIARI C.d.L. in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (8 CFU) C.d.L. in Statistica per le decisioni Finanziarie e attuariali (6 CFU) a.a. 2012-13
Fallimenti del mercato Esternalità
 Fallimenti del mercato Esternalità Prof Giuseppe Migali Universita Magna Graecia a.a 2017-18 Prof Giuseppe Migali (UMG) Fallimenti del mercato Esternalità a.a 2017-18 1 / 24 I Teorema Benessere Il Primo
Fallimenti del mercato Esternalità Prof Giuseppe Migali Universita Magna Graecia a.a 2017-18 Prof Giuseppe Migali (UMG) Fallimenti del mercato Esternalità a.a 2017-18 1 / 24 I Teorema Benessere Il Primo
Economia Politica. Appunti delle lezioni Raffaele Paci. Cap 14 L equilibrio di un impresa nel mercato concorrenziale
 Economia olitica Appunti delle lezioni Raffaele aci testo di riferimento: Mankiw, rincipi di economia, 3 ed., 2, Zanichelli Cap 1 L equilibrio di un impresa nel mercato concorrenziale Inquadramento generale
Economia olitica Appunti delle lezioni Raffaele aci testo di riferimento: Mankiw, rincipi di economia, 3 ed., 2, Zanichelli Cap 1 L equilibrio di un impresa nel mercato concorrenziale Inquadramento generale
La struttura verticale dei mercati. Master in Analisi dei Mercati e Sviluppo Locale. Modulo di Economia Industriale e Settoriale
 Master in Analisi dei Mercati e Sviluppo Locale Modulo di Economia Industriale e Settoriale Dott.ssa Marcella Scrimitore Parte quarta 1 La struttura verticale dei mercati Ogni settore ha una struttura
Master in Analisi dei Mercati e Sviluppo Locale Modulo di Economia Industriale e Settoriale Dott.ssa Marcella Scrimitore Parte quarta 1 La struttura verticale dei mercati Ogni settore ha una struttura
Capitolo VII. Il mercato del lavoro
 Capitolo VII. Il mercato del lavoro 1 In questa lezione parleremo di: Mercato del lavoro in Italia Disoccupazione Determinazione dei salari e dei prezzi Equilibrio del mercato del lavoro e tasso naturale
Capitolo VII. Il mercato del lavoro 1 In questa lezione parleremo di: Mercato del lavoro in Italia Disoccupazione Determinazione dei salari e dei prezzi Equilibrio del mercato del lavoro e tasso naturale
CONCORRENZA OLIGOPOLISTICA INTRODUZIONE E MODELLO DI BERTRAND Prof. Fabrizio Pompei Dipartimento di Economia
 Università degli Studi di Perugia A.A. 2016-2017 ECONOMIA INDUSTRIALE CONCORRENZA OLIGOPOLISTICA INTRODUZIONE E MODELLO DI BERTRAND Prof. Fabrizio Pompei (fabrizio.pompei@unipg.it) Dipartimento di Economia
Università degli Studi di Perugia A.A. 2016-2017 ECONOMIA INDUSTRIALE CONCORRENZA OLIGOPOLISTICA INTRODUZIONE E MODELLO DI BERTRAND Prof. Fabrizio Pompei (fabrizio.pompei@unipg.it) Dipartimento di Economia
MICROECONOMIA. Prof.ssa Carla Massidda
 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2015-2016 MICROECONOMIA Prof.ssa Carla Massidda Argomenti
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale A.A. 2015-2016 MICROECONOMIA Prof.ssa Carla Massidda Argomenti
Economia Politica. Cap L economia del settore pubblico. Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi
 Economia Politica Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 10-11 L economia del settore pubblico Inquadramento generale In
Economia Politica Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 10-11 L economia del settore pubblico Inquadramento generale In
 Facoltà di Scienze Politiche Corso di Economia Politica Esercitazione di Microeconomia sui capitoli da 1 a 4 Integrazione Domanda 1 La frontiera delle possibilità di produzione si sposta verso destra a
Facoltà di Scienze Politiche Corso di Economia Politica Esercitazione di Microeconomia sui capitoli da 1 a 4 Integrazione Domanda 1 La frontiera delle possibilità di produzione si sposta verso destra a
Lezione 17: Le motivazioni del libero commercio: Teoria classica di Smith e Ricardo
 Politiche Economiche Europee stefano.papa@uniroma1.it Lezione 17: Le motivazioni del libero commercio: Teoria classica di Smith e Ricardo Facoltà di Economia Sapeinza, Università di Roma Le motivazioni
Politiche Economiche Europee stefano.papa@uniroma1.it Lezione 17: Le motivazioni del libero commercio: Teoria classica di Smith e Ricardo Facoltà di Economia Sapeinza, Università di Roma Le motivazioni
b) Disegnate, in due grafici distinti, la frontiera di produzione di Zenobia e la frontiera di produzione di Ottavia.
 I VANTAGGI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE In due paesi, Zenobia e Ottavia, si producono 2 soli beni: pane e burro. L unico input produttivo è il lavoro. Ogni paese dispone di 100 lavoratori. Annualmente
I VANTAGGI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE In due paesi, Zenobia e Ottavia, si producono 2 soli beni: pane e burro. L unico input produttivo è il lavoro. Ogni paese dispone di 100 lavoratori. Annualmente
Come l economia si integra nella società
 Come l economia si integra nella società Esistono tre modi fondamentali di integrazione: 1. Reciprocità: prestazione di servizi o cessione di beni materiali con la previsione di avere successivamente una
Come l economia si integra nella società Esistono tre modi fondamentali di integrazione: 1. Reciprocità: prestazione di servizi o cessione di beni materiali con la previsione di avere successivamente una
Capitolo 11 La concorrenza perfetta
 Capitolo 11 La concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile
Capitolo 11 La concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile
OLIGOPOLIO E TEORIA DEI GIOCHI
 OLIGOPOLIO E TEORIA DEI GIOCHI OLIGOPOLIO Caratteristiche di un mercato oligopolistico: Poche imprese presenti sul mercato, che vendono prodotti relativamente omogenei tra loro. Le decisioni di una impresa
OLIGOPOLIO E TEORIA DEI GIOCHI OLIGOPOLIO Caratteristiche di un mercato oligopolistico: Poche imprese presenti sul mercato, che vendono prodotti relativamente omogenei tra loro. Le decisioni di una impresa
Esercitazione 9 10 maggio 2018 Dott.ssa Sabrina Pedrini. Domande a risposta multipla
 Esercitazione 9 10 maggio 2018 Dott.ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Il primo teorema dell economia del benessere sostiene che: a) L equilibrio competitivo dipende dal potere contrattuale
Esercitazione 9 10 maggio 2018 Dott.ssa Sabrina Pedrini Domande a risposta multipla 1) Il primo teorema dell economia del benessere sostiene che: a) L equilibrio competitivo dipende dal potere contrattuale
Paolo Depaoli. Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa» (a cura di Franco Isotta)
 http://it.123rf.com/photo_23991404_cerchio-da-simbolimusicali.html?fromid=bkvnlzzerkhmou9ys3juwwm1yje0ut09 Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa»
http://it.123rf.com/photo_23991404_cerchio-da-simbolimusicali.html?fromid=bkvnlzzerkhmou9ys3juwwm1yje0ut09 Paolo Depaoli Supporti alle lezioni basate sul capitolo 8 del testo «La progettazione organizzativa»
MICROECONOMIA. Modulo 1 Prof.ssa Carla Massidda
 Corso di Laurea in Economia e Finanza Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Università degli Studi di Cagliari MICROECONOMIA Modulo 1 Prof.ssa
Corso di Laurea in Economia e Finanza Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Università degli Studi di Cagliari MICROECONOMIA Modulo 1 Prof.ssa
XVII. Parte I FONDAMENTI ED ESTENSIONI. 1. Gli strumenti di analisi ed i concetti generali
 VII Prefazione XVII Parte I FONDAMENTI ED ESTENSIONI 1. Gli strumenti di analisi ed i concetti generali 1.1. Introduzione 3 1.2. Modelli economici, la nozione di funzione e la nozione di sistema di coordinate
VII Prefazione XVII Parte I FONDAMENTI ED ESTENSIONI 1. Gli strumenti di analisi ed i concetti generali 1.1. Introduzione 3 1.2. Modelli economici, la nozione di funzione e la nozione di sistema di coordinate
Capitolo 11 Concorrenza perfetta. Robert H. Frank Microeconomia - 5 a Edizione Copyright The McGraw-Hill Companies, srl
 Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
Capitolo 11 Concorrenza perfetta MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO In economia tradizionalmente si assume che l obiettivo principale dell impresa sia la massimizzazione del profitto Il profitto contabile è
CAPITOLO 1. Organizzazioni e progettazione organizzativa ORGANIZAZIONE AZIENDALE. Lezione 1 Organizzazioni e progettazione organizzativa
 CAPITOLO 1 Organizzazioni e progettazione organizzativa 1 Agenda Le sfide organizzative Cos è un organizzazione L importanza delle organizzazioni Le dimensioni organizzative Risultati di performance ed
CAPITOLO 1 Organizzazioni e progettazione organizzativa 1 Agenda Le sfide organizzative Cos è un organizzazione L importanza delle organizzazioni Le dimensioni organizzative Risultati di performance ed
Il mercato e i modelli microeconomici
 Il mercato e i modelli microeconomici La microeconomia si preoccupa di spiegare gli equilibri di mercato partendo dal comportamento dei singoli consumatori ed imprese L analisi procede costruento MODELLI:
Il mercato e i modelli microeconomici La microeconomia si preoccupa di spiegare gli equilibri di mercato partendo dal comportamento dei singoli consumatori ed imprese L analisi procede costruento MODELLI:
Lezione 11. Istituzioni e sviluppo economico: il. mercato
 Lezione 11 Istituzioni e sviluppo economico: il mercato 1 Definizione In senso generale il mercato è definito dall esistenza di una relazione di scambio tra due soggetti Bene/Servizio Soggetto A Soggetto
Lezione 11 Istituzioni e sviluppo economico: il mercato 1 Definizione In senso generale il mercato è definito dall esistenza di una relazione di scambio tra due soggetti Bene/Servizio Soggetto A Soggetto
CAPITOLO II. Il Vantaggio Assoluto
 CAPITOLO II Il Vantaggio Assoluto Ragionare di commercio internazionale facendo uso del modello Domanda-Offerta: le esportazioni (importazioni) corrispondono ad un eccesso di offerta (domanda), ai prezzi
CAPITOLO II Il Vantaggio Assoluto Ragionare di commercio internazionale facendo uso del modello Domanda-Offerta: le esportazioni (importazioni) corrispondono ad un eccesso di offerta (domanda), ai prezzi
LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA
 LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA Titolare del modulo di POLITICA ECONOMICA: Dott.ssa Silvia Bertarelli LEZIONE 4 1. Obiettivi microeconomici: l interazione
LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA Titolare del modulo di POLITICA ECONOMICA: Dott.ssa Silvia Bertarelli LEZIONE 4 1. Obiettivi microeconomici: l interazione
STRUTTURE DI MERCATO: CONCORRENZA PERFETTA
 POTERE DI MERCATO STRUTTURE DI MERCATO: CONCORRENZA PERFETTA Il mercato in concorrenza perfetta è ottimale dal punto di vista sociale: I consumatori massimizzano il loro benessere acquistando il prodotto
POTERE DI MERCATO STRUTTURE DI MERCATO: CONCORRENZA PERFETTA Il mercato in concorrenza perfetta è ottimale dal punto di vista sociale: I consumatori massimizzano il loro benessere acquistando il prodotto
Produzione, prezzi e salari
 Economia Internazionale Alireza Naghavi Capitolo 2 (b) Produttività del lavoro e vantaggi comparati: il modello ricardiano 1 Produzione, prezzi e salari Sia Pf il prezzo del formaggio e Pv il prezzo del
Economia Internazionale Alireza Naghavi Capitolo 2 (b) Produttività del lavoro e vantaggi comparati: il modello ricardiano 1 Produzione, prezzi e salari Sia Pf il prezzo del formaggio e Pv il prezzo del
Scienza delle Finanze. Modello Neoclassico
 Scienza delle Finanze Modello Neoclassico Prof. Giuseppe Migali Universita Magna Graecia a.a 2016-17 Prof. Giuseppe Migali (UMG) Scienza delle Finanze Modello Neoclassico a.a 2016-17 1 / 21 Perche discutere
Scienza delle Finanze Modello Neoclassico Prof. Giuseppe Migali Universita Magna Graecia a.a 2016-17 Prof. Giuseppe Migali (UMG) Scienza delle Finanze Modello Neoclassico a.a 2016-17 1 / 21 Perche discutere
Capitolo 10. I fallimenti del mercato Esternalità
 Capitolo 10 I fallimenti del mercato Esternalità Esternalità Quando una transazione tra un compratore e un venditore condiziona direttamente una terza parte, l effetto che questa subisce viene detto esternalità.
Capitolo 10 I fallimenti del mercato Esternalità Esternalità Quando una transazione tra un compratore e un venditore condiziona direttamente una terza parte, l effetto che questa subisce viene detto esternalità.
Indice. Divisione del lavoro e stratificazione sociale: 23. Le «leggi di movimento» del capitalismo, p. 36
 Prefazione v I. L economia e i sistemi economici 3 La scienza economica: 1. Le qualità del buon economista: rigore logico e sensibilità pratica, p. 3-2. La nascita dell economia politica, p. 4-3. L economia
Prefazione v I. L economia e i sistemi economici 3 La scienza economica: 1. Le qualità del buon economista: rigore logico e sensibilità pratica, p. 3-2. La nascita dell economia politica, p. 4-3. L economia
LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA
 LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA Titolare del modulo di POLITICA ECONOMICA: Dott.ssa Silvia Bertarelli 1. Il meccanismo di mercato LEZIONE 2 Definizione
LAUREE SPECIALISTICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA Titolare del modulo di POLITICA ECONOMICA: Dott.ssa Silvia Bertarelli 1. Il meccanismo di mercato LEZIONE 2 Definizione
Indice. Indice. Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione. Capitolo 1. Oggetto e metodologia dell analisi.
 V Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione XIII XIV XV Capitolo 1 Oggetto e metodologia dell analisi 1. Campo di indagine 1 2. Metodologia di analisi 2 2.1. L analisi
V Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione XIII XIV XV Capitolo 1 Oggetto e metodologia dell analisi 1. Campo di indagine 1 2. Metodologia di analisi 2 2.1. L analisi
I FALLIMENTI DEL MERCATO
 I FALLIMENTI DEL MERCATO acarbone@unitus.it Nome docente. Prof. Anna Carbone I limiti del libero mercato Non sempre il mercato funziona in modo così perfetto Talvolta le condizioni in cui operano gli agenti
I FALLIMENTI DEL MERCATO acarbone@unitus.it Nome docente. Prof. Anna Carbone I limiti del libero mercato Non sempre il mercato funziona in modo così perfetto Talvolta le condizioni in cui operano gli agenti
La struttura organizzativa
 Corso di Economia e gestione delle imprese e Marketing (modulo B) Lezione 2 La struttura organizzativa La struttura organizzativa La struttura organizzativa è la risultante delle scelte mediante le quali
Corso di Economia e gestione delle imprese e Marketing (modulo B) Lezione 2 La struttura organizzativa La struttura organizzativa La struttura organizzativa è la risultante delle scelte mediante le quali
Commercio internazionale e tecnologia
 Commercio internazionale e tecnologia Introduzione Commercio internazionale e tecnologia Vantaggi assoluti e vantaggi comparati Modello di specializzazione e salari (reali) La dimensione del paese 2009
Commercio internazionale e tecnologia Introduzione Commercio internazionale e tecnologia Vantaggi assoluti e vantaggi comparati Modello di specializzazione e salari (reali) La dimensione del paese 2009
2. La teoria delle esternalitá
 Economia dell ambiente 2. La teoria delle 2.1 Diritti di proprietá 2.2 Analisi economica delle Economia dell ambiente - Giacomo Branca, Universitá della Tuscia 2.1 Diritti di proprietà esternalità 2.1
Economia dell ambiente 2. La teoria delle 2.1 Diritti di proprietá 2.2 Analisi economica delle Economia dell ambiente - Giacomo Branca, Universitá della Tuscia 2.1 Diritti di proprietà esternalità 2.1
Zingonia 29 marzo 2017
 Zingonia 29 marzo 2017 Parlando di identità La diversa configurazione identitaria Classe sociale Professione Genere La diversa configurazione identitaria Professione Famiglia Religione Quegli ambiti che
Zingonia 29 marzo 2017 Parlando di identità La diversa configurazione identitaria Classe sociale Professione Genere La diversa configurazione identitaria Professione Famiglia Religione Quegli ambiti che
La domanda aggregata in una. economia aperta. Capitolo 12. Mankiw, MACROECONOMIA, Zanichelli editore 2004 Capitolo 12: La domanda aggregata in una
 Capitolo 12 La domanda aggregata in una 1 Il percorso La domanda aggregata in una economia aperta Modello di Mundell-Fleming. Studio della domanda aggregata in una : o Commercio internazionale o Movimenti
Capitolo 12 La domanda aggregata in una 1 Il percorso La domanda aggregata in una economia aperta Modello di Mundell-Fleming. Studio della domanda aggregata in una : o Commercio internazionale o Movimenti
Il sistema finanziario cap.10
 10-5-2017 Il sistema finanziario cap.10 Svolge la funzione di trasferire risorse finanziarie ai soggetti che ne dispongono a quelli che le impiegano Strumenti finanziari principali (par. 10.2.1) Strumenti
10-5-2017 Il sistema finanziario cap.10 Svolge la funzione di trasferire risorse finanziarie ai soggetti che ne dispongono a quelli che le impiegano Strumenti finanziari principali (par. 10.2.1) Strumenti
Economia Politica. Cap 9 Commercio internazionale e benessere. Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi
 Economia Politica Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 9 Commercio internazionale e benessere Inquadramento generale In
Economia Politica Appunti delle lezioni Fabiano Schivardi testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 9 Commercio internazionale e benessere Inquadramento generale In
ICT e le forme di coordinamento delle attività economiche
 ICT e le forme di coordinamento delle attività economiche In linea di principio le tecnologie per il coordinamento Ict-based sono ambivalenti: possono essere usate tanto per il coordinamento interno che
ICT e le forme di coordinamento delle attività economiche In linea di principio le tecnologie per il coordinamento Ict-based sono ambivalenti: possono essere usate tanto per il coordinamento interno che
ALTRI MECCANISMI IMPLICITI DI ENFORCEMENT. Ciò che accomuna questi meccanismi di enforcement:
 ALTRI MECCANISMI IMPLICITI DI ENFORCEMENT Profili salariali crescenti con anzianità (modello Lazear, 1979; 1981) Valutazione soggettiva delle performance Reputazione degli agenti Rendite sui mercati dei
ALTRI MECCANISMI IMPLICITI DI ENFORCEMENT Profili salariali crescenti con anzianità (modello Lazear, 1979; 1981) Valutazione soggettiva delle performance Reputazione degli agenti Rendite sui mercati dei
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 1
 Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 1 Interdipendenza e vantaggi del commercio Mankiw, Capitolo 3 Due dei principi fondamentali dell interazione tra individui sono i seguenti: - lo scambio può
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 1 Interdipendenza e vantaggi del commercio Mankiw, Capitolo 3 Due dei principi fondamentali dell interazione tra individui sono i seguenti: - lo scambio può
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4
 Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4 Premessa Studiando la curva di offerta e di domanda di un bene abbiamo visto che venditori e consumatori hanno la necessità di incontrarsi per vendere e
Economia Politica (Mod I) Nota integrativa n. 4 Premessa Studiando la curva di offerta e di domanda di un bene abbiamo visto che venditori e consumatori hanno la necessità di incontrarsi per vendere e
IL TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE. Harcourt Brace & Company
 IL TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE Categorie della disoccupazione Il problema della disoccupazione può essere diviso in due categorie. Il tasso naturale di disoccupazione La disoccupazione ciclica Tasso
IL TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE Categorie della disoccupazione Il problema della disoccupazione può essere diviso in due categorie. Il tasso naturale di disoccupazione La disoccupazione ciclica Tasso
Caffé
 ESEMPIO DI PRE-ESAME ECONOMIA POLITICA SSS. Domande a risposta multipla Usate il grafico per rispondere alle domande 1-3 1. Se un sistema economico sta operando al punto C (sul grafico), il costo opportunità
ESEMPIO DI PRE-ESAME ECONOMIA POLITICA SSS. Domande a risposta multipla Usate il grafico per rispondere alle domande 1-3 1. Se un sistema economico sta operando al punto C (sul grafico), il costo opportunità
Commercio internazionale con mercati non concorrenziali. Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale
 Commercio internazionale con mercati non concorrenziali Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale 1 Schema della lezione Ripasso di microeconomia: rendimenti di scala crescenti e differenziazione
Commercio internazionale con mercati non concorrenziali Giuseppe De Arcangelis 2015 Economia Internazionale 1 Schema della lezione Ripasso di microeconomia: rendimenti di scala crescenti e differenziazione
Introduzione. Il bene salute. La domanda di prestazioni sanitarie. Il modello di Grossman Critiche al modello di Grossman
 Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente te al libro di testo
Introduzione NB: Questi lucidi presentano solo parzialmente gli argomenti trattati ttati in classe. In particolare non contengono i modelli economici per i quali si rinvia direttamente te al libro di testo
CONSUMATORI, PRODUTTORI ED EFFICIENZA DEI MERCATI
 CONSUMATORI, PRODUTTORI ED EFFICIENZA DEI MERCATI L analisi fino ad ora è stata di tipo positivo : abbiamo visto in quali modi le forze della domanda e dell offerta determinano quantità e prezzo di equilibrio
CONSUMATORI, PRODUTTORI ED EFFICIENZA DEI MERCATI L analisi fino ad ora è stata di tipo positivo : abbiamo visto in quali modi le forze della domanda e dell offerta determinano quantità e prezzo di equilibrio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Walther
 PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA CLASSE IV A LA MONETA E I SISTEMI MONETARI Origini e funzioni della moneta Il valore della moneta I sistemi monetari Gli strumenti di pagamento bancari La liquidità LE TEORIE
PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA CLASSE IV A LA MONETA E I SISTEMI MONETARI Origini e funzioni della moneta Il valore della moneta I sistemi monetari Gli strumenti di pagamento bancari La liquidità LE TEORIE
LE RAGIONI DELL INTERVENTO PUBBLICO. TRA EFFICIENZA ED EQUITÀ (G. Pisauro luglio 2007)
 LE RAGIONI DELL INTERVENTO PUBBLICO NELL ECONOMIA ECONOMIA TRA EFFICIENZA ED EQUITÀ (G. Pisauro luglio 2007) Riferimenti Un manuale moderno di economia pubblica. Ad esempio: R. Artoni, Lezioni di Scienza
LE RAGIONI DELL INTERVENTO PUBBLICO NELL ECONOMIA ECONOMIA TRA EFFICIENZA ED EQUITÀ (G. Pisauro luglio 2007) Riferimenti Un manuale moderno di economia pubblica. Ad esempio: R. Artoni, Lezioni di Scienza
Orari. Lezioni Venerdì 5 ottobre A partire dal 15 ottobre fino 6 novembre, lunedì e martedì Venerdì 9 novembre 17-20
 Economia Politica Laurea triennale in Amministrazione, Governo e Sviluppo Locale Sede di Nuoro Giovanni Sulis (microeconomia) Fabio Cerina (macroeconomia) Orari Lezioni Venerdì 5 ottobre 17-20 A partire
Economia Politica Laurea triennale in Amministrazione, Governo e Sviluppo Locale Sede di Nuoro Giovanni Sulis (microeconomia) Fabio Cerina (macroeconomia) Orari Lezioni Venerdì 5 ottobre 17-20 A partire
Economia Politica. Cap 9 Commercio internazionale e benessere. Appunti delle lezioni Raffaele Paci
 Economia Politica ppunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 9 Commercio zionale e benessere Inquadramento generale In questa sezione
Economia Politica ppunti delle lezioni Raffaele Paci testo di riferimento: Mankiw, Principi di economia, 3 ed., 2004, Zanichelli Cap 9 Commercio zionale e benessere Inquadramento generale In questa sezione
PROGRAMMA SVOLTO IN DIRITTO-ECONOMIA. Anno scolastico L ordinamento della Repubblica.
 PROGRAMMA SVOLTO IN DIRITTO-ECONOMIA Classe 2C programmatori L ordinamento della Repubblica. - Il Parlamento: composizione e funzionamento. Le funzioni del Parlamento. - Lo scioglimento anticipato delle
PROGRAMMA SVOLTO IN DIRITTO-ECONOMIA Classe 2C programmatori L ordinamento della Repubblica. - Il Parlamento: composizione e funzionamento. Le funzioni del Parlamento. - Lo scioglimento anticipato delle
FALLIMENTI DEL MERCATO
 FALLIMENTI DEL MERCATO Il mercato fallisce per: difficoltà delle parti a realizzare un accordo potenzialmente vantaggioso mancanza di controllo pieno sui beni mancanza o incompletezza delle informazioni
FALLIMENTI DEL MERCATO Il mercato fallisce per: difficoltà delle parti a realizzare un accordo potenzialmente vantaggioso mancanza di controllo pieno sui beni mancanza o incompletezza delle informazioni
Lezione 1: Teoria del commercio internazionale: Smith e Ricardo
 Corso di Economia e Politica economica nei mercati globali Secondo modulo S. Papa spapa@unite.it Lezione 1: Teoria del commercio internazionale: Smith e Ricardo Facoltà di Scienze della Comunicazione Università
Corso di Economia e Politica economica nei mercati globali Secondo modulo S. Papa spapa@unite.it Lezione 1: Teoria del commercio internazionale: Smith e Ricardo Facoltà di Scienze della Comunicazione Università
