Sulla necessità della visio beatifica in Cristo a partire dal rapporto tra conoscenza e autocoscienza
|
|
|
- Silvio Rizzi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sulla necessità della visio beatifica in Cristo a partire dal rapporto tra conoscenza e autocoscienza secondo il pensiero di S. Tommaso d Aquino e dei grandi interpreti della teologia del sec. XX Sommario Introduzione... 1 Il pensiero di S. Tommaso d Aquino La persona di Cristo Lo stato di Cristo La conoscenza nel Cristo delle cose e di se stesso nel suo singolare stato La ragione formale della visione beatifica del Cristo... 8 Il pensiero di alcuni teologi del sec. XX P. Galtier P. Parente J. Galot K. Rahner H. U. Von Balthasar Conclusione: le indicazioni suggeriteci Bibliografia Introduzione All interno della Teologia dogmatica un grande capitolo spetta alla Cristologia, alla riflessione nella fede normata dalla S. Scrittura e guidata passo passo dalla Tradizione della Chiesa sul contenuto stesso della fede: la persona del Cristo. L importanza di tale trattato nella teologia dogmatica è così capitale da costituire l elemento formale delle altre discipline teologiche, affrontare quindi la persona di Cristo significa tener conto delle implicanze formali e contenutistiche che tale oggetto possiede, quindi pensare sinotticamente alla questione antropologica come a quella soteriologica, fondamentale e trinitaria. Scopo di tale elaborato sarà solo quello di poter far emergere dal confronto tra la teologia di S. Tommaso d Aquino e quella del sec. XX i tratti imprescindibili e irrinunciabili ad un pensiero che 1
2 si voglia dire teologico circa la necessità o meno della visio beatifica nel rapporto tra conoscenza ed autocoscienza nella persona del Cristo. Per tanto si cercherà di far emergere la visione monumentale del dottore della chiesa S. Tommaso d Aquino e metterla in presenza del pensiero di quegli autori fondamentali del sec. XX che hanno espresso il loro pensiero su tale rapporto, affinché il porli l uno di fronte agli altri evidenzi le opposizioni polari costitutive per un pensiero teologico e quegli assunti, ormai dati, imprescindibili per un qualsiasi nuovo pensiero teologico su tale materia. Il pensiero di S. Tommaso d Aquino Per presentare il pensiero complesso ed articolato del Dottore Angelico faremo riferimento a due suoi testi: al terzo libro del Commento alle sentenze di Pietro Lombardo 1 e alla Summa teologiae 2 ; sarà altresì necessario utilizzare alcuni commenti al pensiero dell autore 3 che faranno però riferimento anche ad altri suoi testi. Cercheremo ora di descrivere il pensiero del Dottore Angelico secondo un ordine logico: partiremo infatti dalla persona divina del Cristo per poterne così affermare la singolarità costitutiva nello stato di viatore e di comprensore, stato di vita unico sia quanto al conoscere le cose sia al conoscere se stesso. Tutto ciò permetterà di dare uno sguardo più illuminato circa il problema della visione beatifica di Cristo e della sua autocoscienza di Figlio di Dio. 1. La persona di Cristo L argomento svolto nella S. Th. III, q. 2 è la trattazione riguardante l «ipsum incarnationem mysterium» 4 a partire dalla incarnazione di Cristo: l unione del Verbo incarnato con la natura umana. L accento è posto principalmente sull unità del Verbo, data da un unico suppositum, la sussistenza divina del Verbo costituente il Verbo come persona divina, anche se non univocamente. Infatti il supposito è ciò che ha l esistenza, nel senso che è il tutto di quell essere che possiede l essere nell esistere; ora in Cristo esiste un suppositum, che è la sostanza divina, in cui c è tutto il divino e, per mezzo dell assunzione della natura umana, viene ad esserci anche tutto l umano incluso in quel tutto divino. L unicità di Cristo appare così dal confronto della sua particolare forma ontologica rispetto a Dio e agli uomini: infatti in Dio si da una sola natura ma tre suppositi, identici proprio quanto alla natura, differenti invece quanto alle loro relazioni, che sono sostanziali; nel mondo creato si afferma il coincidere del supposito con la sostanza dell uomo. Tale unica persona nel Cristo rende coabitanti in lui sia la natura divina che quella umana in modo che in una persona queste esistano «senza confusione e senza trasformazione, senza divisione e senza separazione» 5. La persona sussistente ( ) è una e distinta dalla natura concreta ( ), quella umana e divina. L unità della persona e del supposito rende il Cristo non persona umana, ma persona divina, quindi non ultimamente raffrontabile alla persona umana per tutte quelle facoltà e operazioni tipicamente personali, rendendolo invece un unicum tra tutti gli esseri personali esistenti, il che ci fa ammettere una maggiore discontinuità in una sì grande continuità 6. La singolarità del Cristo è sottolineata fortemente dall Angelico proprio in quelle questioni che riguardano l attività personale del Cristo: circa la sua opera di salvezza, quando si sottolinea che 1 In particolar modo la Distinctio XIV, in Opera Omnia, VII, New York Faremo riferimento alla III pars, q. 15, a. 10, ed. Studio Domenicano, Bologna F. Ruello, La cristologie de S. Thomas d Aquin, Parigi 1987; H. Diepen, La psycologie humaine du Crist selon S. Thomas, in: Revue Thomiste 50 (1950), ; L. Iammarrone, La ragione formale della visione beatifica del Cristo pre-pasquale secondo S. Tommaso, in: Studi Tomistici 13 (1981), Trattasi delle qq della Pars. III. 5 Secondo il concilio di Calcedonia (451): [DS. 302]. 6 [DS. 806]. 2
3 la natura umana è instrumentum coniunctum 7 della divinità, e quando si sottolinea la distinzione tra le due nature nell unica persona, riflettendo sulla potenza dell anima 8, sui limiti assunti da questa e quelli assunti dal corpo dal Cristo nella natura umana 9. Vorrei sottolineare come il dottore Angelico nella sua formulazione delle tesi circa il rapporto tra le due nature, umana e divina, faccia costantemente riferimento a due principi basilari: all incarnazione, che l obbliga a tenere il dato dell unico suppositum e dell unica persona, e alla formulazione del Concilio di Calcedonia circa il loro modo di coesistenza: senza confusione e trasformazione, riferendosi alla trascendenza del Verbo, e senza divisione e separazione, riferendosi alla vita del Cristo, immanente ed economica 10. Faremo continuamente attenzione a tale nota metodologica suggerita da S. Tommaso nel corso dell elaborato mostrandone l acutezza per la risoluzione del problema. 2. Lo stato di Cristo La singolarità del Cristo emerge con una sottolineatura del tutto particolare circa il rapporto tra conoscenza e autocoscienza della persona del Cristo nella vexata questio sulla visione beatifica: se Cristo fosse insieme viatore e comprensore 11. La singolarità della persona del Cristo porta l Angelico a dover riflettere anche sullo stato del Verbo incarnato, il cui stato ne comprende due: lo stato viatore, che tende alla beatitudine eterna, e quello comprensore, che ha già raggiunto la beatitudine. Questo singolare stato del Cristo dipende direttamente dalla sua costituzione personale e naturale: infatti la sola persona, che è presente in Cristo, è quella divina, alla quale è legata indissolubilmente la natura divina, ma con l incarnazione non possiamo non considerare la natura umana, distinta da quella divina senza confusione e mescolanza. Per questo si potrà affermare che l anima del Cristo non fosse onnipotente 12 proprio perché «nel mistero dell incarnazione l unione ipostatica è avvenuta in modo da lasciare le due nature distinte, conservando all una e all altra quanto ciascuna ha di proprio. Ora la potenza attiva di ogni cosa dipende dalla sua forma, che è il principio dell operazione. La forma poi o è la stessa natura o è il costitutivo della natura Perciò è chiaro che la potenza attiva di ogni ente dipende dalla sua natura. Così dunque l onnipotenza consegue alla natura divina siccome dunque l anima di Cristo è una parte della natura umana, è impossibile che abbia l onnipotenza» 13. Si potrà così affermare anche che l anima di Cristo non avesse l onnipotenza per trasformare le creature 14, e l onnipotenza rispetto al proprio corpo 15 e nell attuare la propria volontà 16, facendo 7 S. Th. q «In Cristo dunque la natura divina si serve dell operazione della natura umana come di uno strumento; e a sua volta la natura umana partecipa all operazione della natura divina, come lo strumento partecipa all operazione dell agente principale» (q. 19, a. 1, corp. ). 8 S. Th., q S. Th. qq [DS. 302]. 11 S. Th., q. 15, a S Th., q. 13, a Ibid., corp. Da notare l uso di quel metodo sopra ricordato: tenere insieme il dato dell unica persona e delle due nature, secondo il dogma affermato dal Conc. di Calcedonia. 14 S. Th., q. 13, a S. Th., q 13, a S. Th., q. 13, a. 4. 3
4 sempre riferimento al singolarissimo rapporto tra le due nature nell unica persona divina senza mescolanza e confusione 17. Nella S. Th., q. 15, a. 10 l Angelico affronta proprio il rapporto tra stato viatore e comprensore: «Si dice viatore chi tende alla beatitudine e comprensore chi l ha già raggiunta Ma la beatitudine perfetta dell uomo si riferisce all anima e al corpo: all anima per quello che le è proprio, e che consiste nel vedere Dio e nel godere di lui, al corpo invece in quanto esso risorgerà spirituale, pieno di forza, glorioso ed incorruttibile (1 Cor. 15,42 ss.). Ora Cristo, prima della morte, con la sua intelligenza vedeva Dio perfettamente, e così aveva la beatitudine propria dell anima. Ma quanto al resto la beatitudine gli mancava, poiché la sua anima era passibile ed il corpo passibile e mortale. Quindi era comprensore quanto al possesso della beatitudine propria dell anima, e insieme viatore in quanto tendeva alla beatitudine per ciò che di essa gli mancava» 18. Anche in questo passo ci è possibile ravvisare la bontà del tenere assieme in Cristo, senza confusione alcuna, le due nature grazie all unico supposito: senza tale affermazione e nota metodologica diveniva assai difficile far coincidere in un unico soggetto due stati che appartengono alla natura umana nello stato di viatrice o nella beatitudine finale, ma non contemporaneamente in uno solo di questi. La possibilità resta quindi fondamentalmente ancorata alla singolare persona di Cristo, il quale si trova nello stato di viatore per l opera della incarnazione, che gli fa assumere la natura umana, e nello stato della beatitudine per la sua natura divina, derivante dalla sua persona divina. Crediamo che si possa affermare che vi sia una certa ragione di necessità che lega il ragionamento di S. Tommaso: infatti è strettamente necessario, perché connaturale, lo stato di viatore alla natura umana passibile, ma altresì lo stato di comprensore per la sua persona divina, nella quale non si può ammettere una lontananza tale dal Padre e dallo Spirito che le precluda la visione beatifica. Proprio questa necessità connaturale sarà, come vedremo fra poco, la causa di una distanza tra il pensiero teologico di S. Tommaso e quello dei teologi contemporanei. Il problema per la teologia del sec. XX sembra essere più marcatamente psicologico che teologico: si cerca infatti di trovare il modo in cui possano coesistere il dato dell incarnazione, che impone di prendere sul serio la carne del Cristo, il suo stato di viatore, con il dato della sua persona divina. La domanda soggiacente è in definitiva sul come sentisse il Cristo la sua persona, come si riconoscesse se la sua particolare esistenza gli permetteva di vedere se stesso come il Figlio di Dio, il Verbo, nella sua condizione umana, nel suo modo umano di conoscere, nella sua conoscenza normata dall esperienza, ossia come un io divino potesse comprendersi umanamente. Le domande sopra poste ci chiedono di conoscere quale fosse il pensiero di S. Tommaso circa tali obiezioni, ma il Dottore Angelico non se le pose mai in tale forma, occorrerà quindi soffermarci ora nel distinguere le vari componenti del problema per poter arrivare ad una possibile visione dell Angelico circa la spinosa questione. Porremo quindi il nostro sguardo sulla possibilità in Cristo di una sua comprensione del suo stato di viatore e comprensore analizzando prima il modo di conoscere che il Cristo ebbe, poi la sua autocomprensione di sé. 17 Circa l articolo 2: «Se dunque consideriamo l anima di Cristo nella sua essenza e virtù, sia di natura che di grazia, essa aveva il potere di produrre gli effetti che sono di competenza dell anima Se invece l anima di Cristo viene considerata come strumento congiunto del Verbo, allora essa aveva la virtù strumentale per produrre tutte le mutazioni miracolose ordinabili al fine del la incarnazione»; circa l articolo 3: «l anima di Cristo può essere considerata da due punti di vista: nella sua propria natura e virtù e in quanto strumento unito ipostaticamente al Verbo di Dio»; circa l articolo 4: «l anima di cristo poteva volere una cosa in due modi: per compierla essa stessa (secondo la sua natura, n.d.a.) per attuarla mediante la potenza divina (secondo la sua particolare relazione di strumento congiunto, n.d.a.)». 18 S. Th., q. 15, a. 10, corp. 4
5 3. La conoscenza nel Cristo delle cose e di se stesso nel suo singolare stato In questo paragrafo cercheremo di avvicinarci al mistero della persona del Verbo incarnato per poter così riflettere sulla sua conoscenza, delle cose e di se stesso, in una natura umana. Per far ciò ci avalleremo dello studio cristologico che F. Ruello 19 ha compiuto basandosi sugli scritti del dottore Angelico, soprattutto in quella parte in cui tratta il pensiero del teologo circa la conoscenza del Cristo. Ci baseremo qui soprattutto sul terzo libro del Commento alle sentenze del Pietro Lombardo nella distinctio XIV 20 visto che il pensiero dell autore non se ne distanzierà nelle opere successive (tranne in un solo aspetto 21 ), secondariamente sulla Summa teologiae. Nella d. XIV all art. 1 S. Tommaso riflette proprio a partire da Calcedonia e domandandosi se ciò che attribuiamo a Cristo sia in funzione della persona o della natura, l Angelico risponde scindendo: se si attribuisce qualcosa in funzione della persona lo si può fare solo circa l essere, perché il supposito è unico, se lo si fa in funzione della natura occorre distinguere ancora tra natura umana, in funzione dell anima, e natura divina, un solo essere immenso, e comprendendo entrambe, circa quindi le due libere volontà. Alla domanda allora sulla scienza, a chi sia possibile attribuirla, il Dottore risponde che questa si rapporta alla natura divina come a quella umana: in Cristo quindi si deve parlare di due scienze commisurate alle rispettive nature, umana e divina, creata e increata 22. Secondariamente si domanda se la scienza creata sia attuale o abituale, e nota come nessuna potenza possa passare all atto se la forma di ciò che l attualizza non lo perfeziona, poiché niente agisce se non è in atto (nihil operatur nisi secundum quod est in actu), tale principio attivo si deve quindi applicare al principio passivo secondo due modalità: per passione (per modum passionem) in cui la potenza passiva viene sottomessa a mutazione, e per forma e qualità (per modum qualitas et formae) quando l applicazione del principio attivo, l impressio, diviene connaturale al principio passivo. Similmente quindi per l intelletto, la scienza creata è una potenza passiva in rapporto a ciò a cui tende, per una passione corrispondente questi diverranno simili e li conoscerà. L intelletto è quindi capace di conoscere tutti gli esseri, perché l essere e il vero sono convertibili (ens et verum convertuntur) e perché l essere è l oggetto dell intelletto (ens est objectum intellectus), ma nessuna creatura è in atto tutto ciò che è, solo Dio, sorgente di tutti gli esseri, li possiede tutti di fronte a lui, perché conosce per potenza attiva e non passiva. La creatura conosce invece per potenza passiva, è recettiva («nec sensus nec intellesctus possibilis operari possunt, nisi per sua activa perficiantur vel moveantur»); i sensi non percepiscono se non in presenza del sensibile, occorre quindi che si riceva l impressione, ma questo non è sufficiente per la perfezione dell intelletto, occorre infatti che l impressione del principio attivo esista nel modo della forma e qualità. Esiste quindi un doppio principio attivo: un primo motore, come ad esempio la luce, ed un motore mosso, i colori. Nell intelletto il primo motore sarà quindi la luce dell intelletto e l agente secondo sarà la specie che la luce rende attualmente intelligibile. Poiché l intelletto di Cristo fu molto perfetto nell ordine della 19 F. Ruello, La christologie de Thomas d Aquin, Paris Il titolo del primo articolo della distinctio è Si anima Christi habuerit sapientiam parem cum Deo, et si omnia scit quae Deus. 21 Si confronti infatti nel Commento alle sentenze: 3 Sent., d. 14,a. 1, ad. 3 in cui non ammette una scienza acquisita sperimentale, che implichi un progresso in qualche modo rispondente a quella crescita in sapienza, età e grazia della quale parla esplicitamente il N.T., con la q. 9, a. 4 della Summa Teologiae in cui si afferma:«sebbene altrove io abbia scritto diversamente, bisogna riconoscere in Cristo la scienza acquisita. Essa è una scienza commisurata esattamente all uomo» e sempre nella Summa la q. 12, a. 2, il cui titolo Se Cristo abbia fatto dei progressi nella scienza acquisita o sperimentale, in cui però l Angelico afferma che il Verbo incarnato non può aver imparato qualcosa dagli uomini: «Il maestro insegna, non impara». 22 Solutio I: «Unde cum scientia pertineat ad divinam naturam et humanam, oportet in Christo ponere duas scientia, unam creatam, et aliam increatam». 5
6 conoscenza, esiste in lui un habitus del conoscere tale che l impressione del principio attivo non si presenti a Lui unicamente sotto il modo della passione, ma ancora sotto il modo della forma 23. L habitus della scienza implica l idea di similitudine e affinità e quella circa la luce dell intelletto: possiamo allora, si domanda S. Tommaso riflettendo sulla prima, pensare che l anima di Cristo abbia bisogno di ricorrere ad un habitus per conoscere? L Angelico risponde negativamente, e intravede nel principio gnoseologico del omne quod recipitur in aliquo, sit in eo per modum recipientis la soluzione, infatti nessuna creatura può ricevere una similitudine all essenza divina che la rappresenti perfettamente, perché questa sarà infinitamente distante da Dio. Allora ciò che in Dio è uno e semplice le creature lo rappresentano con delle forme e rappresentazioni diverse, ma se solo una rappresentazione perfetta di questa essenza permette di vederlo, un intelletto che conosce il Verbo per una similitudine non può essere considerato come vedente l essenza del Verbo. L habitus però connota anche l idea di luce dell intelletto, la quale rende ciò che è intelligibile intelligibile in atto, perché le sono illuminate le specie e l intelletto agente può quindi percepirle, si ha quindi un perfezionamento dell intelletto possibile alla conoscenza. Similmente anche il Verbo è una realtà intelligibile in atto ed occorre dunque che l intelletto possibile sia perfezionato per adeguarsi a tale sublime oggetto, occorre che alla luce della natura sia aggiunto il lumen gloriae. L habitus che permette al Verbo incarnato di conoscere il Verbo non è dunque un habitus il cui concetto implichi somiglianza e luce dell intelletto, rendendo intelligibile in atto l intelligibile in potenza, ma un habitus di gloria, che renda l intelletto possibile capace di conosce il Verbo 24. Secondo il principio affermante che ciò in cui si vede qualche cosa è ciò che fa conoscere ciò che si vede in lui, la ragione del conoscere e tale cosa conosciuta formano un solo oggetto conosciuto (ratio cognoscendi et res cognita sunt unum cognitum), segue che la conoscenza abituale e attuale sono una sola conoscenza. Il Cristo quindi non conosce secondo due abiti il Verbo e ciò che in lui vede 25. Infine l Angelico si domanda se Cristo avesse avuto delle cose una scienza differente da quella che egli ne ha nel Verbo, ed ammette che si potrebbe immaginare che tale differenza non esista, ma se il Verbo ha assunto una natura umana, allora ha assunto anche un intelletto possibile. In oltre, riportando Aristotele, l Angelico afferma che l intelletto possibile è in potenza tutti gli intelligibili (intellectus possibilis est in potentia ad omnia intelligibilia, il che lo afferma nel De anima, 3), ma tutto ciò che è in potenza, rispetto ad una forma qualsiasi, rimane imperfetto se tale forma non cade in esso. Poiché l intelletto di Cristo non è imperfetto, occorre che siano impresse in lui tutte le forme di cui egli è in potenza. Ma secondo ciò che conosce il Verbo non ci sono in lui né la similitudine del Verbo, né la similitudine delle cose che il Verbo conosce in sé, allora il Verbo incarnato possiede una triplice scienza: la scienza divina increata, la scienza delle cose nel Verbo e del Verbo stesso (scienza del comprensore) e la scienza delle cose nella loro propria natura (scienza del viatore) 26. Nell art. 2 S. Tommaso si domanda se l anima di Cristo comprendesse il Verbo che lei vedeva, ed egli risponde che l anima di Cristo non può avere la comprensione di Dio. In effetti è 23 Solutio II: «Qia igitur intellectus Christi perfectissimus fuit in cognoscendo, oportebat quod in Christo habitus esset quo cognosceret; ut sic impressio activi non solum esset in ipso per modum passionis, sed etiam per modum formae». 24 Solutio III: «anima Christi et quaelibet anima quae videt Verbum per essentiam, non videt impsum mediante aliqua similitudine sed oportet quod sit ibi quantum ad alium effectum, qui est perficere intellectum possibilem ad cognoscendum ideo ad aliam visionem non sufficit lumen naturae, sed oportet ut superaddatur lumen gloriae». 25 Solutio IV: «non est alius habitus quo cognoscitur Verbum et ea quae in Verbo videtur; sicut nec alius habitus quo cognoscitur medium demostratiois et conclusio, secundum medium ad conclusionem ordinatur». 26 Solutio V: «oportet quod praeter visionem qua videt res in Verbo, habeat aliam scientiam de rebus, secundum quod cognoscit eas per proprias similitudines in propria natura. Et sic habemus tre scientias Christi. Una est divina, quae est increata. Alia qua cognoscit res in Verbo, et Verbum ipsum, quae est scientia comprehensoris. Tertia qua cognoscit res in propria natura, quae competit ei secundum quod est homo in solis naturalibus consideratus». 6
7 propriamente compreso ciò che l intelletto percepisce secondo la sua intera intelligibilità: quando è così l intelletto percepisce i limiti di ciò che conosce. Così in Dio stesso si può affermare che non si autocomprende, poiché egli non possiede limitazione alcuna: egli si conosce secondo tutta la sua intelligibilità. Ora tutto è conoscibile secondo ciò che è ente, dunque la comprensione esiste quando l intelletto conosce adeguatamente l essenza di una cosa. Nell atto di intellezione intervengono: la luce intellettuale, permettendo all intelletto di conoscere, e la similitudine della cosa conosciuta intellettivamente grazie alla quale l operazione intellettiva si porta verso la cosa. Se l essere di una realtà qualunque oltrepassa la luce e la similitudine, di cui si è già parlato, l intelletto non la conosce. Il problema pertanto non è lo stesso se la cosa oltrepassa la similitudine o la luce dell intelletto. Nel primo caso, l intelletto non perviene a vedere l essenza della cosa, perché la similitudine di una cosa la determina alla conoscenza della stessa. Se una cosa invece oltrepassa la luce dell intelletto, ma non la sua specie, questa è vista nella sua essenza, ma non perfettamente, tale e quale è conoscibile, perché per poterla conoscere occorre la luce intellettuale. Ma l essere delle creature, quello che queste ricevono, è in difetto nel rapporto all eminenza dell essere del Creatore. Alcun intelletto creato che conosce Dio a meno di una similitudine impressa o astratta; non vede la sua essenza: per chi vede Dio occorre che la essenza stessa di Dio si unisca a lui come una forma che la determina a poterla conoscere, questo si produce in tutti i beati. Ma poiché la luce intellettuale rende intelligente nel senso assoluto del termine colui che la riceve, occorre che tutto l intelletto la conosca per mezzo della luce che è in lui. Di conseguenza, la luce intellettuale che riceve l intelletto creato, ma per il quale egli vede Dio, è in difetto nel rapporto con l essere divino; benché egli veda l essenza di Dio, egli non la vede perfettamente perché non può essere donato ad alcun intelletto creato di vedere Dio 27. L Aquinate si domanda poi se l anima di Cristo conosceva nel Verbo tutto ciò che il Verbo conosce. La risposta è affermativa, per S. Tommaso infatti l anima di Cristo è tra tutte le creature quella che vede più perfettamente il Verbo: essa perviene dunque al termine di tale conoscenza, ella sa dunque tutto ciò che è, tutto ciò che sarà e che fu, come anche tutto ciò che è pensato, fu pensato e sarà pensato, ella sa tutto ciò che esiste nella potenza seminale. Questa dottrina si oppone così all idea che tutto l intelletto che vede Dio vede tutto ciò che Dio vede. Non sembra però necessario per S. Tommaso che ciò sia in tali termini, infatti il mezzo con cui l anima di Cristo conosce è che le cose sono viste da Dio, ma non è per questo necessario che se si conosce il mezzo allora si conosca tutto ciò che permette di conoscere. Ora, Dio che si comprende conosce egli stesso tutto ciò che è in lui in qualche modo, ma non lo conosce allo stesso modo: egli infatti può conoscere sia per mezzo della scienza della visione tutto ciò che è, sarà e fu perché è visto, dunque l essere è esteriore a chi lo vede. L essenza per la quale Dio vede è una, ma egli vede le cose per mezzo delle ragioni ideali distinte ed ha quindi una conoscenza distinta: egli conosce il bene per la sua idea, il male per l idea opposta al bene. Può però conoscere anche per mezzo della semplice intelligenza ciò che non esiste e non esisterà; le cose non esistono in se stesse, non implicano dunque tra loro alcuna distinzione, esse non esistono che nella potenza divina, nella quale esse sono una sola cosa. Esse non si distinguono dunque secondo il loro rapporto diverso dall esemplare divino, Dio non le conosce per delle idee distinte, ma le conosce nel concepirle, nel vederle in sé. Ora, tutto ciò che fa o può fare qualche cosa lo fa o lo può fare secondo ciò che è in atto. É dunque impossibile che si sappia tutto ciò che una cosa possa produrre se non si comprende la sua entità. Poiché alcun intelletto creato comprende l essenza divina nessuno può sapere ciò che Dio possa fare, mentre nulla si oppone a che un intelletto 27 Solutio I: «Unde per lumen intellectuale quod est in intellectu creato receptum, quo Deum videt, deficit ab esse divino; et ideo quamvis essentiam Dei videat, non tamen perfecto modo videt; et propter hoc intellectui creato communicari non potest quod Deum comprehendat». 7
8 creato conosca per la scienza della visione. Possiamo quindi affermare che Cristo vede nel Verbo tutto ciò che egli vede o conosce di scienza della visione 28. S. Tommaso si domanda infine se questa scienza di cui gode l anima di Cristo sia anche limpida come quella di Dio, e nota come la chiarezza o limpidezza di una visione dipenda da tre cause: dalla forza propria della potenza di vedere, dalla chiarezza della luce che rende possibile di vedere ciò che è invisibile e dal rapporto che esiste tra colui che vede e chi può essere visto o ciò in cui può vederlo. L anima di Cristo non poteva dunque vedere ciò che vedeva nel Verbo così chiaramente come il Verbo la vede; in effetti la sua potenza di conoscenza non uguaglia quella del Verbo, la luce che la illumina è inferiore alla luce increata, l essenza divina, esemplare delle cose nelle quali esse sono viste, è più unita al Verbo che a tutte le creature 29. In sintesi possiamo quindi notare come per il Dottore Angelico esistano tre tipi di scienza: la scienza beatifica, quella infusa e quella sperimentale-acquisita. La scienza beatifica consiste nella visione di Dio e, in lui, di tutte le realtà create, ed è quella scienza che possiedono gli eletti che si trovano nella beatitudine eterna; la ragione per cui, secondo S. Tommaso, questo tipo di scienza non può mancare nel Figlio di Dio fatto uomo, è che Egli è la causa della salvezza, e quindi della beatitudine delle anime, per cui non potrà non possedere in prima persona quella visione beata che è in grado di procurare ad altri 30. In base al medesimo principio, cioè per la funzione salvifica capitale o di preminenza che il Cristo riveste nei confronti di tutte le creature, principio inseparabile da quello della perfezione dell umanità assunta dal Verbo incarnato 31, si deve dire che è presente in lui il privilegio della scienza infusa: sarebbe inconcepibile che quel privilegio che sarebbe stato concesso a qualche uomo fosse assente in Gesù. Si tratta di una scienza soprannaturale che permette di conoscere le cose direttamente in se stesse, a differenza della scienza beatifica, che le percepisce solo attraverso la visione dell essenza divina. Da ultimo, Tommaso afferma l esistenza di una scienza sperimentale e progressiva nel Cristo. 4. La ragione formale della visione beatifica del Cristo Faremo ora riferimento all artico di L. Iammarrone 32 sulla ragione formale della visione beatifica del Cristo pre-pasquale perché ci pare colga il nocciolo del pensiero dell Aquinate, cercheremo qui di riassumere l articolo e nei passaggi centrali faremo parlare l autore stesso. Iammarrone prende inizialmente in considerazione l unione ipostatica per S. Tommaso e la definisce come la «comunicazione dell essere personale del Verbo alla natura assunta, la quale non è attuata dal proprio atto d essere, ma da quello del Verbo per cui esiste non in se stessa ma nel Verbo 28 Solutio II: «Et quia anima Christi perfectissimae inter creaturas Verbum intuetur, ad terminum hujus cognitionis pervenit, scilicet quod scit omnia quae fuerunt vel erunt, non solum facta, sed cogitata vel dicta. Et quia comprehendit quamlibet essentiam creatam, ideo scit omnia quae sunt in potentia seminali creaturae cujuscumque, eo modo quo Deus scit quae sunt in potentia sua. Sic ergo dicendum est, quod videt in Verbo omina quae videt Verbum scientia visioneis». 29 Solutio III. 30 «L uomo è in potenza alla scienza dei beati che consiste nella visione di Dio ed è destinato ad essa come a suo fine, essendo la creatura razionale, fatta com è a immagine di Dio, capace di quella conoscenza beata. Ma gli uomini giungono a questo fine della felicità per mezzo della umanità di Cristo, secondo l Apostolo era giusto che colui per il quale e per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, avendo condotto alla gloria molti figli, elevasse alla perfezione con le sofferenze l autore della loro salvezza (Eb. 2,10). Perciò era necessario che la conoscenza consistente nella visione di Dio fosse in Cristo nella maniera più eccellente» (S. Th., q. 9, a. 3, corp.). 31 De veritate, q. 20, a P. L. Iammarrone, La ragione formale della visione beatifica del Cristo pre-pasquale secondo S. Tommaso, in: Studi Tomistici 13 (1981),
9 dal quale è personificata» 33, notando come sia l essere, l atto d essere l elemento costitutivo del supposito 34. L autore prende ora in considerazione la natura del Cristo, umana e divina, ed afferma: «Ora se la natura umana di Cristo avesse il suo essere proprio distinto da quello del Verbo, l unione ipostatica sarebbe impossibile; ci sarebbero infatti due persone o due soggetti fisici: il Verbo da una parte, e l uomo Cristo, dall altra. Cristo non sarebbe uno, ma diviso. Se nell uomo le diverse parti esistono, non in virtù del loro essere proprio, che non hanno, ma in virtù dell unico essere sostanziale, cioè del tutto, anche in Cristo la natura umana deve essere non in virtù del suo essere che non ha, ma in virtù del suo essere personale del Verbo che lo supplisce e per conseguenza al Verbo in quanto esiste nella natura umana non sopraggiunge un nuovo essere personale, ma soltanto una nuova relazione dell essere personale preesistente alla natura umana, in modo che quella persona è detta sussistere non solo secondo la natura divina, ma anche secondo la natura umana 35 L unione ipostatica non è di ordine dinamico, ma di ordine ontologico-ipostatico» 36. Ora prende in considerazione l unione ipostatica nel suo aspetto psicologico ed afferma che tale unità «implica innanzitutto l unità ontologica del medesimo in base al principio: operari sequitur esse Ma in che modo, il Verbo secondo S. Tommaso si conosce Dio e uomo ad un tempo?» 37. Anche Iammarrone fa notare come S. Tommaso inizi a riflettere dal dogma calcedonese ed afferma: «possedendo due nature intellettuali, Cristo si deve conoscere secondo l una e l altra natura. Mediante l intelletto divino si conosce infinitamente nella natura divina e nel suo essere personale divino, relativo all essere personale del Padre e a quello dello Spirito Santo, ma si conosce pure in quanto attua terminativamente la natura assunta per cui il suo io espresso dall intelletto divino o coscienza divina, abbraccia la sua personalità divina in se stessa e in quanto termina la natura assunta 38. Parimenti Cristo si deve conoscere nella sua condizione ontologico-ipostatica anche mediante la scienza umana o creata, altrimenti si troverebbe in uno stato di totale ignoranza e del tutto inutile sarebbe l incarnazione, l assunzione di una natura umana, cioè razionale» 39. Occorre considerare ora però come l assunzione della natura umana sia come «una introduzione nella filiazione naturale» 40, che consiste nell esprimere «in una identità infinitamente perfetta (quindi numerica) l essere stesso del Padre», costituzionalmente il Verbo è l immagine perfetta del Padre. 33 Ibid., «Tale immagine, realtà perfettamente personale, allorché si comunica ipostaticamente all umanità assunta non può non imprimere nella medesima la sua caratteristica ipostatica, per cui questa deve ripercuotersi coscienzialmente nella sfera intellettiva dell umanità assunta. L unione ipostatica avviene tra due nature intellettuali e non già tra due nature inerti, prive di vita e pertanto la presenza personale dell immagine del Padre deve produrre nella sfera coscienziale dell umanità assunta una percezione o esperienza creata dalla sua Realtà increata di Verbo» Quodl. 9, a. 3, ad 2: «esse est id in quo fundatur unitas suppositi»; S. Th.III, q. 19, a. 1, ad 4: «Esse pertinet ad ipsam constitutionem personae». 35 S. Th. III, q. 17, a L. Iammarrone, Ibid., In III Sent. d. 14, q. 1, a. 1. sol. I et sol V; S. Th. III, q. 9, a L. Iammarrone, S. Tommaso, In Ep. ad Hebr. c. I. lect. 3: «assumptio enim importat motum infiliationem». 41 L. Iammarrone,
10 Qui l autore propone un passo di S. Tommaso in cui si evince la eccezionale capacità intellettuale dell Angelico nel comprendere contemplando il mistero stesso di Dio: «Dove è presente la realtà in se stessa non è necessaria la sua immagine per farne le veci L immagine e la cosa sono però necessariamente simultanei quando l immagine risulta dalla presenza stessa della cosa: come l impronta nella cera viene impressa dal sigillo e l immagine di un uomo in uno specchio si ha quando egli è presente. Allo stesso modo dunque l unione del Verbo di Dio con la mente umana era necessaria per il perfezionamento di quest ultima» 42. L autore continua commentando il passo dell Angelico: «Il Verbo con l incarnazione è presente con la sua realtà personale nella natura assunta e pertanto la sua immagine o ripercussione creata in tale natura non è richiesta per supplire la presenza stessa della Persona del Verbo. Tuttavia l immagine o ripercussione coscienziale creata dalla Persona del Verbo nella natura assunta è richiesta perché essa possa essere realizzata dalla stessa presenza della Persona del Verbo. Come infatti l immagine dell uomo nello specchio è realizzata dalla presenza stessa dell uomo davanti allo specchio e tale immagine è reale fino a quando l uomo rimane davanti allo specchio, così la ripercussione coscienziale della Persona del Verbo nella umanità assunta rimane fino a quando il Verbo termina ipostaticamente tale umanità, cioè sempre. Infatti; il Verbo presente nella sua umanità non può impedire che la sua realtà personale vi si rifletta e che quindi Egli nella sua umana coscienza avverta la presenza sostanziale della sua stessa Realtà personale. Il Verbo con la coscienza umana non può avvertire, percepire la presenza di un soggetto umano possessore della natura umana, perché tale soggetto non c è affatto» 43. In S. Tommaso quindi non si ammette un me umano che si riconosca divino, ma «la coscienza creata di Sé da parte del Verbo nella sua umana coscienza è la ripercussione metafisicamente necessaria della sua presenza ipostatica» ed è necessaria al fine della Rivelazione del mistero di Dio che si comunica all uomo per partecipargli la vita divina. Allora si comprende perché l unione ipostatica esiga naturalmente la visione beatifica, infatti la natura umana è propriamente del Verbo perché è tratta ad esistere dall essere personale del Verbo nella Persona del Verbo, quindi l anima in quanto forma corporis è soggetta all agire naturale, ma in quanto imago Dei nella sua condizione esistenziale dipende dalla Persona del Verbo, il Verbo comunica la propria personalità alla sua anima razionale, e quindi anche al suo corpo. Occorre sottolineare la singolarità dell anima del Cristo: lei sfugge alle leggi del condizionamento del corpo, possiede un sovrappiù, che si ripercuote nella sfera anche conoscitiva. «Il Verbo mediante la sua anima razionale è in grado di conoscersi in quanto Verbo incarnato, suppositante, personalizzante non solo l anima razionale, ma anche il corpo di cui essa è forma. Posta davanti a Dio Verbo l anima di Cristo si trova perciò stesso sommamente attualizzata anche nella sua attività conoscitiva, immune dal divenire, dalla dipendenza nell ordine della sussistenza, l anima di Cristo è anche immune dal condizionamento e dal divenire nell ordine della conoscenza della Persona del Verbo. L anima di Cristo nella sua sommità, o apice, si trova in immediato e diretto contatto con la persona del Verbo ed è di conseguenza beata e impeccabile il Verbo e l anima da lui assunta superano tale distanza nella linea dell ipostasi, in quanto una è l ipostasi e della natura divina posseduta mediante la relazione di filiazione e della natura umana attuata dalla medesima relazione» S. Th. III, q. 5, a. 4, ad L. Iammarrone, Ibid.,
11 Nell apice dell anima avviene il contatto conoscitivo immediato e qui si gode della conoscenza e visione del Verbo, questo va inserito nella sfera naturale perché solo la visione beatifica è attuazione perfetta del conoscere umano: nel Cristo avviene tale visione a motivo della sua appartenenza alla persona divina del Verbo. Iammarrone può quindi così affermare che «in quanto l anima di Cristo conosce il Verbo mediante la scienza beata abbiamo l autocoscienza umana del Verbo, il quale mediante la sua anima umana si conosce come il Soggetto o Persona dell intera natura assunta» 45. Il pensiero di alcuni teologi del sec. XX Fino ad una teologia abbastanza recente, l impostazione sistematica circa la scienza di Cristo si presentava secondo termini esclusivamente oggettivi, senza alcuna attenzione alla coscienza: la questione era di sapere che cosa Cristo conoscesse e secondo quali livelli di perfezione intellettuale; si distinguevano infatti ancora nella manualistica tre tipi di scienza: di visione, infusa e sperimentale. Il criterio seguito era quello della perfezione, dell eccellenza di Cristo rispetto agli altri uomini, e dal momento che la perfezione del Verbo incarnato era così manifesta doveva quindi comportare una conoscenza il più possibile perfetta. Il quadro comprensibile era sensibilmente diverso da quello che la Sacra Scrittura ci presentava: si ha qui piuttosto l impressione di trovarsi di fronte ad un uomo pienamente inserito nel suo ambiente, con un determinato tipo di cultura e di mentalità, la cui conoscenza si va progressivamente costruendo e non appare invece che si cerchi di estendere il più possibile il confine della sua conoscenza privilegiando quei mezzi elevati come la visione e la scienza infusa 46. Un rinnovato contatto con le fonti bibliche e lo studio della Scrittura con il metodo storicocritico iniziarono a mettere in crisi la sistemazione abituale: l orientamento consisteva nel superare la scienza della visione e quella infusa per una loro nuova reinterpretazione, ma il timore era che mettendo in discussione la visione classica della scienza di Cristo si arrivasse a compromettere la sua coscienza di messianicità e filiazione divina 47. Inoltre la tendenza critica nei confronti della visione tradizionale rappresentava una radicale novità rispetto a tutto quell orientamento di pensiero sorto in età patristica e consolidatosi poi nella scolastica e definitivamente nel manuale, secondo il quale, riflettendo a partire dalla controversa agnoeta 48 (sec. VI-VII) doveva essere respinto decisamente 45 Ibid., J. Galot osservava in proposito: «I teologi medioevali hanno conservato il principio che assegna alla scienza di Cristo la più alta perfezione possibile e l estensione più universale. Da questo principio è derivata l affermazione della scienza beatifica, e poi l aggiunta della scienza infusa, tanto che il genere di conoscenza che avrebbe dovuto essere affermato in primo luogo, quello della scienza acquisita o sperimentale, non è stato considerato che in seguito agli altri e ammesso più difficilmente. Sarebbe stato necessario procedere in modo inverso: piuttosto che porre a priori modelli perfetti di scienza che dovevano verificarsi in Cristo, si sarebbe dovuto partire dalla testimonianza evangelica sulle conoscenze realmente manifestate da Gesù, tenendo cont o del principio della incarnazione È l uomo concreto, quale è vissuto tra gli uomini, il solo punto di partenza valido per la nostra riflessione sulle sue conoscenze». (J. Galot, Chi sei tu, o Cristo?, 319, Firenze 1977). 47 Cfr. E. Poulat, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, Paris 1962; C. Porro, La controversia cristologica nel periodo, Venegono Inf. 1971; M. Serenthà, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre, Torino Il Diacono Temistio di Alessandria insegnava che il Cristo non solo ha sopportato le debolezze corporali, ma ha anche sofferto quelle dello spirito, perciò fu soggetto a ignoranza come ogni uomo. Gregorio Magno condannò l errore in una lettera indirizzata al patriarca Eulogio di Alessandria nel 600 affermando: «Intorno a ciò, che è scritto che né il Figlio dell uomo né gli angeli conoscono il giorno e l ora è da riferirsi senz altro non allo stesso Figlio in quanto è capo, ma secondo il suo corpo, che siamo noi. il Figlio onnipotente dice di non conoscere il giorno che non fa conoscere, non perché egli non lo conosca, ma perché non permette affatto che venga conosciuto. Onde si dice anche che il Padre solo lo conosce, giacché il Figlio lui consustanziale, dalla sua natura, per la quale è sopra gli angeli, ha di sapere ciò che gli angeli ignorano. Per cui l Unigenito incarnato e fattosi perfetto uomo per noi nella natura dell umanità conosceva il giorno e l ora del giudizio, tuttavia lo conosceva non dalla natura dell umanità. Ciò dunque che conosceva in essa, non lo conosceva da essa, poiché il Dio fatto uomo conosceva il giorno e l ora del giudizio mediante la potenza della sua divinità.» [DS ]. 11
12 ogni tentativo rivolto a limitare l universalità della scienza del Verbo incarnato. Su questo sfondo va poi ad installarsi la crisi modernista e l intervento del S. Uffizio del 1918 dove si afferma che non possono essere insegnate con certezza (tuto doceri non possint) tali affermazioni: «1. Non è certo che nell anima di Cristo, mentre viveva fra gli uomini, ci fosse la conoscenza che hanno i beati, quelli cioè che hanno la visione beatifica. 2. Non si può dire certa la sentenza che ritiene che l anima di Cristo non abbia ignorato nulla, ma che fin dall inizio abbia conosciuto nel Verbo tutte le cose, le passate, le presenti e le future, cioè tutte le cose che Dio sa per la conoscenza della visione. 3. L opinione di alcuni più recenti riguardo alla conoscenza limitata dell anima di Cristo 49». La riflessione quindi continuò e rifiorì particolarmente nel periodò che va dal 1937 al 1965 con numerosi articoli che studiavano il problema della unità psicologica del Cristo: «alcuni sostenevano la necessità della visione beatifica in Cristo per spiegare la sua autocoscienza personale; altri la ritenevano non necessaria, essendo sufficienti alla soluzione del problema, l unione ipostatica, quale fondamento ontologico, e i doni o carismi soprannaturali (l esperienza mistica) quale mezzo gnoseologico». A questo punto la questione si presentava in questi termini: «nella psicologia umana di Cristo c era un processo conoscitivo diverso dalla visione beatifica che gli permettesse di conoscere la propria divina personalità?» 50 e portò all intervento di alcuni teologi, di cui ora cercheremo di riassumere il pensiero. P. Galtier Il P. Galtier si è sforzato di determinare sistematicamente il contenuto della coscienza umana del Cristo e di chiarire il suo rapporto con la persona divina del Verbo 51. Egli parte dal principio che non si possono identificare persona e coscienza di sé, ammettendo la quale si è costretti ad affermare una sola coscienza in Cristo, ma poiché la persona non è definita dalla coscienza, non vi è difficoltà ad affermare una coscienza umana nel Cristo, pur mantenendo l unità della persona divina. Galtier analizza l atto di coscienza e dichiara che tale atto «procede direttamente e formalmente dalla natura in quanto tale la natura che percepisce se stessa presente nei suoi atti è la natura che, propriamente parlando, vi si riflette e vi è direttamente raggiunta» 52 : la coscienza procede dunque dalla natura e si porta verso la natura come verso il suo oggetto. Occorre ugualmente non identificare l io con la persona, nell esperienza psicologica troviamo un me: che risponde ai fenomeni della vita psichica, alle impressioni, agli stati d animo «percepiti come succedentisi in noi»; ed un io: percepito come «il principio attivo ed unificatore» 53. Il me e l io sono percepiti simultaneamente dalla coscienza, il me si presenta ad essa come oggetto di conoscenza, mentre l io le appare come il soggetto che conosce. Oltre a questo io e me psicologico occorre ammettere un io ed un me profondi, sostanziali, percepibili come immutabili e fissi sotto i vari flussi delle attività coscienti. Si giunge così a dover considerare il caso di Cristo per il quale bisogna, secondo l autore, riconoscere un io umano empirico. Il Cristo non sarebbe veramente uomo se non avesse avuto degli 49 Decreto del S. Uffizio, 5 giugno [DS ]. 50 L. Iammarrone, Il testo in cui attingeremo la teoria dell autore sarà: P. Galtier, L unité du Christ, Etre Personne Conscience, Paris 1939; Id, La conscience humaine du Christ à propos de quelques pubblications récentes, in: Gregorianum 32 (1951), ; Id, La conscience humaine du Christ. Epilogue, in: Gregorianum 35 (1954), ; secondariamente faremo riferimento ad altri testi che riportano la posizione del Galtier presenti in bibliografia. 52 Id, L unité du Christ, Etre Personne Conscience, Ibid., 339 s. 12
13 stati di coscienza unificantisi in un io fenomenico, ma bisogna allo stesso modo riconoscergli un io umano sostanziale, perché i due sono inseparabili: la psicologia umana del Cristo «sarebbe falsa se il suo io superficiale ed empirico non avesse la sua radice e il suo punto di attacco in un io profondo dello stesso ordine» 54. Questo io sostanziale non è d altronde in realtà che la natura umana, poiché la coscienza procede dalla natura ed ha per oggetto la natura, così questo io umano è quello che ritroviamo nel Vangelo e che si esprime in quei discorsi in cui il Cristo usa la prima persona. Riconoscendo un io o un me umano sostanziale «non si fa che enunciare in termini psicologici quello di cui la fede ci assicura la presenza del Cristo: una natura umana che agisce e si manifesta come la nostra, riflettendosi dunque nella sua coscienza ed esprimendosi nell io o nel me che esce dalle sue labbra» 55. Questo io umano sostanziale, considerato in se stesso, è simile a quello degli altri uomini: «in se stesso, niente lo distingue da quel che sarebbe in una persona umana» 56, proprio come la natura, tuttavia questo io non è una persona, perché la natura umana del Cristo non è una persona. Così appare l autonomia della psicologia umana del Cristo: nella coscienza umana, niente di divino traspare direttamente, persino l unione ipostatica le sfugge, ma l autore si affretta ad affermare come tale autonomia psicologica non sia accompagnata da quella ontologica, perché su tale piano vi è dipendenza totale, assoluta: la natura umana del Cristo, fin nel suo essere più profondo, è proprietà del Verbo. La dipendenza ontologica però non porta il Verbo a determinare l agire umano modificandone le strutture (sempre secondo il dogma calcedonese), ma semplicemente si appropria di una attività di cui la natura umana resta il solo principio formale e che non ne diviene dunque modificata in alcunché dalla unione ipostatica. Quando il Verbo governa e dirige l attività umana non lo fa «a titolo dell unione personale» con essa, perché altro è l unione ed altro il movimento impresso alla natura presa in mano come strumento dal Verbo. A differenza dell unione che termina nella persona, il movimento deriva dalla natura divina ed è dunque comune alla tre persone divine: «Il Verbo, solo a possedere lo strumento che si è unito, non è solo e non potrebbe essere solo a muoverlo. Gli impulsi che gli comunica vengono anche dal Padre e dallo Spirito Santo. Anzi, è al Padre stesso che essi sono costantemente attribuiti. È il Padre che consegna suo Figlio alla morte e l invita ad accettarla» 57. La visione del Galtier venne a modificarsi successivamente alla controversia aperta con il P. Parente e così mentre nel suo libro aveva ammesso l esistenza di un me empirico e di un me o di un io sostanziale, nei suoi articoli successivi negò l esistenza di un io ontologico umano 58 e riferì l io alla persona divina 59 in modo da distinguere i me psicologici umani nel Cristo come in ogni uomo, ma così mostrando diversi me psicologici in una persona. In sintesi possiamo notare come il Galtier distinse tra un io psicologico, cioè la coscienza umana di Gesù, che con le sole sue forze è capace di raggiungere solo quell io umano che scaturisce dalla natura umana e che in Cristo non è persona, e un io metafisico, che è invece la persona vera e propria, e che in Cristo, trattandosi della persona del Verbo, può essere raggiunto dalla sua coscienza umana solamente attraverso la conoscenza derivante dalla visione beatifica; dove è da sottolineare che questa tende a divenire semplicemente visione immediata di Dio e non visione beatifica di status 54 Ibid., Ibid., Ibid., Id, La conscience humaine du Christ, in: Gregorianum 32 (1951), Ibid., Id., La conscience humaine du Christ. Epilogue, in: Gregorianum 35 (1954),
Spinoza e il Male. Saitta Francesco
 Spinoza e il Male di Saitta Francesco La genealogia del male è sempre stato uno dei problemi più discussi nella storia della filosofia. Trovare le origini del male è sempre stato l oggetto principale di
Spinoza e il Male di Saitta Francesco La genealogia del male è sempre stato uno dei problemi più discussi nella storia della filosofia. Trovare le origini del male è sempre stato l oggetto principale di
Cap. 1 PUSC. Giulio Maspero I anno, I sem (ver. 2006-7)
 Cap. 1 1) Qual è il trattato più importante del mondo? 2) Perché questa disciplina ha subito un eclissi? 3) Perché si parla di Mistero della Trinità? Si può capire la Trinità? Cos è l apofatismo? 4) Cosa
Cap. 1 1) Qual è il trattato più importante del mondo? 2) Perché questa disciplina ha subito un eclissi? 3) Perché si parla di Mistero della Trinità? Si può capire la Trinità? Cos è l apofatismo? 4) Cosa
La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà
 La Dignità L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà Essa pone la persona al centro delle sue azioni istituendo la cittadinanza dell Unione e
La Dignità L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà Essa pone la persona al centro delle sue azioni istituendo la cittadinanza dell Unione e
#Essere umani. Scuola Statale Primaria di Foglizzo Istituto Comprensivo di Montanaro (To)
 #Essere umani Progetto realizzato dall insegnante di Religione Cattolica Elsa Feira con la collaborazione delle docenti Donatella Gravante, Dolores Chiantaretto, Daniela Milanaccio, Paola Racca. Scuola
#Essere umani Progetto realizzato dall insegnante di Religione Cattolica Elsa Feira con la collaborazione delle docenti Donatella Gravante, Dolores Chiantaretto, Daniela Milanaccio, Paola Racca. Scuola
I libri di testo. Carlo Tarsitani
 I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
La ricerca empirica in educazione
 La ricerca empirica in educazione Alberto Fornasari Docente di Pedagogia Sperimentale Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione Il ricercatore ha il compito di trovare relazioni
La ricerca empirica in educazione Alberto Fornasari Docente di Pedagogia Sperimentale Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione Il ricercatore ha il compito di trovare relazioni
APPUNTI DI MATEMATICA LE FRAZIONI ALGEBRICHE ALESSANDRO BOCCONI
 APPUNTI DI MATEMATICA LE FRAZIONI ALGEBRICHE ALESSANDRO BOCCONI Indice 1 Le frazioni algebriche 1.1 Il minimo comune multiplo e il Massimo Comun Divisore fra polinomi........ 1. Le frazioni algebriche....................................
APPUNTI DI MATEMATICA LE FRAZIONI ALGEBRICHE ALESSANDRO BOCCONI Indice 1 Le frazioni algebriche 1.1 Il minimo comune multiplo e il Massimo Comun Divisore fra polinomi........ 1. Le frazioni algebriche....................................
«Il Padre vi darà un altro Paraclito»
 LECTIO DIVINA PER LA VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO A) Di Emio Cinardo «Il Padre vi darà un altro Paraclito» Gv 14,15-21 Lettura del testo Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) In quel tempo, Gesù disse
LECTIO DIVINA PER LA VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO A) Di Emio Cinardo «Il Padre vi darà un altro Paraclito» Gv 14,15-21 Lettura del testo Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) In quel tempo, Gesù disse
I SIGNIFICATI DEL TERMINE CHIESA.
 LA NASCITA DELLA CHIESA (pagine 170-177) QUALI SONO LE FONTI PER RICOSTRUIRE LA STORIA DELLA CHIESA? I Vangeli, gli Atti degli Apostoli le Lettere del NT. (in particolare quelle scritte da S. Paolo) gli
LA NASCITA DELLA CHIESA (pagine 170-177) QUALI SONO LE FONTI PER RICOSTRUIRE LA STORIA DELLA CHIESA? I Vangeli, gli Atti degli Apostoli le Lettere del NT. (in particolare quelle scritte da S. Paolo) gli
Teorie Etiche - Kant
 Teorie Etiche - Kant Gianluigi Bellin January 27, 2014 Tratto dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy online alle voce Kant s Moral Philosophy. La filosofia morale di Immanuel Kant Immanuel Kant, visse
Teorie Etiche - Kant Gianluigi Bellin January 27, 2014 Tratto dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy online alle voce Kant s Moral Philosophy. La filosofia morale di Immanuel Kant Immanuel Kant, visse
Pareto (1848-1923) Si oppone alla teoria positivista di Comte per essere andato al di là dei limiti della scienza empirica
 Pareto (1848-1923) Si oppone alla teoria positivista di Comte per essere andato al di là dei limiti della scienza empirica Si rifà alla concezione ciclica della storia, formata da fasi alterne che si ripetono
Pareto (1848-1923) Si oppone alla teoria positivista di Comte per essere andato al di là dei limiti della scienza empirica Si rifà alla concezione ciclica della storia, formata da fasi alterne che si ripetono
LA BIBBIA. composto da 46 libri, suddivisi in Pentateuco Storici Sapienziali Profetici 5 16 7 18
 GRUPPOQUINTAELEMENTARE Scheda 02 LA La Parola di Dio scritta per gli uomini di tutti i tempi Antico Testamento composto da 46 libri, suddivisi in Pentateuco Storici Sapienziali Profetici 5 16 7 18 Nuovo
GRUPPOQUINTAELEMENTARE Scheda 02 LA La Parola di Dio scritta per gli uomini di tutti i tempi Antico Testamento composto da 46 libri, suddivisi in Pentateuco Storici Sapienziali Profetici 5 16 7 18 Nuovo
Anno 2004/2005 CORSO SNES-CSI PER FORMATORI. Bologna, 3 dicembre 2005. Lara Rossin
 Anno 2004/2005 LA FIGURA DEL FORMATORE CSI -LE SUE PECULIARITÀ E LA SUA MISSION- CORSO SNES-CSI PER FORMATORI Bologna, 3 dicembre 2005 Lara Rossin 1 INTRODUZIONE Non si insegna e non si può insegnare,
Anno 2004/2005 LA FIGURA DEL FORMATORE CSI -LE SUE PECULIARITÀ E LA SUA MISSION- CORSO SNES-CSI PER FORMATORI Bologna, 3 dicembre 2005 Lara Rossin 1 INTRODUZIONE Non si insegna e non si può insegnare,
Siamo così arrivati all aritmetica modulare, ma anche a individuare alcuni aspetti di come funziona l aritmetica del calcolatore come vedremo.
 DALLE PESATE ALL ARITMETICA FINITA IN BASE 2 Si è trovato, partendo da un problema concreto, che con la base 2, utilizzando alcune potenze della base, operando con solo addizioni, posso ottenere tutti
DALLE PESATE ALL ARITMETICA FINITA IN BASE 2 Si è trovato, partendo da un problema concreto, che con la base 2, utilizzando alcune potenze della base, operando con solo addizioni, posso ottenere tutti
Apporti, Asporti e Regali
 Apporti, Asporti e Regali Collana: Ali d Amore N. 9 A Dilaila e alle anime candide dell Altra Dimensione A P P O R T I Gli apporti sono materializzazioni di oggetti, di animali, di piante o fiori, che
Apporti, Asporti e Regali Collana: Ali d Amore N. 9 A Dilaila e alle anime candide dell Altra Dimensione A P P O R T I Gli apporti sono materializzazioni di oggetti, di animali, di piante o fiori, che
Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni
 Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare
Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare
VANGELO SECONDO GIOVANNI PROF. CARLO RUSCONI ANNO ACCADEMICO 2012-2013
 VANGELO SECONDO GIOVANNI PROF. CARLO RUSCONI ANNO ACCADEMICO 2012-2013 1. VANGELO SECONDO GIOVANNI LEZIONE DEL 21-09-2012 ARGOMENTI: a. Introduzione al corso; i. Il Vangelo di Giovanni parla di che cos
VANGELO SECONDO GIOVANNI PROF. CARLO RUSCONI ANNO ACCADEMICO 2012-2013 1. VANGELO SECONDO GIOVANNI LEZIONE DEL 21-09-2012 ARGOMENTI: a. Introduzione al corso; i. Il Vangelo di Giovanni parla di che cos
Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica. xiv legislatura disegni di legge e relazioni documenti
 Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 450 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 451 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 452 Senato della Repubblica Camera dei
Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 450 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 451 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 452 Senato della Repubblica Camera dei
Antonella Martinucci, Rossana Nencini, 2013 IL PESO. classe quarta
 Antonella Martinucci, Rossana Nencini, 2013 IL PESO classe quarta I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti: penne matite gomme fogli scottex quaderni
Antonella Martinucci, Rossana Nencini, 2013 IL PESO classe quarta I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti: penne matite gomme fogli scottex quaderni
Capitolo II. La forma del valore. 7. La duplice forma in cui si presenta la merce: naturale e di valore.
 Capitolo II La forma del valore 7. La duplice forma in cui si presenta la merce: naturale e di valore. I beni nascono come valori d uso: nel loro divenire merci acquisiscono anche un valore (di scambio).
Capitolo II La forma del valore 7. La duplice forma in cui si presenta la merce: naturale e di valore. I beni nascono come valori d uso: nel loro divenire merci acquisiscono anche un valore (di scambio).
LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE
 Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA?
 Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA? Sac. Don Magloire Nkounga Dott. D Ambrosio Giuseppina 1 Quando ci possono
Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA? Sac. Don Magloire Nkounga Dott. D Ambrosio Giuseppina 1 Quando ci possono
f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da
 Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
Curricolo di Religione Cattolica
 Curricolo di Religione Cattolica Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria - L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù
Curricolo di Religione Cattolica Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria - L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù
Cittadinanza e Costituzione
 Cittadinanza e Costituzione Anno Scolastico 20010/11 Progetto di Cittadinanza e Costituzione Finalità Essere cittadini di un mondo in continuo cambiamento ha come premessa il conoscere e il porre in atto
Cittadinanza e Costituzione Anno Scolastico 20010/11 Progetto di Cittadinanza e Costituzione Finalità Essere cittadini di un mondo in continuo cambiamento ha come premessa il conoscere e il porre in atto
Salvatore Salamone. Manuale d istruzione per. Coppie che. Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE! ... tutto sommato un libro d amore
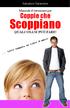 Salvatore Salamone Manuale d istruzione per Coppie che Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE!... tutto sommato un libro d amore CAPITOLO 18 Voler avere ragione Spesso le coppie incontrano delle barriere insormontabili
Salvatore Salamone Manuale d istruzione per Coppie che Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE!... tutto sommato un libro d amore CAPITOLO 18 Voler avere ragione Spesso le coppie incontrano delle barriere insormontabili
IL SISTEMA INFORMATIVO
 LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI
LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI
LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE
 LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE La sequenza costituisce un esempio di SUCCESSIONE. Ecco un altro esempio di successione: Una successione è dunque una sequenza infinita di numeri reali (ma potrebbe
LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE La sequenza costituisce un esempio di SUCCESSIONE. Ecco un altro esempio di successione: Una successione è dunque una sequenza infinita di numeri reali (ma potrebbe
Alessandro Ricci Psicologo Psicoterapeuta Università Salesiana di Roma
 Alessandro Ricci Psicologo Psicoterapeuta Università Salesiana di Roma LA COPPIA NON PUO FARE A MENO DI RICONOSCERE E ACCETTARE CHE L ALTRO E UN TU E COME TALE RAPPRESENTA NON UN OGGETTO DA MANIPOLARE
Alessandro Ricci Psicologo Psicoterapeuta Università Salesiana di Roma LA COPPIA NON PUO FARE A MENO DI RICONOSCERE E ACCETTARE CHE L ALTRO E UN TU E COME TALE RAPPRESENTA NON UN OGGETTO DA MANIPOLARE
Qui cade sua altezza
 Qui cade sua altezza Silvia Sbaragli N.R.D. Bologna DFA, SUPSI Locarno (Svizzera) Pubblicato in: Sbaragli S. (2010). Qui cade sua altezza. La Vita Scolastica. 18, 25-27. Nell insegnamento della matematica
Qui cade sua altezza Silvia Sbaragli N.R.D. Bologna DFA, SUPSI Locarno (Svizzera) Pubblicato in: Sbaragli S. (2010). Qui cade sua altezza. La Vita Scolastica. 18, 25-27. Nell insegnamento della matematica
O P E N S O U R C E M A N A G E M E N T PILLOLE DI TEST COMPRENSIONE. w w w. o s m v a l u e. c o m
 O P E N S O U R C E M A N A G E M E N T PILLOLE DI TEST COMPRENSIONE w w w. o s m v a l u e. c o m COMPRENSIONE (RELAZIONI) Qualità generale delle relazioni. Capacità della persona di costruirsi relazioni
O P E N S O U R C E M A N A G E M E N T PILLOLE DI TEST COMPRENSIONE w w w. o s m v a l u e. c o m COMPRENSIONE (RELAZIONI) Qualità generale delle relazioni. Capacità della persona di costruirsi relazioni
PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA
 PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA INDIVIDUAZIONE DEI TEMI/CONCETTI SELEZIONE DEI TEMI/CONCETTI ESPRESSIONE DEI CONCETTI NEL LINGUAGGIO DI INDICIZZAZIONE TIPI DI INDICIZZAZIONE SOMMARIZZAZIONE INDICIZZAZIONE
PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA INDIVIDUAZIONE DEI TEMI/CONCETTI SELEZIONE DEI TEMI/CONCETTI ESPRESSIONE DEI CONCETTI NEL LINGUAGGIO DI INDICIZZAZIONE TIPI DI INDICIZZAZIONE SOMMARIZZAZIONE INDICIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 1^ - sez. B
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 1^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 1^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
Sommario. Definizione di informatica. Definizione di un calcolatore come esecutore. Gli algoritmi.
 Algoritmi 1 Sommario Definizione di informatica. Definizione di un calcolatore come esecutore. Gli algoritmi. 2 Informatica Nome Informatica=informazione+automatica. Definizione Scienza che si occupa dell
Algoritmi 1 Sommario Definizione di informatica. Definizione di un calcolatore come esecutore. Gli algoritmi. 2 Informatica Nome Informatica=informazione+automatica. Definizione Scienza che si occupa dell
Sezione III. S. Scrittura
 Sezione III. S. Scrittura I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il Mistero di Dio nella Tradizione della Chiesa 2. Il Dio unico e trascendente nell Antico Testamento
Sezione III. S. Scrittura I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il Mistero di Dio nella Tradizione della Chiesa 2. Il Dio unico e trascendente nell Antico Testamento
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO
 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
FINESTRE INTERCULTURALI
 Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA FINESTRA INTERCULTURALE
Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA FINESTRA INTERCULTURALE
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Alla ricerca dell algoritmo. Scoprire e formalizzare algoritmi.
 PROGETTO SeT Il ciclo dell informazione Alla ricerca dell algoritmo. Scoprire e formalizzare algoritmi. Scuola media Istituto comprensivo di Fagagna (Udine) Insegnanti referenti: Guerra Annalja, Gianquinto
PROGETTO SeT Il ciclo dell informazione Alla ricerca dell algoritmo. Scoprire e formalizzare algoritmi. Scuola media Istituto comprensivo di Fagagna (Udine) Insegnanti referenti: Guerra Annalja, Gianquinto
Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I.
 Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I. Non esiste, al giorno d oggi, un parere unanime della comunità scientifica sulla definizione di intelligenza. In generale, potremmo dire che è
Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I. Non esiste, al giorno d oggi, un parere unanime della comunità scientifica sulla definizione di intelligenza. In generale, potremmo dire che è
risulta (x) = 1 se x < 0.
 Questo file si pone come obiettivo quello di mostrarvi come lo studio di una funzione reale di una variabile reale, nella cui espressione compare un qualche valore assoluto, possa essere svolto senza necessariamente
Questo file si pone come obiettivo quello di mostrarvi come lo studio di una funzione reale di una variabile reale, nella cui espressione compare un qualche valore assoluto, possa essere svolto senza necessariamente
Lo Spirito nei nostri cuori. Dalla catechesi del papa Benedetto XVI
 Lo Spirito nei nostri cuori Dalla catechesi del papa Benedetto XVI Lo Spirito Santo presente nella nostra vita San Paolo non si ferma ad illustrare soltanto la dimensione dinamica e operativa della terza
Lo Spirito nei nostri cuori Dalla catechesi del papa Benedetto XVI Lo Spirito Santo presente nella nostra vita San Paolo non si ferma ad illustrare soltanto la dimensione dinamica e operativa della terza
GIANLUIGI BALLARANI. I 10 Errori di Chi Non Riesce a Rendere Negli Esami Come Vorrebbe
 GIANLUIGI BALLARANI I 10 Errori di Chi Non Riesce a Rendere Negli Esami Come Vorrebbe Individuarli e correggerli 1 di 6 Autore di Esami No Problem 1 Titolo I 10 Errori di Chi Non Riesce a Rendere Negli
GIANLUIGI BALLARANI I 10 Errori di Chi Non Riesce a Rendere Negli Esami Come Vorrebbe Individuarli e correggerli 1 di 6 Autore di Esami No Problem 1 Titolo I 10 Errori di Chi Non Riesce a Rendere Negli
BATTESIMO: PROPOSTA DI ARTICOLI PER I REGOLAMENTI ECCLESIASTICI. Testi di riferimento. basati sulla posizione della FCES
 BATTESIMO: PROPOSTA DI ARTICOLI PER I REGOLAMENTI ECCLESIASTICI Testi di riferimento basati sulla posizione della FCES Il battesimo in prospettiva evangelica Osservazione preliminare I seguenti testi
BATTESIMO: PROPOSTA DI ARTICOLI PER I REGOLAMENTI ECCLESIASTICI Testi di riferimento basati sulla posizione della FCES Il battesimo in prospettiva evangelica Osservazione preliminare I seguenti testi
Dio, il mondo e il Big- -Bang
 Dio, il mondo e il Big- -Bang come parlare di Dio creatore ome ha fatto Dio a fare il Mondo? Dio, i miracoli e le leggi della natura DIO e il Mondo Dio, Adamo ed Eva, e l evoluzione Dio o il Big Bang?
Dio, il mondo e il Big- -Bang come parlare di Dio creatore ome ha fatto Dio a fare il Mondo? Dio, i miracoli e le leggi della natura DIO e il Mondo Dio, Adamo ed Eva, e l evoluzione Dio o il Big Bang?
Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni
 Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni 25.1: Introduzione In questo capitolo la teoria economica discussa nei capitoli 23 e 24 viene applicata all analisi dello scambio del rischio nel
Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle assicurazioni 25.1: Introduzione In questo capitolo la teoria economica discussa nei capitoli 23 e 24 viene applicata all analisi dello scambio del rischio nel
L uso e il significato delle regole (gruppo A)
 L uso e il significato delle regole (gruppo A) Regole organizzative: devono essere rispettare per far sì che la struttura possa funzionare e che si possa vivere in un contesto di rispetto reciproco; Regole
L uso e il significato delle regole (gruppo A) Regole organizzative: devono essere rispettare per far sì che la struttura possa funzionare e che si possa vivere in un contesto di rispetto reciproco; Regole
FINESTRE INTERCULTURALI
 Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia Anelia Cassai/lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA
Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia Anelia Cassai/lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA
L età dei vincitori La presenza femminile. L età dei vincitori La presenza femminile. Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
 Premessa Corso-concorso ordinario L età dei vincitori La presenza femminile Corso-concorso riservato L età dei vincitori La presenza femminile Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
Premessa Corso-concorso ordinario L età dei vincitori La presenza femminile Corso-concorso riservato L età dei vincitori La presenza femminile Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
CORSO VENDITE LIVELLO BASE ESERCIZIO PER L ACQUISIZIONE DEI DATI
 CORSO VENDITE LIVELLO BASE ESERCIZIO PER L ACQUISIZIONE DEI DATI 1. Vai a visitare un cliente ma non lo chiudi nonostante tu gli abbia fatto una buona offerta. Che cosa fai? Ti consideri causa e guardi
CORSO VENDITE LIVELLO BASE ESERCIZIO PER L ACQUISIZIONE DEI DATI 1. Vai a visitare un cliente ma non lo chiudi nonostante tu gli abbia fatto una buona offerta. Che cosa fai? Ti consideri causa e guardi
Capitolo 2. Operazione di limite
 Capitolo 2 Operazione di ite In questo capitolo vogliamo occuparci dell operazione di ite, strumento indispensabile per scoprire molte proprietà delle funzioni. D ora in avanti riguarderemo i domini A
Capitolo 2 Operazione di ite In questo capitolo vogliamo occuparci dell operazione di ite, strumento indispensabile per scoprire molte proprietà delle funzioni. D ora in avanti riguarderemo i domini A
Istituto Comprensivo Perugia 9
 Istituto Comprensivo Perugia 9 Anno scolastico 2015/2016 Programmazione delle attività educativo didattiche SCUOLA PRIMARIA Disciplina RELIGIONE CLASSE: PRIMA L'alunno: - Riflette sul significato dell
Istituto Comprensivo Perugia 9 Anno scolastico 2015/2016 Programmazione delle attività educativo didattiche SCUOLA PRIMARIA Disciplina RELIGIONE CLASSE: PRIMA L'alunno: - Riflette sul significato dell
Logica Numerica Approfondimento 1. Minimo Comune Multiplo e Massimo Comun Divisore. Il concetto di multiplo e di divisore. Il Minimo Comune Multiplo
 Logica Numerica Approfondimento E. Barbuto Minimo Comune Multiplo e Massimo Comun Divisore Il concetto di multiplo e di divisore Considerato un numero intero n, se esso viene moltiplicato per un numero
Logica Numerica Approfondimento E. Barbuto Minimo Comune Multiplo e Massimo Comun Divisore Il concetto di multiplo e di divisore Considerato un numero intero n, se esso viene moltiplicato per un numero
Project Cycle Management
 Project Cycle Management Tre momenti centrali della fase di analisi: analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli ambiti di intervento Il presente materiale didattico costituisce
Project Cycle Management Tre momenti centrali della fase di analisi: analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli ambiti di intervento Il presente materiale didattico costituisce
come nasce una ricerca
 PSICOLOGIA SOCIALE lez. 2 RICERCA SCIENTIFICA O SENSO COMUNE? Paola Magnano paola.magnano@unikore.it ricevimento: martedì ore 10-11 c/o Studio 16, piano -1 PSICOLOGIA SOCIALE COME SCIENZA EMPIRICA le sue
PSICOLOGIA SOCIALE lez. 2 RICERCA SCIENTIFICA O SENSO COMUNE? Paola Magnano paola.magnano@unikore.it ricevimento: martedì ore 10-11 c/o Studio 16, piano -1 PSICOLOGIA SOCIALE COME SCIENZA EMPIRICA le sue
Scopri il piano di Dio: Pace e vita
 Scopri il piano di : Pace e vita E intenzione di avere per noi una vita felice qui e adesso. Perché la maggior parte delle persone non conosce questa vita vera? ama la gente e ama te! Vuole che tu sperimenti
Scopri il piano di : Pace e vita E intenzione di avere per noi una vita felice qui e adesso. Perché la maggior parte delle persone non conosce questa vita vera? ama la gente e ama te! Vuole che tu sperimenti
LE PROPRIETÀ DEI METALLI E LA BOTTEGA DEL COLTELLINAIO DI SCARPERIA. Claudia Gurioli
 LE PROPRIETÀ DEI METALLI E LA BOTTEGA DEL COLTELLINAIO DI SCARPERIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI BARBERINO di MUGELLO 2014 Claudia Gurioli DA UN MUSEO DI OGGETTI AD UN MUSEO DI MATERIALI Discutendo
LE PROPRIETÀ DEI METALLI E LA BOTTEGA DEL COLTELLINAIO DI SCARPERIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI BARBERINO di MUGELLO 2014 Claudia Gurioli DA UN MUSEO DI OGGETTI AD UN MUSEO DI MATERIALI Discutendo
IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:
 IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti
IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti
CORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI
 CORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI I I figli crescono Primo incontro 25.11.06 La scuola superiore: l adolescente l tra scuola e famiglia Secondo incontro17.02.07 La relazione tra genitori e figli adolescenti:
CORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI I I figli crescono Primo incontro 25.11.06 La scuola superiore: l adolescente l tra scuola e famiglia Secondo incontro17.02.07 La relazione tra genitori e figli adolescenti:
I colloqui scuola-famiglia: le basi per una comunicazione efficace Dott.ssa Claudia Trombetta Psicologa e psicoterapeuta claudia.trombetta@email.
 I colloqui scuola-famiglia: le basi per una comunicazione efficace Dott.ssa Claudia Trombetta Psicologa e psicoterapeuta claudia.trombetta@email.it CTI Monza, 20 Novembre 2015 Prima parte: comprendere
I colloqui scuola-famiglia: le basi per una comunicazione efficace Dott.ssa Claudia Trombetta Psicologa e psicoterapeuta claudia.trombetta@email.it CTI Monza, 20 Novembre 2015 Prima parte: comprendere
PARTIAMO DA ALCUNE DOMANDE
 PARTIAMO DA ALCUNE DOMANDE Esiste l immagine del disabile intellettivo come persona adulta nella mia mente? Quali sono i maggiori ostacoli che i famigliari/ operatori incontrano nella costruzione di un
PARTIAMO DA ALCUNE DOMANDE Esiste l immagine del disabile intellettivo come persona adulta nella mia mente? Quali sono i maggiori ostacoli che i famigliari/ operatori incontrano nella costruzione di un
Da dove nasce l idea dei video
 Da dove nasce l idea dei video Per anni abbiamo incontrato i potenziali clienti presso le loro sedi, come la tradizione commerciale vuole. L incontro nasce con una telefonata che il consulente fa a chi
Da dove nasce l idea dei video Per anni abbiamo incontrato i potenziali clienti presso le loro sedi, come la tradizione commerciale vuole. L incontro nasce con una telefonata che il consulente fa a chi
Attività destinata a raccogliere e a catalogare documenti con l'obiettivo di farli conoscere e diffonderli.
 DOCUMENTAZIONE Attività destinata a raccogliere e a catalogare documenti con l'obiettivo di farli conoscere e diffonderli. Attività di elaborazione, raccolta, organizzazione e diffusione di documenti.
DOCUMENTAZIONE Attività destinata a raccogliere e a catalogare documenti con l'obiettivo di farli conoscere e diffonderli. Attività di elaborazione, raccolta, organizzazione e diffusione di documenti.
Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2)
 Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2) Riprendiamo l analisi interrotta nel corso della precedente lezione b) struttura dialogica del fatto educativo Per rispondere a criteri ermenutici, l
Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2) Riprendiamo l analisi interrotta nel corso della precedente lezione b) struttura dialogica del fatto educativo Per rispondere a criteri ermenutici, l
SCUOLA MARIA SS. DEL BUON CONSIGLIO Via delle Vigne Nuove, 104 ROMA ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI PROGETTO EDUCATIVO
 SCUOLA MARIA SS. DEL BUON CONSIGLIO Via delle Vigne Nuove, 104 ROMA ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI PROGETTO EDUCATIVO Anno scolastico 2014-2015 1 PREMESSA La SCUOLA CATTOLICA svolge la sua missione educativa
SCUOLA MARIA SS. DEL BUON CONSIGLIO Via delle Vigne Nuove, 104 ROMA ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI PROGETTO EDUCATIVO Anno scolastico 2014-2015 1 PREMESSA La SCUOLA CATTOLICA svolge la sua missione educativa
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO MUGELLO
 IL PESO percorso didattico scuola primaria Sperimentazione didattica ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO MUGELLO I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti:
IL PESO percorso didattico scuola primaria Sperimentazione didattica ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO MUGELLO I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di pesante? Collochiamo su un banco alcuni oggetti:
LE STRATEGIE DI COPING
 Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
PROCEDURA INVENTARIO DI MAGAZZINO di FINE ESERCIZIO (dalla versione 3.2.0)
 PROCEDURA INVENTARIO DI MAGAZZINO di FINE ESERCIZIO (dalla versione 3.2.0) (Da effettuare non prima del 01/01/2011) Le istruzioni si basano su un azienda che ha circa 1000 articoli, che utilizza l ultimo
PROCEDURA INVENTARIO DI MAGAZZINO di FINE ESERCIZIO (dalla versione 3.2.0) (Da effettuare non prima del 01/01/2011) Le istruzioni si basano su un azienda che ha circa 1000 articoli, che utilizza l ultimo
Rappresentazione grafica di entità e attributi
 PROGETTAZIONE CONCETTUALE La progettazione concettuale, ha il compito di costruire e definire una rappresentazione corretta e completa della realtà di interesse, e il prodotto di tale attività, è lo schema
PROGETTAZIONE CONCETTUALE La progettazione concettuale, ha il compito di costruire e definire una rappresentazione corretta e completa della realtà di interesse, e il prodotto di tale attività, è lo schema
Convegno GIOVANI E LAVORO Roma 13-15 ottobre 2008
 Convegno GIOVANI E LAVORO Roma 13-15 ottobre 2008 L Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro in collaborazione con il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile e l Ufficio Nazionale per l Educazione,
Convegno GIOVANI E LAVORO Roma 13-15 ottobre 2008 L Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro in collaborazione con il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile e l Ufficio Nazionale per l Educazione,
Dimensione di uno Spazio vettoriale
 Capitolo 4 Dimensione di uno Spazio vettoriale 4.1 Introduzione Dedichiamo questo capitolo ad un concetto fondamentale in algebra lineare: la dimensione di uno spazio vettoriale. Daremo una definizione
Capitolo 4 Dimensione di uno Spazio vettoriale 4.1 Introduzione Dedichiamo questo capitolo ad un concetto fondamentale in algebra lineare: la dimensione di uno spazio vettoriale. Daremo una definizione
PROGETTO ACCOGLIENZA Classi prime Anno scolastico 2012/2013
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA PROGETTO ACCOGLIENZA Classi prime Anno scolastico 2012/2013 1 Introduzione Il progetto accoglienza nasce dalla convinzione che i primi mesi di lavoro
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA PROGETTO ACCOGLIENZA Classi prime Anno scolastico 2012/2013 1 Introduzione Il progetto accoglienza nasce dalla convinzione che i primi mesi di lavoro
I modelli di qualità come spinta allo sviluppo
 I modelli di qualità come spinta allo sviluppo Paolo Citti Ordinario Università degli studi di Firenze Presidente Accademia Italiana del Sei Sigma 2005 1 Si legge oggi sui giornali che l azienda Italia
I modelli di qualità come spinta allo sviluppo Paolo Citti Ordinario Università degli studi di Firenze Presidente Accademia Italiana del Sei Sigma 2005 1 Si legge oggi sui giornali che l azienda Italia
63 7. Quale geometria per la computer grafica? 75 8. L omografia e l affinità nella digitalizzazione e georeferenziazione
 Indice 7 Presentazione 9 Premessa 11 Introduzione 13 1. Rilevamento ed oggetto 19 2. La stazione totale 23 3. La procedura generale 33 4. Dai punti al modello tridimensionale 45 5. Il modello tridimensionale
Indice 7 Presentazione 9 Premessa 11 Introduzione 13 1. Rilevamento ed oggetto 19 2. La stazione totale 23 3. La procedura generale 33 4. Dai punti al modello tridimensionale 45 5. Il modello tridimensionale
PSA: Laboratorio disciplinare di religione per gli insegnanti della scuola elementare
 PSA: Laboratorio disciplinare di religione per gli insegnanti della scuola elementare Sottogruppo coordinato da Fortunata Capparo (verbale 2 incontro - 18 /11 2002) L ispettore Gandelli ha iniziato l incontro
PSA: Laboratorio disciplinare di religione per gli insegnanti della scuola elementare Sottogruppo coordinato da Fortunata Capparo (verbale 2 incontro - 18 /11 2002) L ispettore Gandelli ha iniziato l incontro
DIMENSIONI CRITERI INDICATORI
 Allegato 4 - Manerbio META EDUCATIVA: autonomia in ambito scolastico (classe 4/5 scuola primaria) DIMENSIONI CRITERI INDICATORI GESTIONALE OPERATIVA Uso degli strumenti Conoscere gli strumenti necessari
Allegato 4 - Manerbio META EDUCATIVA: autonomia in ambito scolastico (classe 4/5 scuola primaria) DIMENSIONI CRITERI INDICATORI GESTIONALE OPERATIVA Uso degli strumenti Conoscere gli strumenti necessari
La propagazione delle onde luminose può essere studiata per mezzo delle equazioni di Maxwell. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è possibile
 Elementi di ottica L ottica si occupa dello studio dei percorsi dei raggi luminosi e dei fenomeni legati alla propagazione della luce in generale. Lo studio dell ottica nella fisica moderna si basa sul
Elementi di ottica L ottica si occupa dello studio dei percorsi dei raggi luminosi e dei fenomeni legati alla propagazione della luce in generale. Lo studio dell ottica nella fisica moderna si basa sul
IMMAGINANDO QUELLO CHE NON SI VEDE
 Laboratorio in classe: tra forme e numeri GRUPPO FRAZIONI - CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA Docenti: Lidia Abate, Anna Maria Radaelli, Loredana Raffa. IMMAGINANDO QUELLO CHE NON SI VEDE 1. UNA FIABA
Laboratorio in classe: tra forme e numeri GRUPPO FRAZIONI - CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA Docenti: Lidia Abate, Anna Maria Radaelli, Loredana Raffa. IMMAGINANDO QUELLO CHE NON SI VEDE 1. UNA FIABA
Capitolo 13: L offerta dell impresa e il surplus del produttore
 Capitolo 13: L offerta dell impresa e il surplus del produttore 13.1: Introduzione L analisi dei due capitoli precedenti ha fornito tutti i concetti necessari per affrontare l argomento di questo capitolo:
Capitolo 13: L offerta dell impresa e il surplus del produttore 13.1: Introduzione L analisi dei due capitoli precedenti ha fornito tutti i concetti necessari per affrontare l argomento di questo capitolo:
Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel
 Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Le funzioni Una funzione è un operatore che applicato a uno o più argomenti (valori, siano essi numeri con virgola, numeri interi, stringhe di caratteri) restituisce
Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Le funzioni Una funzione è un operatore che applicato a uno o più argomenti (valori, siano essi numeri con virgola, numeri interi, stringhe di caratteri) restituisce
PROGETTO REGIONALE MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE BIBLIOTECHE VENETE
 PROGETTO REGIONALE MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE BIBLIOTECHE VENETE Analisi dinamica dei dati dei questionari per le biblioteche di pubblica lettura. GLI INDICATORI Gli indicatori sono particolari rapporti
PROGETTO REGIONALE MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE BIBLIOTECHE VENETE Analisi dinamica dei dati dei questionari per le biblioteche di pubblica lettura. GLI INDICATORI Gli indicatori sono particolari rapporti
Ramón Lucas Lucas SPIEGAMI. la persona
 Ramón Lucas Lucas SPIEGAMI la persona 2012 Edizioni ART Titolo originale dell opera Explícame la persona 2ª edizione 2012 Via dei Del Balzo, 10-00165 ROMA Tel. 06 66 52 77 84 Fax 06 66 52 79 07 E- mail:
Ramón Lucas Lucas SPIEGAMI la persona 2012 Edizioni ART Titolo originale dell opera Explícame la persona 2ª edizione 2012 Via dei Del Balzo, 10-00165 ROMA Tel. 06 66 52 77 84 Fax 06 66 52 79 07 E- mail:
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA
 CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
INTRODUZIONE I CICLI DI BORSA
 www.previsioniborsa.net 1 lezione METODO CICLICO INTRODUZIONE Questo metodo e praticamente un riassunto in breve di anni di esperienza e di studi sull Analisi Tecnica di borsa con specializzazione in particolare
www.previsioniborsa.net 1 lezione METODO CICLICO INTRODUZIONE Questo metodo e praticamente un riassunto in breve di anni di esperienza e di studi sull Analisi Tecnica di borsa con specializzazione in particolare
Compito del magistero nella Chiesa
 Compito del magistero nella Chiesa Definizione Uno specifico carisma conferisce al magistero il compito fondamentale di testimonianza autentica della divina Rivelazione: con l assistenza dello Spirito
Compito del magistero nella Chiesa Definizione Uno specifico carisma conferisce al magistero il compito fondamentale di testimonianza autentica della divina Rivelazione: con l assistenza dello Spirito
PENSIERO DI LENIN. Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840.
![PENSIERO DI LENIN. Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840. PENSIERO DI LENIN. Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840.](/thumbs/38/17920727.jpg) PENSIERO DI LENIN Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840. Articolo datato 6 gennaio 1923 e pubblicato sulla «Pravda» del 27 gennaio 1923. ******
PENSIERO DI LENIN Fonte: Lenin [Vladimir Ilic Ulianov], Scritti economici, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 837-840. Articolo datato 6 gennaio 1923 e pubblicato sulla «Pravda» del 27 gennaio 1923. ******
PROMUOVERSI MEDIANTE INTERNET di Riccardo Polesel. 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15
 Indice Introduzione pag. 9 Ringraziamenti» 13 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15 1. I contenuti curati, interessanti e utili aiutano il business» 15 2. Le aziende
Indice Introduzione pag. 9 Ringraziamenti» 13 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15 1. I contenuti curati, interessanti e utili aiutano il business» 15 2. Le aziende
LOCUZIONI AL MONDO. Il mistero di ogni persona (22/4/2013 24/4/2013) Testi tradotti dai messaggi originali pubblicati sul sito Locutions to the World
 LOCUZIONI AL MONDO Il mistero di ogni persona (22/4/2013 24/4/2013) Testi tradotti dai messaggi originali pubblicati sul sito Locutions to the World 2 Sommario 1. La decisione della SS. Trinità al tuo
LOCUZIONI AL MONDO Il mistero di ogni persona (22/4/2013 24/4/2013) Testi tradotti dai messaggi originali pubblicati sul sito Locutions to the World 2 Sommario 1. La decisione della SS. Trinità al tuo
4 3 4 = 4 x 10 2 + 3 x 10 1 + 4 x 10 0 aaa 10 2 10 1 10 0
 Rappresentazione dei numeri I numeri che siamo abituati ad utilizzare sono espressi utilizzando il sistema di numerazione decimale, che si chiama così perché utilizza 0 cifre (0,,2,3,4,5,6,7,8,9). Si dice
Rappresentazione dei numeri I numeri che siamo abituati ad utilizzare sono espressi utilizzando il sistema di numerazione decimale, che si chiama così perché utilizza 0 cifre (0,,2,3,4,5,6,7,8,9). Si dice
FARE O ESSERE VOLONTARI?
 Corso di formazione FARE O ESSERE VOLONTARI? Il volontariato come manifestazione dell essere e dell operare a favore dell altro Caritas Ambrosiana Salone Mons. Bicchierai via San Bernardino 4 20122 Milano
Corso di formazione FARE O ESSERE VOLONTARI? Il volontariato come manifestazione dell essere e dell operare a favore dell altro Caritas Ambrosiana Salone Mons. Bicchierai via San Bernardino 4 20122 Milano
I.I.S.S. Francesco Ferrara. Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale
 I.I.S.S. Francesco Ferrara Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale Disciplina : Filosofia Docente: Daniela Averna Classe V sez. Q Modulo 1. Kant. Unità 1. La vita e il periodo Precritico. Unità
I.I.S.S. Francesco Ferrara Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale Disciplina : Filosofia Docente: Daniela Averna Classe V sez. Q Modulo 1. Kant. Unità 1. La vita e il periodo Precritico. Unità
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
 CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale
 Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Enunciati atomici e congiunzione In questa lezione e nelle successive, vedremo come fare
Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Dall italiano al linguaggio della logica proposizionale Enunciati atomici e congiunzione In questa lezione e nelle successive, vedremo come fare
Le strategie di promozione della lettura messe in atto dalla. biblioteca comunale di Soriano nel Cimino risultano abbastanza
 CAPITOLO QUARTO ANALISI DEI SERVIZI DI PROMOZIONE PER UNA VALUTAZIONE DEI BENEFICI 1. Premessa Le strategie di promozione della lettura messe in atto dalla biblioteca comunale di Soriano nel Cimino risultano
CAPITOLO QUARTO ANALISI DEI SERVIZI DI PROMOZIONE PER UNA VALUTAZIONE DEI BENEFICI 1. Premessa Le strategie di promozione della lettura messe in atto dalla biblioteca comunale di Soriano nel Cimino risultano
Test d ipotesi. Statistica e biometria. D. Bertacchi. Test d ipotesi
 In molte situazioni una raccolta di dati (=esiti di esperimenti aleatori) viene fatta per prendere delle decisioni sulla base di quei dati. Ad esempio sperimentazioni su un nuovo farmaco per decidere se
In molte situazioni una raccolta di dati (=esiti di esperimenti aleatori) viene fatta per prendere delle decisioni sulla base di quei dati. Ad esempio sperimentazioni su un nuovo farmaco per decidere se
L uso della Balanced Scorecard nel processo di Business Planning
 L uso della Balanced Scorecard nel processo di Business Planning di Marcello Sabatini www.msconsulting.it Introduzione Il business plan è uno strumento che permette ad un imprenditore di descrivere la
L uso della Balanced Scorecard nel processo di Business Planning di Marcello Sabatini www.msconsulting.it Introduzione Il business plan è uno strumento che permette ad un imprenditore di descrivere la
Esercizi su. Funzioni
 Esercizi su Funzioni ๒ Varie Tracce extra Sul sito del corso ๓ Esercizi funz_max.cc funz_fattoriale.cc ๔ Documentazione Il codice va documentato (commentato) Leggibilità Riduzione degli errori Manutenibilità
Esercizi su Funzioni ๒ Varie Tracce extra Sul sito del corso ๓ Esercizi funz_max.cc funz_fattoriale.cc ๔ Documentazione Il codice va documentato (commentato) Leggibilità Riduzione degli errori Manutenibilità
Rappresentare i nessi logici con gli insiemi
 Rappresentare i nessi logici con gli insiemi È un operazione molto utile in quesiti come quello nell Esempio 1, in cui gruppi di persone o cose vengono distinti in base a delle loro proprietà. Un elemento
Rappresentare i nessi logici con gli insiemi È un operazione molto utile in quesiti come quello nell Esempio 1, in cui gruppi di persone o cose vengono distinti in base a delle loro proprietà. Un elemento
Tesina per il corso di Psicotecnologie dell apprendimento per l integrazione delle disabilità
 Tesina per il corso di Psicotecnologie dell apprendimento per l integrazione delle disabilità ANALISI DEL TITOLO Per prima cosa cercheremo di analizzare e capire insieme il senso del titolo di questo lavoro:
Tesina per il corso di Psicotecnologie dell apprendimento per l integrazione delle disabilità ANALISI DEL TITOLO Per prima cosa cercheremo di analizzare e capire insieme il senso del titolo di questo lavoro:
