ALMA Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna. Determinazione della Massa in Astrofisica
|
|
|
- Giordano Zanetti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ALMA Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna SCUOLA DI SCIENZE Corso di Laurea in Astronomia Dipartimento di Fisica e Astronomia Determinazione della Massa in Astrofisica Elaborato Finale Candidato: Eleonora Mizzoni Relatore: Prof. Daniele Dallacasa Sessione I Anno Accademico
2 Indice 1. Introduzione 2. Metodi di misurazione della massa 3. I sistemi doppi La funzione di massa Trasferimento di massa e accrescimento 4. Il diagramma H-R 5. Limite di Chandrasekar 6. La Materia Oscura 7. Criterio di Jeans per la massa 8. Conclusioni 1
3 1. Introduzione La massa è una grandezza fisica propria dei corpi materiali ed è una proprietà intrinseca della materia che si può misurare attraverso delle importanti relazioni, tutte scoperte da Newton, ormai qualche secolo fa. Di sicuro, la massa non è il peso di un oggetto; piuttosto il peso di un oggetto è la conseguenza dello strano comportamento che ha la materia in quanto dotata di massa. Esistono due tipi di massa : la massa inerziale e la massa gravitazionale. Newton osservò che un corpo in quiete o in moto rettilineo uniforme, in un sistema inerziale, cambia il suo stato di moto se sottoposto ad una forza. Ogni corpo, subisce un accelerazione proporzionale alla forza applicata ed anche ad un altra grandezza, tipica del corpo: la massa inerziale. Da queste considerazioni, nacque la famosa seconda legge di Newton: F = m a dove maggiore è la massa, maggiore è la forza da applicare per avere una stessa accelerazione. La massa inerziale rappresenta, quindi, la resistenza che un corpo ha a cambiare il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme: corpi con massa minore vengono accelerati di più rispetto a corpi di massa maggiore, a parità di forza applicata. La massa (inerziale) esiste a prescindere dall ambiente dove si trova il corpo, sia esso sulla superficie terrestre o nello spazio profondo in completa assenza di gravità. La massa gravitazionale è un altra proprietà della materia che non ha alcun legame fisico con la sua massa inerziale. Fu sempre Newton a capire il motivo per il quale ogni corpo cade sulla superficie terrestre: tra due corpi esiste una forza, sempre attrattiva, inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza e direttamente proporzionale alle masse gravitazionali dei due corpi e ad una costante G, detta costante di gravitazione universale. La forza che riesce a far cadere una mela da un albero è responsabile del moto dei pianeti e dell intero universo e viene definita come: F = Gm 1m 2 r 2 1,2 (1) Le masse m 1 e m 2 sono chiamate masse gravitazionali e descrivono le proprietà dei corpi di attrarre altri corpi. Tuttavia, la massa inerziale e la massa gravitazionale, pur descrivendo due proprietà completamente diverse della materia, hanno in realtà lo stesso identico valore. Galileo notò che, in assenza di attrito, tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione, indipendentemente dalla loro massa e, se lasciati cadere allo stesso istante, toccano terra contemporaneamente. Questo comportamento è giustificabile dal punto di vista 2
4 fisico, solo assumendo che la massa inerziale sia uguale a quella gravitazionale. In relatività ristretta, si definisce la massa relativistica che non è più una proprietà intrinseca della materia ma dipende dallo stato della stessa e dal sistema di riferimento ed è direttamente proporzionale all energia della particella. Tuttavia, si può definire un invariante relativistico: la massa a riposo, che si riconduce al caso in cui la particella sia ferma, con velocità nulla. La determinazione della massa dei corpi celesti è una delle misurazioni più difficili da effettuare a causa di problemi osservativi ma è un fattore importante che serve per ottenere altre grandezze. Per esempio: La determinazione esatta delle orbite che percorrono le stelle nei sistemi binari o dei pianeti (e i loro satelliti) nel Sistema Solare; La determinazione della densità media e della composizione chimica, ipotesi sulla struttura interna e sulla stessa dinamica dei pianeti o delle stelle e l eventuale presenza di un campo magnetico; Importanti indizi sulla nascita ed evoluzione del sistema solare; La determinazione della massa del Sole e della nostra Luna che consente di avere informazioni sull evoluzione stellare e del nostro sistema. 2. Metodi di misurazione della massa Ci sono sostanzialmente tre modi per stimare la massa dei corpi celesti: Come prodotto tra il volume e la sua densità media, che dipende dalla composizione chimica. Questo metodo è, però, molto approssimato. Si misura l accelerazione media di gravità di un corpo celeste inviando una sonda e calcolando l accelerazione a cui è sottoposta e se ne calcola accuratamente la massa, tramite la formula: M = gr2 (2) G Questo metodo è tra i più precisi ma è anche quello più difficile da realizzare a causa dell utilizzo di sonde e, proprio a causa di ciò, è quindi limitato al nostro Sistema Solare. Terza legge di Keplero: si ottiene con ottima precisione la massa di un qualunque corpo celeste che possiede un satellite molto meno massiccio. Con questo metodo si può calcolare la massa del Sole e della Luna. 3
5 Quest ultima modalità contiene la teoria di gravitazione di Newton e, nella sua forma esatta, afferma che per un sistema di due corpi il periodo di rivoluzione è dato da: P = 2πa 3 2 G(M1 + M 2 ) (3) dove a è il semiasse maggiore, M 1 ed M 2 sono le masse dei due oggetti presi in considerazione. La richiesta principale è che i corpi orbitino intorno ad un comune centro di massa. 3. I sistemi doppi I sistemi doppi o binari sono formati da due stelle che orbitano intorno ad un comune centro di massa e rivestono un ruolo importante in astrofisica perché il calcolo delle orbite permette di stimare la massa delle due componenti, insieme ad altri elementi come raggio e densità. Nel caso delle binarie visuali, ad esempio, si può utilizzare la terza legge di Keplero per avere una stima delle masse. Riprendendo la formula (2) e dividendola per il periodo della Terra, otteniamo: m 1 + m 2 = ( α 1 )3 (4) p P 2 dove p è l angolo compreso tra due punti di osservazione dello stesso oggetto, detto angolo di parallasse, grazie al quale si può calcolare la distanza. Per trovare le masse bisogna osservare il moto delle singole componenti: queste ruotano attorno al baricentro, che ha un moto rettilineo uniforme. Nella figura sottostante è rappresentato l andamento dei due corpi. Le due componenti disegnano due sinusoidi tagliate dall unica retta per cui vale la relazione: m 1 a 1 = m 2 a 2. Il rapporto tra le dimensioni è costante e sostituendo α 1 α 2 = m 2 m 1 nell equazione (3) si ottengono le singole masse. 4
6 La funzione di massa In generale, la frequenza delle onde cambia in relazione al moto relativo tra sorgente e osservatore a causa dell effetto Doppler. Sfruttando questo fatto osservativo è possibile calcolare la massa di un sistema stellare binario spettroscopico. Il periodo delle due stelle è il medesimo ma noi riusciamo a vedere solo quella di massa maggiore(m 1 ) che è anche quella più vicina al baricentro del sistema, avendo un orbita minore e una velocità inferiore rispetto alla stella di massa minore (M 2 ). Ponendoci nella condizione di orbita circolare, definiamo le costanti: (a)k 1 = 2πa 1 sin i p(1 e 2 ) 1 2 = cost (b)k 2 = 2πa 2 sin i p(1 e 2 ) 1 2 = cost (5) così che il loro rapporto ci dia quello tra le masse delle stelle. Per trovare i singoli valori di M 1 e M 2 si applica la terza legge di Keplero (equazione 3) ottenendo M 1 = (a 1 + a 2 ) 3 p 2 (1 + a (6) 1 a 2 ) Non conoscendo il valore di a 1 singolarmente ma solo il suo prodotto con il sin i, moltiplicando il tutto per questo fattore elevato al cubo, otteniamo: (a)m 1 sin i 3 = (a sin i)3 p 2 (1 + a 1 a 2 ) M 1 (b)m 2 sin i 3 = (a sin i)3 p 2 (1 + a 2 a 1 ) M 2 (7) che sono i limiti inferiori della massa delle due stelle. Se il sistema binario è a due spettri ed è anche ad eclissi, si può calcolare i,a 1 e a 2 in unità spaziali, i raggi in dimensioni reali, le singole masse, la temperatura e la luminosità. Se il sistema è ad un solo spettro, non vedendo l orbita della seconda stella, si può ugualmente applicare la terza legge di Keplero ottenendo la funzione di massa definita come: (a 1 seni) 3 = (m 2seni) 3 = F (M) (8) p 2 (m 1 + m 2 ) 2 che fornisce il limite inferiore della massa della stella di cui non si vede l orbita. Tuttavia, il numero di sistemi binari per cui sono state ottenute le masse stellari è esiguo ma altre indicazioni indirette consentono di ritenere che le masse stellari variano in un intervallo limitato che va da 0,1 M solari a M solari. 5
7 Trasferimento di massa e accrescimento Le stelle binarie possono essere classificate anche in base alla distanza che le separa. Nei sistemi larghi o wide le componenti evolvono come due stelle singole mentre nei sistemi stretti o close, a prescindere dalla configurazione iniziale, le due stelle prima o poi si scambieranno materia cambiando lo sviluppo del sistema. Introduciamo il lobo di Roche: questa è una superficie che può essere descritta, sotto opportune condizioni, da un potenziale che delimita un area contenente del materiale legato gravitazionalmente ad una delle due stelle del sistema doppio. Si hanno quindi due lobi di Roche, uno per stella, che si incontrano in un punto detto L 1 o punto lagrangiano a equilibrio instabile. Se una stella evolve e raggiunge la superficie limite di Roche, la materia passa dal punto L 1 e viene trasferita alla compagna cambiando così il periodo e le dimensioni dell orbita del sistema secondo la relazione α a = (9) (m 1 m 2 ) 2 Nella figura sottostante vengono riportati due esempi di evoluzione di sistemi binari. 6
8 A) In un sistema di piccola massa, all inizio entrambe le stelle sono sulla sequenza principale del diagramma H-R (i); quella di 2M solari diventa una gigante rossa e tocca la superficie di Roche trasferendo materia alla compagna (ii) che accresce la propria massa e diventa più grande mentre la gigante rossa è passata alla fase di nana bianca (iv); la seconda stella accresce la propria massa sino a toccare a sua volta la superficie di Roche e a trasferire materia alla nana binaca (v) che supera il limite di Chandrasekhar ed esplode come una supernova di tipo I (vi). B) In un sistema binario massivo, con entrambe le componenti sulla sequenza principale, la stella con massa maggiore raggiunge presto la superficie di Roche (ii) e comincia il trasferimento di materia fino a quando la stella di Elio (iii) non collassa in una stella compatta di 2M solari, che può essere una stella di neutroni o un buco nero; (iv) la compagna diventa una gigante e trasferisce materia alla prima che diventa una forte sorgente di raggi X mentre il vento stellare disperde materia (v); si raggiunge anche il secondo punto lagrangiano, la materia viene dispersa e la stella più massiva diventa una stella di He con 6 masse solari (vii) che esplode come una supernova che può distruggere o meno il sistema binario (viii). Oggetti collassati come nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri catturano la materia che cade sull oggetto con un movimento a spirale, a causa della conservazione del momento angolare. L accrescimento svolge un ruolo importante nei processi di formazione stellare e dei pianeti. Gli effetti più rilevanti si osservano nei sistemi doppi e nei nuclei galattici attivi. 4. Il diagramma H-R Introduciamo brevemente il diagramma H-R, dalle iniziali di Hertzsprung e Russel, che sarà utile per comprendere meglio la descrizione dell evoluzione stellare e delle fasi che sono state descritte nel precedente paragrafo. Mettendo in relazione la luminosità e la temperatura di una stella, possiamo vedere la posizione che essa occupa all interno del grafico e a che stadio si trova della sua vita. Le stelle evolvono secondo un determinato percorso che dipende in particolar modo dalla loro massa, a cui è legata anche la luminosità secondo la relazione L M 3. Lungo l ordinata si riportano i valori della luminosità ed in ascissa la loro temperatura (i cui valori crescono andando verso sinistra). Le zone evidenziate individuano le diverse fasi dell evoluzione stellare: la maggior parte dei punti è concentrata su una diagonale, detta sequenza principale (main sequence), regione di stabilità lungo la quale le stelle passano la maggior parte della loro vita; in alto a sinistra si trovano le stelle più giovani 7
9 fino a scendere alle stelle più vecchie, che stanno esaurendo l idrogeno. A seconda della massa, alcune stelle diventeranno giganti o supergiganti rosse, nane bianche o buchi neri. A grande massa corrisponde grande luminosità quindi, in alto a destra, troveremo le stelle giganti (giants), la cui dimensione è decine di volte maggiore di quella del Sole, e, più in alto, le supergiganti (supergiants), centinaia di volte più grandi del Sole. Le stelle più calde irradiano di più e sono quelle con maggiore luminosità: si trovano quindi in alto a sinistra nella sequenza principale. In basso si trovano le nane bianche (white dwarfs): sono stelle di alta temperatura ma piccole e poco luminose. Il diagramma H-R fornisce informazioni anche sul raggio, dato che la luminosità dipende dalla temperatura e dalla superficie. Il raggio cresce spostandosi dalla zona in basso a sinistra (alta temperatura e bassa luminosità) verso quella in alto a destra. 5. Limite di Chandrasekhar Nel paragrafo sull accrescimento si è fatta menzione della massa di Chandrasekhar per le nane bianche che può essere definita come il limite superiore della massa di un corpo che si oppone al collasso gravitazionale. Questo collasso è contrastato dalla pressione degli elettroni degeneri. La compressione a cui è soggeta la nana bianca aumenta la densità degli elettroni che, secondo il principio di esclusione di Pauli, non possono occupare tutti contemporaneamente il livello di energia minore ma devono disporsi su livelli di energia sempre più elevati in base alla densità dell oggetto. Lo stato, così definito, viene detto degenere e 8
10 fornisce alla stella l energia necessaria per mantenere l equilibrio idrostatico. Tuttavia, all aumentare della massa della stella il raggio si riduce secondo la relazione R M 1/3 (10) e, ad un certo punto, deve instaurarsi un regime relativistico dovuto alla maggiore velocità degli elettroni nel gas che portò Chandrasekhar a dimostrare l esistenza di una massa limite dalla relazione massa-raggio. Facendo il rapporto tra la pressione centrale del gas e la pressione degenere, si ottiene una relazione che dipende esclusivamente dalla massa e non dalla densità: P c P = M 2/3 costρ 4/3 s ρ 4/3 media media = M 2/3 s (11) che diventa insostenibile per masse superiori alla massa limite di Chandrasekhar: M ch 5, 76µ 2 e M sole 1, 44M sole (12) se prendiamo il peso molecolare medio µ 2, che vale in generale per la materia fortemente ionizzata priva di idrogeno. La linea continua rappresenta la relazione reale, quella tratteggiata la relazione R M 1/3. Lungo la linea continua sono mostrate alcune configurazioni: la regione scura mostra la porzione di nana bianca soggetta a regime relativistico, quella chiara a regime ordinario. Il regime relativistico si instaura in corrispondenza di una certa massa e continua a crescere con essa. 9
11 6. La Materia Oscura Inizialmente indicata come massa mancante, la materia oscura non è direttamente osservabile o individuabile tramite analisi spettroscopica, visto che non emette radiazione elettromagnetica, ma si manifesta tramite i suoi effetti gravitazionali. Prove evidenti della presenza di materia oscura ci vengono fornite, ad esempio, dalle lenti gravitazionali: fenomeni caratterizzati dalla deflessione della radiazione, emessa da una sorgente lontanta, quando incontra una massa sul suo percorso. Tramite l osservazione di migliaia di immagini, furono osservate deviazioni da parte della luce anche in punti dove non vi erano masse visibili. Un altro esempio può essere fornito dalla curva di rotazione delle galassie, oggetti di enormi dimensioni contenenti dalle decine di milioni fino a mille miliardi di stelle, che ruotano attorno ad un comune centro di massa. Nelle zone del disco più esterne delle galassie a spirale, possiamo utilizzare una semplice relazione per descrivere il moto delle stelle attorno ad un centro di massa grazie alle leggi di Keplero; se M è la somma delle masse degli oggetti presenti nella galassia, la velocità orbitale sarà v = GM r e quella angolare ω = v ; supponendo che la distribuzione di massa sia uniforme, sostituendo r in modulo otteniamo : GM ω = (13) r 3/2 Il grafico (1) mostra l andamento delle velocità dei pianeti del sistema solare in base alla legge di Keplero mentre nel grafico (2) è rappresentata la curva di rotazione della Via Lattea. (1) (2) Come è facile notare, la distribuzione non è di tipo kepleriano ma è praticamente piatta e si può ricondurre al caso ideale di un corpo immerso in una distribuzione di massa uniforme. Consideriamo un caso ideale: se un oggetto si trova sulla superficie terrestre e se ne 10
12 allontana, per restare in orbita deve avere una velocità orbitale di tipo kepleriano che diminuisce con l aumentare della distanza; se l oggetto è al centro della terra ed è circondato da materia, la gravità cresce linearmente andando dal centro verso l esterno ed è massima sulla superfice (solo se la densità viene considerata uniforme). La velocità è quindi legata al campo gravitazionale attraverso la seconda legge della dinamica ed è costante all interno della sfera, come si evince dal grafico sottostante. Ritornando alla nostra galassia, ci si aspetterebbe una diminuzione della velocità di rotazione che, invece, risulta costante oltre un certo raggio. La curva di rotazione piatta e costante significa che siamo ancora all interno della galassia e che ci sia una quantità di materia che non siamo in grado di vedere, sia lungo il disco che al suo esterno, la cui esistenza viene postulata solo sulla base dell attrazione gravitazionale esercitata su stelle e pianeti. Bisogna considerare anche altri risultati: le stelle nelle regioni periferiche ruotano con velocità orbitali di 100 km/s che sono superiori alla velocità di fuga da una galassia, considerando solo la materia visibile. Le stelle periferiche dovrebbero quindi lasciare la Via Lattea e molte galassie non dovrebbero neanche esistere perché non sarebbero verificate le condizioni dinamiche. Se questo non succede, deve esserci necessariamente della massa a noi oscura che aumenta il campo gravitazionale della galassia permettendo delle velocità così alte. Stesso discorso per le galassie all interno degli ammassi: dall analisi del moto di rotazione delle singole componenti si può risalire ad una stima della massa totale dell ammasso che è di gran lunga superiore a quella stimata in base alla sola materia luminosa. Anche qui, considerando solo la massa dovuta alla materia visibile, non potremmo giustificare delle velocità di rotazioni maggiori della velocità di fuga mettendo in dubbio l esistenza stessa dell ammasso di galassie. Di seguito, viene riportato un calcolo sulla dispersione di velocità nell ammasso della Chioma di Berenice, applicando il teorema del viriale, da parte di Zwicky nel Supponendo che l ammasso sia a simmetria sferica ed in condizioni di equilibrio, le galassie possono essere considerate come degli elementi di un fluido in equilibrio idrostatico e 11
13 si può applicare il teorema del viriale: 2T + U = 0 (14) Supposta una distribuzione di velocità isotropa dei membri dell ammasso: v 2 = vx 2 + vy 2 + vz 2 = 3 v 2 (15) e la distribuzione di velocità indipendente dalla massa L energia potenziale può essere scritta come: 2T = 1 m j vj 2 = M v 2 (16) j U 3 GM 2 5 R (17) ed applicando il teorema del viriale: 2T + U = M v 2 = 3 GM 2 5 R (18) si ottiene: M R v2 (19) G con v 2 che viene misurato dalla dispersione per effetto Doppler e, generalmente, vale v 1000 kms 1, e con R 1Mpc. Introducendo la materia oscura, si giustificano le dinamiche stellari e l esistenza degli ammassi come oggetti stabili nel tempo. Un modo per stimare l effettiva presenza di materia oscura è tramite il rapporto massaluminosità, accennato in precedenza. La procedura consiste nel misurare, rispetto al Sole, la luminosità di una galassia e, analizzando il moto delle componenti (stelle, galassie), stimare la massa effettuando infine il rapporto con la luminosità. In genere, ci si riferisce al valore del rapporto per il Sole e, ponendolo pari ad 1, si hanno tipici valori sperimentali: Sole 1 Via Lattea(100kpc) 30 Galassia spirale 2-6 Galassia ellittica 5-25 Ammassi galassie Il numero che si ottiene ci dice su quante volte la massa totale è maggiore di quella 12
14 responsabile dell emissione di radiazione. Per le galassie a spirale, i valori oscillano tra 2 e 6 a causa della forma, della composizione e della distribuzione di materia al loro interno. Esistono varie ipotesi sulla materia oscura: potrebbe essere formata da stelle poco luminose e di piccola massa che non si riconoscono con mezzi ottici; buchi neri la cui forza gravitazionale cattura le radiazioni luminose; potrebbe essere composta da neutrini, particelle prive di carica con una massa non misurabile con i metodi attuali. Sono particelle difficili da individuare ma vengono prodotte in abbondanza nei processi termonucleari. Si tratta, comunque, solo di ipotesi dato che il problema sulla natura della massa mancante è ancora aperto. 7. Criterio di Jeans per la massa Il fisico britannico Sir James Jeans studiò le nubi gassose e, in particolare, il loro collasso gravitazionale dimostrando che, sotto opportune condizioni, una nube poteva diventare instabile e collassare con conseguente formazione stellare. Una nube di gas che ha una pressione interna che contrasta quella gravitazionale è in equilibrio idrostatico, secondo la relazione: dp dr = GρM nube r 2 (20) L equilibrio si mantiene se le piccole perturbazioni si dissipano in un tempo relativamente breve. Se consideriamo una regione sferica di raggio R e densità media ρ, queste sono legate alla massa secondo la relazione M ρr 3 (21) con le particelle che hanno velocità v. Valutando la forza di pressione F p e la forza di gravità F g : F p v2 F g GM GρR (22) R R 2 ed eguagliandole, si ottiene una lunghezza caratteristica detta scala di Jeans che rappresenta il limite inferiore del raggio della nube: 1 R j = v (23) Gρ Se R > R j la nube collassa sotto la forza di gravità dando origine a nuove stelle, altrimenti la perturbazione è cancellata e il sistema torna in equilibrio. Lo stesso discorso si può fare su scale temporali: paragonando il tempo gravitazionale di 13
15 free-fall τ ff (tempo impiegato della perturbazione a collassare sotto la propria gravità) e il tempo idrodinamico τ h ( tempo necessario a ristabilire l equilibrio): τ ff 1 Gρ τ h 2R v (24) si può vedere come per τ h < τ ff prevalgano le forze di pressione e il sistema ritorni in equilibrio; in caso contrario, prevale la gravità e il sistema collassa. 14
16 8. Conclusioni In queste poche pagine, è stato introdotto il concetto di massa e l importanza che riveste questa grandezza in astronomia prendendo alcuni esempi che mostrano come può essere determinata la massa, riassunti qui di seguito. Partendo dal primitivo concetto di grandezza legata alla quantità di materia di cui è fatto un corpo, si è arrivati a definire la massa come quella quantità che misura le proprietà gravitazionali e inerziali di un oggetto. Tra i fenomeni più importanti che riguardano la massa, la teoria dell accrescimento occupa uno dei primi posti. Le singole componenti di un sistema evolvono, col tempo, tramite il trasferimento di materia da un corpo all altro, in stadi successivi e si spostano sul diagramma H-R dandoci la possibiltà di ricavare altri valori, quali la luminosità, la temperatura e il tempo di vita. La massa è il parametro su cui si basano le teorie di Chandrasekhar e Jeans: entrambi hanno studiato gli oggetti celesti e stabilito dei valori limite, superati i quali, l oggetto collassa a causa della pressione gravitazionale e dà luogo a stelle di neutroni o buchi neri, nel caso di una nana bianca, oppure ha come conseguenza la formazione di nuove stelle, nel caso delle nubi studiate da Jeans. Questo ci consente di avere un idea della grandezza dell universo e della materia presente in esso e, particolare attenzione, deve essere prestata alla materia oscura. Di questa massa non si hanno riscontri visivi perchè è, appunto, oscura e non emette radiazioni. Conferme della sua esistenza ci vengono date dal fatto che, considerando solo la materia presente, non si hanno riscontri tra teoria ed evidenze sperimentali, come mostrato per il grafico della velocità di rotazione delle galassie che non segue un andamento kepleriamo ma è costante, come se ci fosse ancora materia a circondare gli oggetti nella galassia. Concludendo, si può dire che la determinazione della massa degli oggetti astronomici è un processo complesso che può essere realizzato solo in maniera indiretta, utilizzando le conoscenze fisiche e gli strumenti a nostra disposizione, ma che permette di testare la validità della fisica che abbiamo scoperto in condizioni che, sulla terra, non sono accessibili. I metodi svilupati per determinare la massa hanno portato ad un avanzamento della conoscenza sul nostro universo e, in particolare, sul contenuto di materia presente in esso che, come visto precedentemente, è una quantità di gran lunga superiore a quella che credevamo e, sicuramente, nuovi metodi porteranno a nuove scoperte, in futuro. 15
17 Bibliografia docs.kde.org/stable/it/kdeedu/kstars/ai-darkmatter.html darkmatter/ archive.oapd.inaf.it/pianetav/modelli/l21_03s.html astrofisica.altervista.org/doku.php?id=c07:07_limite_chandrasekhar Astronomy: A Physical Perspective, Marc L. Kutner. Cambridge Elementi di Astronomia, Pietro Giannone. Pitagora Editore Bologna. 16
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali Corso di Laurea Specialistica in Fisica
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali Corso di Laurea Specialistica in Fisica CURRICULUM ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO Anno Accademico 2011-2012 PROGRAMMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali Corso di Laurea Specialistica in Fisica CURRICULUM ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO Anno Accademico 2011-2012 PROGRAMMA
Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino. Scopriamo le scienze della Terra
 Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino Scopriamo le scienze della Terra Capitolo 2 Le stelle e il Sistema solare 3 1. Le stelle e la luce /1 La luce è energia elettromagnetica emessa da una sorgente; si
Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino Scopriamo le scienze della Terra Capitolo 2 Le stelle e il Sistema solare 3 1. Le stelle e la luce /1 La luce è energia elettromagnetica emessa da una sorgente; si
CARATTERISTICHE DELLE STELLE
 CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE. 9.1 Introduzione.
 CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
Come girano stelle e pianeti?
 Sistemi legati Come girano stelle e pianeti? a. pianeti intorno al Sole Simulazione con Interactive Physics (Sole/Terra velocità e gravità, 1^ e ^ Legge di Keplero, periodo e massa del Sole) Simulazione
Sistemi legati Come girano stelle e pianeti? a. pianeti intorno al Sole Simulazione con Interactive Physics (Sole/Terra velocità e gravità, 1^ e ^ Legge di Keplero, periodo e massa del Sole) Simulazione
Olimpiadi Italiane di Astronomia MAGNITUDINI
 Olimpiadi Italiane di Astronomia Preparazione alla fase interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia MAGNITUDINI By Giuseppe Cutispoto Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una
Olimpiadi Italiane di Astronomia Preparazione alla fase interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia MAGNITUDINI By Giuseppe Cutispoto Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una
Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto
 Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 4 febbraio 018 Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una stella
Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 4 febbraio 018 Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una stella
Docente: Alessandro Melchiorri
 Astronomia Lezione 26/11/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Sito web per slides lezioni: oberon.roma1.infn.it:/alessandro/astro2012/ Le lezioni astronomia012_*.pdf
Astronomia Lezione 26/11/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Sito web per slides lezioni: oberon.roma1.infn.it:/alessandro/astro2012/ Le lezioni astronomia012_*.pdf
Oltre il Sistema Solare
 Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
Indizi sull esistenza della Materia Oscura
 Indizi sull esistenza della Materia Oscura Raffaele Pontrandolfi Corso di Astrosica e Particelle Elementari 2 Motivazione e Introduzione Dalla nucleosintesi primordiale sappiamo che la densità di materia
Indizi sull esistenza della Materia Oscura Raffaele Pontrandolfi Corso di Astrosica e Particelle Elementari 2 Motivazione e Introduzione Dalla nucleosintesi primordiale sappiamo che la densità di materia
Le nebulose. Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma.
 Le nebulose Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma. Esistono vari tipi di nebulosa: nebulosa oscura all interno della quale avvengono i fenomeni di nascita e formazione di stelle; nebulosa
Le nebulose Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma. Esistono vari tipi di nebulosa: nebulosa oscura all interno della quale avvengono i fenomeni di nascita e formazione di stelle; nebulosa
Nane bianche e stelle di neutroni. di Roberto Maggiani
 Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova pratica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova pratica - Categoria Senior Variabili Cefeidi Le Cefeidi sono stelle variabili ( m ~ 1) di massa M > 5 M ed aventi periodo 1 < P
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova pratica - Categoria Senior Variabili Cefeidi Le Cefeidi sono stelle variabili ( m ~ 1) di massa M > 5 M ed aventi periodo 1 < P
Principio di inerzia
 Dinamica abbiamo visto come si descrive il moto dei corpi (cinematica) ma oltre a capire come si muovono i corpi è anche necessario capire perchè essi si muovono Partiamo da una domanda fondamentale: qual
Dinamica abbiamo visto come si descrive il moto dei corpi (cinematica) ma oltre a capire come si muovono i corpi è anche necessario capire perchè essi si muovono Partiamo da una domanda fondamentale: qual
Fondamenti di Astrofisica. Alessandro Marconi
 Alessandro Marconi Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Largo E. Fermi 2 email: marconi@arcetri.astro.it, alessandro.marconi@unifi.it
Alessandro Marconi Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Largo E. Fermi 2 email: marconi@arcetri.astro.it, alessandro.marconi@unifi.it
E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la
 1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
Astronomia Lezione 23/1/2012
 Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
Problemi di Fisica. La Gravitazione
 Problemi di Fisica La Gravitazione Calcolare la forza che agisce sulla Luna per effetto dell interazione gravitazionale con la erra e il Sole. I dati sono: massa Sole M S =1,9810 30 kg; massa erra M =5,9810
Problemi di Fisica La Gravitazione Calcolare la forza che agisce sulla Luna per effetto dell interazione gravitazionale con la erra e il Sole. I dati sono: massa Sole M S =1,9810 30 kg; massa erra M =5,9810
Evoluzione stellare: dalla nascita di una stella alla sua fine. Serafina Carpino
 Evoluzione stellare: dalla nascita di una stella alla sua fine Serafina Carpino Oltre a miliardi di stelle, nello spazio ci sono nubi di materia interstellare, formate da estese condensazioni di gas e
Evoluzione stellare: dalla nascita di una stella alla sua fine Serafina Carpino Oltre a miliardi di stelle, nello spazio ci sono nubi di materia interstellare, formate da estese condensazioni di gas e
Determinazione della curva di luce e della massa di NGC 2748
 Determinazione della curva di luce e della massa di NGC 2748 Marco Berton, Liceo Scientifico U. Morin - Mestre Alessio Dalla Valle, Liceo Scientifico G. Bruno Mestre Luca Marafatto, Liceo Classico M. Foscarini
Determinazione della curva di luce e della massa di NGC 2748 Marco Berton, Liceo Scientifico U. Morin - Mestre Alessio Dalla Valle, Liceo Scientifico G. Bruno Mestre Luca Marafatto, Liceo Classico M. Foscarini
Con la parola Universo possiamo intendere tutto ciò che ci circonda: le stelle, i pianeti e tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo (insieme ad
 Con la parola Universo possiamo intendere tutto ciò che ci circonda: le stelle, i pianeti e tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo (insieme ad una enorme quantità di altre cose che non vediamo)
Con la parola Universo possiamo intendere tutto ciò che ci circonda: le stelle, i pianeti e tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo (insieme ad una enorme quantità di altre cose che non vediamo)
Corso di introduzione all Astrofisica
 Corso di introduzione all Astrofisica I modulo Prof. Giuseppe Bertin Anno accademico 9 Indice Il teorema del viriale. Problema....................................... Equazioni del moto e energia per sistemi
Corso di introduzione all Astrofisica I modulo Prof. Giuseppe Bertin Anno accademico 9 Indice Il teorema del viriale. Problema....................................... Equazioni del moto e energia per sistemi
Astronomia INTRODUZIONE
 Astronomia 2015-16 INTRODUZIONE Contenuti: Corso di Astronomia 2015-2016 Prof. Marco Bersanelli Fondamenti Struttura stellare Evoluzione stellare Strumentazione per astrofisica Astrofisica galattica Astrofisica
Astronomia 2015-16 INTRODUZIONE Contenuti: Corso di Astronomia 2015-2016 Prof. Marco Bersanelli Fondamenti Struttura stellare Evoluzione stellare Strumentazione per astrofisica Astrofisica galattica Astrofisica
m s m s. 3, K g
 Le osservazioni hanno permesso una stima della massa pari a : Grande Nube : 0 0 9 m s Piccola Nube : assumendo i valori : m PM 6 0 9 m s, 978 0 0 K g R GM 60 6800 al 5060 al, il punto neutro della Grande
Le osservazioni hanno permesso una stima della massa pari a : Grande Nube : 0 0 9 m s Piccola Nube : assumendo i valori : m PM 6 0 9 m s, 978 0 0 K g R GM 60 6800 al 5060 al, il punto neutro della Grande
quando la vita di una stella sta per giungere al termine l'idrogeno diminuisce limitando le fusione nucleare all interno
 le stelle sono corpi celesti che brillano di luce propria hanno la forma di sfere luminose ed emettono radiazioni elettromagnetiche causate dalle reazioni nucleari che avvengono al loro interno (atomi
le stelle sono corpi celesti che brillano di luce propria hanno la forma di sfere luminose ed emettono radiazioni elettromagnetiche causate dalle reazioni nucleari che avvengono al loro interno (atomi
ESERCITAZIONI ASTROFISICA STELLARE
 ESERCITAZIONI per ASTROFISICA STELLARE (AA 2011-2012) (ultimo aggiornamento: 23/03/2012) Esercizio 1: Una stella con gravita` superficiale pari a 3.42 10 4 cm -2 e luminosita` pari a 562 L ha il massimo
ESERCITAZIONI per ASTROFISICA STELLARE (AA 2011-2012) (ultimo aggiornamento: 23/03/2012) Esercizio 1: Una stella con gravita` superficiale pari a 3.42 10 4 cm -2 e luminosita` pari a 562 L ha il massimo
Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri. Lezione 15
 Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri Lezione 15 Buchi neri nei nuclei galattici Nell ipotesi che gli AGN siano alimentati da accrescimento di massa su un buco nero l attività AGN deva lasciare un resto
Nuclei Galattici Attivi e Buchi Neri Lezione 15 Buchi neri nei nuclei galattici Nell ipotesi che gli AGN siano alimentati da accrescimento di massa su un buco nero l attività AGN deva lasciare un resto
(4 π 2 /kt) m t / r 2 = (4 π 2 /ks) m s / r 2
 Le leggi di Keplero Lo studio del moto dei pianeti, tramite accurate misure, permise a Keplero tra il 1600 ed il 1620 di formulare le sue tre leggi: I legge: I pianeti percorrono orbite ellittiche intorno
Le leggi di Keplero Lo studio del moto dei pianeti, tramite accurate misure, permise a Keplero tra il 1600 ed il 1620 di formulare le sue tre leggi: I legge: I pianeti percorrono orbite ellittiche intorno
. Esprimere il risultato in km, anni luce, parsec, unità astronomiche e raggi solari.
 Olimpiadi Italiane di Astronomia 018, INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania Corso di preparazione alla Finale Nazionale - Incontro 1: arzo 018 A cura di: Giuseppe Cutispoto e ariachiara Falco 8. KA
Olimpiadi Italiane di Astronomia 018, INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania Corso di preparazione alla Finale Nazionale - Incontro 1: arzo 018 A cura di: Giuseppe Cutispoto e ariachiara Falco 8. KA
L origine dell universo
 LE STELLE Le stelle sono corpi celesti luminosi, formati da enormi quantità di gas caldissimo (principalmente idrogeno ed elio), che producono energia attraverso un processo di fusione nucleare dove 4
LE STELLE Le stelle sono corpi celesti luminosi, formati da enormi quantità di gas caldissimo (principalmente idrogeno ed elio), che producono energia attraverso un processo di fusione nucleare dove 4
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2013 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Junior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2013 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Junior 1. L ora a Oriente A un certo istante osserviamo una stella che si trova esattamente sull orizzonte in direzione
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2013 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Junior 1. L ora a Oriente A un certo istante osserviamo una stella che si trova esattamente sull orizzonte in direzione
4 CORSO DI ASTRONOMIA
 4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
La nostra galassia: la Via Lattea. Lezione 13
 La nostra galassia: la Via Lattea Lezione 13 Sommario La struttura della Galassia. Osservazioni in ottico, infrarosso e radio. Disco, sferoide (bulge) e alone. Popolazioni stellari. Braccia a spirale.
La nostra galassia: la Via Lattea Lezione 13 Sommario La struttura della Galassia. Osservazioni in ottico, infrarosso e radio. Disco, sferoide (bulge) e alone. Popolazioni stellari. Braccia a spirale.
Misteri nell Universo
 Misteri nell Universo Quali sono le forme di materia ed energia nell universo osservabile? Quale e la ricetta (ingredienti e proporzioni) del nostro universo? 1 L eredità di Copernico Quale è la relazione
Misteri nell Universo Quali sono le forme di materia ed energia nell universo osservabile? Quale e la ricetta (ingredienti e proporzioni) del nostro universo? 1 L eredità di Copernico Quale è la relazione
1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello
 La gravitazione 1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico); i corpi celesti, sferici e perfetti,
La gravitazione 1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico); i corpi celesti, sferici e perfetti,
La legge di gravità. La mela
 La legge di gravità La caduta dei gravi La legge di Newton Il moto dei pianeti (Kepler) La misura della costante G (Cavendish) Masse estese Masse sferiche Verso il centro della terra... Il concetto di
La legge di gravità La caduta dei gravi La legge di Newton Il moto dei pianeti (Kepler) La misura della costante G (Cavendish) Masse estese Masse sferiche Verso il centro della terra... Il concetto di
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO?
 MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
Le leggi di Keplero modello geocentrico modello eliocentrico
 Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
LA GRAVITAZIONE. Legge di Gravitazione Universale 08/04/2015 =6, /
 LA GRAVITAZIONE Definizione (forza di attrazione gravitazionale) Due corpi puntiformi di massa e si attraggono vicendevolmente con una forza (forza che il corpo A esercita sul corpo B), o (forza che il
LA GRAVITAZIONE Definizione (forza di attrazione gravitazionale) Due corpi puntiformi di massa e si attraggono vicendevolmente con una forza (forza che il corpo A esercita sul corpo B), o (forza che il
1. Le stelle. corpi celesti di forma sferica. costituite da gas (idrogeno ed elio)
 LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
Le leggi di Keplero modello geocentrico modello eliocentrico
 Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
LE FORZE E IL MOTO. Il moto lungo un piano inclinato
 LE FORZE E IL MOTO Il moto lungo un piano inclinato Il moto di caduta lungo un piano inclinato un moto uniformemente accelerato in cui l accelerazione è diretta parallelamente al piano (verso il basso)
LE FORZE E IL MOTO Il moto lungo un piano inclinato Il moto di caduta lungo un piano inclinato un moto uniformemente accelerato in cui l accelerazione è diretta parallelamente al piano (verso il basso)
Le leggi di Keplero e la gravitazione universale. Enrico Degiuli Classe Terza
 Le leggi di Keplero e la gravitazione universale Enrico Degiuli Classe Terza Giovanni Keplero Keplero è stato un astronomo tedesco vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Ha condotto lunghi studi sul
Le leggi di Keplero e la gravitazione universale Enrico Degiuli Classe Terza Giovanni Keplero Keplero è stato un astronomo tedesco vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Ha condotto lunghi studi sul
Dinamica. Giovanni Torrero maggio 2006
 Dinamica Giovanni Torrero maggio 006 1 I sistemi di riferimento inerziali Nello studio della dinamica sono molto importanti i sistemi di riferimento rispetto ai quali vengono studiati i fenomeni. L esperienza
Dinamica Giovanni Torrero maggio 006 1 I sistemi di riferimento inerziali Nello studio della dinamica sono molto importanti i sistemi di riferimento rispetto ai quali vengono studiati i fenomeni. L esperienza
LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei VERONA
 LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei PROGRAMMA PREVISTO Anno Scolastico 2006-2007 Testo di riferimento: "Le Vie della Fisica" vol. 1-2 (Battimelli - Stilli) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili.
LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei PROGRAMMA PREVISTO Anno Scolastico 2006-2007 Testo di riferimento: "Le Vie della Fisica" vol. 1-2 (Battimelli - Stilli) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili.
Olimpiadi Italiane di Astronomia Corso di preparazione per la Gara Interregionale Categoria Senior
 Olimpiadi Italiane di Astronomia Corso di preparazione per la Gara Interregionale Categoria Senior Problema 1. Utilizzando i logaritmi in base 10 determinare: log 10 =? log 1000 =? log 1 =? log (a b) =?
Olimpiadi Italiane di Astronomia Corso di preparazione per la Gara Interregionale Categoria Senior Problema 1. Utilizzando i logaritmi in base 10 determinare: log 10 =? log 1000 =? log 1 =? log (a b) =?
La teoria della Relatività Generale
 Liceo Classico Seneca La teoria della Relatività Generale Prof. E. Modica La massa Dipendenza della massa dalla velocità Se un corpo di massa m è soggetto ad una forza costante F nella direzione della
Liceo Classico Seneca La teoria della Relatività Generale Prof. E. Modica La massa Dipendenza della massa dalla velocità Se un corpo di massa m è soggetto ad una forza costante F nella direzione della
Lezione 4. Vita delle Stelle Parte 2
 Lezione 4 Vita delle Stelle Parte 2 Fusione nucleare 4 atomi di idrogeno si uniscono per formare 1 atomo di elio e produrre energia nucleo H H H He H Due nuclei di idrogeno (due protoni) sospinti l'uno
Lezione 4 Vita delle Stelle Parte 2 Fusione nucleare 4 atomi di idrogeno si uniscono per formare 1 atomo di elio e produrre energia nucleo H H H He H Due nuclei di idrogeno (due protoni) sospinti l'uno
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA CLASSE 1^ H. a. s Prof.ssa RUBINO ALESSANDRA
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "ENRICO FERMI" Via Luosi n. 23-41124 Modena Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478 E-mail: info@fermi.mo.it Pagina web: www.fermi.mo.it PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "ENRICO FERMI" Via Luosi n. 23-41124 Modena Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478 E-mail: info@fermi.mo.it Pagina web: www.fermi.mo.it PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA
TEORIA DELLA RELATIVITA
 Cenni sulle teorie cosmologiche TEORIA DELLA RELATIVITA Nasce dalla constatazione che il movimento è relativo, e dipende dal sistema di riferimento. La teoria è formulata da Einstein che coniuga la precedente
Cenni sulle teorie cosmologiche TEORIA DELLA RELATIVITA Nasce dalla constatazione che il movimento è relativo, e dipende dal sistema di riferimento. La teoria è formulata da Einstein che coniuga la precedente
La relatività generale. Lezioni d'autore
 La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
RICERCA di FABRIZIO PORTA LEGGERE LE STELLE
 RICERCA di FABRIZIO PORTA LEGGERE LE STELLE LEGGERE LE STELLE: MA QUANTE SONO? Le stelle visibili ad occhio nudo dalla superficie terrestre sono esattamente 5.780, anche se dal nostro emisfero se ne può
RICERCA di FABRIZIO PORTA LEGGERE LE STELLE LEGGERE LE STELLE: MA QUANTE SONO? Le stelle visibili ad occhio nudo dalla superficie terrestre sono esattamente 5.780, anche se dal nostro emisfero se ne può
Richiami di Astrofisica Stellare. Lezione 3
 Richiami di Astrofisica Stellare Lezione 3 Evoluzione dopo la seq. principale Le stelle passano gran parte della loro vita nella sequenza principale. P.e. l 80% per il Sole. La sequenza principale è la
Richiami di Astrofisica Stellare Lezione 3 Evoluzione dopo la seq. principale Le stelle passano gran parte della loro vita nella sequenza principale. P.e. l 80% per il Sole. La sequenza principale è la
ESERCIZI SCIENZE: SISTEMA SOLARE
 ESERCIZI SCIENZE: SISTEMA SOLARE 1. Scrivi i nomi dei pianti del Sistema Solare che compaiono nell immagine Sole= 2. Dai le seguenti definizioni Pianeta terrestre= Satelliti galileiani= Pianeta nano= Stella=
ESERCIZI SCIENZE: SISTEMA SOLARE 1. Scrivi i nomi dei pianti del Sistema Solare che compaiono nell immagine Sole= 2. Dai le seguenti definizioni Pianeta terrestre= Satelliti galileiani= Pianeta nano= Stella=
MOTO RETTILINEO UNIFORMEMETE ACCELERATO
 MOTO RETTILINEO UNIFORMEMETE ACCELERATO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO E la velocita? a MEDIA = a ISTANTANEA Siano t 0 l istante di tempo in cui il corpo inizia ad accelerare v 0 la velocita all istante
MOTO RETTILINEO UNIFORMEMETE ACCELERATO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO E la velocita? a MEDIA = a ISTANTANEA Siano t 0 l istante di tempo in cui il corpo inizia ad accelerare v 0 la velocita all istante
Spettro della galassia di Seyfert NGC 4151
 Spettro della galassia di Seyfert NGC 4151 Misura del redshift e della larghezza delle righe di emissione Enrico Ferrari & Michele Previatello Istituto Tecnico Industriale Severi - Padova (22 Aprile 2005)
Spettro della galassia di Seyfert NGC 4151 Misura del redshift e della larghezza delle righe di emissione Enrico Ferrari & Michele Previatello Istituto Tecnico Industriale Severi - Padova (22 Aprile 2005)
Unità 2 - L ambiente celeste
 Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
3.Dinamica e forze. La dinamica è quella parte della meccanica che studia il moto di un corpo facendo riferimento alle cause esterne che lo generano.
 3.Dinamica e forze La dinamica è quella parte della meccanica che studia il moto di un corpo facendo riferimento alle cause esterne che lo generano. Le due grandezze fondamentali che prendiamo in considerazione
3.Dinamica e forze La dinamica è quella parte della meccanica che studia il moto di un corpo facendo riferimento alle cause esterne che lo generano. Le due grandezze fondamentali che prendiamo in considerazione
Tempi Moduli Unità /Segmenti. 2.1 La conservazione dell energia meccanica
 PERCORSO FORMATIVO DEL 3 ANNO - CLASSE 3 A L LSSA A. S. 2015/2016 Tempi Moduli Unità /Segmenti MODULO 0: Ripasso e consolidamento di argomenti del biennio MODULO 1: Il moto dei corpi e le forze. (Seconda
PERCORSO FORMATIVO DEL 3 ANNO - CLASSE 3 A L LSSA A. S. 2015/2016 Tempi Moduli Unità /Segmenti MODULO 0: Ripasso e consolidamento di argomenti del biennio MODULO 1: Il moto dei corpi e le forze. (Seconda
Statica ed equilibrio dei corpi
 Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
Cosa succede se ad un corpo applichiamo una forza?
 LE FORZE Cosa succede se ad un corpo applichiamo una forza? Se ad un corpo applichiamo una forza, essa può: 1. mettere in moto il corpo se è fermo 2. modificare il movimento del corpo se è già in moto
LE FORZE Cosa succede se ad un corpo applichiamo una forza? Se ad un corpo applichiamo una forza, essa può: 1. mettere in moto il corpo se è fermo 2. modificare il movimento del corpo se è già in moto
MECCANICA QUANTISTICA
 La Meccanica MECCANICA: Studio del moto di un corpo in tutti i suoi aspetti. Si divide in: STATICA: Forze e Equilibrio. Studia delle condizioni per l equilibrio (corpi fermi). CINEMATICA: Descrizione il
La Meccanica MECCANICA: Studio del moto di un corpo in tutti i suoi aspetti. Si divide in: STATICA: Forze e Equilibrio. Studia delle condizioni per l equilibrio (corpi fermi). CINEMATICA: Descrizione il
Classificazione delle Galassie
 Classificazione delle Galassie La classificazione delle galassie può essere condotta secondo diversi criteri, quali la dimensione, la morfologia e il tipo di radiazione maggiormente emessa; comunemente
Classificazione delle Galassie La classificazione delle galassie può essere condotta secondo diversi criteri, quali la dimensione, la morfologia e il tipo di radiazione maggiormente emessa; comunemente
SOLE, struttura e fenomeni
 SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
Spettro delle onde elettromagnetiche. Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione
 Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton
 Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
Dinamica: Forze e Moto, Leggi di Newton La Dinamica studia il moto dei corpi in relazione il moto con le sue cause: perché e come gli oggetti si muovono. La causa del moto è individuata nella presenza
Unità 2 - L ambiente celeste
 Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Astronomia Lezione 9/1/2012
 Astronomia Lezione 9/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B.
Astronomia Lezione 9/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B.
Esame di Fisica I Totale (1^ appello estivo) e Secondo Parziale
 Esame di Fisica I Totale (1^ appello estivo) e Secondo Parziale Corso di Laurea in Chimica, 8/06/015 NB: Scrivere'sempre'il'proprio'nome'e'cognome'su'ogni'foglio.'Spiegare,'quanto'possibile,'il' procedimento'per'giungere'ai'risultati.'ordine'e'chiararezza'sono'elementi'di'valutazione.'
Esame di Fisica I Totale (1^ appello estivo) e Secondo Parziale Corso di Laurea in Chimica, 8/06/015 NB: Scrivere'sempre'il'proprio'nome'e'cognome'su'ogni'foglio.'Spiegare,'quanto'possibile,'il' procedimento'per'giungere'ai'risultati.'ordine'e'chiararezza'sono'elementi'di'valutazione.'
Fondamenti di Astrofisica
 Fondamenti di Astrofisica Lezione 12 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) Come visto nella prima lezione l HUDF è l esposizione più profonda
Fondamenti di Astrofisica Lezione 12 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) Come visto nella prima lezione l HUDF è l esposizione più profonda
Meccanica classica. Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dip. DiSAAT - Ing. Francesco Santoro Corso di Fisica
 Meccanica classica A differenza della cinematica in cui i moti sono descritti solo geometricamente attraverso l uso dei vettori posizione, velocità ed accelerazione, nella dinamica vengono analizzate le
Meccanica classica A differenza della cinematica in cui i moti sono descritti solo geometricamente attraverso l uso dei vettori posizione, velocità ed accelerazione, nella dinamica vengono analizzate le
DOMANDE PER CAPIRE LA FISICA
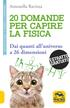 INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
UNIVERSO STATICO E UNIVERSO IN ESPANSIONE
 L UNIVERSO INDICE ARGOMENTI: BIG BANG UNIVERSO STATICO E IN ESPANSIONE TEORIA DELLO STATO STAZIONARIO TEORIA DELLA MATERIA OSCURA LE STELLE E LA LORO EVOLUZIONE STELLE DOPPIE BUCHI NERI UNIVERSI PARALLELI
L UNIVERSO INDICE ARGOMENTI: BIG BANG UNIVERSO STATICO E IN ESPANSIONE TEORIA DELLO STATO STAZIONARIO TEORIA DELLA MATERIA OSCURA LE STELLE E LA LORO EVOLUZIONE STELLE DOPPIE BUCHI NERI UNIVERSI PARALLELI
L'EVOLUZIONE STELLARE
 L'EVOLUZIONE STELLARE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) La vita delle stelle è condizionata dalla loro massa e dalla tendenza inesorabile al collasso causato dal peso degli strati
L'EVOLUZIONE STELLARE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) La vita delle stelle è condizionata dalla loro massa e dalla tendenza inesorabile al collasso causato dal peso degli strati
Astronomia Lezione 17/10/2011
 Astronomia Lezione 17/10/2011 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B. W. Carroll, D. A. Ostlie, Addison Wesley
Astronomia Lezione 17/10/2011 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics B. W. Carroll, D. A. Ostlie, Addison Wesley
F 9, N w. m p. r p 2 n
 campo magnetico planetario nel Sistema Solare Sostituendo i valori numerici nella espressione della forza giroscopica, per la Terra si ottiene : F 9,44 0 5 N w valore assolutamente trascurabile rispetto
campo magnetico planetario nel Sistema Solare Sostituendo i valori numerici nella espressione della forza giroscopica, per la Terra si ottiene : F 9,44 0 5 N w valore assolutamente trascurabile rispetto
Gravità e moti orbitali. Lezione 3
 Gravità e moti orbitali Lezione 3 Sommario Brevi cenni storici. Le leggi di Keplero e le leggi di Newton. La forza di gravitazionale universale e le orbite dei pianeti. 2 L Universo Geocentrico La sfera
Gravità e moti orbitali Lezione 3 Sommario Brevi cenni storici. Le leggi di Keplero e le leggi di Newton. La forza di gravitazionale universale e le orbite dei pianeti. 2 L Universo Geocentrico La sfera
LE DISTANZE ASTRONOMICHE
 LE DISTANZE ASTRONOMICHE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione La misurazione delle distanze dei corpi celesti, dalla scala galattica a quella cosmologica, è molto importante in astronomia
LE DISTANZE ASTRONOMICHE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione La misurazione delle distanze dei corpi celesti, dalla scala galattica a quella cosmologica, è molto importante in astronomia
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia
 Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
L ORIGINE DELLA LUNA
 LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
Esperienza del viscosimetro a caduta
 Esperienza del viscosimetro a caduta Parte del corso di fisica per CTF dr. Gabriele Sirri sirri@bo.infn.it http://ishtar.df.unibo.it/uni/bo/farmacia/all/navarria/stuff/homepage.htm Esperienza del viscosimetro
Esperienza del viscosimetro a caduta Parte del corso di fisica per CTF dr. Gabriele Sirri sirri@bo.infn.it http://ishtar.df.unibo.it/uni/bo/farmacia/all/navarria/stuff/homepage.htm Esperienza del viscosimetro
GRAVITAZIONE INTRODUZIONE ALLA FISICA 2. Dott.ssa Elisabetta Bissaldi
 GRAVITAZIONE INTRODUZIONE ALLA FISICA 2 Dott.ssa Elisabetta Bissaldi Corso di Fisica 2 Testi consigliati: MAZZOLDI NIGRO VOCI Elementi di FISICA Elettromagnetismo TIPLER MOSCA Corso di fisica 2 HALLIDAY
GRAVITAZIONE INTRODUZIONE ALLA FISICA 2 Dott.ssa Elisabetta Bissaldi Corso di Fisica 2 Testi consigliati: MAZZOLDI NIGRO VOCI Elementi di FISICA Elettromagnetismo TIPLER MOSCA Corso di fisica 2 HALLIDAY
VELOCITA' DI FUGA E RAGGIO DELL'ORIZZONTE DEGLI EVENTI SECONDO LA FISICA CLASSICA
 VELOCITA' DI FUGA E RAGGIO DELL'ORIZZONTE DEGLI EVENTI SECONDO LA FISICA CLASSICA Per sfuggire all'attrazione gravitazionale di un corpo celeste ( come una stella o un pianeta) occorre possedere una velocità
VELOCITA' DI FUGA E RAGGIO DELL'ORIZZONTE DEGLI EVENTI SECONDO LA FISICA CLASSICA Per sfuggire all'attrazione gravitazionale di un corpo celeste ( come una stella o un pianeta) occorre possedere una velocità
FISICA. STATICA Le forze. Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica
 FISICA STATICA Le forze Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica L EFFETTO DELLE FORZE Una forza applicata a un oggetto fermo può fare aumentare la sua velocità; mentre applicata
FISICA STATICA Le forze Autore: prof. Pappalardo Vincenzo docente di Matematica e Fisica L EFFETTO DELLE FORZE Una forza applicata a un oggetto fermo può fare aumentare la sua velocità; mentre applicata
Tra le soluzioni pervenute pubblichiamo, con le dovute correzioni e precisazioni, quella inviata da Raffaele Campanile, perché ritenuta la più
 Tra le soluzioni pervenute pubblichiamo, con le dovute correzioni e precisazioni, quella inviata da Raffaele Campanile, perché ritenuta la più completa. I dati forniti permettevano di arrivare alla soluzione
Tra le soluzioni pervenute pubblichiamo, con le dovute correzioni e precisazioni, quella inviata da Raffaele Campanile, perché ritenuta la più completa. I dati forniti permettevano di arrivare alla soluzione
AFAM - Remanzacco. Serata osservativa del 19 novembre
 AFAM - Remanzacco Serata osservativa del 19 novembre Cielo del 19 novembre a Remanzacco Galassie M 31 - M 32 Urano Nettuno Miram Phi Tauri Nebulosa M 76 Stella Polare Ammasso M 15 Doppio Ammasso del Perseo
AFAM - Remanzacco Serata osservativa del 19 novembre Cielo del 19 novembre a Remanzacco Galassie M 31 - M 32 Urano Nettuno Miram Phi Tauri Nebulosa M 76 Stella Polare Ammasso M 15 Doppio Ammasso del Perseo
Notiamo che, per una massa che rotorivoluisca sull orbita senza scorrimento, per la componente giroscopica, con V n. v p
 Natura fisica ed espressione della forza di Lorentz, calcolo del campo magnetico nucleare Abbiamo visto che, se applichiamo il principio di conservazione del momento angolare nello spazio, se la massa
Natura fisica ed espressione della forza di Lorentz, calcolo del campo magnetico nucleare Abbiamo visto che, se applichiamo il principio di conservazione del momento angolare nello spazio, se la massa
988,7 Km ; T 0S. 27, 11 al, con un periodo esattamente
 Coordinate cosmiche del Sistema Solare e caratteristiche di moto del Sole Questo vuol dire che, anche se essa risponde alla definizione di materia, non emette alcuna radiazione sulle frequenze che noi
Coordinate cosmiche del Sistema Solare e caratteristiche di moto del Sole Questo vuol dire che, anche se essa risponde alla definizione di materia, non emette alcuna radiazione sulle frequenze che noi
Come si scopre l esistenza della materia oscura? di Daniele Gasparri
 Come si scopre l esistenza della materia oscura? di Daniele Gasparri Circa il 90% della materia contenuta nell intero Universo non si riesce ad osservare direttamente poiché non emette radiazione elettromagnetica
Come si scopre l esistenza della materia oscura? di Daniele Gasparri Circa il 90% della materia contenuta nell intero Universo non si riesce ad osservare direttamente poiché non emette radiazione elettromagnetica
La Terra nello spazio
 La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
I Diagrammi HR. Russell. Hertzsprung
 Diagramma H-R I Diagrammi HR La scoperta più importante in campo astronomico risale al 1913, quando il danese Enjar Hertzsprung e l americano Henry Norris Russell, indipendentemente l uno dall altro, confrontarono
Diagramma H-R I Diagrammi HR La scoperta più importante in campo astronomico risale al 1913, quando il danese Enjar Hertzsprung e l americano Henry Norris Russell, indipendentemente l uno dall altro, confrontarono
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Junior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Junior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Junior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
I.I.S. N. BOBBIO DI CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S
 I.I.S. N. BOBBIO DI CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S. 2014-15 DISCIPLINA: FISICA (Indirizzo linguistico) CLASSE: TERZA (tutte le sezioni) COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA CONTENUTI ORGANIZZATI PER
I.I.S. N. BOBBIO DI CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S. 2014-15 DISCIPLINA: FISICA (Indirizzo linguistico) CLASSE: TERZA (tutte le sezioni) COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA CONTENUTI ORGANIZZATI PER
I buchi ne!: piccoli. e gran" cannibali
 I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
Alla ricerca di un altra Terra!
 Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
