RIVISTA BIMESTRALE D INFORMAZIONE SCIENTIFICA a cura dell Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia
|
|
|
- Tommasina Moro
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Anno 8 - n. 5 - Ottobre 2005 RIVISTA BIMESTRAE D INFORMAZIONE SCIENTIFICA a cura dell Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione ombardia Regione ombardia Direzione Generale Sanità - Servizio Veterinario Istituto Zooprofilattico Sperimentale della ombardia e dell Emilia Romagna Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale - Via Bianchi, Brescia
2 S ommario Anno 8 - n. 5 - Ottobre 2005 RIVISTA BIMESTRAE D INFORMAZIONE SCIENTIFICA a cura dell Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione ombardia 3 Editoriale Regione ombardia Direzione Generale Sanità - Servizio Veterinario Istituto Zooprofilattico Sperimentale della ombardia e dell Emilia Romagna Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale - Via Bianchi, Brescia 4 Risultati del piano straordinario di controllo su latte UHT in ombardia di G. Bolzoni, G. Varisco, C. Bonacina, M. Astuti, M. Marchetti Direttore responsabile Cesare Bonacina Direttore scientifico Ezio odetti Redattore Giorgio Zanardi Responsabile comitato redazione Giorgio Zanardi Comitato di redazione M. Astuti, P. Cordioli, M. Domenichini, P. Antoniolli,. Gemma, C. Genchi, G. Gridavilla, A. avazza, A. Palma, V.M. Tranquillo 8 Un Sistema di Sorveglianza per infestazioni da Ixodidae: approccio allo studio sulla prevalenza di alcune patologie nella AS 2 di ucca di M. Selmi 16 Notizie da Internet Hanno collaborato a questo numero G. Bolzoni, G. Varisco, C. Bonacina, M. Astuti, M. Marchetti, M. Selmi Segreteria di redazione M. Guerini. Marella Fotocomposizione e Stampa Editrice Vannini - Gussago (BS) Editore Istituto Zooprofilattico Sperimentale della ombardia ed Emilia Romagna Bruno Ubertini Tutti coloro che vogliono scriverci, devono indirizzare le lettere al seguente indirizzo: OSSERVATORIO rubrica a posta dei lettori, via Bianchi, Brescia - tel ; oppure utilizzare la posta elettronica: oevr@oevr.org Osservatorio e i numeri del precedente Bollettino Epidemiologico possono essere consultati anche sul sito web
3 Editoriale Questo numero si apre con il resoconto della sorveglianza applicata alla filiera del latte, in particolare quello UHT, a seguito di segnalazioni di adulterazioni rilevate nei prodotti di un centro di produzione lombardo. E un esempio di intervento attivato dai servizi veterinari regionali per conoscere in tempi rapidi la conformità sanitaria sul territorio di un particolare tipo di prodotto, che ha coinvolto il laboratorio qualità latte dell IZS di Brescia nell esecuzione delle analisi e in una prima valutazione del rischio. attività svolta rientra nella logica della gestione del sistema di allerta della regione ombardia in campo alimentare (Decreto Dir. Gen. Sanità n del 23/12/1999; Decreto Dir. Gen. Sanità n del 20/04/2005). articolo sui risultati della sorveglianza concernente le infestazioni da Ixodidae, eseguita nell arco di due anni presso la AS 2 di ucca, è un esempio di collaborazione istituzionale tra Dipartimento di Prevenzione e le UU.OO. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero dell AS. ecosistema in cui vivono le zecche, vettori di malattie alla popolazione umana, è stato indagato al fine di conoscere le possibili correlazioni uomo-vettore-ambiente in termini di persistenza del parassita e dei possibili contatti con l uomo. Quello che piace rilevare di questo lavoro è l approccio interdisciplinare e la costruzione del sistema di sorveglianza, che può essere un punto di riferimento utile per i colleghi veterinari lombardi, che fossero interessati ad approfondire tematiche di sanità pubblica sul loro territorio di competenza. G. Zanardi OSSERVATORIO 3
4 Risultato del piano di controllo sul latte UHT in ombardia G. Bolzoni 1, G. Varisco 1, C. Bonacina 1, M. Astuti 2, M. Marchetti 2 Premessa A seguito d informazioni parziali, inerenti un indagine giudiziaria in corso e relative ad un caso d adulterazione di latte a lunga conservazione in un centro di produzione nel territorio lombardo, la Direzione Generale Sanità U.O. Veterinaria della regione ombardia ha ritenuto opportuno effettuare un primo ed immediato intervento di controllo sui prodotti della medesima tipologia presenti sul mercato. A tale scopo, cinque Dipartimenti Veterinari delle AA.SS.. furono incaricati di eseguire un campionamento nei punti di vendita di latte U.H.T., finalizzato a raccogliere in tempi brevi un quadro sintetico delle caratteristiche qualitative del prodotto presente in commercio, del rispetto dei requisiti legali per questa tipologia di latte ed, eventualmente, di evidenziare la presenza di prodotti in qualche misura collegabili al caso d adulterazione. attività di prelievo estesa a tutto il territorio regionale si è quindi sovrapposta, soltanto in termini cronologici, a quella già in atto da parte dei N.A.S. Carabinieri e delle stesse Autorità Sanitarie impegnate nelle indagini relative al caso specifico. Il quadro risultante dalla realizzazione del piano di controllo straordinario, basato sugli esiti analitici ottenuti dai laboratori dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della ombardia ed Emilia Romagna di Brescia, costituisce una sorta di fotografia istantanea di questa tipologia di prodotto divenuto, nel corso dell ultimo decennio, quello a più larga diffusione nel settore commerciale del latte alimentare. Pur se con i limiti di un controllo casuale ed occasionale, pertanto non statisticamente rappresentativo dell intera realtà commerciale, pare interessante fornire una sintesi dei risultati ottenuti. E altresì necessario sottolineare che le analisi eseguite non rappresentano l intero panorama delle possibili determinazioni analitiche e dei controlli eseguibili per definire la qualità del latte, ma sono state finalizzate allo scopo di individuare specifiche situazioni di non conformità. campioni (ciascuno composto di 5 aliquote ognuna delle quali di 6 unità campionarie) caratterizzabili come da tabella 1. Tutti i campioni prelevati appartenevano a stabilimenti di produzione nazionali; sono stati differenziati Produttori e Distributori perché, in questo settore, è abbastanza diffusa la commercializzazione di prodotti con differente denominazione (marchi commerciali spesso relativi ad aziende della grande distribuzione o a nomi di fantasia), che derivano però da un medesimo stabilimento di trattamento del latte e di confezionamento. Su tutti i campioni è stato programmato un pannello base di analisi che comprendeva: - Determinazione quantitativa di Grasso, Proteine, attosio e Caseine (Metodo Infrarosso FTIR); per definire le caratteristiche compositive e quindi nutritive, nonché per verificare il rispetto dei requisiti minimi normativi per le differenti categorie commerciali. - Determinazione quantitativa di Acidità SH/ 50 ml eph (Titolazione e Metodo Potenziometrico); per valutare lo stato di conservazione, di eventuali alterazioni indotte da moltiplicazione batterica e, in via presuntiva, di ipotizzate adulterazioni con utilizzo di siero di latte o latticello. - Determinazione quantitativa del Punto Crioscopico (metodo termistore); per la verifica della presenza di acqua estranea ed indirettamente la valutazione di composizioni anormali relative alla composizione salina. - Determinazione qualitativa della Perossidasi (metodo enzimatico); per la conferma dell avvenuto trattamento termico e della sua congruità alla categoria di latte Ultra High Temperature. - Prova di sterilità ai sensi del D.M. 26/03/1992 (metodo microbiologico, conta in piastra); per la determi- Tabella 1. Distribuzione dei campioni di latte UHT esaminati Realizzazione del Piano Dal 11 al 16 marzo 2005, i Servizi Veterinari delle AA.SS.. di Brescia, Bergamo, Milano, Mantova e ecco hanno prelevato presso diversi punti di vendita, prevalentemente della grande distribuzione, 56 Sanità animale 4 OSSERVATORIO
5 nazione quantitativa della Carica Batterica Aerobia Mesofila, dopo incubazione a 30 C per 15 giorni. Finalizzato a verificare il rispetto del limite legale e quindi la proprietà del trattamento termico eseguito. Parametro determinato su 5 aliquote al fine di ottenere una più accurata stima delle eventuali contaminazioni batteriche.a determinazione delle caseine (e conseguentemente del rapporto caseine/proteine) è stata eseguita, aldilà della definizione delle caratteristiche nutritive, con un fine sperimentale: dalla valutazione dell Indice di Caseina s ipotizzava di poter dedurre, in modo indiretto, un indicazione relativa al tipo d adulterazione che ha originato il piano di controllo. In particolare, ipotizzando l aggiunta di componenti del latte provenienti da altri processi produttivi ed in particolare di siero o latticello, si è supposto che il normale rapporto caseine/proteine sarebbe stato significativamente alterato. Non disponendo di campioni di latte adulterato non era, ovviamente, possibile avere riferimenti certi sul tipo di composizione da ricercare, ma ciononostante si è ritenuto interessante evidenziare l eventuale presenza di composizioni anomale rispetto alle attese (una banale considerazione sui costi di caseine o caseinati da aggiungere al latte da adulterare rispetto al prezzo sul mercato del latte U.H.T. rende credibile quest ipotesi). Nel caso di esiti non rispondenti ai requisiti di legge o comunque considerabili come anormali, si era programmato di approfondire le indagini analitiche con un successivo pannello di conferma/approfondimento che comprendeva, a seconda del tipo di caratteristica anomala: - determinazione dell ammoniaca; - numerazione dei germi sporigeni anaerobi e solfito riduttori; - conteggio di Coliformi, E. coli, S. aureus; - ricerca di germi patogeni (Salmonella, isteria monocytogenes, etc.); - sieroproteine; - determinazione delle sieroproteine. Di fatto, il complesso degli esiti ottenuti non ha portato alla necessità di approfondire le analisi non essendosi presentati quadri di composizione o caratteristiche qualitative marcatamente anormali rispetto a quelle normalmente osservate nel corso delle attività di sorveglianza e monitoraggio da parte dei servizi veterinari o in quelle d autocontrollo sviluppate dei singoli produttori. unica eccezione ha riguardato i due campioni di latte U.H.T. ad Alta Digeribilità per i quali le analisi d approfondimento (sulla composizione proteica e glucidica volutamente e dichiaratamente modificate proprio per ottenere le caratteristiche di digeribilità dichiarate) sono state realizzate in conseguenza di limiti tecnici delle normali apparecchiature analitiche utilizzate per il latte. Risultati delle analisi Il risultato delle numerose determinazioni analitiche eseguite è riassunto nelle Tabelle seguenti. Il complesso delle rilevazioni ha evidenziato una situazione di conformità diffusa dei campioni analizzati rispetto tanto ai limiti di egge, per i parametri per i quali sono previsti, quanto per gli aspetti qualitativi generali. In particolare appare degna di nota l uniformità delle caratteristiche compositive (valori di Deviazione Standard, tabella 2) che testimoniano, per le diverse tipologie di prodotto, una certa standardizzazione del prodotto di differenti aziende. Dall analisi complessiva dei dati sono stati esclusi i due campioni di latte parzialmente scremato ad alta digeribilità nel quale, come detto, la composizione si discosta decisamente da quella del latte normale. Confortante è la completa assenza di residui di sostanze inibenti (farmaci, perlopiù di tipo antibiotico utilizzati per interventi terapeutici sulle bovine), che costituisce uno dei prerequisiti fondamentali non solo per il latte U.H.T. ma, più in generale, per qualunque tipo d alimento d origine animale. analisi più particolareggiata mostra comunque una certa variabilità di composizione nelle diverse categorie commerciali: l indice di caseina appare, ad esempio, sensibilmente superiore in alcuni Scremati rispetto alle altre tipologie, ma anche in questo caso non si possono escludere influenze sull esito analitico determinate dal particolare rapporto esistente tra le differenti componenti di questi prodotti rispetto al latte crudo ed intero che costituisce il riferimento classico della strumentazione analitica in uso in laborato- Tabella 2. Parametri compositivi: valori medi e spostamenti OSSERVATORIO 5 Sanità animale
6 Tabella 3. Altri parametri: valori medi e scostamenti rio. Pur tenendo conto di questi elementi d incertezza, pare degno di nota il fatto che nella tipologia P.S. e S. il latte U.H.T. sembra fornire un maggior apporto di componenti nutritive che vanno a compensare, almeno in parte, quella mancante a causa della sottrazione di sostanza grassa. indice di caseina nei campioni analizzati, pur se variabile, non ha evidenziato rapporti tra le componenti proteiche del latte che possano far pensare ad una composizione non genuina dei prodotti; i valori rientrano infatti nella normale variabilità che, nel corso dell anno, si può verificare nel latte crudo consegnato da differenti allevamenti. Purtroppo, l obiettivo per cui si è valutato l indice di caseina non ha potuto essere raggiunto a causa dell impossibilità ad eseguire un confronto con le caratteristiche del latte modificato oggetto dell indagine. Al fine di approfondire quest aspetto si ritiene comunque utile, una volta acquisite informazioni tecniche più particolareggiate, realizzare sperimentalmente in laboratorio la ricostruzione di un latte simile a quell oggetto dell indagine, così da verificare la possibilità di individuarlo attraverso la valutazione della sua composizione ed in particolare del suo rapporto caseine/proteine. Ciò permetterebbe di rendere disponibile un innovativa modalità di controllo sul latte in commercio utilizzando metodologie d analisi già disponibili ed ampiamente applicate per altre finalità. Anche l analisi degli altri parametri analitici (tabella 3) sembra confermare una situazione complessiva d uniformità tra i diversi prodotti sottoposti ad analisi. Degna di nota è la presenza di una tendenza ad un valore elevato d acidità titolabile nei prodotti parzialmente scremato e scremato che, seppur non possa essere considerata eccessiva che in pochi casi, appare indicativa di condizioni di stabilità del prodotto non proprio eccellenti. Una considerazione a parte merita invece il valore di crioscopia, soprattutto se si considera l esistenza di un limite legale (- 0,520 C) che, seppur definito in riferimento alle caratteristiche del latte crudo, è formalmente considerato valido anche per quello trattato termicamente. E noto che il trattamento termico comporta un effetto sul punto di congelamento del latte sia per un effettivo incremento della presenza d acqua estranea (collegata al contatto con gli impianti e, in parte, con il vapore utilizzato in alcuni dei procedimenti di termizzazione) sia per la modifica strutturale che induce in alcune delle componenti del latte che partecipano, poi, alla costruzione della struttura cristallina nella fase di congelamento durante l analisi. Tali modifiche sono tendenzialmente maggiori in funzione dell intensità del trattamento termico e quindi più elevate nel latte U.H.T. che in quello pasteurizzato. Non è purtroppo possibile quantificare con precisione tale effetto, perché dipende oltre che da numerosi altri fattori, anche dal punto crioscopico iniziale del latte crudo di partenza che è di per se variabile. Ciononostante è considerato normale che un latte U.H.T. ottenuto da latte crudo conforme presenti, alla determinazione del punto di congelamento, un valore d alcuni millesimi di grado superiore. Tenendo conto di tali considerazioni, e della variabilità analitica, è possibile concludere che la maggioranza dei campioni controllati ha presentato un valore di crioscopia che può essere considerato normale in questa tipologia di prodotto. Soltanto in 5 campioni (appartenenti a 2 sole marche differenti) il valore osservato sembrerebbe eccessivo anche ad un interpretazione estensiva del limite legale applicato a latte U.H.T E evidente che questo argomento pone degli interrogativi e delle problematiche che rimangono aperte. Anche in questo caso quindi sembra opportuno avviare una forma di sperimentazione finalizzata a chiarire gli effetti delle diverse tipologie di trattamento termico sulle caratteristiche del punto crioscopico del latte, con lo scopo di fornire dei riferimenti certi per i controlli, sia ufficiali sia interni alle aziende di produzione, su un argomento che ha una valenza legale oltre che commerciale. Il test della perossidasi, negativo su tutti i campioni analizzati, conferma che tutto il latte analizzato ha subito un trattamento termico ad alta temperatura. Sanità animale 6 OSSERVATORIO
7 a percentuale di cloruri è risultata sostanzialmente uniforme nei differenti campioni con valori che si attestano attorno a quelli normalmente osservati nel latte della nostra area geografica (0,16-0,17 %). Un solo campione di latte parzialmente scremato si è discostato da tali indici con una concentrazione di 0,20%; elevata seppur non in modo abnorme. Questo parametro può essere utilizzato per il latte di singolo animale per valutazioni indirette delle condizioni sanitarie della mammella (subisce, infatti, significative variazioni nel corso di processi mastitici). Ovviamente nel latte dell intero allevamento vi possono essere variazioni sensibili soltanto se la percentuale di animali contemporaneamente interessati da processi mastitici è elevata. A maggior ragione è decisamente difficile che tali alterazioni si possano osservare nel prodotto in vendita, dopo il trattamento termico, perché sono la risultante della miscelazione del prodotto di più allevamenti. Il medesimo parametro potrebbe però essere utilizzato, ricollegandolo al valore di crioscopia e del tenore in attosio, per individuare situazioni di annacquamento (diminuzione significativa della concentrazione salina) oppure di aggiunta fraudolenta di sostanze liquide la cui composizione salina è riportata a quella del latte tramite un aggiunta, appunto, della componente salina; in quest ultimo caso una correzione eseguita in modo grossolano potrebbe modificare sensibilmente la naturale concentrazione salina del latte che, come osservato anche con questa indagine, è invece sostanzialmente costante. Per quanto riguarda la contaminazione batterica, tutti i campioni sono risultati entro i limiti di contaminazione previsti dalla Normativa (DPR 54/97 uguale o inferiore a 10 UFC/ 0,1 ml). Il conteggio batterico è eseguito dopo l incubazione dei campioni a 30 C per 15 giorni in modo da creare le condizioni più favorevoli alla moltiplicazione d eventuali microrganismi presenti nel prodotto e simulare, di fatto, una condizione di conservazione particolarmente sfavorevole al prodotto in esame (condizione che di norma non si realizza nei punti di vendita, ma che è possibile dopo l apertura del prodotto da parte del consumatore se non è rispettata la temperatura di refrigerazione). Soltanto 4 campioni hanno mostrato una crescita batterica, comunque inferiore al limite previsto dalla normativa. E da sottolineare che in questi 4 casi, tutti riguardanti il latte parzialmente scremato, soltanto una delle 5 aliquote esaminate ha mostrato crescita batterica (1 UFC/0,1ml in 2 casi, 1,5 UFC/0,1ml in uno e 20 UFC/0,1ml in un ultimo caso). Dato il numero limitato di batteri presenti e la loro presenza in una sola delle aliquote analizzate per ciascun campione, è inoltre possibile, da un punto di vista statistico, che tali contaminazioni possano avere origine accidentale e si siano verificate nel corso dell analisi. OSSERVATORIO In funzione del ridottissimo livello di contaminazione batterica osservata non si è quindi ritenuto necessario procedere ad ulteriori indagini per la tipizzazione dei microrganismi e per la ricerca d eventuali patogeni. Conclusioni intervento in emergenza presenta, ovviamente, limiti ed imperfezioni dettate dal carattere d urgenza e, perlomeno in questo caso, dalla non precisa conoscenza del tipo di problema da affrontare (di fatto, nemmeno oggi è ufficialmente noto il tipo d adulterazione che è stata messa in atto né la quantità di prodotto immessa in commercio, trattandosi d elementi parte di un indagine giudiziaria in corso). E quindi a nostro avviso da sottolineare il fatto che sulla base delle poche informazioni disponibili si sia comunque voluto realizzare un primo intervento di controllo. In questo modo si è ottenuta quasi in tempo reale un prima sommaria valutazione delle caratteristiche del prodotto in commercio. E inoltre emersa la possibilità di ottenere, attraverso opportune sperimentazioni, informazioni specifiche (indice di caseina e punto crioscopico in particolare) che potrebbero costituire una nuova forma di controllo, semplice e rapido, sul prodotto in commercio. E evidente che se da quest indagine fosse emersa la presenza, occasionale o diffusa, di prodotti non conformi ai requisiti della normativa vigente oppure in qualche modo ricollegabili all adulterazione sotto indagine si sarebbero potuti mettere in atto rapidamente interventi incisivi e finalizzati alla difesa della salute del consumatore. Di fatto, l insieme delle osservazioni realizzate non ha fatto emergere situazioni da ritenere anche solo potenzialmente rischiose per la salute pubblica e pertanto si è confermato che, nel suo complesso, l attuale sistema di sorveglianza dei Servizi Veterinari sulle attività d autocontrollo messe in atto dalle strutture industriali assicura un apprezzabile livello di conformità. Concludere che il caso d adulterazione emerso di recente sia un caso unico ed isolato non è, evidentemente, possibile sulla sola base dei risultati di questo piano straordinario, ma è comunque certo che il pronto intervento realizzato in quest occasione ha consentito di fare il punto su una situazione potenzialmente preoccupante fornendo gli elementi decisionali per tarare il tipo, l intensità e le modalità di prosecuzione dei controlli ufficiali nel settore. 1.Istituto Zooprofilattico Sperimentale della ombardia e dell Emilia Romagna Brescia Centro di Referenza Nazionale Qualità atte Bovino 2.Direzione Generale Sanità Regione ombardia, U.O. Veterinaria 7 Sanità animale
8 Un sistema di sorveglianza per infezione da Ixodidae: approccio allo studio sulla prevalenza di alcune patologie nella AS 2 di ucca Il lavoro presenta i dati ottenuti in due anni di attività di un Sistema di Sorveglianza per le infestazioni da Ixodidae istituito in collaborazione tra Dipartimento della Prevenzione e UU.OO. di Pronto Soccorso della AS 2 di ucca. Il risultato del lavoro ha fornito dati, finora mai rilevati, sulle specie di zecche ritrovate sui pazienti, sugli habitat a rischio, sulle persone più esposte, indispensabile approccio al dimensionamento del rischio acarologico per la popolazione residente. Introduzione a stima del rischio di contrarre una malattia trasmessa da zecche per la popolazione umana residente in una determinata zona oggetto di studio, può essere ottenuta solo con accurate indagini ambientali, attraverso le quali si ricavano dati su densità, distribuzione e prevalenza di patogeni, sia nei vettori sia nei serbatoi vertebrati. Alcune valutazioni preliminari dovrebbero comunque essere condotte per stimare la frequenza di infestazioni nella popolazione residente. In assenza di dati originali, la costituzione di un Osservatorio dedicato a queste problematiche può risultare uno strumento estremamente utile, permettendo di ottenere informazioni indispensabili per orientarsi in questa fase iniziale dello studio. Per tale finalità presso l AS 2 di ucca è stato istituito un Sistema di Sorveglianza per le infestazioni da Ixodidae in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione e la U.O. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, che ha permesso, nel biennio , di ottenere dati relativi a 684 episodi di puntura da zecca ed ha fornito elementi utili a stimare il rischio del contatto con zecche, quali frequentazione di habitat, svolgimento di particolari attività o categorie esposte, nonché relativi alla prospettiva di rischio biologico, attraverso la statistica delle specie classificate. Oltre a questo aspetto l attivazione del Sistema di Sorveglianza ha contribuito a mantenere alta l attenzione sulle patologie veicolate da zecche all interno del Presidio Ospedaliero ed il maggior coinvolgimento ha influito positivamente sull efficacia e completezza dei flussi relativi. Questo risultato è ancora più interessante in considerazione della difficoltà di applicare un sistema di prevenzione diretto e standardizzato verso alcune patologie trasmesse da Ixodidae ed in M. Selmi 1 questo caso, una maggior attenzione sul rischio di infezione, costituisce una premessa indispensabile per realizzare un efficace profilassi delle malattie trasmesse da questo parassita. Caratteristiche dell area oggetto di studio Il rischio di raccogliere una zecca è collegato alla frequentazione di determinati habitat. In effetti, prima ancora che associate agli ospiti, le zecche sono collegate a particolari ambienti bioclimatici terrestri, ognuno dei quali subordinato a fattori abiotici (altitudine, piovosità, uso del territorio) e biotici (presenza di animali domestici, selvatici e di reservoir, copertura vegetazionale). Oltre alla normale variabilità delle condizioni microclimatiche su aree di ampie dimensioni, la provincia di ucca offre un territorio particolarmente diversificato. a sua posizione, all estremo nord della Toscana, tra il Mar igure Meridionale e lo spartiacque dell Appennino Tosco-Emiliano, nonché la distribuzione altitudinale, che eguaglia quella di certe province alpine, le conferiscono un clima mesotermale-umido, cioè a regime temperato, senza grossi sbalzi fra estate ed inverno, caratterizzato da forte piovosità. a prossimità della costa mediterranea induce un evidente contenimento dell escursione di temperatura giornaliera, mentre la vicinanza della dorsale appenninica è responsabile delle precipitazioni nell entroterra. In definitiva, ad un regime climatico classicamente mediterraneo, si associa un regime meteorico con caratteristiche sub-alpine. a densità di popolazione varia notevolmente, da circa 500 abitanti per kmq nel capoluogo, fino a scendere a densità medie fra cinquanta e cento unità nelle zone montuose, che rappresentano circa l 80% del territorio lucchese. Relativamente all economia locale, l abbandono delle attività agricole e zootecniche nella zona montana, che comunque è progressivo e relativo all intera provincia, è seguito con maggior difficoltà da modelli produttivi delle zone industrializzate, con i rischi di spopolamento ed abbandono di aree sempre più vaste. a presenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane e della zona protetta del Parco dell Orecchiella, indicano la volontà di controllare questo fenomeno e favorire il recupero ambientale. Circa la presenza di animali selvatici è attualmente in corso la costituzione di Sanità animale 8 OSSERVATORIO
9 una carta dei selvatici da parte della Provincia di ucca, dedicata in particolare alla distribuzione e densità di ungulati. Comunque in tutta la Valle del Serchio il capriolo (Capreolus capreolus) ed il daino (Dama dama) costituiscono una popolazione ricca e diversificata dopo l introduzione di nuclei colonizzatori negli anni settanta-ottanta, come pure il cinghiale (Sus scrofa.). Gli altri Artiodattili presenti sono il cervo (Cervus elaphus) ed il muflone (Ovis musimon). Sono inoltre presenti Carnivori quali la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina), la puzzola (Putorius putorius), la martora (Martes martes), il tasso (Meles meles), la volpe (Vulpes vulpes) ed il lupo (Canis lupus). Tra i agomorfi è presente la lepre (epus europaeus) e tra i Roditori di grossa taglia l istrice (Hystrix cristata). Anche i micromammiferi sono ampiamente rappresentati sia da Insettivori come il riccio (Erinaceus europaeus), la talpa europea (Talpa europea), la talpa (Talpa caeca) ed alcune specie di toporagno, sia da Roditori come il campagnolo rossastro (Clethrinomys glareolus), l arvicola di Fatio (Microtus multiplex), l arvicola di Savi (Microtus savii), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il ghiro (Myoxus glis) il quercino (Eliomys quercinus), il moscardino (Muscardinus avellanarius) e lo scoiattolo (Sciurus vulgaris). a copertura vegetale è caratterizzata da boschi sia di antica matrice sia di più recente origine antropica e varia notevolmente in considerazione dell altimetria. In pianura e collina prevalgono boschi misti di cerro (Quercus cerris.), olmo (Ulmus carpinifolia), frassino (Fraxinus excelsior), pino nero (Pinus nigra Arnold), robinia (Robinia pseudoacacia.). Sopra questa fascia e fino a 1200 mt, il castagno (Castanea sativa Miller) è ben rappresentato come bosco ceduo o da frutto, spesso sostituito da robinieti. A quote ancora superiori e fino a 2000 si trova il faggio (Fagus selvatica.), il larice (arix decidua Miller) e l abete bianco (Abies alba) e rosso (Picea abies). In definitiva sono presenti ecosistemi vari e differenziati, ognuno dei quali può favorire la colonizzazione da parte di un particolare genere di zecca. Tuttavia le condizioni ambientali, soprattutto nella zona montana, appaiono favorevoli alla colonizzazione di quelle ixodidae il cui sviluppo è condizionato da alta umidità relativa, come Ixodes ricinus e per la quale è ben definito il biotopo di elezione, che in quest area ricorre comunemente. Scopo della ricerca Il Sistema di Sorveglianza è stato ideato al fine di ottenere dati relativi all ixodofauna locale, alle attitudini all antropofilia delle specie presenti sul territorio della AS 2 ed alla relazione con eventuali patologie correlabili; più in particolare sulla distribuzione di Ixodes ricinus vettore di borreliosi di yme (B, usato di seguito come sinonimo per l infezione da Borrelia burdogferi sensu lato), la malattia nei confronti della quale si ha in zona un sospetto di sottonotifica rispetto ai dati in possesso. a tabella 1 riporta l incidenza dei casi per abitanti dal 1995 al 2001 e relativi alle due patologie trasmesse da zecche presenti sul territorio della AS2 di ucca, la B e la rickettsiosi da R. conori, posti a confronto con la statistica regionale. Nei confronti di B la sieropositività nella popolazione italiana è stimabile attorno al 5%, con estremi molto variabili secondo il campione esaminato. Si passa, infatti, da valori dello 0.3% in Emilia (Parma), al 2% in Sicilia, al 3.2% della ombardia, al 4.1% dell area bolognese, fino a giungere a livelli superiori al 10% in popolazioni residenti in aree endemiche o sottoposti ad elevato rischio per motivi professionali, come i forestali in Toscana e in Friuli, con una media rispettivamente del 18% e 22.3%. In effetti, i dati relativi alla B in Toscana, mostrano la tendenza all aumento tipica delle aree endemiche. Inoltre uno studio condotto sulla prevalenza di alcune patologie trasmesse da zecche in operatori forestali in 10 aree della Toscana, ha permesso di rilevare i più alti tassi per B, tra il 20.9% e 29.4% degli operatori testati, nelle stazioni di San Marcello Pistoiese, Abetone, Fivizzano: delle dieci stazioni considerate nello studio queste tre sono le più vicine alla zona montana lucchese, la Garfagnana, sia geograficamente sia per caratteristiche ambientali. Sulla base di questi elementi, trend regionale per B e sieroprevalenze oltre la media per la categoria di lavoratori esposti testata nella zona, è possibile formulare un dubbio di sottostima della patologia rispetto ai dati AS 2 della ta- Tabella 1. Incidenza dei casi per abitanti dal 1995 al 2001 e relativi alle due patologie trasmesse da zecche presenti sul territorio della AS2 di ucca, la B e la rickettsiosi da R. conori, posti a confronto con la statistica regionale. OSSERVATORIO 9 Sanità animale
10 bella 1, pur in assenza di casistica clinica, che come è noto è riconducibile a difficoltà diagnostiche relative alle manifestazioni spesso in forma sub clinica o paucisintomatica della malattia. Pertanto, in assenza di uno studio sulla sieroprevalenza di B nella popolazione residente nella zona, per definire se tale patologia possa rappresentare un problema di sanità pubblica nella AS 2 di ucca, è stato effettuato uno studio preliminare con l obiettivo di stimare la frequenza delle punture da zecca. Ogni esemplare estratto dai vari pazienti che si recavano al Pronto Soccorso è stato classificato; contemporaneamente è stata svolta un indagine epidemiologica per assumere elementi sulle caratteristiche ambientali del sito di presunta raccolta della zecca, sui dati anagrafici del paziente, sull eventuale sintomatologia conseguente alla puntura. Materiali e Metodi Nel periodo da maggio 2002 a novembre 2003 si è proceduto alla raccolta degli esemplari di zecca estratti dai pazienti afferiti alle Unità Operative di Pronto Soccorso delle sedi di ucca, per la Zona Piana, e di Barga e Castelnuovo Garfagnana, per la Zona Valle del Serchio. a tecnica di rimozione utilizzata prevedeva la forzatura con pinza posta alla base del rostro e leggera rotazione ed estrazione. Non sono mai stati utilizzati presidi di qualsiasi genere o metodi che potessero provocare distacco spontaneo della zecca o dar seguito a rigurgito. I campioni raccolti sono stati inviati per classificazione a Grosseto, U.F. Zoologia Ambientale. e indagini epidemiologiche sono state condotte da Assistenti Sanitarie delle varie Zone di competenza territoriale con due interviste telefoniche a distanza di circa 30 gg, rilevando i dati in una scheda d indagine predisposta. Tabella 2. Distribuzione dei casi osservati Risultati e discussione In tabella 2 è riportata la distribuzione dei casi osservati. I risultati ottenuti dall elaborazione dei dati relativi a 684 punture da zecca sono stati sintetizzati nei grafici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il grafico 1 riporta la distribuzione delle zecche ottenuta nella Zona Piana di ucca, la parte più urbanizzata e pianeggiante. Si nota che Ixodes costituisce il 78% dei campioni esaminati, Rhipicephalus 6.7%, Dermacentor 8.4%, Hyalomma 1%. a voce altro include campioni non riconoscibili o alti artropodi. Nella Zona Valle del Serchio (grafico 2), dove il territorio ha caratteristiche favorevoli allo sviluppo di Ixodes, questa zecca è presente in misura maggiore, l 84% rispetto a Rhipicephalus 2%, Dermacentor 1%. In questo caso non è stato possibile classificare il 13% dei campioni, una percentuale molto alta che ridistribuita sulle specie presenti, farebbe probabilmente pesare ancora di più la frazione Ixodes nella statistica. Il dato ottenuto non indica, in valore assoluto, in quale misura le specie di zecche sono distribuite sul territorio, ma piuttosto quali sono quelle prevalenti negli ambienti maggiormente frequentati dall uomo, pertanto ha ancora maggior interesse pratico al fine di individuare eventuali fattori di rischio per la popolazione residente. alta percentuale di Ixodes ricinus, ben rappresentata in entrambe le Zone, riflette anche quest ultimo aspetto, oltre ad essere giustificata dalle caratteristiche ambientali. E specie endo-esofila, praticamente priva di specificità parassitaria e nella zona montana lucchese la presenza di ungulati selvatici e domestici, il microclima fresco-umido, l abbondanza di castagneti che favoriscono l insediamento di numerosi micromammiferi, ne condizionano favorevolmente la diffusione. In queste aree, un fattore limitante tale diffusione risulta essere l altimetria, come dimostrano studi condotti presso il Parco dell Orecchiella, dove il ritrovamento di I. ricinus è raro sopra 1200 m. Dall osservazione dei casi, I. ricinus è parassita dell uomo a tutti gli stadi e la femmina adulta è risultata responsabile del 57% di tutte le infestazioni da ixodidae registrate, altri autori riportano il 60%, quindi proporzioni molto vicine. E vetto- Sanità animale 10 OSSERVATORIO % 8,4% Piana di ucca 6,7% 5,9% 1% Ixodes Dermacentor Rhipicephalus Hylomma Altro Grafico 1. Distribuzione delle zecche nella Piana di ucca
11 % Ixodes re accertato della borreliosi di yme, della meningoencefalite da zecche (TBE), della ehrlichiosi granulocitica umana (HGE) sostenuta da Anaplasma phagocytophilum, della febbre Q e di diverse specie di babesie tra cui B. microti e B. divergens. Rhipicephalus sanguineus è anch esso diffuso su tutto il territorio ed il suo habitat è costituito essenzialmente da un ambiente urbano o periurbano, dove il biotopo migliore risulta essere un canile o un recinto ospitante un cane e dove si riscontrano le infestazioni più evidenti. Particolarmente nella Piana di ucca, le segnalazioni relative ad inconvenienti per la presenza di questa zecca si concentrano nel periodo dalla seconda metà di maggio a tutto giugno ed è stato notato che le infestazioni più eclatanti si verificano in biotopi di recente orfani della presenza di un cane, dove in special modo gli adulti di R. sanguineus, per la loro attitudine alla ricerca attiva dell ospite, si rendono facilmente visibili nelle vicinanze delle abitazioni. A seguito di sopralluoghi la zecca viene reperita in crepe e fessurazioni della muratura, intonaci parzialmente distaccati ecc. ed anche all interno delle abitazioni dietro battiscopa, sciambrane delle porte ed avvolgibili. R. sanguineus si ritrova sui pazienti in genere allo stadio adulto, raramente di ninfa. o stadio larvale è stato osservato una sola volta in un neonato. E vettore della Febbre bottonosa del Mediterraneo sostenuta da R. conori, della febbre Q, dell ehrlichiosi da E. canis e di diverse babesiosi ed haemobartonellosi. Dermacentor marginatus è specie presente soprattutto in aree semidesertiche di montagna, predilige boschi aperti e pascoli fino alla quota di m 2500 s.l.m. In accordo con quanto riportato in letteratura sull uomo è stata ritrovata esclusivamente la forma adulta. Il OSSERVATORIO 84% Rhipicephalus Valle del Serchio 1% Dermacentor 13% Altro Grafico 2. Distribuzione delle zecche nella Valle del Serchio suo ruolo come vettore di patogeni è stato dimostrato per alcune specie di Babesia (B. caballi, B. equi, B. ovis), per Coxiella burneti e per diversi virus, ma non può essere escluso un ruolo anche nella trasmissione di Francisella tularensis.. Per Hyalomma la classificazione in questo studio è stata effettuata come genere. e specie più diffuse in Italia sono, allo stadio di adulto, parassiti di mammiferi domestici di grande taglia. E un vettore di trascurabile importanza per la nostra area geografica, anche se per Hyalomma marginatum si sospetta un ruolo marginale nella trasmissione della febbre bottonosa. E interessante rilevare che dalla statistica sono assenti morsicature da zecche molli, questo nonostante le infestazioni da Argas reflexus siano frequentemente segnalate nelle abitazioni del centro storico del capoluogo. Certamente le aggressioni all uomo da parte di Argasidi sono un evento più raro rispetto a quanto accade per gli Ixodidi, ma casi non rilevati potrebbero essere giustificati dal comportamento trofico delle zecche molli, che si nutrono di notte e solo per poche ore. Il grafico 3 riporta la distribuzione per fascia d età e presenta due picchi. Il primo, nella fascia tra 0-10 anni, si presume giustificato da alcuni fattori di peso diverso. Certamente il più importante riguarda l alta percentuale di casi presentati al Pronto Soccorso rispetto all incidenza. In effetti, la sensazione che deriva dalle interviste effettuate è che, soprattutto le categorie di persone particolarmente esposte al contatto con zecche, provvedano personalmente all estrazione, eludendo pertanto le statistiche. Al contrario, la maggior apprensione per le eventuali conseguenze sanitarie nei confronti dei pazienti più giovani, esita in segnalazioni più costanti. Inoltre, la cura del corpo del bambino, soprattutto nei casi di incompleta autosufficienza igienica, permette di svelare zecche che, per stadio o sede, sarebbero altrimenti di difficile localizzazione. In questa fascia di età sono state notate età (anni) Grafico 3. Distribuzione delle zecche per fascia di età 11 Sanità animale
12 Tabella 3. Confronto tra la distribuzione di Forme Immature e Zecche adulte in Adulti e Bambini Forme Immature Zecche Adulte Bambini Adulti X 2 =14.5, g.d.l=1, p-value= Bosco Prato Casa/Giardino Bosco e Prato Orto NO Grafico 4. Distribuzione della casistica rispetto all habitat con maggior frequenza le forme immature di zecca. In effetti, distribuendo i casi di zecche adulte e forme immature tra i pazienti divisi in due classi di età, inferiore ed uguale, oppure superiore a 10 anni, le differenze osservate con il test del X 2 sono risultate altamente significative (tabella 3). Il secondo picco, nella fascia anni, si ottiene dopo un progressivo e regolare aumento dei casi con l età ed è collegato allo svolgimento di attività lavorative ed hobbistiche con alto rischio per raccolta di zecche. A questo proposito le interviste hanno confermato che molti dei lavori agricoli a bassa redditività, come pulizia dei boschi, taglio di legname, lavorazione di piccoli appezzamenti, sono svolti da persone in pensione, per lo più su fondi di proprietà e che la loro disponibilità di tempo li espone per lunghi periodi in questi ambienti. Il fenomeno dell utilizzo del bosco sia per attività ricreative sia per integrare un reddito, è considerato un fattore di rischio molto importante anche in altri paesi europei dove è stato studiato. Il 65% degli individui infestati è risultato di sesso maschile. a distribuzione della casistica rispetto al tipo di habitat (grafico 4) è stata ottenuta, attraverso le interviste, riconducendo le zone frequentate ad alcune semplici tipologie: bosco, prato, casa/giardino.con bosco si intende un habitat dove prevalgono alberi di alto fusto, mentre la voce prato rappresenta habitat per lo più privi di alberature. Sotto la voce casa/giardino sono state aggregate tutte le attività svolte tra le mura domestiche o nel giardino, inoltre sono state inserite delle tipologie intermedie. Questa classificazione non può essere considerata esaustiva ed ogni habitat individuato potrebbe a sua volta essere ulteriormente suddiviso, tuttavia tale distribuzione permette di ricollegare un habitat ad attività e comportamenti che espongono al rischio di puntura di zecca, quali raccolta di funghi, passeggiate o caccia per il bosco, oppure sfalcio del fieno ed altri lavori agricoli per il prato. E stato possibile rappresentare in una statistica di settore la distribuzione delle specie di zecca rispetto alla frequentazione di questi habitat. Ad esempio nel caso della voce casa/giardino benché Ixodes ricinus sia sempre la zecca più rappresentata (78,3%), Rhipicephalus sanguineus si ricava in questo habitat maggior spazio (21,7%), giustificato dalla vicinanza del cane all uomo. Per meglio stimare il rischio relativo alla frequentazione di determinati habitat, i dati ottenuti dovranno essere confrontati con dati della fenologia delle zecche, in particolare di I. ricinus, nel corso dell anno. In effetti, le attività sia lavorative sia hobbistiche, hanno una stagionalità che va confrontata con il picco di massima densità in zona delle ninfe, lo stadio univocamente riconosciuto il più pericoloso per la trasmissione che patogeni. Questo confronto permette di ottenere una stima più attendibile, in considerazione del fatto che lo stadio di ninfa elude le statistiche più facilmente dell adulto. All atto pratico, definire attività e comportamenti che espongono individui o categorie al rischio acarologico, è indispensabile a sviluppare eventuali strategie di prevenzione. Il grafico 5 riporta la distribuzione secondo sedi di infissione. e zecche possono attaccarsi sull uomo in numerose sedi e recentemente è stato osservato che alcune specie preferiscono determinate sedi: Dermacentor preferisce il capo, Rhipicephalus il capo nei bambini e le rimanenti parti del corpo negli adulti, mentre Ixodes sembra non avere preferenze. Da quanto è stato osservato in questo studio le zecche vengono più frequentemente estratte dal tronco (29%), dagli arti inferiori (21%), dagli arti superiori (15%). Nella fascia di età tra 1-10 anni la sede più comune è il capo (32%), rispetto ad esempio al tronco (21%), come è confermato anche in letteratura. a voce multipla si riferisce al ritrovamento di esemplari in diverse sedi, esclusivamente osservato nelle forme immature di Ixodes. Pertanto il ritrovamento di una ninfa e ancor più di una larva, deve prevedere una meticolosa ispezione di ogni parte del corpo. Il grafico 6 riporta le manifestazioni cutanee che sono state registrate durante lo studio. In caso di puntura di zecca è normalmente segnalata una zona arrossata e non rilevata, attorno al punto di infissione del rostro, di circa 7-8 mm di diametro, che regredisce spontaneamente dopo un paio di giorni Sanità animale 12 OSSERVATORIO
13 Arto inferiore Arto Superiore Ascella Capo e collo Inguine Multipla Tronco NO Grafico 5. Distribuzione della casistica secondo le sedi di infissione dall estrazione. Reazioni di maggior intensità possono essere messe in relazione a diverse cause quali: sensibilità individuale accentuata, tipo di zecca in causa, eventuali sovrapposizioni batteriche, estrazioni incomplete, sensibilizzazione per precedenti infestazioni, fatti tossici, reazioni di ipersensibilità, patogeni veicolati dalla zecca. I meccanismi patogenetici della reazione da puntura da zecca sono stati ampiamente studiati negli animali da laboratorio. Durante le prime ore dall attacco, la zecca non si nutre e l attività predominante è la produzione di una secrezione salivare che contiene diverse sostanze utili ad ancorare le parti boccali alla cute ed a facilitare il successivo pasto. Questa attività provoca, ad esempio nella cavia, lo sviluppo di un infiltrato infiammatorio costituito essenzialmente da neutrofili in corrispondenza della puntura. Il punto di attacco risulta disepitelizzato, e le parti distali della bocca terminano in una piccola area emorragica (feeding pool degli autori di lingua inglese) che facilita l assunzione di liquidi. Non si nota reazione cellulare del derma o ispessimento epidermico. In contatti successivi l istologia cambia e l infiltrato infiammatorio coinvolge sia derma sia epidermide, con presenza di basofili ed eosinofili. Questo infiltrato varia in intensità tra ospite e ospite come l ispessimento dell epidermide. area emorragica è meno evidente e la zecca ha maggiori difficoltà ad ingorgarsi. Inoltre sembra che basofili, eosinofili e cellule del angerhans abbiano un ruolo determinante nello sviluppo di forme di resistenza alla zecca, attraverso la liberazione di mediatori chimici o attivandosi nella presentazione di antigeni. Nell uomo non esistono studi di questo tipo anche se il risultato delle biopsie, di test e l esame delle reazioni locali ha permesso una valutazione in questo senso. Gauci et al. (1988), suggeriscono di classificare le reazioni locali in 6 categorie: 1) reazione locale di lieve entità, non collegata a fenomeni di tipo allergico; 2) reazione locale estesa, la cui patogenesi può coinvolgere fenomeni di ipersensibilità ritardata, una risposta Ig E tardiva, oppure una diretta azione tossica delle secrezioni della zecca; 3) reazione anafilattica, Ig dipendente, dimostrata da un risultato positivo ad un test cutaneo con estratto di ghiandole di Ixodes holocyclus, una zecca australiana. Gli antigeni salivari sono stati identificati in due proteine di 28 e 55 kd; 4) reazione atipica, Ig E dipendente, come sopra; 5) paralisi da zecche, sostenuta da tossina; 6) malattia di yme, sostenuta da spirochete. a presenza di sostanze allergizzanti è stata dimostrata anche per Ixodes ricinus, responsabile di reazioni immediate con formazione di alone eritematoso di 55 mm. Non è attualmente disponibile una statistica sull incidenza di questo fenomeno che comunque potrebbe non essere raro. Sui dati in possesso una relazione è stata ricercata tra reazioni locali anomale ed auto estrazioni domiciliari, che esitano spesso nella ritenzione del rostro della zecca nello spessore della cute e che afferiscono al Pronto Soccorso solo successivamente, a volte a distanza di uno o due giorni dal tentativo di estrazione. I dati della maggior intensità delle reazioni sono stati confrontati nel gruppo delle autoestrazioni e nel gruppo di coloro che si recavano direttamente al Pronto Soccorso per la rimozione della zecca. elaborazione con il test X 2 è risultata non significativa, perciò, almeno nel nostro caso, le reazioni anomale non possono essere messe in relazione con un tentativo incompleto di estrazione e con le relative possibili complicazioni. In altri studi effettuati presso la U.O. Malattie Infettive pediatriche dell Azienda Ospedaliera Meyer, su bambini di età compresa tra undici mesi e quindici anni, le complicanze locali furono verificate con frequenza maggiore nel gruppo dei soggetti nei quali l estrazione della zecca era avvenuta a domicilio. Per contro, dalle nostre osservazioni, nel gruppo delle autoestrazioni è più frequente la somministrazione di farmaci per uso topico o per via generale dopo la dimissione (tabella 4) ed esprime, evidentemen Prurito 28 Arrossamento 17 Associazione 7 Dolore 1 Eritema Grafico 6. Distribuzione delle manifestazioni cutanee 1 Pomfo OSSERVATORIO 13 Sanità animale
14 Reazione estesa Tumefazione Ifn Malgie Artralgie Associazione Febbre Dolori renali Grafico 7. Distribuzione dei sintomi di carattere generale te, una valutazione di maggiore gravità di questi casi da parte del medico. Il grafico 7 riporta i dati dei sintomi di carattere generale. Due dei casi osservati, afferiti al PS di ucca nel 2002, svilupparono sintomi caratteristici della febbre bottonosa, entrambi successivamente confermati alla sierologia. Il primo caso, un individuo di sesso maschile, di 29 anni, si presentò verso i primi di giugno al PS per estrazione di una zecca, poi classificata come R. sanguineus (femmina adulta). Alla notifica della malattia venne eseguito un sopralluogo presso l abitazione, una struttura di recente costruzione, isolata da altre in una zona collinare del comune di ucca. Nel corso del sopralluogo venne accertata la presenza di molti esemplari di R.sanguineus sui muri e sul cordolo perimetrale dell abitazione e in generale nelle immediate vicinanze. A distanza di due settimane, un altro componente del nucleo familiare, un bambino di 2 anni, venne presentato al PS per estrazione di un esemplare di R. sanguineus al capo. In questo caso non ci furono conseguenze. Inoltre, vennero testati per Rickettsia conori i due cani di proprietà ed il cane dell unica abitazione vicina (test di immunofluorescenza indiretta, presso IZS di Roma), uno dei cani di casa, un meticcio maschio di 15 anni, da sempre in famiglia, risultò positivo. Il secondo caso era riferito ad un adulto di sesso maschile, di anni 48 presentatosi al PS a metà giugno per estrazione di una zecca dal torace, poi classificata come Ixodes ricinus. All indagine epidemiologica riferiva di aver avuto un ulteriore morsicatura da zecca, senza però essersi recato dal medico. Riferiva inoltre di non possedere animali. I casi umani di rickettsiosi Tabella 4. Confronto tra modalità di somministrazione di antibiotici Si antibiotici No antibiotici Dimissione Pronto soccorso X 2 =11.2, g.d.l=1, p-value= sono progressivamente aumentati in tutta Italia dal 1970 in poi, mentre i dati relativi alla regione Toscana per questi ultimi anni (tabella 1), mostrano una tendenza contraria. Certamente la maggior sensibilità sullo stato sanitario del cane, ha influito notevolmente sulla densità delle popolazioni di R. sanguineus nei canili e soprattutto l introduzione di molecole polivalenti nei confronti di parassiti interni ed esterni, ha modificato l approccio al controllo, passando da trattamenti esterni tradizionali che venivano effettuati solo su soggetti massivamente infestati dalle forme più visibili, cioè gli adulti, ad un trattamento preventivo efficace sui diversi stadi di zecca. Benché sia noto che il cane non sia un reservoir efficiente, non vi è dubbio che contribuisca in modo significativo alla disseminazione delle zecche negli ambienti domestici ed alla amplificazione della popolazione dell artropode, pertanto un intervento efficace su un anello fondamentale della catena epidemiologica della malattia, non può che avere evidenti ricadute positive sul contenimento della casistica umana. A livello locale R. conori ha una incidenza per abitanti interessante nella Piana di ucca, zona da dove provengono tutti i casi notificati e risulta la patologia trasmessa da zecche più importante, benché le punture da Rhipicephalus sanguineus, il vettore della rickettsiosi, siano solo il 6,7% del totale. Questi dati indicano, inequivocabilmente, la presenza dell agente eziologico in zona, ma risultando più agevole la diagnosi e disponendo di test di buona affidabilità, una sottostima è praticamente inesistente. Sarà interessante seguire l andamento dei casi nei prossimi anni, al fine di valutare eventuali riallineamenti alla tendenza regionale, che per quanto osservato, si ritengono probabili. Paradossalmente, per la B la situazione è diametralmente opposta, con una incidenza per abitanti che dimostra a livello regionale una tendenza evolutiva, mentre in zona l ultimo caso clinico risale al 1998 e con il vettore, Ixodes ricinus, che rappresenta fino al 78% del totale delle zecche estratte (Valle del Serchio). In effetti, in Italia la B è sottoposta a notifica obbligatoria dal 1990, come malattia di classe V (D.M. 15 Dic. 1990), tuttavia il sospetto di sottostima è relativo all intero territorio nazionale ed in pratica diffuso in tutte le zone dove la situazione eco-epidemiologica è complicata per la presenza di diverse genospecie di Borrelia. Nei due anni di lavoro del Sistema di Sorveglianza non si sono verificati casi clinici di B. Tuttavia in alcuni dei casi osservati sono stati registrati sintomi quali, tumefazione linfonodale, dolorabilità muscolare ed articolare, febbre, comunemente descritti in letteratura tra i casi clinici di B, inducendo particolare attenzione per il caso specifico. Purtroppo su questi pazienti non sono stati effettuati accertamenti sierologici specifici per patologie veicolate da zecche e comunque l inda- Sanità animale 14 OSSERVATORIO
15 gine conclusiva ha sempre confermato condizioni cliniche nella norma. Ad eccezione di una indagine svolta nel 1996 dal settore di Medicina del avoro, a seguito di due casi di B verificatesi nella Piana di ucca in allevatori di ovini, in zona non è mai stato condotto uno studio esteso sulla sieroprevalenza di questa patologia. All epoca venne individuato un campione di 39 persone (29 di sesso maschile e 10 di sesso femminile), senza riscontrare ulteriori positività. Pertanto in mancanza di uno studio su un campione più rappresentativo per la popolazione esposta al rischio, non è semplice spiegare il significato dei sintomi riportati nei grafici 6 e 7. Sappiamo che la maggiore manifestazione cutanea della B è l eritema cronico migrante, simile in tutte le parti del mondo in cui compare, ma è noto anche che vi sono delle differenze che riguardano la severità e la frequenza di altre manifestazioni, che possono riflettere variazioni regionali della genospecie di borrelia. A complicare il quadro clinico contribuiscono anche le infezioni miste, fino ad un 40%, acquisite dalla zecca nutrendosi su un ospite infetto da diverse genospecie, oppure su diversi ospiti nei suoi diversi stadi. Approfondire ed integrare i dati ottenuti dal Sistema di Sorveglianza con quelli riguardanti la prevalenza di patogeni nella popolazione di zecche campionate nella zona oggetto di studio, permetterà una maggiore comprensione dell epidemiologia delle patologie veicolate da zecche in quest area. Conclusioni obiettivo principale di questo lavoro è stato quello di iniziare uno studio sulla prevalenza delle specie di zecche presenti in questa area e sulle ricadute epidemiologiche per la diffusione di patologie trasmesse da questi vettori. Sono stati ottenuti dati sulla casistica delle punture da zecca che, rispetto alla popolazione residente, hanno indicato una interessante concentrazione di casi nella Zona Valle del Serchio; sulla prevalenza di Ixodes ricinus, vettore di B, presente in tutta l area e particolarmente nella zona montana; sui determinanti climatici ed ambientali e sulle attività più a rischio per la raccolta di zecche. Queste informazioni sono state poi incrociate con i dati di altri studi ottenendo una conferma circa le variabili più significative individuate e sulle categorie professionali a rischio e prevalenze per B osservate. Nel complesso queste informazioni posizionano la zona montana lucchese, tra quelle dove il rischio acarologico per la popolazione residente deve essere sospettato, quindi un risultato concreto, indispensabile a giustificare ulteriori investimenti in direzione della maggior comprensione del fenomeno. o studio condotto ha evidenziato per questa zona la prospettiva che focolai naturali di infezione siano sempre più intimamente collegati alle attività umane per ragioni dovute alle evoluzioni di tipo socio economico (diffusione dell agriturismo), di trasformazione del territorio (frammentazione aree boschive), di frequente utilizzo del bosco sia per attività ricreative sia per reddito. Tuttavia gli scenari che si prospettano non esauriscono l aumento del rischio nel semplice utilizzo più frequente di queste aree e le ipotesi sulla co-evoluzione di microrganismi, zecche ed animali ospiti, offrono interessanti spunti alla riflessione. E noto, ad esempio, che la pressione antropica induce modifiche alla biodiversità, che a loro volta condizionano la selezionare di organismi più adattabili, come i micromammiferi. Inoltre, alla riduzione del numero di specie può associarsi una perdita di variabilità genetica che permette un miglior adattamento di microrganismi patogeni e la selezione di ceppi più virulenti, con conseguenti forme cliniche più severe a carico dei frequentatori dell habitat, uomo compreso. Pur non essendo ancora ben noti i meccanismi che condizionano la dinamica evolutiva delle patologie trasmesse da zecche in un area piuttosto che in altre, è comunque sufficientemente chiaro che essa dipende da fattori che caratterizzano un dato territorio, compreso il suo utilizzo ed il grado di pressione antropica esercitato. Non è escluso, considerando le ipotesi sulla co-evoluzione, che in determinate condizioni se ne possa prevedere un aumento, alimentato dalle diverse specie di microrganismi ritrovati nelle zecche e per i quali non è stata ancora ben determinata la patogenicità nei confronti dell uomo; altrimenti una diminuzione di incidenza, come registra il trend regionale dell ultimo decennio per rickettsiosi. Da questo punto di vista, per le caratteristiche ambientali che sono state indicate, la zona montana lucchese si presenta come un territorio interessante per lo studio delle patologie trasmesse da zecche. Oltre a spiegare alcuni meccanismi che contribuiscono a far emergere alcune malattie rispetto ad altre, queste considerazioni offrono lo spunto per eventuali azioni da intraprendere a tutela della salute pubblica. Infatti, le prospettive di controllo per le patologie trasmesse da zecche, variano notevolmente in base alla complessità dell ecologia e biologia della specie vettore in causa, nonché dell habitat, in particolare dei fattori biotici. Questo permette di discriminare tra patologie nei confronti delle quali un intervento sulla catena epidemiologica è efficace e vantaggioso ai fini del controllo, rispetto ad altre per le quali l unica attività di prevenzione possibile è una più accurata conoscenza dei vari determinanti in causa. 1. Osservatorio Permanente per Patologie a trasmissione Vettoriale- AS 2 ucca a rassegna bibliografica è disponibile presso l Autore. OSSERVATORIO 15 Sanità animale
16 Notizie da Internet Queste notizie sono tratte dalla lista elettronica di epidemiologia ProMED-mail (Http// OIE: nuovo sistema di notifica delle malattie animali (sistema ADNS) Al fine di fornire informazioni sulla sanità animale in maniera trasparente, l OIE gestisce un sistema di informazioni mondiale sulla sanità animale, basato sulla notifica degli Stati Membri dell evenienza delle principali malattie animali, incluse le zoonosi. Nel maggio 2005 è stata approvata un unica lista di malattie da notificare, eliminando le precedenti due liste A e B. Il nuovo sistema prescrive 4 tipi di rapporto principali: immediato, a seguire, semestrale e annuale. 1. a notifica immediata è prevista per avvertire ed allertare la comunità internazionale di eventi epidemiologici eccezionali negli Stati Membri (OIE Early Warning System), in cui siano specificate le seguenti informazioni: a. la prima emergenza di una malattia della lista OIE o dell infezione in un paese o zona/compartimento; b. la ri-emergenza di una malattie della lista OIE o dell infezione in un paese o zona/compartimento che segue un report da parte del delegato dello Stato Membro che dichiara che i precedenti focolai sono stati eradicati; c. la prima emergenza di un nuovo ceppo di patogeno di una malattia nell elenco o dell infezione in un paese o zona/compartimento; d. un improvviso e inaspettato aumento nella morbilità o mortalità causata da una malattia nell elenco; e. una malattia emergente con morbilità/mortalità significative o potenziale zoonosico; f. l evidenza di un mutamento nell epidemiologia di una malattia nell elenco (e.g. spettro d ospite, patogenicità, etc.), in particolare se ha impatto zoonosico. Questo sistema è rivolto ai Servizi Veterinari degli Stati Membri in grado di applicare le necessarie misure di protezione il più rapidamente possibile per prevenire l introduzione di patogeni che originano da paesi infetti. 2. Il report a seguire è redatto con frequenza settimanale, susseguente alla notifica immediata, allo scopo di fornire ulteriori informazioni sull evoluzione di un incidente che ha giustificato la notifica immediata. Il report settimanale va inviato fino a quando la situazione si è risolta attraverso l eradicazione della malattia o perché sta diventando endemica; si passa allora a report semestrali. 3. Il report semestrale contiene dati sull evoluzione, assenza o presenza di tutte le malattie nell elenco OIE e le informazioni di significato epidemiologico per gli altri paesi. 4. Il questionario annuale concerne ogni altro tipo d informazione significativa per gli altri paesi. Maggiori dettagli sulle procedure e gli obblighi degli Stati Membri si possono trovare nel capitolo del Terrestrial Animal Health Code ( Il mantenimento o l eliminazione di una malattia precedentemente inserita nelle liste A e B si è basato su 4 criteri: a. diffusione internazionale; b. diffusione significativa in una popolazione vergine; c. potenziale zoonosico; d. malattie emergenti. Ogni malattia è stata valutata in prima istanza per la sua potenziale diffusione internazionale. In caso di risposta affermativa, la malattia era considerata per il suo potenziale zoonosico con gravi conseguenze o ad alto impatto a livello di paese o di zona. Per essere incluse nella lista, le malattie emergenti devono mostrare un potenziale zoonosico. Il modello decisionale è inserito nell articolo del Terrestrial Animal Health Code (
13/01/2017 I PIU EFFICIENTI VETTORI BIOLOGICI DI MALATTIE. Dr. Calovi Fausto SISTEMATICA. Famiglia Ixodidae o zecche dure Argasidae o zecche molli
 LE ZECCHE I PIU EFFICIENTI VETTORI BIOLOGICI DI MALATTIE Dr. Calovi Fausto SISTEMATICA Regno Philum Classe Ordine Animale Artropodi Aracnidi Acari Famiglia Ixodidae o zecche dure Argasidae o zecche molli
LE ZECCHE I PIU EFFICIENTI VETTORI BIOLOGICI DI MALATTIE Dr. Calovi Fausto SISTEMATICA Regno Philum Classe Ordine Animale Artropodi Aracnidi Acari Famiglia Ixodidae o zecche dure Argasidae o zecche molli
Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia LORO SEDI
 Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Data: Protocollo: Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia LORO SEDI Circ. 13 /SAN Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle
Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Data: Protocollo: Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia LORO SEDI Circ. 13 /SAN Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle
Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni )
 Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni 1995 2005) Prefazione Il sistema di notifica della tubercolosi, elemento indispensabile al programma di controllo della malattia stessa, ha tra gli obiettivi
Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni 1995 2005) Prefazione Il sistema di notifica della tubercolosi, elemento indispensabile al programma di controllo della malattia stessa, ha tra gli obiettivi
Caratteristiche qualitative CNR Centro Studi Latte-Milano. del latte crudo IL LATTE. Roberta Lodi 1
 CNR-ISPA Sede di Vendita diretta di latte crudo: qualità e sicurezza Tradate 11.09.08 Caratteristiche qualitative CNR Centro Studi Latte- del latte crudo Roberta Lodi 1 IL LATTE è una complessa miscela
CNR-ISPA Sede di Vendita diretta di latte crudo: qualità e sicurezza Tradate 11.09.08 Caratteristiche qualitative CNR Centro Studi Latte- del latte crudo Roberta Lodi 1 IL LATTE è una complessa miscela
Il controllo del latte
 Il controllo del latte diagnosi di patologie mammarie controlli funzionali controlli tecnologici controlli qualitativi (pagamento qualità) controlli di legge 1 Analisi Inibenti Carica batterica Grasso,
Il controllo del latte diagnosi di patologie mammarie controlli funzionali controlli tecnologici controlli qualitativi (pagamento qualità) controlli di legge 1 Analisi Inibenti Carica batterica Grasso,
Piano Nazionale di controllo dell Arterite Virale Equina in Italia. Report sulle attività analitiche svolte dagli IIZZSS in Italia nel 2014
 Ufficio di staff Osservatorio Epidemiologico CERME Centro Nazionale di Referenza per le malattie degli equini Alla cortese attenzione Dott. Luigi Ruocco Dott. Mattia Paglialunga Ufficio II Direzione generale
Ufficio di staff Osservatorio Epidemiologico CERME Centro Nazionale di Referenza per le malattie degli equini Alla cortese attenzione Dott. Luigi Ruocco Dott. Mattia Paglialunga Ufficio II Direzione generale
Valutazione dell andamento dei casi di meningite nella ASL della Provincia di Milano 3
 Valutazione dell andamento dei casi di meningite nella ASL della Provincia di Milano 3 Introduzione Il primo trimestre 2008 è stato caratterizzato, nell ASL della Provincia di Milano 3, da un numero di
Valutazione dell andamento dei casi di meningite nella ASL della Provincia di Milano 3 Introduzione Il primo trimestre 2008 è stato caratterizzato, nell ASL della Provincia di Milano 3, da un numero di
Un Piano per il controllo della Leishmaniosi canina nelle Marche. Stefano Gavaudan Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche
 Un Piano per il controllo della Leishmaniosi canina nelle Marche Stefano Gavaudan Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche L Istituto Zooprofilattico Sperimentale Si occupa di diagnostica
Un Piano per il controllo della Leishmaniosi canina nelle Marche Stefano Gavaudan Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche L Istituto Zooprofilattico Sperimentale Si occupa di diagnostica
UE: focolai attribuiti a LC di vacca (EFSA, 2015)
 Latte crudo in Emilia Romagna: risultatidel progetto Sibilla LC2011 2012 Claudia Weiss, AUSL RE, ATV Scandiano Claudia.Weiss@ausl.re.it 0522 850342 UE: focolai attribuiti a LC di vacca (EFSA, 2015) Anno
Latte crudo in Emilia Romagna: risultatidel progetto Sibilla LC2011 2012 Claudia Weiss, AUSL RE, ATV Scandiano Claudia.Weiss@ausl.re.it 0522 850342 UE: focolai attribuiti a LC di vacca (EFSA, 2015) Anno
Segnalazioni alle prefetture
 Segnalazioni alle prefetture Segnalazioni alle prefetture SEGNALAZIONI ALLE PREFETTURE Le segnalazioni alle Prefetture (ai sensi degli art. 75 e 121 del DPR 309/90), per utilizzo o possesso di sostanze
Segnalazioni alle prefetture Segnalazioni alle prefetture SEGNALAZIONI ALLE PREFETTURE Le segnalazioni alle Prefetture (ai sensi degli art. 75 e 121 del DPR 309/90), per utilizzo o possesso di sostanze
Gestione delle NC microbiologiche
 Gestione delle NC microbiologiche IL CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI: CAMPIONAMENTO, INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO, FLUSSI INFORMATIVI e GESTIONE DELLE NC Torino 10-11 11 giugno 2013 Asti 18-19
Gestione delle NC microbiologiche IL CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI: CAMPIONAMENTO, INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO, FLUSSI INFORMATIVI e GESTIONE DELLE NC Torino 10-11 11 giugno 2013 Asti 18-19
EU Reference Laboratory for E.coli Registro Italiano della SEU
 EU Reference Laboratory for E.coli Registro Italiano della SEU Istituto Superiore di Sanità Attività di sorveglianza delle infezioni da VTEC in pazienti pediatrici con Sindrome Emolitico Uremica nell anno
EU Reference Laboratory for E.coli Registro Italiano della SEU Istituto Superiore di Sanità Attività di sorveglianza delle infezioni da VTEC in pazienti pediatrici con Sindrome Emolitico Uremica nell anno
Gli incidenti domestici nel Az. Ulss 19 di Adria: definizione del fenomeno e valutazione delle azioni di prevenzione
 Gli incidenti domestici nel Az. Ulss 19 di Adria: definizione del fenomeno e valutazione delle azioni di prevenzione Gli incidenti domestici nella prima infanzia sono una causa importante di morte e, molto
Gli incidenti domestici nel Az. Ulss 19 di Adria: definizione del fenomeno e valutazione delle azioni di prevenzione Gli incidenti domestici nella prima infanzia sono una causa importante di morte e, molto
«MTA: lo stato dell arte in Emilia-Romagna»
 «MTA: lo stato dell arte in Emilia-Romagna» Bologna, 26 novembre 2015 Corso di formazione su Malattie a trasmissione alimentare e microbiologia predittiva Anna Rosa Gianninoni e Bianca Maria Borrini 1
«MTA: lo stato dell arte in Emilia-Romagna» Bologna, 26 novembre 2015 Corso di formazione su Malattie a trasmissione alimentare e microbiologia predittiva Anna Rosa Gianninoni e Bianca Maria Borrini 1
GIORNATA STUDIO SULLE PROBLEMATICHE ATTUALI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
 GIORNATA STUDIO SULLE PROBLEMATICHE ATTUALI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO Produzione latte alla stalla: esiti dei controlli ufficiali Carlo Rusconi 2 Il controllo del latte crudo alla stalla per la verifica
GIORNATA STUDIO SULLE PROBLEMATICHE ATTUALI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO Produzione latte alla stalla: esiti dei controlli ufficiali Carlo Rusconi 2 Il controllo del latte crudo alla stalla per la verifica
Toxoplasma gondii Un problema ispettivo attuale? Indagine epidemiologica in suini macellati a domicilio in Toscana.
 Toxoplasma gondii Un problema ispettivo attuale? Indagine epidemiologica in suini macellati a domicilio in Toscana. Dati preliminari Daniela Gianfaldoni e Francesca Mancianti Dipartimento di Patologia
Toxoplasma gondii Un problema ispettivo attuale? Indagine epidemiologica in suini macellati a domicilio in Toscana. Dati preliminari Daniela Gianfaldoni e Francesca Mancianti Dipartimento di Patologia
Osservatorio per le Politiche Sociali - Terzo Rapporto
 1 STRUTTURA E DINAMICA DEMOGRAFICA Il capitolo si articola in due paragrafi. Nel primo sono riportati i dati e i commenti riguardanti la struttura demografica della popolazione della Valle d Aosta. Nel
1 STRUTTURA E DINAMICA DEMOGRAFICA Il capitolo si articola in due paragrafi. Nel primo sono riportati i dati e i commenti riguardanti la struttura demografica della popolazione della Valle d Aosta. Nel
Sommario. Bologna. selvatica
 Sorveglianza del virus West Nile in Emilia Romagnaa Sommario IZSLER Sorveglianza Epidemiologica, Bologna 311 agosto 2018 1. Introduzione... 2 2. Sorveglianza sull avifauna selvatica... 3 3. Sorveglianza
Sorveglianza del virus West Nile in Emilia Romagnaa Sommario IZSLER Sorveglianza Epidemiologica, Bologna 311 agosto 2018 1. Introduzione... 2 2. Sorveglianza sull avifauna selvatica... 3 3. Sorveglianza
FluNews Rapporto Epidemiologico Settimanale
 Numero 19, del 11 Aprile 213 FluNews Rapporto Epidemiologico Settimanale Aggiornamento alla 1 settimana del 213 (1-7 Aprile 213) Il presente rapporto integra i risultati di differenti sistemi di sorveglianza
Numero 19, del 11 Aprile 213 FluNews Rapporto Epidemiologico Settimanale Aggiornamento alla 1 settimana del 213 (1-7 Aprile 213) Il presente rapporto integra i risultati di differenti sistemi di sorveglianza
Piano Regionale per il monitoraggio permanente dell'influenza aviare. Risultati dei controlli anno 2007
 Piano Regionale per il monitoraggio permanente dell'influenza aviare. Risultati dei controlli anno 2007 La presenza e la circolazione naturale nei volatili selvatici, in particolar modo negli anatidi,
Piano Regionale per il monitoraggio permanente dell'influenza aviare. Risultati dei controlli anno 2007 La presenza e la circolazione naturale nei volatili selvatici, in particolar modo negli anatidi,
AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO - 31 MARZO 2016
 AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO - 31 MARZO 2016 MORBILLO Dopo un anno (il 2015) nel corso del quale sono stati segnalati pochi casi di morbillo, il 2016 sembra mostrare
AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO - 31 MARZO 2016 MORBILLO Dopo un anno (il 2015) nel corso del quale sono stati segnalati pochi casi di morbillo, il 2016 sembra mostrare
Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici. MIF NEWSLETTER ANNO 2005 Le malattie infettive nel Distretto di Modena
 MIF NEWSLETTER ANNO 25 Le malattie infettive nel di Nell anno 25 sono stati notificati, nel solo distretto di, 627 casi di malattia infettiva (58 casi singoli e 119 casi riuniti in 26 focolai). Il tasso
MIF NEWSLETTER ANNO 25 Le malattie infettive nel di Nell anno 25 sono stati notificati, nel solo distretto di, 627 casi di malattia infettiva (58 casi singoli e 119 casi riuniti in 26 focolai). Il tasso
3.6.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO
 3.6 - REGIONE PUGLIA Ing. Alfredo Ferrandino Tutor regionale 3.6.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO 3.6.1.1 - Scelta del campione Sulla base dei concetti generali formatori
3.6 - REGIONE PUGLIA Ing. Alfredo Ferrandino Tutor regionale 3.6.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO 3.6.1.1 - Scelta del campione Sulla base dei concetti generali formatori
Piano di Gestione area SIC Foresta di Monte Arcosu
 VALUTAZIONE GENERALE E IDENTIFICAZIONE DELLE MINACCE L analisi delle caratteristiche del SIC ha permesso di procedere ad una valutazione generale dello stato del territorio e alla identificazione delle
VALUTAZIONE GENERALE E IDENTIFICAZIONE DELLE MINACCE L analisi delle caratteristiche del SIC ha permesso di procedere ad una valutazione generale dello stato del territorio e alla identificazione delle
Calcolo dell inflazione per differenti tipologie di famiglie milanesi
 Settore Statistica e S.I.T Servizio Statistica Calcolo dell inflazione per differenti tipologie di famiglie milanesi Introduzione L Indagine sui consumi delle famiglie milanesi realizzata dalla Camera
Settore Statistica e S.I.T Servizio Statistica Calcolo dell inflazione per differenti tipologie di famiglie milanesi Introduzione L Indagine sui consumi delle famiglie milanesi realizzata dalla Camera
LETTURA CRITICA DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA
 LA STATISTICA NELLA RICERCA Raccolta dei dati Elaborazione Descrizione Una raccolta di dati non corretta, una loro presentazione inadeguata o un analisi statistica non appropriata rendono impossibile la
LA STATISTICA NELLA RICERCA Raccolta dei dati Elaborazione Descrizione Una raccolta di dati non corretta, una loro presentazione inadeguata o un analisi statistica non appropriata rendono impossibile la
STANZIALI NOMADI TOTALE APIARI ALVEARI APIARI ALVEARI APIARI ALVEARI
 Premessa Nel corso degli ultimi anni si sono manifestati rilevanti problemi di sopravvivenza delle famiglie di api in molte zone del mondo. In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, dal confronto
Premessa Nel corso degli ultimi anni si sono manifestati rilevanti problemi di sopravvivenza delle famiglie di api in molte zone del mondo. In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, dal confronto
Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia LORO SEDI
 Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Data: Protocollo: Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia LORO SEDI Circ. 19/SAN/07 Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari
Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Data: Protocollo: Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia LORO SEDI Circ. 19/SAN/07 Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari
LEPRE, SITUAZIONE SANITARIA IN LOMBARDIA
 Giornata di studio e confronto: la lepre, ecologia, patologie e modelli gestionali che ne influenzano l andamento demografico LEPRE, SITUAZIONE SANITARIA IN LOMBARDIA Mario Chiari Sorveglianza Epidemiologica
Giornata di studio e confronto: la lepre, ecologia, patologie e modelli gestionali che ne influenzano l andamento demografico LEPRE, SITUAZIONE SANITARIA IN LOMBARDIA Mario Chiari Sorveglianza Epidemiologica
Indice di Paterson. Luigi Mariani, Simone Gabriele Parisi. Università degli Studi di Milano DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
 Indice di Paterson Luigi Mariani, Simone Gabriele Parisi Università degli Studi di Milano DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Il calcolo dell indice di Paterson o indice C.V.P. (Clima-Vegetazione-Produzione),
Indice di Paterson Luigi Mariani, Simone Gabriele Parisi Università degli Studi di Milano DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Il calcolo dell indice di Paterson o indice C.V.P. (Clima-Vegetazione-Produzione),
IZSLER e IUV(ENE) Tavola rotonda: l Igiene Urbana veterinaria un opportunità da cogliere per la Sanità Pubblica Veterinaria
 Marco Tamba Sorveglianza Epidemiologica Emilia Romagna Tavola rotonda: l Igiene Urbana veterinaria un opportunità da cogliere per la Sanità Pubblica Veterinaria IZSLER e IUV(ENE) Teramo 22 settembre 2017
Marco Tamba Sorveglianza Epidemiologica Emilia Romagna Tavola rotonda: l Igiene Urbana veterinaria un opportunità da cogliere per la Sanità Pubblica Veterinaria IZSLER e IUV(ENE) Teramo 22 settembre 2017
Dossier 4. Le spese delle amministrazioni locali nell'ultimo decennio
 Dossier 4 Le spese delle amministrazioni locali nell'ultimo decennio Audizione del Presidente dell Istituto nazionale di statistica, Luigi Biggeri presso le Commissioni riunite V Commissione "Programmazione
Dossier 4 Le spese delle amministrazioni locali nell'ultimo decennio Audizione del Presidente dell Istituto nazionale di statistica, Luigi Biggeri presso le Commissioni riunite V Commissione "Programmazione
Le analisi che si effettuano sul latte. Percorso didattico quarta/quinta ITIS Cartesio Indirizzo chimico-biotec. sanitario
 Le analisi che si effettuano sul latte Percorso didattico quarta/quinta ITIS Cartesio Indirizzo chimico-biotec. sanitario Per il controllo della qualità del latte vengono rilevati determinati parametri:
Le analisi che si effettuano sul latte Percorso didattico quarta/quinta ITIS Cartesio Indirizzo chimico-biotec. sanitario Per il controllo della qualità del latte vengono rilevati determinati parametri:
Studio sui micromammiferi del Parco Regionale di Veio
 La biodiversità del Parco di Veio a 0 anni dalla sua istituzione I risultati degli studi e delle ricerche Formello (RM) Teatro J.P Velly, 4 novembre 2008 Studio sui micromammiferi del Parco Regionale di
La biodiversità del Parco di Veio a 0 anni dalla sua istituzione I risultati degli studi e delle ricerche Formello (RM) Teatro J.P Velly, 4 novembre 2008 Studio sui micromammiferi del Parco Regionale di
IZSLER. Bologna. 06 agosto Sommario ...
 Sommario Sorveglianza del virus West Nile in Emilia Romagnaa IZSLER Sorveglianza Epidemiologica, Bologna 06 agosto 2018 1. Introduzione... 2 2. Sorveglianza sull avifauna selvatica... 3 3. Sorveglianza
Sommario Sorveglianza del virus West Nile in Emilia Romagnaa IZSLER Sorveglianza Epidemiologica, Bologna 06 agosto 2018 1. Introduzione... 2 2. Sorveglianza sull avifauna selvatica... 3 3. Sorveglianza
Centro Regionale di documentazione e informazione sul farmaco
 La segnalazione di Reazioni Avverse in Calabria: Resoconto del 2011. Introduzione L obiettivo principale della Farmacovigilanza è l incremento della segnalazione spontanea delle reazioni avverse ai farmaci.
La segnalazione di Reazioni Avverse in Calabria: Resoconto del 2011. Introduzione L obiettivo principale della Farmacovigilanza è l incremento della segnalazione spontanea delle reazioni avverse ai farmaci.
Soppravivenza e cause di morte in Campania e Provincia
 Università degli Studi di Napoli Facoltà di Economia Soppravivenza e cause di morte in Campania e Provincia di Laura Abbate Relatore prof. Aurelio Pane A. A. 2008/09 Presentazione E noto che l Italia è
Università degli Studi di Napoli Facoltà di Economia Soppravivenza e cause di morte in Campania e Provincia di Laura Abbate Relatore prof. Aurelio Pane A. A. 2008/09 Presentazione E noto che l Italia è
Igiene nelle Scienze motorie
 Il metodo epidemiologico consiste nel : Igiene nelle Scienze motorie Studi epidemiologici 1. Porre un ipotesi 2. Verificarla per mezzo di una ricerca specifica 3. Utilizzare le conclusioni per porre nuove
Il metodo epidemiologico consiste nel : Igiene nelle Scienze motorie Studi epidemiologici 1. Porre un ipotesi 2. Verificarla per mezzo di una ricerca specifica 3. Utilizzare le conclusioni per porre nuove
AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2014
 AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2014 MORBILLO Il presente rapporto mostra i risultati del Sistema di Sorveglianza Integrata del Morbillo e della Rosolia
AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2014 MORBILLO Il presente rapporto mostra i risultati del Sistema di Sorveglianza Integrata del Morbillo e della Rosolia
LA FAUNA. Riccardo Fontana
 LA FAUNA Riccardo Fontana riccardo.fontana@studio-geco.it Specie trattate: Uccelli Alectoris rufa - Pernice rossa Phasianus colchicus- Fagiano Perdix perdix - Starna Specie trattate: Mammiferi Lepus europaeus
LA FAUNA Riccardo Fontana riccardo.fontana@studio-geco.it Specie trattate: Uccelli Alectoris rufa - Pernice rossa Phasianus colchicus- Fagiano Perdix perdix - Starna Specie trattate: Mammiferi Lepus europaeus
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA SETTORE SALUTE UFFICIO V - MALATTIE INFETTIVE
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA SETTORE SALUTE UFFICIO V - MALATTIE INFETTIVE
Il codice della giornata è giallo
 OLYMPIC WATCH Sorveglianza delle emergenze di salute pubblica Bollettino del 14 Febbraio 2006 Breve sintesi delle informazioni raccolte dal sistema di sorveglianza nel giorno 13 febbraio 2006. Ogni giorno
OLYMPIC WATCH Sorveglianza delle emergenze di salute pubblica Bollettino del 14 Febbraio 2006 Breve sintesi delle informazioni raccolte dal sistema di sorveglianza nel giorno 13 febbraio 2006. Ogni giorno
Il tuo quartiere sotto la lente di ingrandimento
 Il tuo quartiere sotto la lente di ingrandimento American Express in collaborazione con Experian, leader mondiale nell informazione commerciale e nella protezione dei dati di aziende e consumatori, nei
Il tuo quartiere sotto la lente di ingrandimento American Express in collaborazione con Experian, leader mondiale nell informazione commerciale e nella protezione dei dati di aziende e consumatori, nei
ASL MILANO 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA U. O.C. Igiene e Sanità Pubblica Area tematica Malattie Infettive e strutture sanitarie
 ASL MILANO 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA U. O.C. Igiene e Sanità Pubblica Area tematica Malattie Infettive e strutture sanitarie Morbillo: situazione nel territorio dell Asl Milano 1 al 30 giugno
ASL MILANO 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA U. O.C. Igiene e Sanità Pubblica Area tematica Malattie Infettive e strutture sanitarie Morbillo: situazione nel territorio dell Asl Milano 1 al 30 giugno
FORTE ACCELERAZIONE DELL OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI PIACENZA NEL 2017.
 Piacenza, 19 marzo 2018 FORTE ACCELERAZIONE DELL OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI PIACENZA NEL 2017. SINTESI Riprendiamo i dati ufficiali sul mercato del lavoro nelle province nel 2017 diffusi nei giorni scorsi
Piacenza, 19 marzo 2018 FORTE ACCELERAZIONE DELL OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI PIACENZA NEL 2017. SINTESI Riprendiamo i dati ufficiali sul mercato del lavoro nelle province nel 2017 diffusi nei giorni scorsi
LE MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI
 ASSESSORATO SANITÀ settore Prevenzione & Veterinaria Centro di Riferimento Regionale per le MTA LE MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI DATI EPIDEMIOLOGICI REGIONE PIEMONTE BIENNIO 2016-2017 IL CONTESTO INTERNAZIONALE
ASSESSORATO SANITÀ settore Prevenzione & Veterinaria Centro di Riferimento Regionale per le MTA LE MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI DATI EPIDEMIOLOGICI REGIONE PIEMONTE BIENNIO 2016-2017 IL CONTESTO INTERNAZIONALE
1 Sito Internet
 1.5 Analisi di tendenza demografica Al fine di effettuare una più adeguata programmazione per la realizzazione delle strutture di offerta idonee a soddisfare i bisogni della della Regione Molise è stata
1.5 Analisi di tendenza demografica Al fine di effettuare una più adeguata programmazione per la realizzazione delle strutture di offerta idonee a soddisfare i bisogni della della Regione Molise è stata
FluNews Rapporto Epidemiologico Settimanale
 Numero 11, del 1 Febbraio 213 FluNews Rapporto Epidemiologico Settimanale Aggiornamento alla 6 settimana del 213 ( - 1 Febbraio 213) Il presente rapporto integra i risultati di differenti sistemi di sorveglianza
Numero 11, del 1 Febbraio 213 FluNews Rapporto Epidemiologico Settimanale Aggiornamento alla 6 settimana del 213 ( - 1 Febbraio 213) Il presente rapporto integra i risultati di differenti sistemi di sorveglianza
Il latte crudo è un prodotto come gli altri? Il latte crudo è un prodotto a rischio?
 Il latte crudo è un prodotto come gli altri? Il latte crudo è un prodotto a rischio? tutti i prodotti alimentari non sottoposti a trattamento sono più a rischio dei prodotti trattati la qualità igienico
Il latte crudo è un prodotto come gli altri? Il latte crudo è un prodotto a rischio? tutti i prodotti alimentari non sottoposti a trattamento sono più a rischio dei prodotti trattati la qualità igienico
REPORT INTERMEDIO. INDAGINE AMBIENTALE Campagna di misura della Qualità dell aria PAT/RFS305-14/01/
 PAT/RFS305-14/01/2019-0021123 AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Settore tecnico per la tutela dell ambiente U.O. aria, agenti fisici e bonifiche Via Mantova, 16 38122 Trento P +39 0461
PAT/RFS305-14/01/2019-0021123 AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Settore tecnico per la tutela dell ambiente U.O. aria, agenti fisici e bonifiche Via Mantova, 16 38122 Trento P +39 0461
Qual è la percezione del rischio di subire un infortunio domestico? TOTALE CLASSI D'ETA' SESSO. uomini.
 Sicurezza domestica Gli incidenti domestici rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica: i gruppi di popolazione maggiormente a rischio sono bambini e anziani, in particolare sopra gli 8 anni.
Sicurezza domestica Gli incidenti domestici rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica: i gruppi di popolazione maggiormente a rischio sono bambini e anziani, in particolare sopra gli 8 anni.
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
ISTRUZIONE OPERATIVA PER PRESENZA DI CARICA E/O CELLULE SOMATICHE NEL LATTE
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Udine, 20.02.2014 ISTRUZIONE OPERATIVA PER PRESENZA DI CARICA E/O CELLULE SOMATICHE NEL LATTE Decreto del Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Udine, 20.02.2014 ISTRUZIONE OPERATIVA PER PRESENZA DI CARICA E/O CELLULE SOMATICHE NEL LATTE Decreto del Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della
Evoluzione del clima in Veneto nell ultimo cinquantennio
 DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO Centro Meteorologico di Teolo Evoluzione del clima in Veneto nell ultimo cinquantennio Il Veneto si colloca in una zona di transizione confinante a Nord con
DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO Centro Meteorologico di Teolo Evoluzione del clima in Veneto nell ultimo cinquantennio Il Veneto si colloca in una zona di transizione confinante a Nord con
IL CONCETTO DI ZOONOSI CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI. Zoonosi dirette. Ciclozoonosi. Metazoonosi. Saprozoonosi
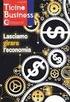 IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
Sorveglianza della West Nile Disease in Emilia-Romagna Bollettino n. 2 del 20 /08 /2010
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) ------------------------------------- BRESCIA Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) ------------------------------------- BRESCIA Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA
Le malattie delle piante. Classificazione e riconoscimento
 Le malattie delle piante Classificazione e riconoscimento MALATTIA: è una deviazione, uno sconvolgimento, delle normali funzioni vitali (di ricambio o di sviluppo) dell organismo; può essere causata da
Le malattie delle piante Classificazione e riconoscimento MALATTIA: è una deviazione, uno sconvolgimento, delle normali funzioni vitali (di ricambio o di sviluppo) dell organismo; può essere causata da
Indagine statistica sui fallimenti dichiarati dal Tribunale di Pescara dal 2001 al 2010 a cura di Luca Cosentino
 Indagine statistica sui fallimenti dichiarati dal Tribunale di Pescara dal 2001 al 2010 a cura di Luca Cosentino La presente analisi statistica è basata sui dati forniti dal Tribunale di Pescara per il
Indagine statistica sui fallimenti dichiarati dal Tribunale di Pescara dal 2001 al 2010 a cura di Luca Cosentino La presente analisi statistica è basata sui dati forniti dal Tribunale di Pescara per il
ATTIVITA DI MONITORAGGIO E DI PREVENZIONE NEL PARCO DEL BEIGUA nuove proposte progettuali
 ATTIVITA DI MONITORAGGIO E DI PREVENZIONE NEL PARCO DEL BEIGUA nuove proposte progettuali Maurizio Burlando Direttore Parco naturale regionale del Beigua 2 Provincie Genova e Savona 10 Comuni Arenzano
ATTIVITA DI MONITORAGGIO E DI PREVENZIONE NEL PARCO DEL BEIGUA nuove proposte progettuali Maurizio Burlando Direttore Parco naturale regionale del Beigua 2 Provincie Genova e Savona 10 Comuni Arenzano
Errori (o bias) negli studi epidemiologici
 Errori (o bias) negli studi epidemiologici Errore casuale o random: sono i più pericolosi perché i più difficili da individuare e per questo motivo non è possibile tenerne conto in fase di analisi Variazione
Errori (o bias) negli studi epidemiologici Errore casuale o random: sono i più pericolosi perché i più difficili da individuare e per questo motivo non è possibile tenerne conto in fase di analisi Variazione
UTILIZZO DI FITODERIVATI PER IL CONTENIMENTO DELLE PARASSITOSI DEGLI OVINI
 Progetto interregionale E.Qu.I.Zoo.Bio UTILIZZO DI FITODERIVATI PER IL CONTENIMENTO DELLE PARASSITOSI DEGLI OVINI Giuliano Palocci CRA - PCM Monterotondo (RM) Macomer, 19 novembre 2008 Introduzione La
Progetto interregionale E.Qu.I.Zoo.Bio UTILIZZO DI FITODERIVATI PER IL CONTENIMENTO DELLE PARASSITOSI DEGLI OVINI Giuliano Palocci CRA - PCM Monterotondo (RM) Macomer, 19 novembre 2008 Introduzione La
Piano di sorveglianza Leishmania in Emilia-Romagna dati storici e prospettive
 Seminario Le malattie da vettore - 4 aprile 2012 Piano di sorveglianza Leishmania in Emilia-Romagna dati storici e prospettive Annalisa Santi Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia-Romagna
Seminario Le malattie da vettore - 4 aprile 2012 Piano di sorveglianza Leishmania in Emilia-Romagna dati storici e prospettive Annalisa Santi Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia-Romagna
Albo IP: analisi dei flussi
 Federazione nazionale Collegi Ipasvi Via Agostino Depretis 70 Tel. 06 46200101 00184 Roma Fax 06 46200131 Albo IP: analisi dei flussi Rapporto 2007 Marzo 2008 1. Presentazione Dal 2007, dopo due anni di
Federazione nazionale Collegi Ipasvi Via Agostino Depretis 70 Tel. 06 46200101 00184 Roma Fax 06 46200131 Albo IP: analisi dei flussi Rapporto 2007 Marzo 2008 1. Presentazione Dal 2007, dopo due anni di
CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA
 CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA Valeria Bottura, C. Desandré, E. Imperial, Leo Cerise ARPA Valle d Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St.
CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA Valeria Bottura, C. Desandré, E. Imperial, Leo Cerise ARPA Valle d Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St.
Protocollo operativo di controllo d colombi in ambiente urbano: ruolo dei Servizi Veterinari
 Protocollo operativo di controllo d colombi in ambiente urbano: Dott. Stefania Mancini USL Umbria 1 Protocollo operativo di controllo dei colombi in ambiente AMBIENTE URBANO favorevole a colonizzazione
Protocollo operativo di controllo d colombi in ambiente urbano: Dott. Stefania Mancini USL Umbria 1 Protocollo operativo di controllo dei colombi in ambiente AMBIENTE URBANO favorevole a colonizzazione
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE LEGIONELLA
 CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE LEGIONELLA RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 201 1. Introduzione, informazioni sulla legionellosi e sulla sua incidenza Il Centro di Riferimento Regionale per la ricerca di Legionella
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE LEGIONELLA RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 201 1. Introduzione, informazioni sulla legionellosi e sulla sua incidenza Il Centro di Riferimento Regionale per la ricerca di Legionella
PRESENZA DI MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS NEL SUD ITALIA: PREVALENZA E CONTAMINAZIONE DEL LATTE
 PRESENZA DI MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS NEL SUD ITALIA: PREVALENZA E CONTAMINAZIONE DEL LATTE Andrea Serraino, Giacomo Marchetti, Federica Giacometti Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
PRESENZA DI MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS NEL SUD ITALIA: PREVALENZA E CONTAMINAZIONE DEL LATTE Andrea Serraino, Giacomo Marchetti, Federica Giacometti Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
La prevenzione degli infortuni stradali Report annuale 2011 sulle fonti di dati disponibili
 [2011] La prevenzione degli infortuni stradali Report annuale 2011 sulle fonti di dati disponibili Unità Organizzativa Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria DG Sanità La prevenzione degli infortuni
[2011] La prevenzione degli infortuni stradali Report annuale 2011 sulle fonti di dati disponibili Unità Organizzativa Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria DG Sanità La prevenzione degli infortuni
QUANDO RACCOGLIERE DATI SU BASE CAMPIONARIA??
 QUANDO RACCOGLIERE DATI SU BASE CAMPIONARIA?? 1) QUANDO SI ESEGUE UNA SPERIMENTAZIONE PILOTA 2) QUANDO E IMPRATICABILE, PER MOTIVI PRATICI, ECONOMICI ecc... RACCOGLIERE DATI SULL INTERA POPOLAZIONE (ad
QUANDO RACCOGLIERE DATI SU BASE CAMPIONARIA?? 1) QUANDO SI ESEGUE UNA SPERIMENTAZIONE PILOTA 2) QUANDO E IMPRATICABILE, PER MOTIVI PRATICI, ECONOMICI ecc... RACCOGLIERE DATI SULL INTERA POPOLAZIONE (ad
Presentazione dei risultati e delle valutazioni preliminari
 Presentazione dei risultati e delle valutazioni preliminari Obiettivi del piano di campionamento 2016-2017 Obiettivo del piano è la stima del livello di contaminazione da PFAS delle principali produzioni
Presentazione dei risultati e delle valutazioni preliminari Obiettivi del piano di campionamento 2016-2017 Obiettivo del piano è la stima del livello di contaminazione da PFAS delle principali produzioni
ALLEGATO 1 SPECIE E SOTTOSPECIE ENDEMICHE ORDINE SPECIE SOTTOSPECIE
 ALLEGATI ALLEGATO 1 SPECIE E SOTTOSPECIE ENDEMICHE ORDINE SPECIE SOTTOSPECIE INSETTIVORI LAGOMORFI CARNIVORI ARTIODATTILI Toporagno italico o appenninico Talpa romana Lepre italica Orso marsicano Camoscio
ALLEGATI ALLEGATO 1 SPECIE E SOTTOSPECIE ENDEMICHE ORDINE SPECIE SOTTOSPECIE INSETTIVORI LAGOMORFI CARNIVORI ARTIODATTILI Toporagno italico o appenninico Talpa romana Lepre italica Orso marsicano Camoscio
Indagine qualita percepita
 Sistema di Gestione per la Qualità - Ospedale M. G. Vannini Report sulla qualità percepita OSPEDALE M. G. VANNINI AUTORIZZATO ED ACCREDITATO CON D.C.A. DEL 28 LUGLIO 2015 N. 355 CERTIFICATO SISTEMA GESTIONE
Sistema di Gestione per la Qualità - Ospedale M. G. Vannini Report sulla qualità percepita OSPEDALE M. G. VANNINI AUTORIZZATO ED ACCREDITATO CON D.C.A. DEL 28 LUGLIO 2015 N. 355 CERTIFICATO SISTEMA GESTIONE
HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE
 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE 1 Aids in Italia e in Europa 2 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ AIDS IN ITALIA E IN EUROPA Giovanni Rezza Centro Operativo Aids - Istituto Superiore di Sanità
HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE 1 Aids in Italia e in Europa 2 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ AIDS IN ITALIA E IN EUROPA Giovanni Rezza Centro Operativo Aids - Istituto Superiore di Sanità
Prodotti e processi di conservazione e trasformazione del latte
 Prodotti e processi di conservazione e trasformazione del latte MATERIE PRIME PROCESSI DI CONSERVAZIONE PROCESSI DI TRASFORMAZIONE CONSERVAZIO NE DI BREVE TERMINE CONSERVAZIONE DI LUNGO TERMINE TRASFORMAZIONE
Prodotti e processi di conservazione e trasformazione del latte MATERIE PRIME PROCESSI DI CONSERVAZIONE PROCESSI DI TRASFORMAZIONE CONSERVAZIO NE DI BREVE TERMINE CONSERVAZIONE DI LUNGO TERMINE TRASFORMAZIONE
CESENA Turdus pilaris
 CESENA Turdus pilaris Distribuzione nel Paleartico occidentale Areale di svernamento Areale di presenza stabile Areale di nidificazione Stato giuridico Convenzione di Berna Convenzione di Bonn Direttiva
CESENA Turdus pilaris Distribuzione nel Paleartico occidentale Areale di svernamento Areale di presenza stabile Areale di nidificazione Stato giuridico Convenzione di Berna Convenzione di Bonn Direttiva
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE LEGIONELLA RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2014
 CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE LEGIONELLA RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2014 L AQUILA, 26 FEBBRAIO 201 1. Introduzione, informazioni sulla legionellosi e sulla sua incidenza Il Centro di Riferimento Regionale
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE LEGIONELLA RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2014 L AQUILA, 26 FEBBRAIO 201 1. Introduzione, informazioni sulla legionellosi e sulla sua incidenza Il Centro di Riferimento Regionale
OLYMPIC WATCH Sorveglianza e controllo dei giochi paralimpici
 Report del 14 marzo 2006 OLYMPIC WATCH Sorveglianza e controllo dei giochi paralimpici Sintesi delle informazioni raccolte dal sistema di sorveglianza nel giorno 13 marzo 2006 Ogni giorno alla valutazione
Report del 14 marzo 2006 OLYMPIC WATCH Sorveglianza e controllo dei giochi paralimpici Sintesi delle informazioni raccolte dal sistema di sorveglianza nel giorno 13 marzo 2006 Ogni giorno alla valutazione
Presentazione dei risultati e delle valutazioni preliminari
 Presentazione dei risultati e delle valutazioni preliminari Obiettivi del piano di campionamento 2016-2017 Obiettivo del piano è la stima del livello di contaminazione da PFAS delle principali produzioni
Presentazione dei risultati e delle valutazioni preliminari Obiettivi del piano di campionamento 2016-2017 Obiettivo del piano è la stima del livello di contaminazione da PFAS delle principali produzioni
Stagione Influenzale Report epidemiologico conclusivo Regione Emilia-Romagna
 Stagione Influenzale 0-0 Report epidemiologico conclusivo Regione Emilia-Romagna Descrizione dell epidemia Nel grafico è riportata l incidenza totale settimanale in Emilia-Romagna dei casi di sindromi
Stagione Influenzale 0-0 Report epidemiologico conclusivo Regione Emilia-Romagna Descrizione dell epidemia Nel grafico è riportata l incidenza totale settimanale in Emilia-Romagna dei casi di sindromi
La Salute raggiungibile per...
 La Salute raggiungibile per... 79 Nota introduttiva per la lettura delle patologie La scelta di descrivere le patologie più frequenti attraverso l analisi dell andamento dei ricoveri ospedalieri è stata
La Salute raggiungibile per... 79 Nota introduttiva per la lettura delle patologie La scelta di descrivere le patologie più frequenti attraverso l analisi dell andamento dei ricoveri ospedalieri è stata
INTRODUZIONE AL FENOMENO DELL ANTIBIOTICO RESISTENZA
 Bologna, 21 settembre 2015 L USO RESPONSABILE DELL ANTIBIOTICO NELL ALLEVAMENTO SUINO E BOVINO DA LATTE Bologna 13 GIUGNO 2018 INTRODUZIONE AL FENOMENO DELL ANTIBIOTICO RESISTENZA Andrea Luppi Istituto
Bologna, 21 settembre 2015 L USO RESPONSABILE DELL ANTIBIOTICO NELL ALLEVAMENTO SUINO E BOVINO DA LATTE Bologna 13 GIUGNO 2018 INTRODUZIONE AL FENOMENO DELL ANTIBIOTICO RESISTENZA Andrea Luppi Istituto
PROGETTO FEDERCHIMICA
 PROGETTO FEDERCHIMICA Scuola secondaria di I AS 2016-2017 SEZIONE SPECIALE: FARMACI PER ANIMALI Categoria B: cod. B00052 I FARMACI VETERINARI 1 I farmaci veterinari: cosa sono e come si usano. Nell opinione
PROGETTO FEDERCHIMICA Scuola secondaria di I AS 2016-2017 SEZIONE SPECIALE: FARMACI PER ANIMALI Categoria B: cod. B00052 I FARMACI VETERINARI 1 I farmaci veterinari: cosa sono e come si usano. Nell opinione
Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute
 Ministero della Salute Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie Dipartimento della Protezione Civile - DPC Centro di Competenza Nazionale di Prevenzione degli Effetti del Caldo
Ministero della Salute Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie Dipartimento della Protezione Civile - DPC Centro di Competenza Nazionale di Prevenzione degli Effetti del Caldo
OGM nella filiera agro-alimentare: linee guida, sistemi di gestione per la tracciabilità e metodi innovativi per il controllo ufficiale
 GLI OGM NELLA FILIERA AGROALIMENTARE: UNA RINUNCIA RAGIONATA O UNA OPPORTUNITA NON COLTA Roma 10 febbraio 2015, ISS OGM nella filiera agro-alimentare: linee guida, sistemi di gestione per la tracciabilità
GLI OGM NELLA FILIERA AGROALIMENTARE: UNA RINUNCIA RAGIONATA O UNA OPPORTUNITA NON COLTA Roma 10 febbraio 2015, ISS OGM nella filiera agro-alimentare: linee guida, sistemi di gestione per la tracciabilità
CESENA Turdus pilaris. Stato giuridico. Stato di conservazione. Convenzione di Berna. Allegato III. Convenzione di Bonn.
 CESENA Turdus pilaris Distribuzione nel Paleartico occidentale Areale di svernamento Areale di presenza stabile Areale di nidificazione Stato giuridico Convenzione di Berna Convenzione di Bonn Direttiva
CESENA Turdus pilaris Distribuzione nel Paleartico occidentale Areale di svernamento Areale di presenza stabile Areale di nidificazione Stato giuridico Convenzione di Berna Convenzione di Bonn Direttiva
SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
 Dicembre 2017 - n 23 Direzione Generale dei Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica, Monitoraggio dati e Comunicazione SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ATTIVAZIONI Nel terzo trimestre 2017
Dicembre 2017 - n 23 Direzione Generale dei Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica, Monitoraggio dati e Comunicazione SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ATTIVAZIONI Nel terzo trimestre 2017
RILEVAZIONE SULL INTERESSE DELL INFORMAZIONE ANNO 2010
 RILEVAZIONE SULL INTERESSE DELL INFORMAZIONE ANNO 2010 Nel mese di novembre 2010 il Centro Documentazione ha realizzato un indagine per rilevare l interesse dei contenuti informativi proposti dal Servizio
RILEVAZIONE SULL INTERESSE DELL INFORMAZIONE ANNO 2010 Nel mese di novembre 2010 il Centro Documentazione ha realizzato un indagine per rilevare l interesse dei contenuti informativi proposti dal Servizio
Generalità sugli Ungulati
 CORSO PER CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI URCA Cremona 2016 Generalità sugli Ungulati A cura di Elisa Armaroli Alcuni concetti Nella nomenclatura binomiale ogni specie animale o vegetale viene
CORSO PER CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI URCA Cremona 2016 Generalità sugli Ungulati A cura di Elisa Armaroli Alcuni concetti Nella nomenclatura binomiale ogni specie animale o vegetale viene
ANALISI EPIDEMIOLOGICA SULLA FREQUENZA DEI TUMORI NELLA ZONA SOCIO-SANITARIA VALDARNO ARETINA Eta anni
 ANALISI EPIDEMIOLOGICA SULLA FREQUENZA DEI TUMORI NELLA ZONA SOCIO-SANITARIA VALDARNO ARETINA Eta 30-49 anni SINTESI DEI DATI PRESENTATI Con una metodologia analoga a quella utilizzata per l analisi della
ANALISI EPIDEMIOLOGICA SULLA FREQUENZA DEI TUMORI NELLA ZONA SOCIO-SANITARIA VALDARNO ARETINA Eta 30-49 anni SINTESI DEI DATI PRESENTATI Con una metodologia analoga a quella utilizzata per l analisi della
L accesso in Pronto Soccorso nei minori di 14 anni
 L accesso in Pronto Soccorso nei minori di 14 Il Pronto Soccorso (PS) rappresenta un interessante punto di osservazione della popolazione, nell ottica delle disuguaglianze in salute. Infatti, le caratteristiche
L accesso in Pronto Soccorso nei minori di 14 Il Pronto Soccorso (PS) rappresenta un interessante punto di osservazione della popolazione, nell ottica delle disuguaglianze in salute. Infatti, le caratteristiche
RING TEST NAZIONALE LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA PER LA RICERCA DI ANTICORPI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche Centro di Referenza Nazionale per lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie infettive dei Ruminanti RING TEST NAZIONALE PER LA RICERCA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche Centro di Referenza Nazionale per lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie infettive dei Ruminanti RING TEST NAZIONALE PER LA RICERCA
IZSLER. Bologna. 14 agosto Sommario ...
 Sommario Sorveglianza del virus West Nile in Emilia Romagnaa IZSLER Sorveglianza Epidemiologica, Bologna 14 agosto 2018 1. Introduzione... 1 2. Sorveglianza sull avifauna selvatica... 2 3. Sorveglianza
Sommario Sorveglianza del virus West Nile in Emilia Romagnaa IZSLER Sorveglianza Epidemiologica, Bologna 14 agosto 2018 1. Introduzione... 1 2. Sorveglianza sull avifauna selvatica... 2 3. Sorveglianza
GLOSSARIO. L azione da attuare ogni qualvolta si verifichino delle non conformità o deviazioni rispetto ai limiti critici individuati.
 GLOSSARIO ANALISI DEL PERICOLO Il processo di raccolta e valutazione delle informazioni riguardanti i pericoli e le condizioni che ne provocano la presenza, per decidere quali necessitano di essere considerati.
GLOSSARIO ANALISI DEL PERICOLO Il processo di raccolta e valutazione delle informazioni riguardanti i pericoli e le condizioni che ne provocano la presenza, per decidere quali necessitano di essere considerati.
Il sistema a rete dell epidemiologia veterinaria: randagismo e Leishmaniosi. Anna Duranti Centro Epidemiologico Regionale Veterinario
 Il sistema a rete dell epidemiologia veterinaria: randagismo e Leishmaniosi. Anna Duranti Centro Epidemiologico Regionale Veterinario Leishmaniosi canina Grave malattia del cane, con andamento generalmente
Il sistema a rete dell epidemiologia veterinaria: randagismo e Leishmaniosi. Anna Duranti Centro Epidemiologico Regionale Veterinario Leishmaniosi canina Grave malattia del cane, con andamento generalmente
I PROGETTI MULTICENTRICI:FIRENZE Massimo Confortini Citologia Analitica e Biomolecolare-ISPO Firenze
 CONVEGNO NAZIONALE GISCI GESTIRE IL CAMBIAMENTO Venezia 27-28 maggio 2010 I PROGETTI MULTICENTRICI:FIRENZE Massimo Confortini Citologia Analitica e Biomolecolare-ISPO Firenze PROGETTI DI FATTIBILITA MULTICENTRICO
CONVEGNO NAZIONALE GISCI GESTIRE IL CAMBIAMENTO Venezia 27-28 maggio 2010 I PROGETTI MULTICENTRICI:FIRENZE Massimo Confortini Citologia Analitica e Biomolecolare-ISPO Firenze PROGETTI DI FATTIBILITA MULTICENTRICO
Ebola, caso sospetto nelle Marche, ma dovrebbe trattarsi di malaria. La dichiarazione di Mezzolani
 Ebola, caso sospetto nelle Marche, ma dovrebbe trattarsi di malaria. La dichiarazione di Mezzolani SOSPETTO CASO EBOLA, IN CORSO IL TRASFERIMENTO DELLA PAZIENTE DALL OSPEDALE DI CIVITANOVA ALLA DIVISIONE
Ebola, caso sospetto nelle Marche, ma dovrebbe trattarsi di malaria. La dichiarazione di Mezzolani SOSPETTO CASO EBOLA, IN CORSO IL TRASFERIMENTO DELLA PAZIENTE DALL OSPEDALE DI CIVITANOVA ALLA DIVISIONE
EXPOSICURAMENTE. La sicurezza alimentare. DALLA TERRA ALLA TAVOLA. BRESCIA, 25 gennaio dalle alle BRESCIA, martedì 10 aprile 2018
 Convegno Nazionale con workshop EXPOSICURAMENTE. La sicurezza alimentare. DALLA TERRA ALLA TAVOLA Relatore: Dr. Paolo Daminelli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'emilia Romagna
Convegno Nazionale con workshop EXPOSICURAMENTE. La sicurezza alimentare. DALLA TERRA ALLA TAVOLA Relatore: Dr. Paolo Daminelli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'emilia Romagna
