La fauna dell'insediamento dei Pizzini di Castellano (TN) e l'allevamento nell'italia nord orientale nel corso dell'antica età del bronzo.
|
|
|
- Floriana Garofalo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Maurizio Battisti, Stefano Marconi La fauna dell'insediamento dei Pizzini di Castellano (TN) e l'allevamento nell'italia nord orientale nel corso dell'antica età del bronzo. The fauna of the settlement Pizzini di Castellano (TN) and the animal economy in the north-eastern Italy during the early Bronze Age. Riassunto (italiano) Questo contributo prende in esame la fauna inedita di un insediamento dell antica età del bronzo ubicato lungo la valle dell Adige, nel Trentino meridionale. Si cerca poi di ampliare lo sguardo per fare il punto sulle ricerche svolte fin ora sull allevamento nell età del bronzo in tutta l Italia nord-orientale e per distinguere e delimitare, ove possibile, aree economiche che presentino una diversa gestione pastorale. Riassunto (inglese) This paper present the unpublished fauna of an early Bronze Age settlement located in the Adige Valley, in southern Trentino. Then it takes into consideration the researches carried out -up to now- on the animal economy during the Bronze Age in north-eastern Italy in order to determine and delimit, when possible, the economic areas presenting a different pastoral management. Introduzione Il sito dei Pizzini, prossimo all abitato odierno di Castellano (comune di Villalagarina), si trova sul versante occidentale della Vallagarina, pochi chilometri a nord di Rovereto, su un terrazzo naturale a 700 m/s.l.m. che strapiomba sulla valle. Il sito, scoperto alla fine degli anni 60 dello scorso secolo, è stato indagato stratigraficamente dal Museo Civico di Rovereto a partire dal Gli scavi sono stati effettuati nella porzione più orientale di questo terrazzo che, nel corso dei millenni, si è staccata dal resto del versante di qualche metro dando origine ad una lunga e profonda gola di origine tettonica denominata dai locali Zolina. L area interessata dai ritrovamenti archeologici si presenta quindi completamente circondata da dirupi fortemente scoscesi 1. Si tratta di un nucleo insediativo la cui vita copre quasi tutta l antica età del bronzo (Ba 1 e Ba 2) 2. 1 Se si eccettua il punto di accesso attuale, creato grazie all accumulo artificiale di grandi quantità di terra attuato dai contadini nel corso degli ultimi due secoli. 2 Nella cronologia proposta in De Marinis, 2000;
2 Il sito ha restituito numerosi resti faunistici legati alle attività agropastorali e venatorie dell abitato. In questo contributo vengono presentati i risultati dell analisi della fauna relativa alle prime fasi dell abitato, inquadrabili quindi nel periodo iniziale del bronzo antico (XX-XIX sec. a.c.). Lo strato più antico (US 24) è stato datato con il radiocarbonio tra il 2047 e il 1871 a.c. 3 Si è cercato poi di ampliare lo sguardo per definire un quadro d insieme delle conoscenze fin ora acquisite sulle composizioni faunistiche dell antica età del bronzo, nel panorama dell Italia Nord-Orientale. Fig. 1 Posizionamento del sito 3 Laboratorio dell Istituto di Fisica del Politecnico di Zurigo (ETH), datazione non calibrata: 3610±50 BP.
3 Abbreviazioni ed elenco dei siti di confronto analizzati. Quando non espressamente indicato le misure si intendono in millimetri ed il peso in grammi. Le misure sono state prese secondo le indicazioni fornite da DRIESCH V. D La distinzione delle ossa tra capra e pecora e stata eseguite secondo quanto riportato sul testo di BOESSNEK, MÜLLER, TEICHERT N.R. = numero dei resti (ossei); N.M.I. = numero minimo degli individui; g = grammi; % = percentuale; I.F. = indice di frammentazione; n = numero; N. inv. = numero di inventario; U.S. = unità stratigrafica; E = eneolitico (o età del rame); Bz = età del bronzo; Fe = età del ferro; a/m/r = antico/medio/recente; ant. = anteriore; post. = posteriore; (-) = misura incerta; B = larghezza; Bd = massima larghezza distale; BFcr = larghezza della superficie articolare craniale; BFp = larghezza della superficie articolare prossimale; Bp = massima larghezza prossimale; BPC = larghezza del processo coronoideo; BT = larghezza della troclea; DD = minima profondità della dialisi; Dl = massimo spessore laterale; DLS = lunghezza diagonale della suola; Dm = massimo spessore mediale; Dp = massima profondità prossimale; DPA = spessore sul processo anconaeus; GB = larghezza massima; GD = spessore massimo; GL = massima lunghezza; GLl = massima lunghezza laterale; GLm = massima lunghezza mediale; Glpe = massima lunghezza periferica; H = altezza; L = lunghezza; LAd = lunghezza dell arco dorsale; LAR = lunghezza dell acetabolo al bordo; Ld = lunghezza della superficie dorsale; MBS = larghezza nel mezzo della suola; SD = minima larghezza della dialisi;
4 Sonnenburg (BZ) (E Bz/a) RIEDEL 1984; Lasino (TN) (E/r Bz/a) TECCHIATI 1990/91; RIEDEL, TECCHIATI 1993a e 1993b; Colombo di Mori (TN) (Bz/a) BONARDI, MARCONI, RIEDEL, TECCHIATI 2002; Pizzini(TN) (Bz/a) BATTISTI, MARCONI, questo lavoro; Barche di Solferino (MN) (Bz/a) RIEDEL 1976a; Naturno(BZ) (Bz/a) RIEDEL, TECCHIATI 2000; Monte Covolo (Bz/a) BARKER 1979; Ostiano (CR) (Bz/a) CLARK 1980; Lagazzi (CR) (Bz/a) CAVALLO 2000; Ledro (TN) (Bz/a/m) RIEDEL 1976b; Nössing (BZ) (Bz /a/m) RIEDEL, TECCHIATI 1999; Fiavè (TN) (Bz/a/m) JARMAN 1975; CLARK, GAMBLE 1984; Cisano(VR) (Bz/a/m) RIEDEL 1990; Albanbühel (BZ) (Bz/m) RIEDEL, RIZZI 1995; Nogarole Rocca (VR) (Bz/m) RIEDEL 1994; Monte Leoni (PR) Bz/m) BONARDI, SCARPA 1982; Tabina di Magreta (MO) (Bz/m) DE GROSSI MAZZORIN 1988 Sotciastel (BZ) (Bz/m/r) RIEDEL, TECCHIATI 1998; Isolone (MN) (Bz/m/r) RIEDEL 1975; Poviglio (Bz/m/r) RIEDEL 1989; Appiano (BZ) (Bz/r) RIEDEL 1985; Canar (RO) (Bz/r) RIEDEL 1998; La fauna dei Pizzini di Castellano Tutte le unità stratigrafiche indagate sono caratterizzate da un alta concentrazione di resti faunistici. Questa testimonianza indiretta di una persistente attività produttiva legata al sostentamento dell insediamento induce a pensare che l abitato abbia conosciuto una certa stabilità e continuità nel corso di tutta la sua esistenza. Presso il laboratorio di archeozoologia del Museo Civico di Rovereto sono stati studiati fin ora solo i resti provenienti, come già detto, dalle unità stratigrafiche più antiche ossia essenzialmente da US 14, 15, 16, 18 e Come accade quasi sempre nel caso di fauna proveniente da insediamenti, lo stato di conservazione del materiale analizzato è scarso: le ossa si presentano tutte molto frammentate e le poche che conservano una certa integrità sono quelle dure e di piccole dimensioni come gli astragali, i denti e le falangi. L indice di frammentazione, indicativo del grado di conservazione degli ossi, è pari a 4,6 g/resto per il totale della fauna, 11,9 g/resto per i reperti determinati e 2 g/resto per l insieme dei non determinati. Questi sono valori piuttosto comuni per gli insediamenti umani di epoca preistorica dove i resti ossei sono sottoposti ad intense sollecitazioni soprattutto di tipo meccanico (fatturazione per l estrazione del midollo, calpestio, ecc.). I frammenti si presentano con colore variabile entro le gradazioni del bruno con predominanza delle tonalità tendenti al beige. Solo 5 frammenti ossei, 3 di maiale, uno di bovino e uno non determinato, presentano caratteristiche cromatiche che sono imputabili agli esiti di una esposizione diretta alla 4 Studio eseguito da uno degli autori di questo contributo, il dott. Stefano Marconi insieme al dott. Alfredo Riedel.
5 fiamma del fuoco, altri 6 reperti presentano poi tracce e solchi dovuti alla masticazione operata da altri animali (probabilmente cani). Una cavicchia di capra mostra segni di lavorazione ed inoltre un astragalo e una tibia di cervo, una tibia di bue e un ulna di maiale evidenziano incisioni dovute a pratiche di macellazione. Sono stati analizzati in totale 1771 resti, fra i quali 462 sono stati determinati in relazione sia alla specie che al tipo di osso. Il quadro che ne esce (fig.2) mostra, nel numero resti, una predominanza di caprovini, seguiti da quelli di suini e bovini. La selvaggina è rappresentata da cervo, capriolo e camoscio. Individuata inoltre anche la presenza del cane. Numero resti selvatici 8% cane 2% maiale 31% bue 21% capra e pecora 37% Numero resti Peso N. % g. % Bos primigenius f. taurus 89 21,2 2375,2 44,8 Capra hircus / Ovis aries* ,1 838,4 15,8 Sus scrofa f. domestica ,4 1078,1 20,3 Canis lupus f. familiaris 10 2,4 67,5 1,3 Cervus elaphus** 30 7,1 914,2 17,2 Capreolus capreolus 2 0,5 19,5 0,4 Rupicapra rupicapra 1 0,2 7,2 0,1 Tot. Determinati** ,0 5300,1 100,0 Indeterminati ,6 Totale** ,7 Totale complessivo ,4 Fig. 2 (* Fra questi 13 resti sono attribuiti a Ovis aries e 10 a Capra hircus. ** Nell insieme non sono considerati i palchi) Un discorso a parte si può fare per la cacciagione, che rappresenta nel sito dei Pizzini di Castellano, meno dell 8% della fauna totale Questo dato è tuttavia molto più rilevante che in altri contesti coevi, dove si attesta, in genere, al massimo attorno al 4% (vedi fig.7). L animale più cacciato in assoluto risulta essere il cervo a cui si aggiungono pochi resti di capriolo e camoscio. Alta anche la percentuale della presenza di cani che raggiunge un 2% superato solo dal sito di Barche di Solferino.
6 Il calcolo del numero minimo di individui (fig.3), mostra un quadro molto simile a quello dato dal numero di resti: predominanza dei caprovini, seguiti dai suini e dai bovini. E probabile che la caccia al cervo fosse un attività di particolare importanza in questo sito e che non fosse dovuta ad abbattimenti casuali dettati dalla necessità di difendere i coltivi. Questa ipotesi sembra avvalorata dalla considerazione che ad esempio il capriolo, la cui dannosità per le coltivazioni è paragonabile a quella del cervo, è presente in questa fauna con soli due resti ossei (contro i 35 dell altro). L'importanza che doveva rivestire la caccia a questo ungulato potrebbe essere indicata anche dal fatto che il numero minimo di individui calcolato per i bovini è solo di poco superiore a quello dei cervi. N.M.I % Bos primigenius f. taurus 6 15,4 Capra hircus / Ovis aries 13 33,3 Sus scrofa f. domestica 11 28,2 Canis lupus f. familiaris 2 5,1 Cervus elaphus* 5 12,8 Capreolus capreolus 1 2,6 Rupicapra rupicapra 1 2,6 Fig.3 (* Non sono stati considerati i palchi) Prendendo in esame la distribuzione dei ritrovamenti per ogni singola unità stratigrafica (fig.4) si può tentare di dare un senso cronologico, seppur parziale, al quadro economico fin qui descritto. Tale operazione, di primo acchito, potrebbe apparire un po azzardata dal momento che il numero di resti rinvenuti per ogni singolo strato è poco significativo e perciò a livello statistico forse non sufficiente. Riteniamo comunque utile un tentativo in questo senso data la buona affidabilità stratigrafica di questo contesto archeologico (cosa relativamente rara fra gli studi archeozoologici finora editi), e vista la notevole corrispondenza, come vedremo in seguito, tra i dati ricavati dall analisi faunistica e quelli elaborati attraverso l analisi dei reperti archeologici. Durante le prime fasi di insediamento (US 16) l animale prevalentemente allevato è il maiale, seguito dai caprovini e dai bovini. Nella fase immediatamente successiva c è poi un incremento dell allevamento dei caprovini che supera quello dei suini (US 18). In seguito (US 14) l insediamento si stabilizza su quest ultimo schema con una prevalenza di caprovini, seguiti dai suini e infine dai bovini che hanno recuperano una certa importanza. Data la scarsità dei resti recuperati non vengono prese in considerazione US 15 e US 27. La prevalenza di suini sul resto dei domestici che emerge nel periodo iniziale della vita dell abitato risulta essere del tutto anomala nel panorama della locale età del bronzo (vedi fig.7). Bisogna però sottolineare che questa primissima fase insediativa si presenta in modo irregolare anche tenendo presente tutto il campione dei manufatti archeologici. In questo periodo, infatti, manca del tutto la documentazione di alcune attività artigianali ben presenti nelle successive unità stratigrafiche. Tali valutazioni inducono a pensare che siamo di fronte ad un uso iniziale non direttamente residenziale del settore indagato, forse un area periferica di un abitato che quindi, come tale, non può essere considerata come elemento chiave per formulare un interpretazione globale dell economia dell insediamento.
7 US 14 Numero resti Peso N. % g. % Bos primigenius f. taurus 27 23,9 709,2 49,7 Capra hircus / Ovis aries 47 41,6 234,4 16,4 Sus scrofa f. domestica 28 24,8 241,3 16,9 Canis lupus f. familiaris 5 4,4 40,8 2,9 Cervus elaphus 4 3,5 174,9 12,3 Capreolus capreolus 1 0,9 18,3 1,3 Rupicapra rupicapra 1 0,9 7,2 0,5 Tot. Determinati ,0 1426,1 100,0 Indeterminati ,4 Totale ,5 Capra hircus 4 15,5 Ovis aries 2 22,1 US 16 Numero resti Peso N. % g. % Bos primigenius f. taurus 20 17,5 505,8 42,1 Capra hircus / Ovis aries 40 35,1 224,9 18,7 Sus scrofa f. domestica 45 39,5 298,9 24,9 Canis lupus f. familiaris 1 0,9 0,9 0,1 Cervus elaphus 8 7,0 172,0 14,3 Tot. Determinati ,0 1202,5 100,0 Indeterminati ,4 Totale ,9 Capra hircus 2 7,6 Ovis aries 3 14,1 US 18 Numero resti Peso N. % g. % Bos primigenius f. taurus 9 13,2 182,9 35,6 Capra hircus / Ovis aries 28 41,2 123,6 24,1 Sus scrofa f. domestica 26 38,2 149,6 29,2 Canis lupus f. familiaris 3 4,4 20,5 4,0 Cervus elaphus 2 2,9 36,5 7,1 Tot. Determinati ,0 513,1 100,0 Indeterminati ,1 Totale ,2 Capra hircus 1 0,9 Fig. 4 Composizione faunistica per ciascuna unità stratigrafica
8 Il sesso predominante tra i resti delle quattro specie di domestici principali, in età adulta, è quello femminile, con maggiore evidenza nel caso di bovini e caprovini (fig.5). La maggior quantità di femmine è una scelta naturale ed ovvia soprattutto per il gruppo dei caprovini e dipende da due fattori principali: il primo, di origine culturale, è dovuto all approvvigionamento di latte, lana, prole, mentre il secondo, naturale, riguarda la territorialità spiccata dei maschi di alcune specie. Per i bovini la maggiore quantità di animali adulti di sesso femminile non era, invece, sempre scontata, infatti poteva anche esserci una notevole quantità di individui castrati di grande utilità nelle mansioni lavorative la cui presenza è testimoniata ad esempio nei siti coevi di Ledro e Barche di Solferino, ma che non è stato possibile confermare per l abitato dei Pizzini. Per quanto riguarda i suini invece le quantità di individui dei due sessi probabilmente tendevano ad equivalersi, fino ad un età poco superiore alla maturità sessuale (circa 2 anni), età dopo la quale l incremento della massa corporea non varia più di molto, per cui risultava più conveniente eliminare le bestie in eccesso, soprattutto del sesso meno produttivo (quello maschile). Sesso 5 4 N. di resti Bovini Caprovini Suini Femmine Maschi Fig.5 L età di morte degli animali (fig.6) indica un allevamento di bovini finalizzato, con pari importanza, al rifornimento di carne, di latte e forza lavoro. I caprovini presentano un età di morte molto diversificata con una maggiore percentuale di individui adulti che farebbe supporre un prolungato sfruttamento di questi animali per la produzione di lana, latte e secondariamente di carne. Bisogna però tener conto che 3 degli individui adulti ricavati attraverso il metodo del N.M.I., sono in realtà giovani adulti, cioè animali che hanno appena raggiunto la maturità sessuale e che perciò non sono stati sfruttati a lungo. Quindi da questa elaborazione si acquisisce che in realtà il numero teorico di animali utilizzabile per gli scopi sopra detti verrebbe ridotto al numero di 4 contro i 9 delle altre classi d età ed indurrebbe così a pensare ad una notevole importanza anche del rendimento in carne. I suini, fra i quali, come già accennato, la presenza di maschi e di femmine sarebbe stata sostanzialmente equilibrata, erano sfruttati soprattutto per l approvvigionamento di carne e spesso venivano macellati in giovane età o non appena raggiunta la maturità. Difatti anche per questi animali bisogna far notare come 2 dei 3 individui adulti calcolati col metodo del N.M.I. in realtà corrispondano a giovani adulti, cioè ad elementi poco più che subadulti. La totale assenza di cani neonati, giovani e subadulti indica che probabilmente morivano di morte naturale e che quindi costituivano essenzialmente un animale da compagnia e probabilmente utile nella conduzione delle greggi, per la caccia, la guardia, ecc.
9 Età 8 N. di individui Bovini Caprovini Suini Cani Cervi infante Giovane Subadulto Adulto Fig.6 Si è potuto ricavare l altezza al garrese di due pecore e di un maiale grazie alla lunghezza laterale dei rispettivi astragali. I risultati sono per gli ovini 71,2 e 66,6 cm 5, per il suino 74,1 cm 6. Per mezzo delle misure prese sulle varie ossa si è potuto anche determinare che in generale i bovini e gli ovini avevano dimensioni simili a quelli dei siti coevi della zona del Trentino Alto Adige e del Veneto, mentre i suini sembra fossero leggermente più grandi di quelli di Ledro e del Colombo e forse più vicini a quelli di Barche di Solferino. Sulla base delle considerazioni finora espresse si è tentato di formulare un ipotesi sul tipo di economia pastorale del sito in esame. E possibile evidenziare innanzitutto la presenza di vaste zone pianeggianti o poco scoscese che dovevano ospitare, come al giorno d oggi, una parziale copertura boschiva rappresentata soprattutto dalla compresenza del faggio e della quercia (a questa quota altimetrica, infatti, si sovrappongono il limite superiore dei querceti e quello inferiore dei grandi boschi di faggio). Questa situazione era ideale per il pascolo dei suini, pratica ormai scomparsa ma in uso anche nel medioevo 7, che sono molto ghiotti di ghiande e faggiole. Il taglio degli alberi per la creazione di nuovi terreni agricoli o di pascolo, per la costruzione delle case e per il riscaldamento non doveva aver determinato la totale eliminazione della copertura arborea circostante, vista l abbondante presenza di palchi e di ossa di cervo, non così comune nell ambito degli altri insediamenti coevi (vedi fig.7). Per il pascolo dei caprovini e soprattutto dei bovini, infine, erano disponibili e facilmente raggiungibili i prati in quota, sopra al limite della vegetazione arborea. L attività venatoria, come in tutti i siti dell antica età del bronzo, costituiva una pratica accessoria e poco influente nel sistema economico dell insediamento anche se, come già sottolineato, ai Pizzini la caccia al cervo rivestiva una certa importanza. 5 Altezza desunta basandosi sui coeficienti tratti da Teichert, Altezza desunta basandosi sui coeficienti tratti da Teichert, Sebesta, 1996, pp
10 Le faune dell Italia Nord-orientale nel bronzo antico Nel tentativo di inquadrare il sito nell ambito dell economia regionale e interregionale sono stati indicati su una carta geografica dell Italia nord-orientale tutti i siti del bronzo antico di cui si conosce la fauna (fig.6) cercando di evidenziare eventuali affinità o divergenze legate a scelte economiche diverse. Basandosi sulle percentuali del numero di resti domestici sono state poi delimitate le aree che conservano caratteri comuni nel tipo di allevamento dando origine a sei gruppi distinti. La carta si presenta purtroppo lacunosa in più punti a causa della modesta documentazione oggi esistente relativamente al periodo preso in esame. Per ovviare a questa incompletezza poteva essere utile prendere in considerazione anche faune di insediamenti del bronzo medio visto che i fattori culturali ed ambientali che stanno alla base delle diverse scelte pastorali causano in genere lenti cambiamenti inquadrabili nei processi di lunga durata. Non è quindi considerato un errore affiancare faune di insediamenti del bronzo antico a faune del bronzo medio nella stessa analisi economica, come dimostrano del resto numerose ricerche già pubblicate 8. L allevamento è infatti un fenomeno che ha un carattere relativamente più stabile di altre manifestazioni culturali quali, ad esempio, la tipologia dei manufatti, la tecnologia edilizia, ecc. Esso è comunque, in quanto espressione dell economia, un prodotto fondamentale della cultura e come tale risulta storicamente determinato. Tuttavia, in questa sede, non sono stati preliminarmente considerati i siti relativi al bronzo medio 9 in quanto l arco cronologico esaminato ( a.c.) è stato ritenuto sufficientemente lungo per tentare di formulare alcune ipotesi di lavoro che inquadrino meglio il tipo di economia che si andava sviluppando nell Italia nord-orientale nel pieno del processo di stabilizzazione degli insediamenti. Questo processo, che vede tra i più macroscopici fenomeni la diminuzione sostanziale della presenza dei selvatici nelle composizioni faunistiche, inizia già sporadicamente nell Eneolitico, periodo di cui manca purtroppo una sufficiente documentazione archeologica. 8 Vedi ad es. Riedel, Tecchiati, 1998; Riedel, Per un quadro più generale sull età del bronzo vedi l ultimo paragrafo.
11 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6 Fig. 6 LEGENDA 1. Barche di Solferino 4. Lagazzi 7. Fiavè 10. Colombo di Mori 13. M.Covolo 2. Canàr 5. Lasino 8. Sonnenburg 11. Naturns 14. Ostiano 3. Cisano 6. Ledro 9.Pizzini 12. Nössing
12 Ledro Fiavé Lasino Cisano Naturns Bos primigenius f. taurus 23, ,6 34,2 27,3 Capra hircus / Ovis aries 65,2 71,5 49,7 50,5 65 Sus scrofa f. domestica 8 8,5 14,0 15,3 5,1 Canis lupus f. familiaris 0,4-0,4 0 2,7 Equus ferus f. caballus Cervus elaphus 2,2-3,8 0 0 Ursus arctos 0,8-0,1 0 0 Rupicapra rupicapra 0, Capreolus capreolus 0,2-0,1 0 0 Lepus europaeus 0-0,1 0 0 Sus scrofa Vulpes vulpes 0, Altri* 0-0, Nössing Sonnenburg Colombo Pizzini M. Covolo (Fase 4) Bos primigenius f. taurus 45,2 51,2 21,8 21,62 30,1 Capra hircus / Ovis aries 42, ,68 34,5 Sus scrofa f. domestica 9,5 8,5 23,1 31,26 33,1 Canis lupus f. familiaris 0,3 1,6 1,6 1,96 0,24 Equus ferus f. caballus 0 0,8 0,4 0 0 Cervus elaphus 2 0 1,6 6,85 0,89 Ursus arctos 0,2 0 1,1 0 0 Rupicapra rupicapra 0, ,22 0 Capreolus capreolus 0,3 0 0,1 0,43 0,4 Lepus europaeus 0 0 0,5 0 0 Sus scrofa 0,2 0 0,4 0 0 Vulpes vulpes 0 0 0,1 0 0,24 Altri* 0 0 0,1 0 0,4 Barche Ostiano Lagazzi Canar Bos primigenius f. taurus 31,6 50,56 29,2 25,5 Capra hircus / Ovis aries 24,3 26,96 40,6 29,1 Sus scrofa f. domestica 25,1 21,9 24,6 45,4 Canis lupus f. familiaris 2,5 0 1,2 0,8 Equus ferus f. caballus 0, Cervus elaphus 8,8 0 2,4 1,8 Ursus arctos 0, Rupicapra rupicapra 0 0 0,1 0 Capreolus capreolus 3,5 0 0,4 0,2 Lepus europaeus 0 0,56 0,06 0 Sus scrofa 3 0 0,3 1,4 Vulpes vulpes 0 0 0,06 0 Altri* 0 0 0,56 0,5 Fig 7 (* = Ci si riferisce alla cacciagione di minor rilevanza percentuale costituita da stambecchi, uccelli, roditori, tartarughe, pesci, martore, lupi, lontre, gatti selvatici. Il trattino indica l indisponibilità del dato. Per il sito di Fiavè mancano i dati relativi ai selvatici per il periodo in esame e quindi le percentuali si riferiscono unicamente al totale dei domestici)
13 Il primo gruppo individuato si colloca nella zona della Val Pusteria, in Alto Adige. Gli unici due siti considerati, Sonnenburg e Nössing, hanno restituito una fauna dove spiccano soprattutto i bovini, seguiti a breve distanza dai caprovini, con una scarsa presenza di suini (fig.8). Allevamento: gruppo 1 Perc. (%) Nössing Sonnenburg Bovini Caprovini Suini Fig.8 10 Il secondo gruppo comprende una vasta area che va dal Lago di Garda meridionale, con il sito di Cisano, alla Val Venosta, con il sito di Naturns/Naturno. Qui predominano i caprovini, seguiti a lunga distanza dai bovini mentre i suini superano raramente il 10%. Di questo folto gruppo fanno parte anche i siti di Ledro, Fiavè 11 e Lasino (fig.9). 80 Allevamento: gruppo 2 Perc.(%) Bovini Caprovini Suini 0 Ledro Fiavé Lasino Cisano Naturns Fig.9 Il sito dei Pizzini di Castellano rientra nel terzo gruppo insieme al vicino sito del Colombo di Mori e a quello di Monte Covolo. E caratterizzato da una predominanza non troppo accentuata di caprovini, seguiti dai bovini di poco superiori ai suini. Questi siti presentano 10 Le percentuali considerate per l elaborazione di questi grafici sono state calcolate sul totale della fauna, compresi i selvatici. 11 Clark, Gamble, 1984 (sono state considerate solo le fasi D ed E, riferibili al bronzo antico).
14 una fauna che si discosta di poco da quella del secondo gruppo. La differenza più evidente sta nella percentuale maggiore di suini (fig. 10). Che le differenze fra un gruppo e l altro non siano così marcate lo dimostrano le faune di Cisano e di Lasino, appartenenti al secondo gruppo ma con una percentuale di suini che si avvicina a quelle del terzo gruppo. Allevamento: gruppo 3 Perc. (%) Colombo Pizzini M. Covolo (Fase 4) Bovini Caprovini Suini Fig.10 Spostandoci in pianura troviamo un quarto gruppo, nel quale rientrano il sito di Barche di Solferino e quello di Ostiano. Le faune analizzate mostrano una prevalenza di bovini, seguiti da caprovini e suini in proporzioni quasi identiche o con lievi differenze percentuali (fig.11). Allevamento: gruppo 4 Perc. (%) Barche Ostiano Bovini Caprovini Suini Fig.11 Il quinto e il sesto gruppo sono costituiti da un solo sito ciascuno, con faune però radicalmente diverse fra loro. Si tratta del sito di Lagazzi, che vede la prevalenza dei caprovini sui bovini seguiti da una buona percentuale di suini e del sito di Canar, nel quale spiccano invece i suini, seguiti da caprovini e bovini (fig.12). Solo in presenza di nuovi dati su insediamenti coevi circostanti sarebbe possibile verificare l effettiva estensione del gruppo.
15 Allevamento: gruppi 5 e 6 Perc. (%) Lagazzi Canar Bovini Caprovini Suini Fig.12 I siti appartenenti al secondo gruppo sorgono in posizioni geomorfologiche ed altimetriche radicalmente diverse fra loro. Il fatto che avessero comunque un economia pastorale simile induce a pensare che le scelte alla base dell assetto economico fossero maggiormente influenzate da fattori di tipo culturale, e che i parametri ambientali avessero una incidenza meno rilevante. Il terzo gruppo sembra costituire una zona di contatto fra il secondo e il quarto, i quali manifestano orientamenti economici profondamente diversi. Mentre per Monte Covolo ciò è facilmente spiegabile vista la sua posizione intermedia, per i siti dell alta Vallagarina occorre fare alcune osservazioni. La valle dell Adige ha da sempre avuto un ruolo fondamentale come via principale di comunicazione transalpina. Di conseguenza questa valle costituisce un area culturale molto permeabile, nel panorama del Trentino Alto Adige, sempre pronta ad acquisire le novità provenienti sia da Nord sia dalla pianura Padana. In questo contesto risulta molto facile comprendere come in Vallagarina possa esistere una zona di contatto fra il secondo gruppo e il quarto. Sia nel caso di Monte Covolo, sia in quello dei siti trentini, questo sarebbe testimoniato dall elevata presenza di suini, a scapito dei caprovini. I contatti fra il terzo ed il quarto gruppo, potrebbero essere comprovati anche dalle numerose affinità che si riscontrano tra la fauna dei Pizzini e quella di Barche di Solferino. Molto suggestivo appare il confronto fra le percentuali relative al numero minimo di individui domestici che risultano essere molto simili 12 (fig.13), nonostante ci si trovi in contesti ecologici diversi. Questo dato va però trattato con estrema cautela in quanto il numero di individui è fortemente influenzato dalla quantità e dal livello di conservazione dei resti recuperati. Di solito, infatti, si fa molto più affidamento sul numero di resti, dato sicuramente più oggettivo. Altri fattori che li accomunano, per quanto riguarda la fauna, sono l alta percentuale di resti di cervo, che supera di molto in entrambi i casi lo standard stabilito dagli altri insediamenti della stessa epoca e la buona presenza di resti di cane. 12 Per il N.M.I di Barche di Solferino vedi Riedel, 1976, p. 299.
16 Numero Minimo Individui Perc. (%) Bovini Caprovini Suini 0 Pizzini di Castellano Barche di Solferino Fig.13 (percentuali calcolate sul totale dei domestici) L analisi del tipo di economia pastorale regionale vista precedentemente dà solo alcuni spunti per comprendere eventuali tendenze culturali seguite dalle comunità umane nel tempo. Bisogna però sottolineare che devono aver avuto molta importanza anche le scelte economiche effettuate in base ad altri fattori di natura locale quali: la geomorfologia del territorio, l altitudine, il clima, la copertura vegetazionale e le risorse primarie più accessibili. Tutti questi elementi vanno a modificare in modo rilevante ma forse non così significativo il tipo di economia sviluppato dall insediamento. Le scelte economiche legate all allevamento, come qui ipotizzato, potrebbero essere determinate da fattori culturali propri della comunità insediata che, lontane dall essere arbitrarie, sembrerebbero seguire modelli economici geograficamente o culturalmente vicini. Le faune dell Italia Nord-orientale nell età del bronzo in generale Se si allarga lo sguardo alla composizione faunistica dell intera età del bronzo, sempre con riferimento ai tre principali gruppi di domestici, si può notare come i rapporti quantitativi tra i diversi animali siano sostanzialmente gli stessi che si è potuto rilevare considerando la sola antica età del bronzo. Questo permette di espandere le valutazioni finora prodotte a tutta l età del bronzo, almeno riguardo ai contesti qui presi in esame. I siti riportati nelle ascisse delle figure 14, 15 e 16 sono disposti da sinistra a destra in un ordine che segue, in generale ma non esclusivamente, la diminuzione della latitudine degli stessi e sono stati grossolanamente raggruppati in relazione a valutazioni sulla reciproca contiguità o ad una supposta separazione territoriale basata su caratteristiche geomorfologiche. I bovini evidenziano presenze percentuali che, con l'eccezione di Naturno, toccano le quantità massime nella zona altoatesina e nella pianura padana settentrionale presso il lago di Garda.
17 % N.R. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 56,5 54,4 46,6 45,5 40,4 33,2 28,0 33,8 34,2 25,7 15,0 23,9 30,8 39,0 43,9 37,6 50,9 19,4 Bos 18,6 16,0 0,0 Siti ed età Fig. 14 confronto percentuale tra le quantità relative dei bovini in alcuni siti, dell'italia nord orientale nel corso dell età del bronzo. % N.R. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 66,7 53,1 50,1 43,6 35,3 22,5 65,7 58,4 52,1 50,5 56,3 41,6 35,3 41,8 30,0 36,1 27,1 Capra/Ovis 54,0 48,4 48,0 Siti ed età Fig. 15 confronto percentuale tra le quantità relative dei caprovini in alcuni siti, dell'italia nord orientale nel corso dell età del bronzo. I caprovini invece, al variare della posizione geografica, non sembrano seguire una particolare tendenza riguardo al N.R., anche se è possibile notare delle leggere variazioni al passaggio da una zona all altra. Si può perciò vedere come in Alto Adige si abbia una situazione mista, dove cioè le percentuali aumentano al diminuire della latitudine (con le solite eccezioni di Appiano e Naturno 13 ), mentre dal Trentino meridionale alla pianura padana si abbia una generale diminuzione delle presenze, che tornano poi ad aumentare in vicinanza degli Appennini. 13 Come già sottolineato nel paragrafo precedente la fauna di Naturno è avvicinabile alle faune dell alto Garda.
18 % N.R. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Sus 23,3 14,7 15,3 34,5 33,9 31,0 28,7 20,6 22,0 20,0 26,7 36,0 32,9 10,0 5,0 8,2 9,8 6,5 4,4 5,3 7,6 8,6 0,0 Siti ed età Fig. 16 confronto percentuale tra le quantità relative dei suini in alcuni siti, dell'italia nord orientale nel corso dell età del bronzo. Il fenomeno più appariscente che si può infine desumere dall osservazione della figura 16 è la graduale ascesa della quantità relativa dei suini rispetto agli altri due gruppi di domestici, mano a mano che ci si sposta verso meridione, e nel passaggio dalla zona del bacino gardesano a quella dell asta dell Adige (che potremmo inoltre vedere comprensiva dell insediamento di Appiano che pure giace in prossimità del fiume) e quindi alla pianura padana. A causa della carenza di studi editi per quanto riguarda le faune degli insediamenti dell età del bronzo non è ragionevolmente possibile formulare ipotesi di lavoro più approfondite di quelle accennate. Queste lacune influenzano soprattutto la comprensione del fenomeno in senso diacronico, dal momento che il numero delle faune edite è sproporzionalmente disribuito nell arco cronologico con una netta prevalenza di documentazione che interessa l antica età del bronzo. Il problema lo si affronta anche quando si cerca di definire aree a diversa economia pastorale in senso spaziale per la media e la recente età de bronzo.
19 Fig. 17: Carta geografica con tutti i siti dell'età del bronzo Legenda: 1.Sonnenburg; 2.Nössing; 3.Albanbühel; 4.Sotciastel; 5.Appiano/Eppan; 6.Lasino; 7.Fiavè; 8.Ledro; 9.Colombo di Mori; 10. Pizzini di Castellano; 11.Cisano; 12.Monte Covolo; 13.Barche di Solferino; 14.Nogarole Rocca; 15.Isolone; 16.Poviglio; 17. Monte Leoni; 18.Lagazzi; 19.Tabina di Magreta; 20.Canar; 21.Ostiano; 22.Naturno/Naturns.
20 Misure relative alla fauna dell insediamento dei Pizzini di Castellano Bos taurus 44)=circonferenza basale della cavicchia; 8)=lunghezza della fila dei molari; Processus cornualis Mandibula N. inv. 44 N. inv , ,9 Pelvis Tibia N. inv. LA N. inv. Bd Dd , ,8 36,5 Calcaneus N. inv. GB ,1 Astragalus N. inv. GLl Glm Dl Dm Bd ,8 56,7 34,2 32,0 41, ,6 53,4 33,2 33,0 39,2 Os centrotarsale Metatarsus N. inv. GB N. inv. Bd , ,7 Phalanx I N. inv. GLpe Bp SD Bd ,3 29,3 23,6 25,7 ant ,2 28,1 22,3 25,8 ant ,2 35,2 ant ,3 30,0 22,3 25,3 post ,0 26,4 22,3 25,3 post. Phalanx II N. inv. GLpe Bp SD Bd ,0 31,2 23,9 25,2 ant ,4 30,0 23,6 26,3 ant ,3 30,5 26,1 ant. Phalanx III N. inv. DLS Ld MBS ,6 57,3 26, ,5 52, ,7 53,7
21 Capra/Ovis 9)=lunghezza della fila dei premolari; 10)L=lunghezza dell M3; 10)B=larghezza dell M3; Mandibula N. inv. 9 10L 10B , ,0 7, , ,6 19 7, ,4 9, ,2 8,4 Capra hircus Humerus N. inv. Bd BT ,8 28, ,0 27,8 Phalanx III N. inv. DLS Ld MBS ,3 20,7 5,1 Ovis aries 40)= circonferenza basale della cavicchia; 41)= diametro basale maggiore della cavicchia; 42)= diametro basale minore della cavicchia; Processus cornualis N. inv ,0(-) 23,8 14,8 Humerus N. inv. Bp Bd BT ,6 26, ,1 Astragalus N. inv. GLl Glm Dl Bd ,4 30,9 17,5 20, ,4 28,1 16,4 18,3 Metatarsus N. inv. Bp SD DD Bd , ,8 11,7 9,7
22 Phalanx I N. inv. GLpe Bp SD Bd , ,5 11,8 8,7 10, ,8 Sus domesticus 30)=lunghezza dell M3; 31)=larghezza dell M3; Maxilla N. inv ,2 19, ,9 19,8 7a)=lunghezza della fila P2-M3; 8)=lunghezza della fila dei molari; 9a)= lunghezza della fila P2-P4; 10)L= lunghezza dell M3; 10)B= larghezza dell M3; Mandibula N. inv. 7a 8 9a 10L 10B 26 73, ,2 65,6 35,8 28,6 14,0 Scapula Humerus N. inv. SLC N. inv. Bd , , ,5 Ulna Metacarpus II N. inv. DPA BPC N. inv. GL ,5(-) 22, ,5 Tibia N. inv. Bd Dd ,0 25,7 Astragalus N. inv. GLl Glm 44 37, ,4 38 Canis familiaris 7) = Lunghezza dal bordo aborale dell' alveolo dell' M 3, al bordo aborale dell' alveolo
23 del canino 8) = Lunghezza della fila dei molari e premolari, P 1-M 3, misurata al bordo alveolare 10) = Lunghezza della fila dei molari, misurata al bordo alveolare 11) = Lunghezza della fila dei premolari, P 1-P 4, misurata al bordo alveolare 13L) = Lunghezza del ferino misurata a livello del cingulum 13B) = Larghezza del ferino misurata a livello del cingulum 14) = Lunghezza dell' alveolo del ferino 15L) = Lunghezza dell' M 2 misurata a livello del cingulum 15B) = Larghezza dell' M 2 misurata a livello del cingulum 17) = Spessore massimo del corpo della ganascia (al di sotto del ferino) 19) = Altezza della mandibola dietro al ferino, misurata dal lato linguale e ad angolo retto rispetto al bordo basale 20) = Altezza della mandibola tra P 2 e P 3, misurata dal lato linguale e ad angolo retto rispetto al bordo basale Mandibula N. inv )L 13)B , ,5 20,9 7, ,8 58,2 31,6 28,2 Mandibula N. inv )L 15)B ,5 8,5 6,2 10,4 17, ,2 8,6 6,3 10,3 17, ,1 8,3 6,0 18,6 14,7 Humerus N. inv. Dp 42 31,7 Cervus elaphus Scapula N. inv. LG GLP BG SLC ,4 55,6 40,2 33,3 Ulna N. inv. SDO BPC , ,0 Tibia Calcaneus N. inv. Bd Dd N. inv. GL ,5 38, , ,6 Astragalus N. inv. GLl Glm Dl Bd 10 56,4 53,6 29,8 34, ,8 52,6 30,5 36, ,0 51,0 35,2 28, ,8 51,0 30,1 35, ,9 51,0 29,0 35,3
24 Phalanx I N. inv. GLpe Bp SD Bd ,4 21,2 17,2 19, ,0 Phalanx II N. inv. GLpe Bp SD Bd 43 44,4 22,2 16,3 20, ,3 20,1 14,2 17, , ,4 22,2 16,6 19, ,8 19,6 15,0 16,9 Capreolus capreolus Humerus N. inv. SD Bd BT 23 12,5 27,8 23,6 Rupicapra rupicapra Phalanx I N. inv. GLpe Bp SD Bd 4 51,9 14,8 10,1 14,1
25 Bibliografia. Barker G., 1979, The animal bones, site catchment and discussion of the prehistoric economy, in: Barfield L.H., Barker G.W.W., Chesterman J.T., Pals J.P., Voorrips A., 1979, Excavations at Monte Covolo, Villanuova sul Clisi, Brescia ( ), parte II, Annali del Museo di Gavardo, n.13, pp Battisti M., 1999, Il castelliere dei Pizzini di Castellano, Il Comunale, n.29, anno XV, giugno 1999, pp Battisti M., Tecchiati U., c.d.s., Il sito dei Pizzini di Castellano (Villalagarina TN), in: Atti della XXXV Riunione Scientifica dell Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Lipari, 2-7 giugno Bazzanella, c.d.s., L industria in materia dura animale dell insediamento del Bronzo antico dei Pizzini di Castellano (Villalagarina, Trento): analisi preliminare, in: Atti della XXXV Riunione Scientifica dell Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Lipari, 2-7 giugno Boessneck J., Müller H., Teichert M., 1964, Osteologische Unterscheidungmerkmale zwischen Schaf (Ovis aries L.) und Ziege (Capra hircus L.). Kühn-Archiv, 78(1/2), pp Bonardi S., Marconi S., Riedel A., Tecchiati U., 2000, La fauna del sito dell antica età del bronzo del Colombo di Mori (TN), campagne di scavo 1881 e 1970: aspetti archeozoologici, paleoeconomici e paleoambientali, Annali del Museo Civico di Rovereto, v.16, pp Bonardi S., Scarpa G., 1982, Ricerca paleoecologica a Monte Leoni in Val Parma. Analisi del materiale osteologico. Preistoria Alpina, Museo Tridentino di Scienze Naturali, vol. 18, Trento, pp Cavallo C., 2000, Analisi dei resti faunistici rinvenuti nel villaggio palafitticolo dell antica età del bronzo (cultura di Polada) di Lagazzi di piadina (CR), in: Atti del 2 Convegno Nazionale di Archeozoologia, Asti, novembre 1997, Abaco Edizioni, Forlì, pp Clark G., 1980, A note on the animal bones from a group of pits at S.Salvatore, Ostiano (Cremona), Natura Bresciana. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Brescia, Vol.17, pp Clark R., Gamble C., 1984, The faunal remains from Fiavè: pastoralism, nutrition and butchery, in: Perini R. (cur.), 1984, Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiavè Carera, parte II, Campagne , Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, pp De Grossi Mazzorin J., 1988, La Terramara e i resti di età etrusca (campagna di scavo ). Nota preliminare sulla fauna dell insediamento della media età del bronzo, in Modena dalle origini all anno mille. Studi di archeologia e storia, I, Modena, pp De Marinis R., 2000, Il Museo Archeologico Giovanni Rambotti. Una introduzione alla preistoria del lago di Garda, Comune di Desenzano del Garda (TN). Driesch v. d. A., 1976, A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites,peabody Museum Bulletin, 1, pp Habermehl K. H,. 1975, Die Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren, Parey ed., pp Jarman, 1975,The fauna and Economy of Fiavè. Preistoria Alpina 11, pp Marconi S., 1999/00, I resti faunistici del sito del Colombo di Mori (TN) dell età del bronzo antico, tesi di laurea in Scienze Naturali, Università degli studi di Parma, Facoltà di Scienze MM.FF.NN, a.a. 1999/00.
26 Perini R., 1992, Profilo cronologico dell Età del Bronzo nel Trentino, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Band 8, 1992, Innsbruck, pp Perini R., 1994, Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiavè-Carera, a cura del Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Perini R., 2001, L età del Bronzo Antico e Medio, in: Lanzingher M., Marzatico F., Pedrotti A. (cur.), Storia del Trentino. Volume I. La preistoria e la protostoria, Il Mulino, Bologna, pp Riedel A., 1975, La fauna del villaggio preistorico di Isolone della Prevaldesca; 1975, Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale-Verona, vol. II, pp Riedel A., 1976a, La fauna del villaggio preistorico di Barche di Solferino, Atti del Museo civico di Storia naturale di Trieste, vol XXIX, fasc. 4, n.12, pp Riedel A., 1976b, La fauna del villaggio preistorico di Ledro. Archeo-zoologia e paleoeconomia, Studi Trentini di Scienze Naturali, vol.53, n.5b, 1976, Trento, pp Riedel A., 1984, Die Fauna der Sonnenburger Ausgrabungen, Preistoria Alpina, n.20, 1984, Trento, pp Riedel A., 1985, Die Fauna einer bronzezeitlichen Siedlung bei Eppan (Südtirol); Rivista di Archeologia IX; Venezia 1985; pp Riedel A., 1989, L economia animale (della terramara di Poviglio). In: Bernabò Brea M., Cremaschi M., La Terramara di Poviglio. Le campagne di Scavo (ed. prelim. fuori commercio); Reggio Emilia 1989; pp Riedel A., 1990, La fauna dell età del bronzo di Cisano (Verona), in: Salzani L. (cur.), 1990, Nuovi scavi nella palafitta di Cisano, Comune di Bardolino, pp Riedel A., 1994, Archaeozoological investigations in North-eastern Italy: the exploitation of animals since the Neolithic, Preistoria Alpina, n.30, 1994, Trento, pp Riedel A., 1994, The Bronze Age animal bone deposit of Nogarole - Rocca I Camponi (Verona); Padusa; vol. 28 (1992); pp , Rovigo. Riedel A., 1998, The Bronze Age deposit of Canar (Rovigo), In: Quaderni di Padusa, n.2, 1998, Rovigo, pp , Riedel A., Rizzi J., 1995, The Middle Bronze Age fauna of Albanbühel, Padusa Quaderni N 1; 1995; pp Riedel A., Tecchiati U., 1993, I resti faunistici dell Eneolitico e dell antica età del bronzo provenienti dal riparo del santuario (TN), in: Atti del 1 Convegno Nazionale di Archeozoologia, Quaderni di Padusa, n.1, pp Riedel A., Tecchiati U., 1993, La fauna del Riparo del Santuario (Comune di Lasino- Trentino): aspetti archeozoologici, paleoeconomici e rituali, Annali del Museo Civico di Rovereto, n.8, 1992, pp Riedel A., Tecchiati U., 1998, Die Tierknochenfunde der Mittel-Spätbronzezeitlichen Siedlung von Sotćiastel im Gadertal. In (a cura di Tecchiati U.) "Sotćiastel", Landesdenkmalamt Südtirol und Istitut Cultural Ladin M. de Rü, pp , Bozen, Riedel A., Tecchiati U., 1998, Insediamenti ed economia nell età del bronzo e del ferro in Trentino Alto Adige. Appunti per un modello archeozoologico, Preistoria Alpina, n.34, Riedel A., Tecchiati U., 1999, I resti faunistici dell abitato d altura dell antica e media età del bronzo di Nössing in Val d Isarco (com. di Varna, Bolzano). Atti Acc. Rov. Agiati, ser. VII, vol IX, pp Riedel A., Tecchiati U., 2000, La fauna dell antica età del bronzo di Naturno-Naturns, Loc. Schnalserhof (Bolzano), in: Atti del 2 Convegno Nazionale di Archeozoologia, Asti, novembre 1997, Abaco Edizioni, Forlì, pp
27 Schmid E., 1972, Atlas of Animal Bones. Elsvier Publishing Company, Amsterdam, London & New York. Sebesta G., 1996, Il lavoro dell uomo nel ciclo dei Mesi di Torre Aquila, Provincia Autonoma di Trento, Trento. Tecchiati U., 1990/1991, Il riparo del santuario in Val Cornelio (Comune di Lasino- Trentino): una successione stratigrafica dall Eneolitico recente al Bronzo finale, tesi di laurea inedita, Università degli studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1990/91. Tecchiati U., 1998, Il castelliere Nössing: un insediamento d altura dell antica e media età del bronzo in Val d Isarco (Bolzano), tesi di dottorato di ricerca in Archeologia, Università degli Studi di Pisa, Teichert M., 1969, Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen. Kühn-Archiv, 83, pp Teichert M., 1975, Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei Schafen. In Clason A.T. (Ed.), Archaeozoological Studies, Amsterdam & New York, pp
ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO. Sezione: Archeologia Storia Scienze Naturali
 ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO 33 2017 Sezione: Archeologia Storia Scienze Naturali Sezione: Archeologia 33 2017 Storia Scienze Naturali DIRETTORE RESPONSABILE Alessandra Cattoi Comitato di Redazione
ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO 33 2017 Sezione: Archeologia Storia Scienze Naturali Sezione: Archeologia 33 2017 Storia Scienze Naturali DIRETTORE RESPONSABILE Alessandra Cattoi Comitato di Redazione
PREMESSA Il sito Il sito oggetto di questo studio è posto ai piedi dell altura nota localmente come Doss Castion, una piccola appendice terminale del
 Ann Mus civ Rovereto Sez : Arch, St, Sc nat Vol 16 (2000) 63-102 2002 SANDRO BONARDI, STEFANO MARCONI, ALFREDO RIEDEL & UMBERTO TECCHIATI (*) LA FAUNA DEL SITO DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DEL COLOMBO DI
Ann Mus civ Rovereto Sez : Arch, St, Sc nat Vol 16 (2000) 63-102 2002 SANDRO BONARDI, STEFANO MARCONI, ALFREDO RIEDEL & UMBERTO TECCHIATI (*) LA FAUNA DEL SITO DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DEL COLOMBO DI
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
2 LA FAUNA DELLA VILLA DI ISERA. ALLEVAMENTO E RISORSE AMBIENTALI IN UN CONTESTO RUSTICO DI I SECOLO
 2 LA FAUNA DELLA VILLA DI ISERA. ALLEVAMENTO E RISORSE AMBIENTALI IN UN CONTESTO RUSTICO DI I SECOLO Alfredo Riedel, Umberto Tecchiati Il presente contributo analizza i resti faunistici provenienti dalle
2 LA FAUNA DELLA VILLA DI ISERA. ALLEVAMENTO E RISORSE AMBIENTALI IN UN CONTESTO RUSTICO DI I SECOLO Alfredo Riedel, Umberto Tecchiati Il presente contributo analizza i resti faunistici provenienti dalle
B. WILKENS BERBENTINA DI SASSOFERRATO: I RESTI FAUNISTICI
 Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 96 (1989) pagg. 257 267 B. WILKENS BERBENTINA DI SASSOFERRATO: I RESTI FAUNISTICI Riassunto - Sulla base del numero di frammenti, gli animali più abbondanti risultano
Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 96 (1989) pagg. 257 267 B. WILKENS BERBENTINA DI SASSOFERRATO: I RESTI FAUNISTICI Riassunto - Sulla base del numero di frammenti, gli animali più abbondanti risultano
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
I resti faunistici dell età del Rame del Col del Buson, Valle dell Ardo (Belluno). Aspetti archeozoologici e paleoeconomici
 Annali dell'università degli Studi di Ferrara ISSN1824-2707 Museologia Scientifica e Naturalistica volume 11 n. 2 (2015) Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia DOI: http://dx.doi.org/10.15160/1824-2707/1044
Annali dell'università degli Studi di Ferrara ISSN1824-2707 Museologia Scientifica e Naturalistica volume 11 n. 2 (2015) Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia DOI: http://dx.doi.org/10.15160/1824-2707/1044
B. WILKENS S: PAOLINA DI FILOTTRANO (MARCHE): I RESTI FAUNISTICI
 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 95 (1988) pagg. 345-361 B. WILKENS S: PAOLINA DI FILOTTRANO (MARCHE): I RESTI FAUNISTICI Riàssunto - i:animaleo' più importante nell'economia di S. Paolina era
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 95 (1988) pagg. 345-361 B. WILKENS S: PAOLINA DI FILOTTRANO (MARCHE): I RESTI FAUNISTICI Riàssunto - i:animaleo' più importante nell'economia di S. Paolina era
I resti faunistici di epoca romana rinvenuti nel corso delle campagne di scavo a San Candido Cantiere Böden (BZ)
 Archaeozoological studies in honour of Alfredo Riedel Bolzano 2006 pp. 217-230 I resti faunistici di epoca romana rinvenuti nel corso delle campagne di scavo a San Candido Cantiere Böden (BZ) Stefano Marconi
Archaeozoological studies in honour of Alfredo Riedel Bolzano 2006 pp. 217-230 I resti faunistici di epoca romana rinvenuti nel corso delle campagne di scavo a San Candido Cantiere Böden (BZ) Stefano Marconi
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
LA FAUNA DEL SITO DI SOLAROLO VIA ORDIERE ANALISI PRELIMINARE DEL SETTORE 1
 VOL. 2 2009,1 PP. 292-303 ISSN 1974-7985 LA FAUNA DEL SITO DI SOLAROLO VIA ORDIERE ANALISI PRELIMINARE DEL SETTORE 1 ELENA MAINI, ANTONIO CURCI 1 PAROLE CHIAVE Archeozoologia, Età del Bronzo, fauna domestica,
VOL. 2 2009,1 PP. 292-303 ISSN 1974-7985 LA FAUNA DEL SITO DI SOLAROLO VIA ORDIERE ANALISI PRELIMINARE DEL SETTORE 1 ELENA MAINI, ANTONIO CURCI 1 PAROLE CHIAVE Archeozoologia, Età del Bronzo, fauna domestica,
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO. Sezione: Archeologia Storia Scienze Naturali. In ricordo di Riccarda Stedile Rauss
 ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO In ricordo di Riccarda Stedile Rauss 32 2016 Sezione: Archeologia Storia Scienze Naturali Sezione: Archeologia 32 2016 Storia Scienze Naturali DIRETTORE RESPONSABILE
ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO In ricordo di Riccarda Stedile Rauss 32 2016 Sezione: Archeologia Storia Scienze Naturali Sezione: Archeologia 32 2016 Storia Scienze Naturali DIRETTORE RESPONSABILE
Generalità sugli Ungulati
 CORSO PER CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI URCA Cremona 2016 Generalità sugli Ungulati A cura di Elisa Armaroli Alcuni concetti Nella nomenclatura binomiale ogni specie animale o vegetale viene
CORSO PER CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI URCA Cremona 2016 Generalità sugli Ungulati A cura di Elisa Armaroli Alcuni concetti Nella nomenclatura binomiale ogni specie animale o vegetale viene
LA FAUNA DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DELLE GROTTE DI CASTEL CORNO (ISERA - TN)
 Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 25 (2009) 27-66 2010 ALEX FONTANA, STEFANO MARCONI & UMBERTO TECCHIATI LA FAUNA DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DELLE GROTTE DI CASTEL CORNO (ISERA -
Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 25 (2009) 27-66 2010 ALEX FONTANA, STEFANO MARCONI & UMBERTO TECCHIATI LA FAUNA DELL ANTICA ETÀ DEL BRONZO DELLE GROTTE DI CASTEL CORNO (ISERA -
Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali di Bolzano, Ufficio Beni archeologici, Laboratorio di Archeozoologia 2
 Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali di Bolzano, Ufficio Beni archeologici, Laboratorio di Archeozoologia 2
 Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
I resti faunistici dell abitato del Neolitico Tardo, dell Età del Bronzo e di Età medievale, moderna e contemporanea di Castelrotto-Grondlboden (BZ)
 Preistoria Alpina vol. 49 2017 Preistoria Alpina ISSN 2532-5957 Preistoria Alpina, 49 (2017): 37-50 homepage: http://www.muse.it/it/editoria-muse/preistoria-alpina 2017 MUSE - Museo delle Scienze, Trento,
Preistoria Alpina vol. 49 2017 Preistoria Alpina ISSN 2532-5957 Preistoria Alpina, 49 (2017): 37-50 homepage: http://www.muse.it/it/editoria-muse/preistoria-alpina 2017 MUSE - Museo delle Scienze, Trento,
Inquadramento sistematico
 CAPRIOLO Inquadramento sistematico Superordine: Ungulati (Ungulata) Ordine: Artiodattili (Artiodactyla) Sottordine: Ruminanti (Ruminantia) Famiglia: Cervidi (Cervidae) Sottofamiglia: Odocoileini (Odocoileinae)
CAPRIOLO Inquadramento sistematico Superordine: Ungulati (Ungulata) Ordine: Artiodattili (Artiodactyla) Sottordine: Ruminanti (Ruminantia) Famiglia: Cervidi (Cervidae) Sottofamiglia: Odocoileini (Odocoileinae)
OSSERVAZIONI SUI RESTI FAUNISTICI TARDOANTICHI E PRIMO-MEDIOEVALI PROVENIENTI DAL CASTRUM DI LAMPRECHT
 UMBERTO TECCHIATI OSSERVAZIONI SUI RESTI FAUNISTICI TARDOANTICHI E PRIMO-MEDIOEVALI PROVENIENTI DAL CASTRUM DI LAMPRECHT 1. INTRODUZIONE. CARATTERI GENERALI DEL LOTTO FAUNISTICO STUDIATO Dell importante
UMBERTO TECCHIATI OSSERVAZIONI SUI RESTI FAUNISTICI TARDOANTICHI E PRIMO-MEDIOEVALI PROVENIENTI DAL CASTRUM DI LAMPRECHT 1. INTRODUZIONE. CARATTERI GENERALI DEL LOTTO FAUNISTICO STUDIATO Dell importante
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici, Laboratorio di Archeozoologia e Tafonomia
 Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
NOTA Le assunzioni a tempo indeterminato. Le tendenze nazionali 2014-2015
 Fvg prima regione per crescita di assunzioni a (+110%). Voucher boom: ne sono stati venduti 5 milioni nel 2015 Elaborazione Ires Fvg Nel 2015 il Friuli Venezia Giulia è la regione in cui si è registrata
Fvg prima regione per crescita di assunzioni a (+110%). Voucher boom: ne sono stati venduti 5 milioni nel 2015 Elaborazione Ires Fvg Nel 2015 il Friuli Venezia Giulia è la regione in cui si è registrata
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972)
 Luciano Salzani 111 SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972) Luciano Salzani Nell autunno del 1971 i lavori di una cava di sabbia intaccavano l ultimo sperone di una collina
Luciano Salzani 111 SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972) Luciano Salzani Nell autunno del 1971 i lavori di una cava di sabbia intaccavano l ultimo sperone di una collina
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2011 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ANNA PIZZARELLI* L analisi
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ANNA PIZZARELLI* L analisi
Resti faunistici del iv ii sec. a.c. provenienti dal sito di Urtijëi/St. Ulrich/ Ortisei, Ciamp da Mauriz
 Resti faunistici del iv ii sec. a.c. provenienti dal sito di Urtijëi/St. Ulrich/ Ortisei, Ciamp da Mauriz Umberto Tecchiati, Lenny Salvagno 1. Introduzione. Ubicazione, caratteristiche del sito e cronologia
Resti faunistici del iv ii sec. a.c. provenienti dal sito di Urtijëi/St. Ulrich/ Ortisei, Ciamp da Mauriz Umberto Tecchiati, Lenny Salvagno 1. Introduzione. Ubicazione, caratteristiche del sito e cronologia
Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1
 ARIMNESTOS Ricerche di Protostoria Mediterranea 1/2018, pp. 147-155 Patrizia von Eles* Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1 Gli anelli in osso sono relativamente numerosi a Verucchio
ARIMNESTOS Ricerche di Protostoria Mediterranea 1/2018, pp. 147-155 Patrizia von Eles* Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1 Gli anelli in osso sono relativamente numerosi a Verucchio
La consistenza degli allevamenti bovini e suini al 1 giugno 2005
 25 Novembre 2005 La consistenza degli allevamenti bovini e suini al 1 giugno 2005 Allevamenti bovini e bufalini Ufficio della comunicazione Tel. + 39 06 4673.2243-2244 Centro di informazione statistica
25 Novembre 2005 La consistenza degli allevamenti bovini e suini al 1 giugno 2005 Allevamenti bovini e bufalini Ufficio della comunicazione Tel. + 39 06 4673.2243-2244 Centro di informazione statistica
Associazione di Volontariato del CANE LUPINO DEL GIGANTE ANALISI DEI DATI BIOMETRICI RILEVATI. Introduzione
 Introduzione La presente analisi biometrica illustra una prima approssimazione etnologica del Cane Lupino del Gigante ed è stata effettuata su un primo quantitativo di 155 esemplari (75 maschi e 80 femmine)
Introduzione La presente analisi biometrica illustra una prima approssimazione etnologica del Cane Lupino del Gigante ed è stata effettuata su un primo quantitativo di 155 esemplari (75 maschi e 80 femmine)
I resti faunistici del sito di Wallneregg (Renon, Bolzano). Dati preliminari
 Annali dell'università degli Studi di Ferrara ISSN1824-2707 Museologia Scientifica e Naturalistica volume 11 n. 2 (2015) Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia DOI: http://dx.doi.org/10.15160/1824-2707/1039
Annali dell'università degli Studi di Ferrara ISSN1824-2707 Museologia Scientifica e Naturalistica volume 11 n. 2 (2015) Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia DOI: http://dx.doi.org/10.15160/1824-2707/1039
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
Aratro. cultura di Polada.
 Aratro cultura di Polada Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/2k050-00020/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede-complete/2k050-00020/ CODICI
Aratro cultura di Polada Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/2k050-00020/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede-complete/2k050-00020/ CODICI
I RESTI FAUNISTICI COME INDICATORI CLIMATICI ALLA LUCE DI UNO STUDIO RECENTE
 Quaderni Friulani di Archeologia I/1991 I RESTI FAUNISTICI COME INDICATORI CLIMATICI ALLA LUCE DI UNO STUDIO RECENTE Donatella D ANGELA - Università degli Studi di Trieste Introduzione L archeologia moderna
Quaderni Friulani di Archeologia I/1991 I RESTI FAUNISTICI COME INDICATORI CLIMATICI ALLA LUCE DI UNO STUDIO RECENTE Donatella D ANGELA - Università degli Studi di Trieste Introduzione L archeologia moderna
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
Università degli Studi di Firenze
 La storia delle RGA è cominciata 12 000-14 000 anni fa, durante la rivoluzione agricola del primo Neolitico con la domesticazione delle principali colture e animali. Dopo gli eventi di domesticazione iniziale,
La storia delle RGA è cominciata 12 000-14 000 anni fa, durante la rivoluzione agricola del primo Neolitico con la domesticazione delle principali colture e animali. Dopo gli eventi di domesticazione iniziale,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Dipartimento di Scienze della terra e dell ambiente Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura Uso delle aree aperte da parte di medio mammiferi nel
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Dipartimento di Scienze della terra e dell ambiente Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura Uso delle aree aperte da parte di medio mammiferi nel
Analisi statistica dati rilevati razze Registro Anagrafico Equidi
 A.N.A.C.R.HA.I Ufficio Centrale del Libro Genealogico del Cavallo Haflinger in Italia Analisi statistica dati rilevati razze Registro Anagrafico Equidi PSRN 2014-2020 Sottomisura 10.2 (step progettuale
A.N.A.C.R.HA.I Ufficio Centrale del Libro Genealogico del Cavallo Haflinger in Italia Analisi statistica dati rilevati razze Registro Anagrafico Equidi PSRN 2014-2020 Sottomisura 10.2 (step progettuale
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
INDAGINE SULLE CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO SUINO IN EMILIA ROMAGNA. Anno 1999
 INDAGINE SULLE CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO SUINO IN EMILIA ROMAGNA. Anno 1999 Con lo scopo di individuare i principali fattori di rischio per la presenza dell'infezione, il piano nazionale di controllo
INDAGINE SULLE CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO SUINO IN EMILIA ROMAGNA. Anno 1999 Con lo scopo di individuare i principali fattori di rischio per la presenza dell'infezione, il piano nazionale di controllo
10. Lo studio palinostratigrafico e archeobotanico dei depositi archeologici e delle attività dell uomo
 Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
Utenti di veicoli a 2Ruote coinvolti in incidente stradale per localizzazione e conseguenza dell incidente Anno 2012
 Utenti di veicoli a 2Ruote coinvolti in incidente stradale per localizzazione e conseguenza dell incidente Anno 2012 Motociclisti Ciclisti Conducenti e passeggeri di Ciclomotori Localizzazione 2012 2012
Utenti di veicoli a 2Ruote coinvolti in incidente stradale per localizzazione e conseguenza dell incidente Anno 2012 Motociclisti Ciclisti Conducenti e passeggeri di Ciclomotori Localizzazione 2012 2012
Iscritto presso l Ordine degli Architetti della Provincia di Udine n posizione Regione Friuli - Venezia Giulia. Comune di Pradamano
 Pagina1 Regione Friuli - Venezia Giulia Comune di Pradamano INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PRADAMANO CUP B78J18000000005 - CIG Z8622BD840 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Pagina1 Regione Friuli - Venezia Giulia Comune di Pradamano INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PRADAMANO CUP B78J18000000005 - CIG Z8622BD840 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
situazione a livello nazionale
 LA RISORSA SELVAGGINA TRA ECOPATOLOGIA, BIORISCHI E SICUREZZA ALIMENTARE Bologna 30 settembre 2016 Trend delle popolazioni di ungulati: la situazione a livello nazionale Merli E., Grignolio S., Braghiroli
LA RISORSA SELVAGGINA TRA ECOPATOLOGIA, BIORISCHI E SICUREZZA ALIMENTARE Bologna 30 settembre 2016 Trend delle popolazioni di ungulati: la situazione a livello nazionale Merli E., Grignolio S., Braghiroli
Agriturismo e turismo rurale
 Agriturismo e turismo rurale Negli ultimi anni attenzione è stata dedicata al ruolo che l agriturismo può avere per stimolare lo sviluppo nelle aree rurali e diversificare l attività dell azienda agricola.
Agriturismo e turismo rurale Negli ultimi anni attenzione è stata dedicata al ruolo che l agriturismo può avere per stimolare lo sviluppo nelle aree rurali e diversificare l attività dell azienda agricola.
Monitoraggio Ungulati selvatici Anno 2012
 Monitoraggio Ungulati selvatici Anno 2012 1. Materiali e metodi Per la primavera 2012, è stato applicata la tecnica del pellet group count con le stesse modalità individuate negli scorsi anni, vale a dire
Monitoraggio Ungulati selvatici Anno 2012 1. Materiali e metodi Per la primavera 2012, è stato applicata la tecnica del pellet group count con le stesse modalità individuate negli scorsi anni, vale a dire
ANIMALE DOMESTICO: riproduzione in condizioni di isolamento dalla specie selvatica all interno di un sistema sociale umano
 ANIMALE DOMESTICO: riproduzione in condizioni di isolamento dalla specie selvatica all interno di un sistema sociale umano Domesticazione (degli animali) 1.1. Definizioni Che cosa significa animali domestici?
ANIMALE DOMESTICO: riproduzione in condizioni di isolamento dalla specie selvatica all interno di un sistema sociale umano Domesticazione (degli animali) 1.1. Definizioni Che cosa significa animali domestici?
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
COMPRENSORIO ALPINO CN2 Valle Varaita
 COMPRENSORIO ALPINO CN2 Valle Varaita CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RUMINANTI - 2013 - A cura di: Giordano Omar Tecnico faunistico C.A. CN2 DETERMINAZIONE DELL ETÀ DEI SOGGETTI
COMPRENSORIO ALPINO CN2 Valle Varaita CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RUMINANTI - 2013 - A cura di: Giordano Omar Tecnico faunistico C.A. CN2 DETERMINAZIONE DELL ETÀ DEI SOGGETTI
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi umanistici, Laboratorio di Archeozoologia e Tafonomia
 Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
Rilevazione sugli Scrutini ed Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo
 Rilevazione sugli Scrutini ed Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo (Luglio 2007) Il Ministero diffonde i dati sugli esiti degli scrutini e degli esami di Stato delle scuole secondarie di primo e
Rilevazione sugli Scrutini ed Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo (Luglio 2007) Il Ministero diffonde i dati sugli esiti degli scrutini e degli esami di Stato delle scuole secondarie di primo e
INDAGINI ARCHEOZOOLOGICHE SUI RESTI FAUNISTICI DELLA MEDIA-RECENTE ETÀ DEL BRONZO DI LAION-WASSERBÜHEL (BZ) ( 1 )
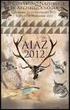 Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 26 (2010) 105-131 2011 UMBERTO TECCHIATI, ALEX FONTANA & STEFANO MARCONI INDAGINI ARCHEOZOOLOGICHE SUI RESTI FAUNISTICI DELLA MEDIA-RECENTE ETÀ DEL
Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 26 (2010) 105-131 2011 UMBERTO TECCHIATI, ALEX FONTANA & STEFANO MARCONI INDAGINI ARCHEOZOOLOGICHE SUI RESTI FAUNISTICI DELLA MEDIA-RECENTE ETÀ DEL
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
 Disciplinare per l indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga. ART. 1 FINALITÀ 1. Il presente Disciplinare,
Disciplinare per l indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga. ART. 1 FINALITÀ 1. Il presente Disciplinare,
Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia
 Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
Associazione Italiana di ArcheoZoologia Dipartimento di Scienze Archeologiche Atti del 6 Convegno Nazionale di Archeozoologia Centro visitatori del Parco dell Orecchiella 21-24 maggio 2009 San Romano in
SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
 Dicembre 2017 - n 23 Direzione Generale dei Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica, Monitoraggio dati e Comunicazione SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ATTIVAZIONI Nel terzo trimestre 2017
Dicembre 2017 - n 23 Direzione Generale dei Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica, Monitoraggio dati e Comunicazione SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ATTIVAZIONI Nel terzo trimestre 2017
INDAGINE DI OPINIONE SULLA PERCEZIONE DELLA POLITICA IN TRENTINO E CONOSCENZA DEL PARTITO. Analisi dei dati
 INDAGINE DI OPINIONE SULLA PERCEZIONE DELLA POLITICA IN TRENTINO E CONOSCENZA DEL PARTITO Analisi dei dati Di seguito riportremo in maniera grafica e tabellare i risultati ottenuti dalle risposte Domanda
INDAGINE DI OPINIONE SULLA PERCEZIONE DELLA POLITICA IN TRENTINO E CONOSCENZA DEL PARTITO Analisi dei dati Di seguito riportremo in maniera grafica e tabellare i risultati ottenuti dalle risposte Domanda
LA FAUNA. Riccardo Fontana
 LA FAUNA Riccardo Fontana riccardo.fontana@studio-geco.it Specie trattate: Uccelli Alectoris rufa - Pernice rossa Phasianus colchicus- Fagiano Perdix perdix - Starna Specie trattate: Mammiferi Lepus europaeus
LA FAUNA Riccardo Fontana riccardo.fontana@studio-geco.it Specie trattate: Uccelli Alectoris rufa - Pernice rossa Phasianus colchicus- Fagiano Perdix perdix - Starna Specie trattate: Mammiferi Lepus europaeus
Carmelo Petronio & Luca Pandolfi
 VIII Edizione Giornate di Paleontologia SIMPOSIO DELLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA Siena 9-12 settembre 2008 RESTI DI STEPHANORHINUS HEMITOECHUS (FALCONER, 1868) PRESENTI NELLA COLLEZIONE MIRIGLIANO
VIII Edizione Giornate di Paleontologia SIMPOSIO DELLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA Siena 9-12 settembre 2008 RESTI DI STEPHANORHINUS HEMITOECHUS (FALCONER, 1868) PRESENTI NELLA COLLEZIONE MIRIGLIANO
LE DINAMICHE STRUTTURALI DELL AGRICOLTURA PUGLIESE: i primi risultati del 6 Censimento generale dell agricoltura.
 LE DINAMICHE STRUTTURALI DELL AGRICOLTURA PUGLIESE: i primi risultati del 6 Censimento generale dell agricoltura. 1. Premessa I primi risultati provvisori del 6 Censimento generale dell agricoltura, riferiti
LE DINAMICHE STRUTTURALI DELL AGRICOLTURA PUGLIESE: i primi risultati del 6 Censimento generale dell agricoltura. 1. Premessa I primi risultati provvisori del 6 Censimento generale dell agricoltura, riferiti
Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche
 Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA
 DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
Accumuli di ossa animali Cause della formazione
 Accumuli di ossa animali Cause della formazione Trappole naturali pozzi carsici sabbie mobili... Eventi catastrofici siccità alluvioni Tane abitazione, ibernazione Predatori carnivori uomo (iena, leone,
Accumuli di ossa animali Cause della formazione Trappole naturali pozzi carsici sabbie mobili... Eventi catastrofici siccità alluvioni Tane abitazione, ibernazione Predatori carnivori uomo (iena, leone,
Premio Bandiera 2012 Gubbio
 Premio Bandiera 2012 Gubbio Comunicato stampa scavi a Col di Marzo (PG) campagna 2013 L alimentazione degli Etruschi La valle dominata dall abbazia di Montelabate si arricchisce di nuova storia, anzi
Premio Bandiera 2012 Gubbio Comunicato stampa scavi a Col di Marzo (PG) campagna 2013 L alimentazione degli Etruschi La valle dominata dall abbazia di Montelabate si arricchisce di nuova storia, anzi
RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE
 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE Foto: Alfred Hinteregger Luglio 2014 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE 2014 1. Gruppi montuosi Unità gestionali Pagina
RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE Foto: Alfred Hinteregger Luglio 2014 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL FAGIANO DI MONTE IN ALTO ADIGE 2014 1. Gruppi montuosi Unità gestionali Pagina
MODIFICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA CON LA PRATICA DEL GYROTONIC. Massimo De Ritis
 MODIFICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA CON LA PRATICA DEL GYROTONIC Massimo De Ritis OBIETTIVI E SCOPI DELLA RICERCA L importanza del ruolo dell esercizio fisico nel controllo del peso corporeo è nota
MODIFICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA CON LA PRATICA DEL GYROTONIC Massimo De Ritis OBIETTIVI E SCOPI DELLA RICERCA L importanza del ruolo dell esercizio fisico nel controllo del peso corporeo è nota
Acquarossa: tramonto.
 La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
L ATTIVITA EDILIZIA PROGETTATA ANNO 2016
 L ATTIVITA EDILIZIA PROGETTATA ANNO 2016 La rilevazione ISTAT Attività edilizia residenziale progettata Le serie statistiche sull attività edilizia rese disponibili a scala territoriale dall ISTAT sono
L ATTIVITA EDILIZIA PROGETTATA ANNO 2016 La rilevazione ISTAT Attività edilizia residenziale progettata Le serie statistiche sull attività edilizia rese disponibili a scala territoriale dall ISTAT sono
A.T.C. AN1 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI STAGIONE VENATORIA 2014/2015 RELAZIONE CONSUNTIVA
 A.T.C. AN1 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI STAGIONE VENATORIA 2014/2015 RELAZIONE CONSUNTIVA La presente relazione è stata redatta dal Dott. Filippo Savelli in veste di tecnico faunistico incaricato
A.T.C. AN1 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI STAGIONE VENATORIA 2014/2015 RELAZIONE CONSUNTIVA La presente relazione è stata redatta dal Dott. Filippo Savelli in veste di tecnico faunistico incaricato
Figura 10.1: Produzione dei rifiuti urbani 1
 CAPITOLO 10 La produzione totale dei rifiuti urbani ha fatto rilevare, tra il 2006 e il 2007, una sostanziale stabilità, con una crescita dello 0,1% circa. Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti
CAPITOLO 10 La produzione totale dei rifiuti urbani ha fatto rilevare, tra il 2006 e il 2007, una sostanziale stabilità, con una crescita dello 0,1% circa. Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti
Il censimento della popolazione straniera
 19 dicembre 2012 Il censimento della popolazione straniera Nel corso dell ultimo decennio la popolazione straniera residente in Italia è triplicata: da poco più di 1 milione e 300 mila persone nel 2001
19 dicembre 2012 Il censimento della popolazione straniera Nel corso dell ultimo decennio la popolazione straniera residente in Italia è triplicata: da poco più di 1 milione e 300 mila persone nel 2001
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO
 CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Per l anno scolastico 2016-2017 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Lenny Salvagno ¹, Umberto Tecchiati ², Elodia Bianchin Citton ³, Antonio Persichetti 4
 Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
Annali dell'università degli Studi di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica Atti del 7 Convegno Nazionale di Archeozoologia a cura di U. Thun Hohenstein, M. Cangemi, I. Fiore, J. De Grossi Mazzorin
L'occupazione in agricoltura,
 20 dicembre #lavoro L'occupazione in agricoltura, 2008-2017 Aumenta l occupazione dipendente, ma solo quella a tempo determinato Tra il 2008 e il 2017 il numero di operai agricoli occupati in Friuli Venezia
20 dicembre #lavoro L'occupazione in agricoltura, 2008-2017 Aumenta l occupazione dipendente, ma solo quella a tempo determinato Tra il 2008 e il 2017 il numero di operai agricoli occupati in Friuli Venezia
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
Povertà assoluta in Lombardia e nelle regioni del nord Italia - Anno 2014
 Lombardia Statistiche Report N 4 / 10 maggio 2016 Povertà assoluta in Lombardia e nelle regioni del nord Italia - Anno 2014 Sintesi A Milano una famiglia composta da una coppia e un bambino di 4-10 è considerata
Lombardia Statistiche Report N 4 / 10 maggio 2016 Povertà assoluta in Lombardia e nelle regioni del nord Italia - Anno 2014 Sintesi A Milano una famiglia composta da una coppia e un bambino di 4-10 è considerata
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica. Relazione sul rischio archeologico Lavori eseguiti dalla
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica. Relazione sul rischio archeologico Lavori eseguiti dalla
Censimento della popolazione
 Censimento della popolazione Pagine tratte dal sito http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/ aggiornato al 24 marzo 2014 Censimento della popolazione Il 9 Ottobre 2011 si è svolto in Italia
Censimento della popolazione Pagine tratte dal sito http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/ aggiornato al 24 marzo 2014 Censimento della popolazione Il 9 Ottobre 2011 si è svolto in Italia
ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA
 1 / 20 ST-001 ALLEGATO I ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA 2 / 20 ST-001 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE Gli impianti di trattamento e di compressione gas della Concessione Stoccaggio
1 / 20 ST-001 ALLEGATO I ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA 2 / 20 ST-001 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE Gli impianti di trattamento e di compressione gas della Concessione Stoccaggio
CONFRONTI DELLA DISTRIBUZIONE GROCERY IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON ALTRE REGIONI E ALTRE NAZIONI EUROPEE
 Osservatorio regionale del commercio CONFRONTI DELLA DISTRIBUZIONE GROCERY IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON ALTRE REGIONI E ALTRE NAZIONI EUROPEE Aprile 2015 Andamento della rete al dettaglio alimentare e
Osservatorio regionale del commercio CONFRONTI DELLA DISTRIBUZIONE GROCERY IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON ALTRE REGIONI E ALTRE NAZIONI EUROPEE Aprile 2015 Andamento della rete al dettaglio alimentare e
Capitolo 3 La mortalità per malattie del sistema circolatorio
 Capitolo 3 La mortalità per malattie del sistema circolatorio Introduzione Le malattie del sistema circolatorio sono le principali cause di morte nei paesi occidentali come l Italia: quasi il 4% dei decessi
Capitolo 3 La mortalità per malattie del sistema circolatorio Introduzione Le malattie del sistema circolatorio sono le principali cause di morte nei paesi occidentali come l Italia: quasi il 4% dei decessi
TELL MOZAN / URKESH: ARCHEOZOOLOGIA DELLA STRUTTURA SOTTERRANEA IN A12. di SILVIA Dr MARTINO
 TELL MOZAN / URKESH: ARCHEOZOOLOGIA DELLA STRUTTURA SOTTERRANEA IN A12 di SILVIA Dr MARTINO Qui di seguito vengono presentati i dati emersi dallo studio di un primo campione di reperti provenienti dal
TELL MOZAN / URKESH: ARCHEOZOOLOGIA DELLA STRUTTURA SOTTERRANEA IN A12 di SILVIA Dr MARTINO Qui di seguito vengono presentati i dati emersi dallo studio di un primo campione di reperti provenienti dal
PREMESSA LO SCAVO. Fratta Nord
 1 PREMESSA L intervento oggetto di questa relazione si è svolto nelle giornate dal 23 al 25 novembre 2010, nel comune di Fossalta di Portogruaro (VE), presso le stazioni di servizio Fratta Nord e Fratta
1 PREMESSA L intervento oggetto di questa relazione si è svolto nelle giornate dal 23 al 25 novembre 2010, nel comune di Fossalta di Portogruaro (VE), presso le stazioni di servizio Fratta Nord e Fratta
I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE IN FVG NEL 2015 (gennaiodicembre)
 18 febbraio #lavoro Rassegna stampa TG3 RAI FVG 16feb2016 Messaggero Veneto 17feb2016 Il Piccolo 17feb2016 Il Gazzettino 17feb2016 I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE IN FVG NEL 2015 (gennaiodicembre)
18 febbraio #lavoro Rassegna stampa TG3 RAI FVG 16feb2016 Messaggero Veneto 17feb2016 Il Piccolo 17feb2016 Il Gazzettino 17feb2016 I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE IN FVG NEL 2015 (gennaiodicembre)
Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro
 Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro L obiettivo iniziale dell intervento era di completare l indagine archeologica del piano interno del propileo (già oggetto di scavi nel 1996-97 e
Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro L obiettivo iniziale dell intervento era di completare l indagine archeologica del piano interno del propileo (già oggetto di scavi nel 1996-97 e
IL LAVORO IN FVG NELL ULTIMO DECENNIO
 2 maggio #lavoro IL LAVORO IN FVG NELL ULTIMO DECENNIO 2008-2018 È diminuita l occupazione ma ancora di più la popolazione Il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia, nonostante il recupero degli ultimi
2 maggio #lavoro IL LAVORO IN FVG NELL ULTIMO DECENNIO 2008-2018 È diminuita l occupazione ma ancora di più la popolazione Il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia, nonostante il recupero degli ultimi
31 Marzo 2011 n 5 STATISTICA - COMUNE DI FERRARA. L occupazione a Ferrara nel 2010
 31 Marzo 2011 n 5 STATISTICA - COMUNE DI FERRARA L occupazione a Ferrara nel 2010 L andamento positivo dell economia italiana nel 2010, tornata a crescere dopo la crisi iniziata nella seconda metà del
31 Marzo 2011 n 5 STATISTICA - COMUNE DI FERRARA L occupazione a Ferrara nel 2010 L andamento positivo dell economia italiana nel 2010, tornata a crescere dopo la crisi iniziata nella seconda metà del
IL CINGHIALE Sus scrofa
 Le schede di M.C.P. www.matteocervo.wordpress.com A cura di Serena Storaci e Elisa Masseroni IL CINGHIALE Sus scrofa CINGHIALE DISTRIBUZIONE IN ITALIA SUPERORDINE: Ungulati ORDINE: Artiodattili FAMIGLIA:
Le schede di M.C.P. www.matteocervo.wordpress.com A cura di Serena Storaci e Elisa Masseroni IL CINGHIALE Sus scrofa CINGHIALE DISTRIBUZIONE IN ITALIA SUPERORDINE: Ungulati ORDINE: Artiodattili FAMIGLIA:
LE POPOLAZIONI DEGLI UNGULATI IN ITALIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI DELL INFS
 LE POPOLAZIONI DEGLI UNGULATI IN ITALIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI DELL INFS Paolo Montanaro Francesco Riga Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica A. Ghigi Obiettivi del progetto BDU Definizione ed aggiornamento
LE POPOLAZIONI DEGLI UNGULATI IN ITALIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI DELL INFS Paolo Montanaro Francesco Riga Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica A. Ghigi Obiettivi del progetto BDU Definizione ed aggiornamento
IL RILEVAMENTO BIOMETRICO NEGLI UNGULATI. Paolo Montanaro
 IL RILEVAMENTO BIOMETRICO NEGLI UNGULATI Paolo Montanaro UNGULATI Incremento numerico Espansione degli areali Aumento del prelievo venatorio DIFFUSIONE DEL RILEVAMENTO BIOMETRICO Approcci diversi Disomogeneità
IL RILEVAMENTO BIOMETRICO NEGLI UNGULATI Paolo Montanaro UNGULATI Incremento numerico Espansione degli areali Aumento del prelievo venatorio DIFFUSIONE DEL RILEVAMENTO BIOMETRICO Approcci diversi Disomogeneità
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
Gamberi di fiume alieni invasivi nel Veronese Pordenone, 19 giugno 2014
 Ivano Confortini Provincia di Verona Gamberi di fiume alieni invasivi nel Veronese Pordenone, 19 giugno 2014 Reticolo idrografico della provincia di Verona In provincia di Verona vi sono circa 800 corsi
Ivano Confortini Provincia di Verona Gamberi di fiume alieni invasivi nel Veronese Pordenone, 19 giugno 2014 Reticolo idrografico della provincia di Verona In provincia di Verona vi sono circa 800 corsi
Barghini G. L età evolutiva termina a 14 anni? No continua dopo i 14 anni.
 Barghini G. L età evolutiva termina a 14 anni? No continua dopo i 14 anni. Il D.P.R. 28.7.2000 n. 272 con l art. 1 stabilì I medici specialisti in pediatria.sono parte attiva.nel settore preposto alla
Barghini G. L età evolutiva termina a 14 anni? No continua dopo i 14 anni. Il D.P.R. 28.7.2000 n. 272 con l art. 1 stabilì I medici specialisti in pediatria.sono parte attiva.nel settore preposto alla
Monitoraggio Ungulati selvatici Anno 2010
 Monitoraggio Ungulati selvatici Anno 2010 1. Materiali e metodi Per la primavera 2010, è stato applicata la tecnica del pellet group count con le stesse modalità individuate negli scorsi anni, vale a dire
Monitoraggio Ungulati selvatici Anno 2010 1. Materiali e metodi Per la primavera 2010, è stato applicata la tecnica del pellet group count con le stesse modalità individuate negli scorsi anni, vale a dire
Realizzazione centro di allevamento per Emys orbicularis, controllo nutria e testuggini esotiche
 Realizzazione centro di allevamento per Emys orbicularis, controllo nutria e testuggini esotiche Relazione finale 2017 Macerata, dicembre 2017 Studio Faunistico Chiros s.s. Dott. Giorgio Marini Riepilogo
Realizzazione centro di allevamento per Emys orbicularis, controllo nutria e testuggini esotiche Relazione finale 2017 Macerata, dicembre 2017 Studio Faunistico Chiros s.s. Dott. Giorgio Marini Riepilogo
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE)
 Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
RELAZIONE SULL INTERVENTO DI RECUPERO DI ALCUNE SEPOLTURE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI
 Povegliano Veronese f. 1 RELAZIONE SULL INTERVENTO DI RECUPERO DI ALCUNE SEPOLTURE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI POVEGLIANO VERONESE, EFFETUATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL VENETO IN COLLABORAZIONE
Povegliano Veronese f. 1 RELAZIONE SULL INTERVENTO DI RECUPERO DI ALCUNE SEPOLTURE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI POVEGLIANO VERONESE, EFFETUATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL VENETO IN COLLABORAZIONE
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
Dottoressa FRANCESCA GUANDALINI
 Dottoressa FRANCESCA GUANDALINI Archeologa, coordinatrice degli scavi effettuati nel territorio di Montegibbio a partire dall estate del 2006. Finalità principale di questa ricerca, oggetto della sua tesi
Dottoressa FRANCESCA GUANDALINI Archeologa, coordinatrice degli scavi effettuati nel territorio di Montegibbio a partire dall estate del 2006. Finalità principale di questa ricerca, oggetto della sua tesi
2. IL SETTORE AGRICOLO La struttura delle aziende e l utilizzazione del territorio
 25 2. IL SETTORE AGRICOLO La conformazione del territorio su cui insiste il nostro Comune, stretto tra le Alpi Apuane ed il mare, non ha certamente favorito lo sviluppo della pratica agricola, tanto che
25 2. IL SETTORE AGRICOLO La conformazione del territorio su cui insiste il nostro Comune, stretto tra le Alpi Apuane ed il mare, non ha certamente favorito lo sviluppo della pratica agricola, tanto che
