Cosa sono i ghiacciai
|
|
|
- Giacomo Randazzo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Cosa sono i ghiacciai Come funzionano La massa di ghiaccio che costituisce un ghiacciaio non è una massa statica e omogenea: il ghiaccio ha diverse caratteristiche nei diversi punti del ghiacciaio e si comporta in modo differente a seconda della sua compattezza, della sua densità, della temperatura all interno e alla base del ghiacciaio e delle caratteristiche del substrato roccioso su cui poggia. Sulla superficie di ogni ghiacciaio è quindi possibile individuare diverse zone, dove processi diversi sono all opera per plasmare la forma del ghiacciaio e determinarne il comportamento. In ogni ghiacciaio si individuano due zone fondamentali: la zona di accumulo, dove la neve caduta durante l inverno rimane conservata anche durante la stagione calda, che costituisce la zona dove il ghiacciaio riceve l alimentazione nevosa necessaria alla sua sopravvivenza, e la zona di ablazione. In questa zona si ha invece una perdita di ghiaccio, principalmente per fusione della neve caduta nella precedente stagione invernale e del ghiaccio messo a nudo dopo la fusione nivale, ma anche per crolli e distacchi di materiale dal corpo del ghiacciaio, come avviene, per esempio, nella formazione di iceberg. Vi sono quindi zone del ghiacciaio dove si produce ghiaccio e zone dove il ghiaccio viene invece distrutto e allontanato. Le due zone sono ben riconoscibili in estate: la zona di accumulo presenta una superficie bianca, coperta di neve e Firn, mentre la zona di ablazione mostra ghiaccio vivo, in genere di aspetto sporco per la presenza di detriti rocciosi affioranti dal ghiaccio. L estensione e l importanza di queste due zone caratterizza ciascun ghiacciaio e ne condiziona il comportamento. L estensione delle due zone non è fissa nel tempo: esse, infatti, sono delimitate tra loro dalla linea di equilibrio, che coincide, grossomodo, con il limite delle nevi perenni. Poichè questo limite varia molto in funzione delle condizioni climatiche, variazioni del clima a breve e a lungo termine influiscono grandemente sulla sua posizione, e, di conseguenza, sull ampiezza della zona di alimentazione e della zona di ablazione. Il corpo di un ghiacciaio montano è normalmente confinato dalle pareti rocciose che lo circondano, in genere, su quasi tutti i lati, ma di norma esiste sempre un lato non confinato, dove il ghiacciaio è libero di espandersi o di ritirarsi: è la zona della fronte, che segna il limite oltre il quale il ghiacciaio non può più esistere, perchè qui, semplicemente, l ablazione distrugge tutto il ghiaccio. Una delle caratteristiche più evidenti di un ghiacciaio, che lo differenzia da un deposito di neve, è che il ghiaccio si muove, scivolando verso valle sotto la spinta del suo stesso peso. In questo modo, il ghiaccio perso nella zona di ablazione viene continuamente rimpiazzato da nuovo ghiaccio che, formatosi nella zona di accumulo, viene trasportato dal movimento verso valle. Come si muovono Il movimento di un ghiacciaio non è uniforme in tutta la massa e nemmeno costante nel tempo. La velocità di movimento è più bassa in prossimità delle pareti e della base, dove il ghiacciaio è rallentato dall attrito con il substrato roccioso, e massima nelle zone centrali, dove gli attriti sono minimi e lo spessore del ghiaccio è massimo. Differenti velocità si possono osservare anche alla confluenza di due lingue glaciali, di solito marcate da una morena mediana galleggiante, una lunga striscia di detriti che percorre il ghiacciaio per tutta la lunghezza della zona di ablazione. Se alla base si trova dell acqua di fusione, il ghiacciaio si muove più velocemente: i ghiacciai temperati sono quindi quelli che camminano di più, mentre quelli a base fredda possono rimanere ancorati al substrato gelato e muoversi molto poco, o a scatti, un po come avviene lungo una faglia. Le velocità di movimento variano molto a seconda delle caratteristiche del ghiacciaio e del substrato: si va da pochi metri all anno a parecchie centinaia di metri annui. Uno dei più veloci ghiacciai è il Columbia, in Nord America, che a partire dagli anni 70 si muove con una velocità di 24 metri al giorno. Intuitivamente, si può pensare che questo inarrestabile movimento spinga continuamente la fronte verso valle: più il ghiacciaio è veloce, più questo dovrebbe farlo avanzare.
2 Quindi, l osservazione continua nel tempo della posizione e della forma della fronte di un ghiacciaio dovrebbe darci indicazioni attendibili sul suo stato di avanzamento o di ritiro. Ma le cose sono, nella realtà, molto più complesse. Anche quando la fronte è stabile, apparentemente ferma, il ghiacciaio continua a muoversi verso valle: il fatto che la fronte non si sposti, significa che il ghiaccio perso per ablazione viene continuamente rimpiazzato da nuovo ghiaccio proveniente dalla zona di accumulo, allo stesso ritmo con cui viene perduto. Nel caso del Ghiacciaio Columbia, la cui elevata velocità ce lo farebbe pensare in rapida avanzata, le abbondanti perdite alla fronte ne fanno un ghiacciaio complessivamente in ritiro: dal 1982 il regresso è stato di 14 km. Delicati equilibri Per valutare lo stato di un ghiacciaio, in particolare se questo sia in fase di avanzata o di ritiro, non basta quindi valutare le variazioni di posizione della fronte, ma occorre considerare il delicato equilibrio tra apporti nevosi, e quindi formazione di nuovo ghiaccio, e perdite di ghiaccio nella zona di ablazione: in poche parole, si devono valutare le variazioni di volume del ghiacciaio, studiando il bilancio tra questi due fattori, realizzando quello che i ricercatori chiamano bilancio di massa. Si tratta, in pratica, di misurare gli apporti e le perdite, un po come in un bilancio aziendale, e dedurre da questo se il volume del ghiacciaio stia aumentando o diminuendo. Se il bilancio è positivo, e gli apporti superano le perdite, il ghiacciaio tenderà ad espandersi, spostando la posizione della fronte più a valle, mentre se il bilancio è negativo, il ghiacciaio si ridurrà, sia assottigliando il proprio spessore, sia ritirando progressivamente la fronte verso monte. Una fronte stabile nel tempo indica invece una situazione stazionaria, di equilibrio tra apporti e perdite (ma non significa affatto che il ghiacciaio sia fermo!). La risposta del ghiacciaio non è però immediata: in genere, il ghiacciaio risponde con una certa inerzia, che dipende anche dalle sue dimensioni, e occorrono alcuni anni di bilancio positivo per assistere ad un avanzata e viceversa. Molti ghiacciai delle Alpi sono studiati da decenni, alcuni da oltre un secolo, e i ricercatori dispongono quindi di lunghe serie temporali di misure di variazioni alla fronte e di bilanci di massa: questo ha permesso, confrontando gli avanzamenti e i ritiri dei ghiacciai con dati climatici e meteorologici, di comprendere come i ghiacciai hanno reagito alle variazioni climatiche più recenti, permettendo quindi di avanzare ipotesi sul futuro dei nostri ghiacciai. Un materiale particolare Il ghiaccio gode di singolari proprietà fisiche, che condizionano tutti i processi che si svolgono sulla superficie e all interno di un ghiacciaio. A pressione ambiente, il ghiaccio è un materiale molto fragile, che, se sottoposto a sollecitazioni meccaniche come compressione o distorsioni reagisce fratturandosi e rompendosi in modo fragile (per verificarlo, provate a far cadere un cubetto di ghiaccio: otterrete una miriade di schegge che si fonderanno rapidamente sul pavimento della vostra cucina...). In condizioni di pressione elevata, come, per esempio, all interno di un ghiacciaio, o per sollecitazioni applicate molto lentamente,il ghiaccio, invece, si comporta in modo plastico, deformandosi e distorcendosi in modo continuo, senza dare luogo a fratture (un po come fa un panetto di Pongo ). Per verificare, provate il classico esperimento di appoggiare su un cubetto di ghiaccio un filo caricato da due pesi all estremità: lentamente, il filo penetrerà all interno del cubetto, con i bordi del passaggio che si risaldano mano a mano che il filo avanza, fino ad attraversarlo completamente senza lasciare traccia del proprio passaggio. Questo fa sì che il ghiaccio di un ghiacciaio si comporti in modo molto diverso in superficie e in profondità. La cosa potrebbe sembrare di poco importanza, ma è fondamentale per la circolazione di acqua e l immagazzinamento di riserve idriche all interno del ghiacciaio. Il ghiaccio, infatti, è di per sè un materiale impermeabile, che non consente il passaggio dell acqua: diviene permeabile, però, consentendo una circolazione idrica, quando è fratturato. La fragilità degli strati superficiali è anche responsabile di quelle che sono tra le più conosciute morfologie della superficie di un ghiacciaio: i crepacci e i seracchi, immense fratture che a volte rendono estremamente difficile e pericoloso il percorrere i ghiacciai. Spesso descritti come abissi senza fondo, in realtà raggiungono, proprio grazie alle caratteristiche fisiche sopra descritte, una profondità che di rado supera i m (poca cosa su un ghiacciaio dove lo spessore del ghiaccio supera gli 800 m, come il ghiacciaio dell Aletsch, ma sufficienti ad ispirarci un reverente timore!).
3 La disposizione dei crepacci e delle fratture dipende dalle tensioni che si originano nel ghiaccio in risposta alle irregolarità del substrato roccioso e dell attrito lungo le pareti, e ci può essere utile per ricostruire l andamento della roccia sottostante o per valutare lo spessore del ghiaccio. Per esempio, campi di seracchi, grandi cascate di blocchi di ghiaccio intensamente crepacciati, possono indicare una brusca variazione di pendenza del substrato, o una soglia rocciosa, che potrebbe far supporre la presenza di laghi sottoglaciali, estremamente pericolosi per la loro instabilità. L innalzamento verificatosi alla fine dell ultima glaciazione è in gran parte mascherato dall innalzamento del livello marino conseguente alla fusione di grandi quantità di ghiacci continentali. Un grande nastro trasportatore Con il movimento del ghiacciaio e l attrito con la roccia lungo le pareti e sul fondo, la caduta di materiale dai versanti circostanti, la polvere portata dal vento, carcasse di animali, rifiuti lasciati dall uomo, ivi compresi residuati bellici e corpi di sfortunati soldati o alpinisti possono essere catturati e inglobati nel ghiaccio di un ghiacciaio, sia in superficie che all interno. Il movimento del ghiacciaio, prima descritto come uno scivolamento verso valle, è in realtà più complesso, e contribuisce a far penetrare in profondità i detriti nella zona di accumulo e a riportarli a giorno nella zona di ablazione, dove anche la fusione collabora a metterli allo scoperto. Quando un ghiacciaio avanza, come una gigantesca ruspa spinge detriti e rocce incoerenti sotto e avanti a sè, quando si ritira abbandona tutto il materiale che aveva in carico, costituendo depositi glaciali, detti anche till, da un termine scozzese, che prendono diversi nomi in funzione di come il ghiacciaio li ha messi in posto (per esempio, spalmandoli sui versanti e sul fondo, schiacciandoli e stirandoli con il suo peso, come per i till di alloggiamento, oppure accumulandoli per lenta fusione del ghiaccio che li contiene, come per i till di ablazione ). I depositi glaciali presentano caratteristiche inconfondibili (per esempio, la presenza contemporanea di grossi massi e di matrice finissima, i ciottoli arrotondati e striati dalle enormi pressioni e dal reciproco attrito cui sono stati sottoposti durante il trasporto) che fanno sì che sia possibile riconoscerli anche quando il ghiacciaio che li ha prodotti è scomparso da molto tempo. Proprio grazie al rinvenimento di depositi di origine glaciale è stato possibile ricostruire il succedersi di vari episodi di glaciazione nel tempo: talvolta, i luoghi dove sono stati rinvenuti depositi glaciali sono davvero sorprendenti. Per esempio, i recenti ritrovamenti nel deserto della Namibia o del Sahara, a testimonianza di una glaciazione di più di 400 milioni di anni fa. I depositi più giovani spesso conservano anche delle forme particolari, come le morene, che permettono di ricostruire non solo la presenza del ghiacciaio, ma anche la forma della sua fronte e la quota dei suoi fianchi. Poichè i ghiacciai possono anche essere lunghi decine o centinaia di km, e in passato esistevano apparati glaciali ancora più estesi, anche lo studio del tipo di rocce che costituiscono i depositi glaciali ci da importanti informazioni, permettendoci di ricostruire il percorso di antichi ghiacciai ora scomparsi. Per esempio, nei territori a Nord di Milano si ritrovano ciottoli di rocce provenienti dalla Valtellina e dalla Valchiavenna, cosa che ha permesso di ricostruire il percorso di un antico ghiacciaio che, a più riprese, scendeva lungo la valle dell Adda occupando quello che è ora il lago di Como. Studi di dettaglio hanno permesso, in quest area, di ricostruire esattamente il percorso delle diverse lingue in cui si divideva il ghiacciaio principale, aggirando diversi nunatak, al suo sbocco in pianura. Lo studio dei sedimenti glaciali è quindi fondamentale per comprendere le variazioni di estensione e di forma dei ghiacciai nel tempo, ma questo può essere fatto in modo efficace soltanto se si conoscono molto bene i processi che regolano il comportamento dei ghiacciai attuali. Ghiacciai bianchi e ghiacciai neri La quantità di detriti all interno e sulla superficie di un ghiacciaio è molto variabile, e dipende sia dal movimento del ghiacciaio, sia dal tipo di substrato su cui si muove, sia dalla conformazione e dalle caratteristiche geologiche delle pareti che lo sovrastano. Particolari tipi di rocce, sensibili a processi di alterazione come il crioclastismo, o versanti soggetti a frequenti franamenti e colate di detriti, possono fornire grandi quantità di materiale detritico che va a ricoprire la superficie del ghiacciaio. Questa normalmente appare bianca, costituita da neve nella zona di accumulo, e da ghiaccio disseminato di detriti nella zona di ablazione. Quando l apporto di materiali detritici dai versanti è elevato, tuttavia, la
4 superficie del ghiacciaio può risultare completamente coperta di detriti rocciosi di varie dimensioni, fino a rendere praticamente invisibile il ghiaccio: si parla allora di ghiacciai neri, in contrapposizione ai ghiacciai bianchi. Esempi di questo tipo sono molti ghiacciai dell Himalaya o del Karakorum. In Italia, un esempio molto bello è costituito dal Ghiacciaio del Miage, in Valle d Aosta, celebre anche per il suo lago terminale. La presenza di detriti protegge il ghiaccio dalla fusione: i ghiacciai neri sono quindi più protetti dei loro colleghi che, bianchi e nudi, non possono difendersi dalla radiazione solare. Chi è passato di qui? Tutti i ghiacciai lasciano tracce del loro passaggio, tracce che possono conservarsi anche per migliaia e persino milioni di anni. Studiando i ghiacciai attuali, i geologi sono in grado di riconoscere agevolmente gli indizi dell esistenza di antichi ghiacciai. Un ghiacciaio, muovendosi e scivolando sul substrato roccioso, lascia due diversi tipi di tracce: può depositare il materiale che trasporta al suo interno e sulla sua superficie, dando depositi glaciali accumulati in forme caratteristiche e facilmente riconoscibili, oppure può erodere le rocce su cui si muove, lasciando superfici lisciate e levigate. I depositi glaciali sono in genere caratterizzati da una granulometria che comprende sia materiale molto fine, che deriva dalla frantumazione di ciottoli e detriti per attrito tra loro e con il substrato roccioso, sia materiale molto grossolano, compresi blocchi di parecchi metri di diametro. Questo deriva dalle proprietà viscose del ghiaccio, che fa sì che possa prendere in carico materiali di peso e densità molto diversi, al contrario di altri agenti di trasporto, molto più selettivi (come, per esempio, il vento, che è in grado di trasportare soltanto sabbia, o le acque correnti, che trasportano materiale le cui dimensioni sono funzione della velocità della corrente). I blocchi più grandi sono noti con il nome di massi erratici e sono un buon metodo per capire fino a che quota e a che distanza si siano spinti i ghiacciai del passato. Se le forme dei depositi glaciali sono conservate, si hanno anche testimonianze sulla forma della fronte, sulle caratteristiche del trasporto e del movimento del ghiacciaio, sulle sue avanzate e sui suoi ritiri e molto altro. Le forme più caratteristiche e conosciute sono sicuramente le morene, che possono essere morene laterali, o di sponda, formate tra i bordi del ghiacciaio e il versante, o le morene frontali, o terminali, messe in posto davanti al ghiacciaio, in genere a formare archi concentrici. Altre forme, meno conosciute sui ghiacciai alpini, si originano alla base del ghiacciaio, per effetto sia delle deformazioni dovute al peso del ghiaccio, come le fluted moraine o i drumlin, sia per effetto delle acque che circolano alla base, come gli esker. Altre forme si originano al contatto tra il ghiacciaio e i versanti, nei depositi di contatto glaciale, come i terrazzi di kame, depressioni formate tra le morene di sponda e il versante, che possono ospitare piccoli laghi, essere colmate da detriti di versante o depositi di frana o da valanga che scendono dai versanti. Lo studio dei depositi e delle forme permette di ricostruire con molto dettaglio la forma e le caratteristiche di antichi ghiacciai, ed è fondamentale per ricostruire gli ambienti e i climi del passato. Le forme di erosione, o di esarazione, costituiscono anch esse un ottimo indizio del passaggio di un ghiacciaio e possono a volte essere l unico tipo di traccia conservata. Possono essere forme molto grandi, come intere valli con il caratteristico profilo a U, circhi glaciali separati da creste sottili (a dare i cosiddetti horn, come il Cervino), oppure essere riconosciute su singoli affioramenti rocciosi, come nelle rocce montonate, dette anche dorsi di balena, per la forma allungata e arrotondata. Le rocce montonate, lisciate e levigate dall azione abrasiva del ghiaccio ricco di detriti, mostrano spesso delle caratteristiche strie e scanalature della roccia, dovute al raschiamento operato sul substrato da ciottoli duri, e permettono di ricostruire non soltanto il passaggio, ma anche la direzione e il verso in cui il ghiacciaio fluiva. Molto importante è la ricostruzione, attraverso lo studio delle forme e dei depositi lasciati dai ghiacciai, del limite massimo raggiunto dai ghiacciai nel corso delle glaciazioni del Quaternario. Con l acronimo MEG (Maximum Extention Glacier), si indica la quota massima raggiunta dai ghiacciai pliocenici e quaternari, mentre il termine LGM (Last Glacial Maximum) indica la quota massima raggiunta dai ghiacciai nel corso dell ultima glaciazione: le due quote non sono uguali, soprattutto in zone di pianura, poichè i ghiacciai non hanno raggiunto la massima espansione durante l ultima glaciazione. L età dei depositi glaciali più recenti viene ricavata osservando lo stato di alterazione delle rocce che li costituiscono, il
5 grado di sviluppo di suoli, che determina un diverso grado di copertura vegetale, l età della vegetazione (dendrocronologia) e dei licheni (lichenometria) che ricoprono le rocce. E per il futuro? I ghiacciai sono sensibili indicatori delle variazioni climatiche, in particolare delle variazioni di temperatura e di precipitazioni e come, attraverso lo studio delle variazioni frontali e dei bilanci di massa, sia possibile seguirne il comportamento nel corso degli anni. In generale, a partire dalla metà degli anni 80, dopo una breve fase di avanzamento, la maggior parte dei ghiacciai in tutto il mondo è in fase di regresso, anche se, naturalmente, non mancano le eccezioni. Per esempio, in Norvegia, il ghiacciaio Nigardsbreen, uno dei ghiacciai di sbocco del grande Jostedalsbreen, il più grande d Europa, esclusa l Islanda, monitorato dal 1962, mostra, in 40 anni di osservazione, 26 anni di bilancio positivo, ed è avanzato di 260 m tra il 1988 e il 2000, mostrando quindi una grande differenza con i colleghi alpini. Proprio queste differenze ci fanno comprendere come i processi che legano il comportamento dei ghiacciai alle variazioni climatiche siano molto poco conosciuti e molti anni di ricerche sul campo siano ancora necessari per poter fare ipotesi sul futuro che attende, insieme ai ghiacciai, anche noi e l intero nostro pianeta. Anche per quanto riguarda le grandi calotte, i dati sono ancora incompleti per avere un quadro generale. Si può osservare che i distacchi di iceberg, anche di grandi dimensioni, sono un evento comune, così come anche le dimensioni delle piattaforme di ghiaccio oscillano continuamente, espandendosi e ritirandosi con una tendenza che non è ancora stato possibile determinare. Nel maggio 2002 la piattaforma di Ross ha perso un iceberg lungo poco meno di 200 km e nel giro di pochi mesi almeno altri tre giganti, lunghi da 80 a 50 km, si sono staccati dalla stessa zona: dopo questi eventi, la piattaforma di Ross è ritornata alle dimensioni rilevate nel 1911 dall esploratore Robert Scott. Questo sembrerebbe indicare un espansione rispetto ai primi anni del secolo scorso. Dal 1979, sembrerebbe però che la frammentazione delle piattaforme antartiche si stia intensificando, tuttavia soltanto dalle osservazioni sugli icerberg non è possibile dire se i ghiacci dell Antartide si stiano riducendo. Ogni anno le piattaforme antartiche perdono circa km3 di ghiaccio, ma questo dato non è sufficiente: per poter fare affermazioni più precise, occorre verificare se la quantità di ghiacci persi sotto forma di iceberg superi o meno la quantità di nuovo ghiaccio formatosi a seguito delle annuali precipitazioni nevose. Soltanto con questi dati a disposizione su un certo numero di anni è possibile determinare un bilancio e quindi azzardare una previsione sul futuro dei ghiacci antartici. Quello che è certo è che rispetto agli anni 40 si è registrato un aumento della temperatura media annua di 2,5 C, che dovrebbe accelerare la fusione dei ghiacci, ma accanto a questo in alcune zone dell Antartide si è registrato da alcuni anni un aumento delle precipitazioni nevose, che dovrebbe andare ad alimentare la calotta e i suoi ghiacciai: quale di queste due tendenze prevarrà in futuro, non è dato ancora saperlo, ma è evidente come tutto dipenda da un fragile equilibrio, in cui i fattori accennati sopra sono soltanto due tra le tante variabili nel complesso gioco del clima terrestre. In definitiva, occorrono ancora anni di studi e di costanti osservazioni per poter comprendere il funzionamento del clima del nostro pianeta e per poter di conseguenza presentare modelli previsionali per il prossimo futuro: si comprende quindi come la ricerca sul campo sia di fondamentale importanza per suffragare, con dati oggettivi raccolti in natura, teorie scientifiche e modelli di previsione.
Cosa sono i ghiacciai
 Cosa sono i ghiacciai Come funzionano La massa di ghiaccio che costituisce un ghiacciaio non è una massa statica e omogenea: il ghiaccio ha diverse caratteristiche nei diversi punti del ghiacciaio e si
Cosa sono i ghiacciai Come funzionano La massa di ghiaccio che costituisce un ghiacciaio non è una massa statica e omogenea: il ghiaccio ha diverse caratteristiche nei diversi punti del ghiacciaio e si
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
Ghiaccio e ghiacciai. Il ghiaccio. Introduzione. Come si forma il ghiaccio
 Ghiaccio e ghiacciai Introduzione I ghiacciai sono immensi corpi di ghiaccio, ma il ghiaccio che li costituisce solo in minima parte è formato da ghiaccio di congelamento. La gran parte della massa di
Ghiaccio e ghiacciai Introduzione I ghiacciai sono immensi corpi di ghiaccio, ma il ghiaccio che li costituisce solo in minima parte è formato da ghiaccio di congelamento. La gran parte della massa di
Ghiaccio e ghiacciai. Il ghiaccio. Introduzione. Come si forma il ghiaccio
 Ghiaccio e ghiacciai Introduzione I ghiacciai sono immensi corpi di ghiaccio, ma il ghiaccio che li costituisce solo in minima parte è formato da ghiaccio di congelamento. La gran parte della massa di
Ghiaccio e ghiacciai Introduzione I ghiacciai sono immensi corpi di ghiaccio, ma il ghiaccio che li costituisce solo in minima parte è formato da ghiaccio di congelamento. La gran parte della massa di
Cosa sono le acque continentali?
 Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
Influenza del cambiamento climatico sulla biodiversità e sugli ecosistemi delle aree Protette
 Perché si parla di cambiamenti climatici? Queste sono alcune delle variazioni finora riscontrate (i fatti): Negli ultimi 150 anni la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa 0.74
Perché si parla di cambiamenti climatici? Queste sono alcune delle variazioni finora riscontrate (i fatti): Negli ultimi 150 anni la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa 0.74
LA VALUTAZIONE E LA PREVENZIONE DEL PERICOLO/RISCHIO VALANGHE è una questione di forma mentale, di preparazione e di metodo.
 LA VALUTAZIONE E LA PREVENZIONE DEL PERICOLO/RISCHIO VALANGHE è una questione di forma mentale, di preparazione e di metodo. Mario Di Gallo gennaio 2012 Il consolidamento del manto nevoso è inversamente
LA VALUTAZIONE E LA PREVENZIONE DEL PERICOLO/RISCHIO VALANGHE è una questione di forma mentale, di preparazione e di metodo. Mario Di Gallo gennaio 2012 Il consolidamento del manto nevoso è inversamente
Azoto. La molecola di azoto e formata da due atomi di azoto, legati insieme con un triplo legame:
 Aria ed atmosfera L aria Questo sottile strato, inodore ed incolore è una miscela di gas: 78 % di azoto; 21 % di ossigeno; 0,03 % di anidride carbonica; 0,97 % altri gas. Azoto La molecola di azoto e formata
Aria ed atmosfera L aria Questo sottile strato, inodore ed incolore è una miscela di gas: 78 % di azoto; 21 % di ossigeno; 0,03 % di anidride carbonica; 0,97 % altri gas. Azoto La molecola di azoto e formata
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
 TICINO: record storico per l'intero mese di maggio... lo comunica meteosvizzera in un articolo appena uscito. MeteoSvizzera - Maggio 2009: caldo? No, caldissimo! Aprile ci ha lasciato abbondanti precipitazioni
TICINO: record storico per l'intero mese di maggio... lo comunica meteosvizzera in un articolo appena uscito. MeteoSvizzera - Maggio 2009: caldo? No, caldissimo! Aprile ci ha lasciato abbondanti precipitazioni
Attività aggiuntive Nuovo Gulliver News n Gennaio Dopo l osservazione delle immagini, completa la tabella scrivendo le differenze.
 3 a geografia Attività aggiuntive Nuovo Gulliver News n. 174 - Gennaio 2016 ATTIVITÀ n. 1 Dopo l osservazione delle immagini, completa la tabella scrivendo le differenze. ELEMENTI COLLINA MONTAGNA CIME
3 a geografia Attività aggiuntive Nuovo Gulliver News n. 174 - Gennaio 2016 ATTIVITÀ n. 1 Dopo l osservazione delle immagini, completa la tabella scrivendo le differenze. ELEMENTI COLLINA MONTAGNA CIME
Escursione ai piedi del ghiacciaio
 Escursione ai piedi del ghiacciaio Per alpinisti ed escursionisti l immagine della Valle Anzasca è legata sicuramente alla parete est del Monte Rosa, un imponente muraglia di ghiaccio e roccia che precipita
Escursione ai piedi del ghiacciaio Per alpinisti ed escursionisti l immagine della Valle Anzasca è legata sicuramente alla parete est del Monte Rosa, un imponente muraglia di ghiaccio e roccia che precipita
Montagne: rilievi superiori ai 600 metri di altezza. Colline: rilievi tra i 300 e i 600 metri di altezza
 Montagne: rilievi superiori ai 600 metri di altezza Colline: rilievi tra i 300 e i 600 metri di altezza 3) PER ACCUMULO SUI FONDALI MARINI DI ROCCIA E SABBIA che, col tempo e la spinta delle placche, si
Montagne: rilievi superiori ai 600 metri di altezza Colline: rilievi tra i 300 e i 600 metri di altezza 3) PER ACCUMULO SUI FONDALI MARINI DI ROCCIA E SABBIA che, col tempo e la spinta delle placche, si
Unità 8 - Il clima e le sue variazioni
 Unità 8 - Il clima e le sue variazioni 1 1. I climi del pianeta In base alle temperature e alle precipitazioni sono stati individuati 5 gruppi climatici fondamentali 2 1. I climi del pianeta Il climatogramma
Unità 8 - Il clima e le sue variazioni 1 1. I climi del pianeta In base alle temperature e alle precipitazioni sono stati individuati 5 gruppi climatici fondamentali 2 1. I climi del pianeta Il climatogramma
Carte meteorologiche, fronti, instabilità
 Carte meteorologiche, fronti, instabilità Le scale meteorologiche Le masse d aria Alte e basse pressioni Le carte meteorologiche I sistemi frontali Plampincieux, 28 maggio 2007 Le scale meteorologiche
Carte meteorologiche, fronti, instabilità Le scale meteorologiche Le masse d aria Alte e basse pressioni Le carte meteorologiche I sistemi frontali Plampincieux, 28 maggio 2007 Le scale meteorologiche
Il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico
 Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Il cambiamento climatico
 Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
LE FORME DEL TERRITORIO
 VOLUME 1 CAPITOLO 1 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE LE FORME DEL TERRITORIO 1. Parole per capire A. Conosci già queste parole? Scrivi il loro significato o fai un disegno: carta geografica... altezza...
VOLUME 1 CAPITOLO 1 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE LE FORME DEL TERRITORIO 1. Parole per capire A. Conosci già queste parole? Scrivi il loro significato o fai un disegno: carta geografica... altezza...
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio
 UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO MORFOLOGIA GLACIALE. INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO
 ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO MORFOLOGIA GLACIALE INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss Un ghiacciaio
ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO MORFOLOGIA GLACIALE INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss Un ghiacciaio
Corso aaag 2006 Pagina 1 di 7 Geologia Morfologia glaciale
 MORFOLOGIA GLACIALE Un ghiacciaio è una spessa massa di ghiaccio che si forma sulla terraferma in conseguenza della compattazione e ricristallizzazione della neve, e non dal semplice raffreddamento dell'acqua,
MORFOLOGIA GLACIALE Un ghiacciaio è una spessa massa di ghiaccio che si forma sulla terraferma in conseguenza della compattazione e ricristallizzazione della neve, e non dal semplice raffreddamento dell'acqua,
Il sistema Terra Acqua, Aria e Suolo
 Il sistema Terra Acqua, Aria e Suolo Il pianeta Terra il pianeta Terra, il pianeta in cui viviamo e che condividiamo con decine di milioni di specie viventi È un pianeta unico nell ambito del Sistema Solare
Il sistema Terra Acqua, Aria e Suolo Il pianeta Terra il pianeta Terra, il pianeta in cui viviamo e che condividiamo con decine di milioni di specie viventi È un pianeta unico nell ambito del Sistema Solare
LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE
 Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
Elementi di meteorologia. Corso per docenti delle scuole primaria, secondaria di I e II grado
 Elementi di meteorologia Corso per docenti delle scuole primaria, secondaria di I e II grado 1 BOLLETTINO METEO Il sole riscalda la terra 2 Come si crea il tempo meteorologico? 3 Il sole riscalda la terra
Elementi di meteorologia Corso per docenti delle scuole primaria, secondaria di I e II grado 1 BOLLETTINO METEO Il sole riscalda la terra 2 Come si crea il tempo meteorologico? 3 Il sole riscalda la terra
La montagna. Ghiacciai. Clima e vegetazione
 La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
LA NEVE E LE VALANGHE
 3^LEZIONE INTERVENTO METEOROLOGO LUCA LOMBROSO Il ciclo dell acqua LA NEVE E LE VALANGHE Prima di capire cos è la neve è opportuno approfondire la conoscenza del liquido più comune sulla Terra: l acqua
3^LEZIONE INTERVENTO METEOROLOGO LUCA LOMBROSO Il ciclo dell acqua LA NEVE E LE VALANGHE Prima di capire cos è la neve è opportuno approfondire la conoscenza del liquido più comune sulla Terra: l acqua
LE ROCCE. (seconda parte) Lezioni d'autore. di Simona Mazziotti Tagliani
 LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LA CONOSCENZA DEL FENOMENO
 LA CONOSCENZA DEL FENOMENO Il processo di combustione L incendio è il prodotto della rapida combinazione di tre elementi fondamentali: il combustibile, l ossigeno e la temperatura necessaria per innescare
LA CONOSCENZA DEL FENOMENO Il processo di combustione L incendio è il prodotto della rapida combinazione di tre elementi fondamentali: il combustibile, l ossigeno e la temperatura necessaria per innescare
Capitolo 12 Le acque sotterranee
 Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
La fabbrica del ghiaccio
 La fabbrica del ghiaccio I ghiacciai della Valle d Aosta. intro > Numerose sono le leggende valdostane che narrano di prati lussureggianti e ricchi pascoli in luoghi dove oggi ci sono dei ghiacciai. Le
La fabbrica del ghiaccio I ghiacciai della Valle d Aosta. intro > Numerose sono le leggende valdostane che narrano di prati lussureggianti e ricchi pascoli in luoghi dove oggi ci sono dei ghiacciai. Le
IL GIARDINO ROCCIOSO. Dott. ssa geol. Annalisa Antonelli
 IL GIARDINO ROCCIOSO QUANDO È NATO? Origini che risalgono al Rinascimento (1350-1550); ricchi Signori collezionavano pietre, spugne, conchiglie, ossa di animali acquatici, ecc Periodo del paesaggismo inglese
IL GIARDINO ROCCIOSO QUANDO È NATO? Origini che risalgono al Rinascimento (1350-1550); ricchi Signori collezionavano pietre, spugne, conchiglie, ossa di animali acquatici, ecc Periodo del paesaggismo inglese
LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
Francesco Comiti! Facoltà di Scienze e Tecnologie! Libera Università di Bolzano
 Processi erosivi ed evoluzione dei corsi d acqua nel contesto dei cambiamenti climatici Prad am Stilfser Joch - Prato allo Stelvio 19.06.2015 Francesco Comiti Facoltà di Scienze e Tecnologie Libera Università
Processi erosivi ed evoluzione dei corsi d acqua nel contesto dei cambiamenti climatici Prad am Stilfser Joch - Prato allo Stelvio 19.06.2015 Francesco Comiti Facoltà di Scienze e Tecnologie Libera Università
IL PIANETA MARTE E LA SUA EVOLUZIONE CLIMATICA
 Università del Salento IL PIANETA MARTE E LA SUA EVOLUZIONE CLIMATICA Vincenzo Orofino Gruppo di Astrofisica Marte osservato dall Hubble Space Telescope La superficie di Marte ripresa dal MER03 Spirit
Università del Salento IL PIANETA MARTE E LA SUA EVOLUZIONE CLIMATICA Vincenzo Orofino Gruppo di Astrofisica Marte osservato dall Hubble Space Telescope La superficie di Marte ripresa dal MER03 Spirit
STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA
 STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA La Terra è schiacciata ai poli e rigonfia all'equatore a causa della sua rotazione (ellissoide di rotazione). Il raggio equatoriale misura 6.378 km. Il raggio polare misura
STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA La Terra è schiacciata ai poli e rigonfia all'equatore a causa della sua rotazione (ellissoide di rotazione). Il raggio equatoriale misura 6.378 km. Il raggio polare misura
LE NUVOLE BREVE INTRODUZIONE
 LE NUVOLE BREVE INTRODUZIONE DEFINIZIONE Ammasso di goccioline d acqua o di minuscoli cristalli di ghiaccio in sospensione nell aria, di spessore e densità tali da impedire più o meno la vista del cielo,
LE NUVOLE BREVE INTRODUZIONE DEFINIZIONE Ammasso di goccioline d acqua o di minuscoli cristalli di ghiaccio in sospensione nell aria, di spessore e densità tali da impedire più o meno la vista del cielo,
climaticamente questa vasta area ed eventualmente verificare se sono stati registrati cambiamenti significativi degli stessi
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE UMIDE CON ESTATE CALDA Introduzione Con questo articolo inauguriamo una rassegna sui climi italiani iniziando da quelli identificati, nella convenzione internazionale,
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE UMIDE CON ESTATE CALDA Introduzione Con questo articolo inauguriamo una rassegna sui climi italiani iniziando da quelli identificati, nella convenzione internazionale,
Un processo morfogenetico è un particolare meccanismo attraverso il quale un agente morfogenetico riesce a creare o modificare forme e depositi.
 Un agente morfogenetico è un fenomeno fisico e/o chimico che, attraverso l attivazione di meccanismi caratteristici, può generare o modificare le forme del rilevo e/o le caratteristiche dei depositi (morfogenesi).
Un agente morfogenetico è un fenomeno fisico e/o chimico che, attraverso l attivazione di meccanismi caratteristici, può generare o modificare le forme del rilevo e/o le caratteristiche dei depositi (morfogenesi).
IL SUOLO. La natura è un artista capace di modellare rocce e montagne nelle forme piu strane.
 La natura è un artista capace di modellare rocce e montagne nelle forme piu strane. Esistono vari tipi di suolo. Questo, che sicuramente riconoscerai, è formato da tanti piccoli e finissimi granellini
La natura è un artista capace di modellare rocce e montagne nelle forme piu strane. Esistono vari tipi di suolo. Questo, che sicuramente riconoscerai, è formato da tanti piccoli e finissimi granellini
INDAGINI GEO-ELETTRICHE
 INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
4 FORZE FONDAMENTALI
 FORZA 4! QUANTE FORZE? IN NATURA POSSONO ESSERE OSSERVATE TANTE TIPOLOGIE DI FORZE DIVERSE: GRAVITA' O PESO, LA FORZA CHE SI ESERCITA TRA DUE MAGNETI O TRA DUE CORPI CARICHI, LA FORZA DEL VENTO O DELL'ACQUA
FORZA 4! QUANTE FORZE? IN NATURA POSSONO ESSERE OSSERVATE TANTE TIPOLOGIE DI FORZE DIVERSE: GRAVITA' O PESO, LA FORZA CHE SI ESERCITA TRA DUE MAGNETI O TRA DUE CORPI CARICHI, LA FORZA DEL VENTO O DELL'ACQUA
Lab10 Leggere il paesaggio
 SCIENZE Laboratorio natura Lab10 Leggere il paesaggio Quando guardi fuori dalla finestra, mentre viaggi o mentre cammini durante una gita, vedi senz altro il paesaggio intorno a te. Ma tra vedere, osservare
SCIENZE Laboratorio natura Lab10 Leggere il paesaggio Quando guardi fuori dalla finestra, mentre viaggi o mentre cammini durante una gita, vedi senz altro il paesaggio intorno a te. Ma tra vedere, osservare
Gli habitat. Scuola primaria (4^-5^) e secondaria di 1 o grado
 Gli habitat Scuola primaria (4^-5^) e secondaria di 1 o grado Che cos è un habitat? Un habitat è un ambiente che presenta condizioni adatte alla sopravvivenza di determinati animali. Esso costituisce la
Gli habitat Scuola primaria (4^-5^) e secondaria di 1 o grado Che cos è un habitat? Un habitat è un ambiente che presenta condizioni adatte alla sopravvivenza di determinati animali. Esso costituisce la
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
3 - Tettonica delle placche crostali: una teoria globale
 3 - Tettonica delle placche crostali: una teoria globale Tettonica delle placche crostali Concetto fondamentale delle Scienze della Terra Risultato dell integrazione di molte discipline Basata su considerazioni
3 - Tettonica delle placche crostali: una teoria globale Tettonica delle placche crostali Concetto fondamentale delle Scienze della Terra Risultato dell integrazione di molte discipline Basata su considerazioni
Un terremoto o sisma (dal latino terrae motus - movimento della terra) è una vibrazione del terreno causata da una liberazione di energia.
 Un terremoto o sisma (dal latino terrae motus - movimento della terra) è una vibrazione del terreno causata da una liberazione di energia. La liberazione di energia si verifica in seguito alla frattura
Un terremoto o sisma (dal latino terrae motus - movimento della terra) è una vibrazione del terreno causata da una liberazione di energia. La liberazione di energia si verifica in seguito alla frattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH)
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH) CURRICOLO A.S. 2012-1013 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE TRAGUARDI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH) CURRICOLO A.S. 2012-1013 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE TRAGUARDI
L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando:
 L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando: 1) laghi 2) fiumi 3) falde acquifere LE FALDE ACQUIFERE L'acqua penetra nel terreno
L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando: 1) laghi 2) fiumi 3) falde acquifere LE FALDE ACQUIFERE L'acqua penetra nel terreno
CAI S.Donà e Treviso Scuole Alpinismo e Scialpinismo
 CAI S.Donà e Treviso Scuole Alpinismo e Scialpinismo La Neve 2 La Neve L organizzazione mondiale della meteorologia ha stabilito 10 forme principali, tra le più comuni: 3 Il manto nevoso Il manto nevoso
CAI S.Donà e Treviso Scuole Alpinismo e Scialpinismo La Neve 2 La Neve L organizzazione mondiale della meteorologia ha stabilito 10 forme principali, tra le più comuni: 3 Il manto nevoso Il manto nevoso
Il legno legno scorza cilindro centrale corteccia epidermide libro legno cambio
 Il legno Comunemente si indica come legno la parte del fusto degli alberi che si trova sotto la cosiddetta scorza (comunemente detta corteccia). Nel 1 anno di vita del fusto si distingue una zona a funzione
Il legno Comunemente si indica come legno la parte del fusto degli alberi che si trova sotto la cosiddetta scorza (comunemente detta corteccia). Nel 1 anno di vita del fusto si distingue una zona a funzione
Caduta di un corpo in un fluido
 Come si muove un oggetto che cade in un fluido (acqua e sapone)? 1. Prendiamo delle sferette identiche tra loro e le lasciamo cadere all interno di un cilindro pieno di un fluido, ad esempio acqua e sapone...
Come si muove un oggetto che cade in un fluido (acqua e sapone)? 1. Prendiamo delle sferette identiche tra loro e le lasciamo cadere all interno di un cilindro pieno di un fluido, ad esempio acqua e sapone...
PERCEZIONE DEL TERRITORIO
 5.2 PERCEZIONE DEL TERRITORIO Di seguito viene proposta l identificazione del comune attraverso visuali di foto aeree, che ne riportano la reale conformazione fisica, e attraverso ricostruzioni tridimensionali
5.2 PERCEZIONE DEL TERRITORIO Di seguito viene proposta l identificazione del comune attraverso visuali di foto aeree, che ne riportano la reale conformazione fisica, e attraverso ricostruzioni tridimensionali
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI
 SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
Reggio Emilia, Parco Nazionale dell Appennino Tosco-Emiliano Via Comunale, Sassalbo di Fivizzano (MS)
 GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
1. Le stelle. corpi celesti di forma sferica. costituite da gas (idrogeno ed elio)
 LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
STORIA DELLA TERRA E SUE DINAMICHE
 STORIA DELLA TERRA E SUE DINAMICHE Una delle teorie più accreditate afferma che la Terra nasce da una nube di gas e polveri che ruota intorno al disco solare in formazione. Possiamo distinguere alcune
STORIA DELLA TERRA E SUE DINAMICHE Una delle teorie più accreditate afferma che la Terra nasce da una nube di gas e polveri che ruota intorno al disco solare in formazione. Possiamo distinguere alcune
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA
 RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
I movimenti e la struttura della terra
 I movimenti e la struttura della terra è un pianeta che appartiene al Sistema solare, infatti, è costituito da una stella: il Sole ed ha come satellite la Luna. è costituita da: La crosta Parte esterna
I movimenti e la struttura della terra è un pianeta che appartiene al Sistema solare, infatti, è costituito da una stella: il Sole ed ha come satellite la Luna. è costituita da: La crosta Parte esterna
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
A scala del mezzo poroso
 C È ACQUA E ACQUA!! A scala del mezzo poroso Acqua pellicolare Acqua capillare Argilla { Tavola { d acqua Zona satura Zona non satura A scala dell acquifero Piano campagna Zona vadosa Frangia capillare
C È ACQUA E ACQUA!! A scala del mezzo poroso Acqua pellicolare Acqua capillare Argilla { Tavola { d acqua Zona satura Zona non satura A scala dell acquifero Piano campagna Zona vadosa Frangia capillare
LEGGI O ASCOLTA IL TESTO POI ORGANIZZA IL CONTENUTO NELLA MAPPA IL LAGO E UNA GRANDE MASSA D'ACQUA DOLCE, RACCOLTA IN UNA CAVITÀ
 LEGGI O ASCOLTA IL TESTO POI ORGANIZZA IL CONTENUTO NELLA MAPPA IL LAGO E UNA GRANDE MASSA D'ACQUA DOLCE, RACCOLTA IN UNA CAVITÀ DELLA TERRA. E ALIMENTATO DA FIUMI CHIAMATI IMMISSARI, DA SORGENTI, DA GHIACCIAI
LEGGI O ASCOLTA IL TESTO POI ORGANIZZA IL CONTENUTO NELLA MAPPA IL LAGO E UNA GRANDE MASSA D'ACQUA DOLCE, RACCOLTA IN UNA CAVITÀ DELLA TERRA. E ALIMENTATO DA FIUMI CHIAMATI IMMISSARI, DA SORGENTI, DA GHIACCIAI
Il LAMBRO è un FIUME non è un TORRENTE
 Il LAMBRO è un FIUME non è un TORRENTE Il fiume è un corso d acqua a regime perenne, non secca mai, scorre di solito in superficie, ma può scorrere anche sotterraneo, può essere alimentato da: 1) falde
Il LAMBRO è un FIUME non è un TORRENTE Il fiume è un corso d acqua a regime perenne, non secca mai, scorre di solito in superficie, ma può scorrere anche sotterraneo, può essere alimentato da: 1) falde
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica
 Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica A cura di: Fabrizio Berra, Daria Mazzoccola, Enrico Sciesa, Dario Sciunnach con la collaborazione di Simonetta De Donatis e Nicola la Rovere
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica A cura di: Fabrizio Berra, Daria Mazzoccola, Enrico Sciesa, Dario Sciunnach con la collaborazione di Simonetta De Donatis e Nicola la Rovere
GEOMORFOLOGIA GLACIALE
 Stage didattico Ventina 2013 GEOMORFOLOGIA GLACIALE Francesca.ferrario@uninsubria.it Riferimenti G.B. Castiglioni, Geomorfologia. Utet, 1989. M. Panizza, Manuale di geomorfologia applicata. Ed. Angeli,
Stage didattico Ventina 2013 GEOMORFOLOGIA GLACIALE Francesca.ferrario@uninsubria.it Riferimenti G.B. Castiglioni, Geomorfologia. Utet, 1989. M. Panizza, Manuale di geomorfologia applicata. Ed. Angeli,
MASSE D ARIA E FRONTI. Prof.ssa C. Agizza
 MASSE D ARIA E FRONTI Prof.ssa C. Agizza 1 Porzione limitata di atmosfera. Si può estendere verticalmente fino al limite della troposfera. Massa d aria Caratterizzata da temperatura e umidità. Può coprire
MASSE D ARIA E FRONTI Prof.ssa C. Agizza 1 Porzione limitata di atmosfera. Si può estendere verticalmente fino al limite della troposfera. Massa d aria Caratterizzata da temperatura e umidità. Può coprire
CAI Milano Scuola di Scialpinismo MARIO RIGHINI
 Fronte caldo L aria calda, scorrendo sulla superficie frontale, si alza, si raffredda, condensa e dà luogo a precipitazioni estese generalmente non molto intense. Queste sono annunciate dalla presenza
Fronte caldo L aria calda, scorrendo sulla superficie frontale, si alza, si raffredda, condensa e dà luogo a precipitazioni estese generalmente non molto intense. Queste sono annunciate dalla presenza
TERMODINAMICA. Studia le trasformazioni dei sistemi in relazione agli scambi di calore e lavoro. GENERALITÀ SUI SISTEMI TERMODINAMICI
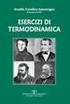 TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
SCIENZE. La formazione delle rocce metamorfiche. Tipi di metamorfismo. il testo:
 01 Ad alte temperature e/o alte pressioni le rocce possono cambiare: la loro struttura (cioè come sono messi i minerali all interno delle rocce); la loro composizione mineralogica (cioè il tipo di minerali
01 Ad alte temperature e/o alte pressioni le rocce possono cambiare: la loro struttura (cioè come sono messi i minerali all interno delle rocce); la loro composizione mineralogica (cioè il tipo di minerali
La velocità. Isabella Soletta - Liceo Fermi Documento riadattato da MyZanichelli.it
 La velocità Isabella Soletta - Liceo Fermi Documento riadattato da MyZanichelli.it Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare con materiali o strumenti presenti nel nostro laboratorio
La velocità Isabella Soletta - Liceo Fermi Documento riadattato da MyZanichelli.it Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare con materiali o strumenti presenti nel nostro laboratorio
L EROSIONE (osservando la Sardegna)
 Scuola Secondaria di I Grado G. Bearzi Udine Volpetti Francesca - II B Ricerca di scienze L EROSIONE (osservando la Sardegna) Erosione L erosione è l insieme di processi naturali, fisici e chimici attraverso
Scuola Secondaria di I Grado G. Bearzi Udine Volpetti Francesca - II B Ricerca di scienze L EROSIONE (osservando la Sardegna) Erosione L erosione è l insieme di processi naturali, fisici e chimici attraverso
20 Corso SA Scuola Intersezionale di Alpinismo e Scialpinismo Valle dell Adda
 20 Corso SA1 2011 - Scuola Intersezionale di Alpinismo e Scialpinismo Valle dell Adda Introduzione Gli scialpinisti rappresentano quasi il 50 % delle vittime da valanga La conoscenza del manto nevoso e
20 Corso SA1 2011 - Scuola Intersezionale di Alpinismo e Scialpinismo Valle dell Adda Introduzione Gli scialpinisti rappresentano quasi il 50 % delle vittime da valanga La conoscenza del manto nevoso e
Facoltà di Farmacia - Anno Accademico A 18 febbraio 2010 primo esonero
 Facoltà di Farmacia - Anno Accademico 2009-2010 A 18 febbraio 2010 primo esonero Corso di Laurea: Laurea Specialistica in FARMACIA Nome: Cognome: Matricola Aula: Canale: Docente: Riportare sul presente
Facoltà di Farmacia - Anno Accademico 2009-2010 A 18 febbraio 2010 primo esonero Corso di Laurea: Laurea Specialistica in FARMACIA Nome: Cognome: Matricola Aula: Canale: Docente: Riportare sul presente
I fiumi e i laghi. Mondadori Education
 I fiumi e i laghi L Italia è un paese ricco di fiumi e laghi. I fiumi possono essere alpini e appenninici. I primi hanno una portata regolare, cioè trasportano per tutto l anno una quantità d acqua costante,
I fiumi e i laghi L Italia è un paese ricco di fiumi e laghi. I fiumi possono essere alpini e appenninici. I primi hanno una portata regolare, cioè trasportano per tutto l anno una quantità d acqua costante,
Decomposizione e biomi di Laura Cassata
 Decomposizione e biomi di Laura Cassata Autore Laura Cassata Referente scientifico Michela Mayer Grado scolastico Scuola Secondaria di I grado Percorso collegato La vita in un pugno di terra Nucleo Leggere
Decomposizione e biomi di Laura Cassata Autore Laura Cassata Referente scientifico Michela Mayer Grado scolastico Scuola Secondaria di I grado Percorso collegato La vita in un pugno di terra Nucleo Leggere
Sulla Terra possiamo distinguere quattro parti strettamente connesse tra loro: 1. idrosfera 2. atmosfera 3. litosfera 4. biosfera Possiamo definire
 IL SISTEMA TERRA Sulla Terra possiamo distinguere quattro parti strettamente connesse tra loro: 1. idrosfera 2. atmosfera 3. litosfera 4. biosfera Possiamo definire la Terra un sistema, cioè un insieme
IL SISTEMA TERRA Sulla Terra possiamo distinguere quattro parti strettamente connesse tra loro: 1. idrosfera 2. atmosfera 3. litosfera 4. biosfera Possiamo definire la Terra un sistema, cioè un insieme
Geologo Andrea Dignani ANALISI DELLA LINEA DI COSTA DI PORTONOVO (ANCONA)
 Geologo Andrea Dignani ANALISI DELLA LINEA DI COSTA DI PORTONOVO (ANCONA) APAT 2007 Una falesia attiva subisce una degradazione fisica, che comporta la frantumazione delle rocce avviene, per mezzo dei
Geologo Andrea Dignani ANALISI DELLA LINEA DI COSTA DI PORTONOVO (ANCONA) APAT 2007 Una falesia attiva subisce una degradazione fisica, che comporta la frantumazione delle rocce avviene, per mezzo dei
La sorgente è il punto dove nasce il fiume e di solito si trova in montagna.
 I fiumi e i laghi Il fiume I fiumi sono corsi d acqua di grandi dimensioni e perenni, cioè non sono mai completamente asciutti. I ruscelli sono corsi d acqua di piccole dimensioni. I torrenti sono corsi
I fiumi e i laghi Il fiume I fiumi sono corsi d acqua di grandi dimensioni e perenni, cioè non sono mai completamente asciutti. I ruscelli sono corsi d acqua di piccole dimensioni. I torrenti sono corsi
Impatti dei cambiamenti climatici nella Provincia di Torino
 CRES - Climaresilienti II INCONTRO: Misure di adattamento ai cambiamenti climatici Impatti dei cambiamenti climatici nella Provincia di Torino Rilvevanza per la vostra regione (1=interesse elevato, 2=importante,
CRES - Climaresilienti II INCONTRO: Misure di adattamento ai cambiamenti climatici Impatti dei cambiamenti climatici nella Provincia di Torino Rilvevanza per la vostra regione (1=interesse elevato, 2=importante,
m = 53, g L = 1,4 m r = 25 cm
 Un pendolo conico è formato da un sassolino di 53 g attaccato ad un filo lungo 1,4 m. Il sassolino gira lungo una circonferenza di raggio uguale 25 cm. Qual è: (a) la velocità del sassolino; (b) la sua
Un pendolo conico è formato da un sassolino di 53 g attaccato ad un filo lungo 1,4 m. Il sassolino gira lungo una circonferenza di raggio uguale 25 cm. Qual è: (a) la velocità del sassolino; (b) la sua
Erickson. Cosa studia la geografia, gli spazi terrestri e gli spazi acquatici. Scuola primaria. Carlo Scataglini. Collana diretta da Dario Ianes
 Strumenti per la didattica, l educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno Collana diretta da Dario Ianes Carlo Scataglini GEOGRAFIA facile per la classe TERZA Cosa studia la geografia, gli
Strumenti per la didattica, l educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno Collana diretta da Dario Ianes Carlo Scataglini GEOGRAFIA facile per la classe TERZA Cosa studia la geografia, gli
Morfologia, attività e classificazione dei vulcani
 Capitolo 4B I vulcani Lezione 9B Morfologia, attività e classificazione dei vulcani Alfonso Bosellini Le scienze della Terra. Minerali, rocce, vulcani, terremoti Italo Bovolenta editore 2014 1 4.1 Definizioni
Capitolo 4B I vulcani Lezione 9B Morfologia, attività e classificazione dei vulcani Alfonso Bosellini Le scienze della Terra. Minerali, rocce, vulcani, terremoti Italo Bovolenta editore 2014 1 4.1 Definizioni
Capitolo 1 : CENNI SULL ANALISI TECNICA
 Capitolo 1 : CENNI SULL ANALISI TECNICA 1.1 INTRODUZIONE L analisi tecnica è uno strumento utilizzato dagli operatori borsistici per cercare di prevedere l andamento del corso dei titoli trattati. Volendo
Capitolo 1 : CENNI SULL ANALISI TECNICA 1.1 INTRODUZIONE L analisi tecnica è uno strumento utilizzato dagli operatori borsistici per cercare di prevedere l andamento del corso dei titoli trattati. Volendo
PRIMI ELEMENTI DI TERMODINAMICA. La termodinamica studia le leggi con cui i sistemi scambiano (cedono e ricevono) energia con l ambiente.
 PRIMI ELEMENTI DI TERMODINAMICA Un sistema è un insieme di corpi che possiamo immaginare avvolti da una superficie chiusa, ma permeabile alla materia e all energia. L ambiente è tutto ciò che si trova
PRIMI ELEMENTI DI TERMODINAMICA Un sistema è un insieme di corpi che possiamo immaginare avvolti da una superficie chiusa, ma permeabile alla materia e all energia. L ambiente è tutto ciò che si trova
Ghiacciaio Ciardoney: nuova stazione meteorologica e rinnovo delle paline ablatometriche
 Ghiacciaio Ciardoney: nuova stazione meteorologica e rinnovo delle paline ablatometriche Luca Mercalli, Daniele Cat Berro Società Meteorologica Italiana Giovanni Mortara CNR-IRPI, Torino Giovanni Badino
Ghiacciaio Ciardoney: nuova stazione meteorologica e rinnovo delle paline ablatometriche Luca Mercalli, Daniele Cat Berro Società Meteorologica Italiana Giovanni Mortara CNR-IRPI, Torino Giovanni Badino
Unità 8 - Il clima e le sue variazioni
 1 1. I climi del pianeta: le fasce climatiche Nella Terra si distinguono in base alla latitudine: 5 GRANDI FASCE CLIMATICHE delimitate da isoterme 1 FASCIA CALDA TROPICALE 2 FASCE TEMPERATE 2 FASCE FREDDE
1 1. I climi del pianeta: le fasce climatiche Nella Terra si distinguono in base alla latitudine: 5 GRANDI FASCE CLIMATICHE delimitate da isoterme 1 FASCIA CALDA TROPICALE 2 FASCE TEMPERATE 2 FASCE FREDDE
SOLE, struttura e fenomeni
 SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
GLI IDROCARBURI. Gli idrocarburi sono sostanze organiche formate da molecole di idrogeno e carbonio. Sono idrocarburi il PETROLIO e il METANO
 GLI IDROCARBURI Gli idrocarburi sono sostanze organiche formate da molecole di idrogeno e carbonio. Idrogeno Carbonio Sono idrocarburi il PETROLIO e il METANO molecola del metano GLI IDROCARBURI: FORMAZIONE
GLI IDROCARBURI Gli idrocarburi sono sostanze organiche formate da molecole di idrogeno e carbonio. Idrogeno Carbonio Sono idrocarburi il PETROLIO e il METANO molecola del metano GLI IDROCARBURI: FORMAZIONE
VALUTAZIONE DEL CARICO TERMICO
 VALUTAZIONE DEL CARICO TERMICO Le industrie petrolifere (raffinerie), metallurgiche, chimiche ecc. producono un cascame di calore che viene smaltito nelle acque dei fiumi, dei laghi o dei mari (acque di
VALUTAZIONE DEL CARICO TERMICO Le industrie petrolifere (raffinerie), metallurgiche, chimiche ecc. producono un cascame di calore che viene smaltito nelle acque dei fiumi, dei laghi o dei mari (acque di
I terremoti in Italia
 I TERREMOTI I terremoti in Italia Data Intensità (scala Mercalli) Magnitudo Regione Note 8 settembre 1905 X 6.8 Calabria 557 vittime, 300.000 senzatetto 28 dicembre 1908 XI 7.1 Calabro-Messinese Circa
I TERREMOTI I terremoti in Italia Data Intensità (scala Mercalli) Magnitudo Regione Note 8 settembre 1905 X 6.8 Calabria 557 vittime, 300.000 senzatetto 28 dicembre 1908 XI 7.1 Calabro-Messinese Circa
1 di 5 12/02/ :23
 Verifica: tibo5794_me08_test1 nome: classe: data: Esercizio 1. La traiettoria di un proiettile lanciato con velocità orizzontale da una certa altezza è: un segmento di retta obliqua percorso con accelerazione
Verifica: tibo5794_me08_test1 nome: classe: data: Esercizio 1. La traiettoria di un proiettile lanciato con velocità orizzontale da una certa altezza è: un segmento di retta obliqua percorso con accelerazione
Capitolo 6 Rilevamento geologico
 Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª)
 SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª) scientifico. all ambiente. Osservare e descrivere i cambiamenti della natura in rapporto al trascorrere delle stagioni. Analizzare oggetti e coglierne le principali
SCUOLA PRIMARIA SCIENZE (Classe 1ª) scientifico. all ambiente. Osservare e descrivere i cambiamenti della natura in rapporto al trascorrere delle stagioni. Analizzare oggetti e coglierne le principali
9. La morena. Il fianco destro orografico della Val Martello (carta geologica 2) 8. Le strie glaciali
 Il fianco destro orografico della Val Martello (carta geologica 2) 8. Le strie glaciali L azione erosiva del ghiacciaio, in senso stretto, viene indicata con il termine esarazione; una delle forme caratteristiche
Il fianco destro orografico della Val Martello (carta geologica 2) 8. Le strie glaciali L azione erosiva del ghiacciaio, in senso stretto, viene indicata con il termine esarazione; una delle forme caratteristiche
Energia geotermica. Energia Calore
 Energia geotermica Energia Calore Tutte le energie Meccanica Radiante o elettromagnetica Termica Potenziale Cinetica Chimica Elettrica Nucleare L energia è una proprietà della materia; essa si evidenzia
Energia geotermica Energia Calore Tutte le energie Meccanica Radiante o elettromagnetica Termica Potenziale Cinetica Chimica Elettrica Nucleare L energia è una proprietà della materia; essa si evidenzia
Analisi radar e GPS per lo studio dei ghiacciai Alpini
 Analisi radar e GPS per lo studio dei ghiacciai Alpini F.Villa(¹),, M.DeAmicis(¹),, S.Sironi(¹),, V.Maggi(¹), A.Tamburini(²) (²), G.Rossi(³) fabio.villa@unimib.it (¹)Università degli Studi di Milano -
Analisi radar e GPS per lo studio dei ghiacciai Alpini F.Villa(¹),, M.DeAmicis(¹),, S.Sironi(¹),, V.Maggi(¹), A.Tamburini(²) (²), G.Rossi(³) fabio.villa@unimib.it (¹)Università degli Studi di Milano -
Progetto di scienze Pasquale,Gennaro e Nicola
 Progetto di scienze Pasquale,Gennaro e Nicola CHE COS E IL MAGNETISMO Magnetismo Classe di fenomeni generati da cariche elettriche in movimento. Mentre una carica ferma genera intorno a sé un campo puramente
Progetto di scienze Pasquale,Gennaro e Nicola CHE COS E IL MAGNETISMO Magnetismo Classe di fenomeni generati da cariche elettriche in movimento. Mentre una carica ferma genera intorno a sé un campo puramente
CORSO DI METEOROLOGIA GENERALE E AERONAUTICA 6 - Le Correnti a Getto
 CORSO DI METEOROLOGIA GENERALE E AERONAUTICA 6 - DEFINIZIONE - ANALISI - GETTO POLARE GETTI A BASSA QUOTA - GETTO SUBTROPICALE GETTO TROPICALE DA EST C.A.T. - CLEAR AIR TURBULENCE Dr. Marco Tadini meteorologo
CORSO DI METEOROLOGIA GENERALE E AERONAUTICA 6 - DEFINIZIONE - ANALISI - GETTO POLARE GETTI A BASSA QUOTA - GETTO SUBTROPICALE GETTO TROPICALE DA EST C.A.T. - CLEAR AIR TURBULENCE Dr. Marco Tadini meteorologo
Corso di Idraulica Agraria ed Impianti Irrigui
 Corso di Idraulica graria ed Impianti Irrigui Docente: Ing. Demetrio ntonio Zema Lezione n. 8: Foronomia nno ccademico 2011-2012 2012 1 Generalità La foronomia studia l'efflusso di una corrente liquida
Corso di Idraulica graria ed Impianti Irrigui Docente: Ing. Demetrio ntonio Zema Lezione n. 8: Foronomia nno ccademico 2011-2012 2012 1 Generalità La foronomia studia l'efflusso di una corrente liquida
Dalla meteorologia alla climatologia (un excursus sui cambiamenti climatici)
 23 marzo 2015, Giornata Mondiale della Meteorologia Cambiamenti Climatici: capire per agire Dalla meteorologia alla climatologia (un excursus sui cambiamenti climatici) a cura di Alessandro M. S. Delitala
23 marzo 2015, Giornata Mondiale della Meteorologia Cambiamenti Climatici: capire per agire Dalla meteorologia alla climatologia (un excursus sui cambiamenti climatici) a cura di Alessandro M. S. Delitala
Laboratorio FISICA. La direzione della forza di gravità. Hai bisogno di: filo a piombo; asta di sostegno; cartoncino.
 La direzione della forza di gravità Hai bisogno di: filo a piombo; asta di sostegno; cartoncino. la forza di gravità è diretta verso il centro della Terra; il filo a piombo si dispone secondo la verticale
La direzione della forza di gravità Hai bisogno di: filo a piombo; asta di sostegno; cartoncino. la forza di gravità è diretta verso il centro della Terra; il filo a piombo si dispone secondo la verticale
