Novitas e dialettica del desiderio
|
|
|
- Leonzia Dorotea Calo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Novitas e dialettica del desiderio RAFFAELE PINTO Universitat de Barcelona Societat Catalana d Estudis Dantescos 1. Sebbene il campo semantico della 'novità' (al quale mi riferisco con il latinismo novitas) abbia in Dante una estensione, come si vedrà, estremamente ampia, la ricerca si è finora concentrata sui significati che si riferiscono immediatamente alla letteratura e ai suoi procedimenti, di tipo poetico (la novità che per tua forma luce di Amor tu vedi ben, la nuova matera di V.N. XVII, le nove rime di Purg. XXIV etc.) o teologico (il canticum novum della Scrittura e dei suoi commentatori). La novitas dantesca è stata così spiegata come la svolta che sul piano storiografico una certa poetica rappresenta rispetto alla tradizione, oppure come il rinnovamento interiore promosso da una esperienza mistica dell'amore. Con l'analisi che segue mi propongo di dimostrare che tale concetto viene inteso da Dante in un senso innanzitutto estetico, che afferisce al sistema percettivo e categoriale della mente, ed a processi psichici originari, anteriori all'attività letteraria ed al contenuto ideologico che eventualmente la orienta. Descriverò quindi una poetica dantesca della novitas, ma intendendo 'poetica' in un senso antropologico che non ha inizialmente nulla a che vedere con la nozione retorica (o religiosa) di poesia. Per avere subito un idea delle implicazioni estetico-trascendentali del concetto di novitas, possiamo partire da Par. XXIX 76-81: Queste sustanze, poi che fur gioconde de la faccia di Dio, non volser viso da essa, da cui nulla si nasconde: 193
2 Tenzone nº però non hanno vedere interciso da novo obietto, e però non bisogna rememorar per concetto diviso, (passaggio utilmente integrabile con Purg. X, 94-95: Colui che mai non vide cosa nova produsse esto visibile parlare, novello a noi perché qui non si trova ). Il tema svolto qui è quello del tipo di conoscenza che hanno gli angeli, se essi dispongano cioè di memoria, e se il loro sapere si distenda nel tempo. A differenza di Tommaso, il quale, riprendendo la tesi di Agostino, ammette che nella mente angelica esiste un certo tipo di memoria ("Est igitur in intellectu substantiae separatae quaedam intelligentiarum successio" 1 ), e allineato con Aristotele e Averroè, Dante sostiene che gli angeli (o sostanze separate) non hanno memoria perché, mantenendo il loro sguardo sempre diretto verso Dio, nel quale la realtà e l universo sono eternamente e sincronicamente dispiegati, non ne hanno bisogno. Non essendoci immagini materiali né pieghe di temporalità nell oggetto della loro intellezione (che è il reale in quanto si riflette sulla "faccia di Dio"), sarebbe superflua una funzione memorativa 2. Si osservi ora il senso che ha il sintagma novo obietto all interno dell argomentazione complessiva: la visione divina degli angeli è costante perché non viene intercisa, cioè interrotta, da oggetti nuovi e diversi. D'altra parte Dio è definito (in Purg. X, 94) come "Colui che mai non vide cosa nova", ed è appunto questo panorama sinottico del tempo, dall'osservatorio dell'eterno, che si riflette nella visione angelica fissa in Dio. Ciò vuol dire che la 'novità' è caratteristica di chi pensa per sensazioni ed immagini, discontinue per definizione (sono finite), e quindi propria dell'uomo. Proprio perché priva di materia, la percezione degli angeli viene descritta in opposizione a quella umana, la quale è caratterizzata appunto da una visione costantemente intercisa da nuovi obietti, il che rende necessaria una funzione psichica come la memoria, che rappresenta immaginariamente alla mente le cose che non sono 194
3 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio attualmente obietto di percezione. Ecco allora che l aspetto nuovo dell oggetto è immediatamente collegato alla funzione percettiva umana, poiché la sua 'novità' coincide con quella differenza, rispetto ad altri oggetti già noti, che lo rende attualmente presente in quanto stimolo della sensibilità. Noi potremmo anche capovolgere il ragionamento, e dire: la funzione passato, in quanto procedimento di archiviazione dell esperienza attraverso la memoria, è attivata ogni volta che un oggetto presente, cioè 'nuovo', sostituisce l'oggetto della percezione anteriore, trasformandolo in ricordo. La novitas quindi è da una parte la forma percettiva del presente, dall'altra il fattore psichico che attiva la memoria del passato. Relativamente alla memoria degli angeli, Tommaso è, come si è visto, di diversa opinione. E intuiamo immediatamente il motivo di tale posizione osservando la sua argomentazione, svolta in serrata polemica con Averroè, che sulla scia di Aristotele vuole eterni, come il mondo e la specie umana, l'intelletto possibile e quello agente [Contra Gentiles, lib. 2 cap. 73 n ]: 27. Si unus est intellectus possibilis omnium hominum, oportet ponere intellectum possibilem semper fuisse, si homines semper fuerunt, sicut ponunt: et multo magis intellectum agentem, quia agens est honorabilius patiente, ut Aristoteles dicit. Sed si agens est aeternum, et recipiens aeternum, oportet recepta esse aeterna. Ergo species intelligibiles ab aeterno fuerunt in intellectu possibili. Non igitur de novo recipit aliquas species intelligibiles. Ad nihil autem sensus et phantasia sunt necessaria ad intelligendum nisi ut ab eis accipiantur species intelligibiles. Sensus igitur non erit necessarius ad intelligendum, neque phantasia. Et redibit opinio Platonis, quod scientiam non acquirimus per sensus, sed ab eis excitamur ad rememorandum prius scita. Averroè viene qui messo in contraddizione con se stesso, giacché l'eternità dell'intelletto (sia quello agente che quello passivo, quindi l'eternità della razionalità nel suo complesso, necessariamente da postulare se si concepisce eterna la specie umana ed unico per tutti gli uomini l'intelletto) renderebbe inutile la funzione della sensibilità nel 195
4 Tenzone nº processo conoscitivo, che rappresenta il fondamento della gnoseologia aristotelica e dello stesso Averroè, e si cadrebbe nella prospettiva di Platone, per il quale la sensibilità e gli oggetti esterni non hanno altra funzione che quella di suscitare il ricordo di cose già note. Le specie intelligibili non sarebbero, infatti, accolte de novo dall'intelletto, ma da sempre presenti ad esso. 28. Sed ad hoc respondet Commentator praedictus, quod species intelligibiles habent duplex subiectum: ex uno quorum habent aeternitatem, scilicet ab intellectu possibili; ab alio autem habent novitatem, scilicet a phantasmate; sicut etiam speciei visibilis subiectum est duplex, scilicet res extra animam et potentia visiva. Averroè però risponde a questa obiezione che il contenuto delle specie intelligibili è duplice, eterno per ciò che riguarda la considerazione dell'intelletto possibile, e nuovo (quindi materiale e storico) per ciò che riguarda i fantasmi elaborati dalla sensibilità. 29. Haec autem responsio stare non potest. Impossibile enim est quod actio et perfectio aeterni dependeat ab aliquo temporali. Phantasmata autem temporalia sunt, de novo quotidie in nobis facta ex sensu. Impossibile est igitur quod species intelligibiles, quibus intellectus possibilis fit actu et operatur, dependeant a phantasmatibus, sicut species visibilis dependet a rebus quae sunt extra animam. Ma l'obiezione viene rigettata per l'aporia rappresentata da una sostanza intellettuale eterna che dipenderebbe, per la sua perfezione ed attualizzazione, da un elemento temporale come sono i fantasmi, che i sensi producono in noi in modo intermittente, ogni volta di nuovo. Ciò che Tommaso mira ad escludere, negando l'eternità delle intelligenze angeliche ed attribuendo ad esse un certo tipo di memoria, è la dimostrabilità di un mondo e una specie umana coeterni a Dio, che renderebbe privo di senso il principio della creazione ex nihilo (fondamento della teologia giudeo-cristiana, estranea sia ad Aristotele che ad Averroè)
5 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio La temporalità, dunque, è propria dei phantasmata, "de novo quotidie in nobis facta ex sensu", e quindi dell'umano. Se si intendono le intelligenze (e quindi gli angeli) completamente scevre di materia (cioè "puro atto", v. 33 di questo stesso canto), bisogna immaginarle anche prive di novitas, cioè di temporalità 4. L'allineamento di Dante con Averroè, sul problema della conoscenza degli angeli, non è però totale. All'inizio del ragionamento di Beatrice, infatti, nei vv dello stesso canto, il nesso fra novitas e temporalità era stato posto con chiarezza come premessa alla descrizione delle intelligenze angeliche: in sua etternità di tempo fore, fuor d'ogni altro comprender, come i piacque, s'aperse in nuovi amor l'etterno amore. L'idea dei "nuovi amor" esclude preliminarmente l'ipotesi aristotelica (anticreazionista ed averroista) della coeternità del mondo (cioè il mondo, per Dante, non è sempre esistito) 5. Nuovo è quindi tutto ciò che, essendo creato, ha avuto un inizio, come gli angeli e l'universo che essi governano. Il nuovo si oppone all'eterno in quanto situato nel tempo (almeno nell'estremo iniziale della sua esistenza). Da tutto ciò inferiamo che solo a Dio è estranea la nozione di novitas, e che tutte le creature, se colte nell'istante del loro originario affacciarsi all'esistenza, sono nuove. 2. Osserviamo ora un altro aspetto del concetto di novitas, e cioè il suo rapporto negativo con la libertà (Par. VII, 67-72): Ciò che da lei sanza mezzo distilla non ha poi fine, perché non si move la sua imprenta quand'ella sigilla. Ciò che da essa sanza mezzo piove libero è tutto, perché non soggiace a la virtute de le cose nove. Qui Dante distingue fra ciò che è creato direttamente da Dio (ossia le intelligenze celesti, i cieli, la materia prima e l'anima razionale) e ciò che 197
6 Tenzone nº è creato indirettamente da Lui (attraverso le cause seconde), e cioè gli elementi e i loro composti 6. Solo il primo tipo di creature gode dei privilegi della eternità e della libertà, quasi che la caducità delle cose e il loro determinismo siano funzioni direttamente proporzionali alla distanza originaria dal creatore. L'eternità è definita positivamente, in quanto collegata ad una indelebile imprenta divina, mentre la libertà è definita negativamente come indipendenza dalla virtute, cioè il potere informativo, delle cose nove, che sono le intelligenze celesti, cause seconde nella creazione degli esseri, definite "nuovi amor" in Par. XXIX 18. L'anima razionale umana, in quanto creata direttamente da Dio, è eterna e libera, ma in quanto mescolata alla materia, ha perso entrambi gli attributi, e soggiace alla virtute delle cose nove. Si osservi qui come la libertà venga intesa da Dante come autonomia dai condizionamenti del reale. La virtute delle cose nove è appunto la dipendenza della sostanza spirituale da ciò che, appartenendo al tempo, è materiale, e che al soggetto umano si presenta come necessità. Il nesso temporalità - materia - necessità rappresenta l'orizzonte reale e storico rispetto al quale si configura utopicamente la tensione dell'anima umana verso l'eterno - lo spirito - la libertà. Ed è, ancora una volta, la novitas dell'esperienza ciò che traccia l'orizzonte del reale entro il quale si dispiega la eticità del soggetto umano. Ci avviciniamo ulteriormente alla dimensione psichica e quindi antropologica della novitas in Purg. XVIII 19-27: L'animo, ch'è creato ad amar presto, ad ogne cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto è desto. Vostra apprensiva da esser verace tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, sì che l'animo ad essa volger face; e se, rivolto, inver' di lei si piega 7, quel piegare è amor, quell'è natura che per piacer di novo in voi si lega. 198
7 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio Ciò che occorre innanzitutto sottolineare di questo brano, decisivo per intendere la teoria del desiderio, e quindi la poetica, di Dante, è la sua indeducibilità da ogni approccio di tipo platonico-agostiniano al problema della conoscenza. Si osservi nel De Trinitate (X 10 6) la contrapposizione di ogni conoscenza corporea ed esterna (per definizione falsa) a quella spirituale ed interna (l'unica certa e vera): Qui omnes non advertunt, mentem nosse se etiam cum quaerit se, sicut iam ostendimus. Nullo modo autem recte dicitur sciri aliqua res, dum eius ignoratur substantia. Quapropter, dum se mens novit, substantiam suam novit; et cum de se certa est, de substantia sua certa est. Certa est autem de se, sicut convincunt ea quae supra dicta sunt. Nec omnino certa est, utrum aer, an ignis sit, an aliquod corpus, vel aliquid corporis. Non est igitur aliquid eorum. Totumque illud quod se iubetur ut noverit, ad hoc pertinet ut certa sit non se esse aliquid eorum de quibus incerta est, idque solum esse se certa sit, quod solum esse se certa est. Sic enim cogitat ignem aut aerem, et quidquid aliud corporis cogitat. Neque ullo modo fieri posset ut ita cogitaret id quod ipsa est, quemadmodum cogitat, id quod ipsa non est. Per phantasiam quippe imaginariam cogitat haec omnia, sive ignem, sive aerem, sive illud vel illud corpus, partemve illam, seu compaginem temperationemque corporis; nec utique ista omnia, sed aliquid horum esse dicitur. Si quid autem horum esset, aliter id quam cetera cogitaret, non scilicet per imaginale figmentum, sicut cogitantur absentia, quae sensu corporis tacta sunt, sive omnino ipsa, sive eiusdem generis aliqua; sed quadam interiore, non simulata, sed vera praesentia (non enim quidquam illi est se ipsa praesentius); sicut cogitat vivere se, et meminisse, et intellegere, et velle se. Novit enim haec in se, nec imaginatur quasi extra se illa sensu tetigerit, sicut corporalia quaeque tanguntur. Ex quorum cogitationibus si nihil sibi affingat, ut tale aliquid esse se putet, quidquid ei de se remanet, hoc solum ipsa est. Risulta da questo brano che l'interiorità che Agostino considera come sede del vero (nelle sue tre funzioni psichiche di memoria, intelletto e volontà) è intrinsecamente incompatibile con ogni immagine che provenga dall'esterno, e che anzi l'adesione della mente ai corpi, 199
8 Tenzone nº attraverso la sensibilità e la fantasia, ne scalfisce la purezza estetica, che sola le permette di attingere, attraverso un desiderio che è orientato verso se stessa, la conoscenza di sé come sostanza spirituale simile al suo creatore. Tale autocoscienza spirituale è definita come residuale ("quidquid ei de se remanet") rispetto a tutte le rappresentazioni corporali che la mente ha di se stessa. Tutto il contrario è in Dante, che all'interno di un orizzonte epistemico aristotelico-tomista considera come "esser verace" ogni oggetto esterno che stimoli la sensibilità ("vostra apprensiva"), e quindi come naturali e necessari tanto il dispiegarsi della intenzione nella mente (attraverso l'immaginazione e le altre funzioni psichiche che rappresentano internamente la cosa) quanto l'inclinarsi su di essa dell'animo attraverso il desiderio. L'interiorità che ne risulta, lungi dall'essere anestetizzata dal rigetto dei corpi e delle loro immagini, è vitalizzata dalla loro presenza e riempita dal loro significato. Il piacere prodotto dalla cosa nuova (cioè per la prima volta percepita: "piacer di novo") è appunto l'incremento di vita che il reale genera nell'anima umana attraverso l'infinita varietà dei suoi aspetti. La procedura del desiderio in quanto motore dell'agire era stata descritta in Conv. IV xii e in Conv. IV xiii I due passaggi esemplificano nella prassi esistenziale ed intellettuale del soggetto quella funzione di stimolo dell'agire che la novitas, incarnata ogni volta da oggetti diversi, esercita sull'anima, di cui l'amore, inteso come inclinazione generata dal piacere che desta il nuovo oggetto di desiderio, è principio energetico. "Spirito novo" è poi definita l'anima intellettiva, creata direttamente da Dio come i "nuovi amor" di Par. XXIX 18, che assorbe in sé le altre anime dell'embrione fino a farsi "un'alma sola, / che vive e sente e sé in sé rigira" (Purg. XXV 74-75). La modernità radicale di tale tematizzazione estetico-trascendentale della novitas risulterà più chiaramente se si pensa che ad essa è collegato il tema della curiositas, cioè l'attenzione prestata in modo disinteressato a tutto ciò che non rientra nella normalità quotidiana dell'esistenza, e che solo per questo suscita il piacere che muove l'anima 10. La stessa 200
9 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio autocomprensione estetica di Dante si conforma a tale antropologia, come risulta da Purg. X : Li occhi miei, ch'a mirare eran contenti per veder novitadi ond'e' son vaghi... Tommaso aveva perfettamente diagnosticato il legame che esiste tra il piacere e il desiderio da una parte, e lo stupore prodotto da una cosa ignota dall'altra (in una linea di riflessione che sarà ripresa da Cartesio nel Trattato sulle passioni dell'anima) 11. È appunto l'inversione di segno della curiositas (cioè la admiratio che ogni novitas in quanto tale produce nel soggetto) che riorienta in senso moderno l'estetica europea, rendendo obsoleta la diffidenza della cultura antica nei confronti di ogni avventura conoscitiva nel territorio dell'alterità. Si veda in Agostino l'opposizione fra l'apprendere (discere, inteso come sperimentazione intellettuale) e il sapere (noscere, inteso come conoscenza già posseduta), e la condanna parallela della novitas, da una parte, e della curiositas, dall'altra (De vera religione, ): Sed miseri homines, quibus cognita vilescunt, et novitatibus gaudent, libentius discunt quam norunt, cum cognitio sit finis discendi... Quare qui fines ipsos desiderant, prius curiositate carent, cognoscentes eam esse certam cognitionem quae intus est, et ea perfruentes quantum in hac vita queunt 12. Ma ciò che deve essere sottolineato con forza di tale incomprensione della novitas nella cultura antica (ed in particolare platonicoagostiniana), è l'ostilità del sapere, al suo livello più alto, nei confronti della poesia, che per il fatto di essere legata istituzionalmente ai phantasmata e alle loro fictiones è condannata all'ostracismo filosofico proprio nella misura in cui si alimenta di novitates che espongono l'anima al rischio della perdita del controllo razionale di sé. Nella stessa pagina del De vera religione (51 100), le vuote immagini della poesia sono contrapposte alla meditazione della Sacra Scrittura, in una visione dicotomica di corpo e anima, materia e spirito, che riserva la bellezza e lo stupore da essa suscitati al solo mondo invisibile: 201
10 Tenzone nº Omissis igitur et repudiatis nugis theatricis et poeticis, divinarum Scripturarum consideratione et tractatione pascamus animum atque potemus vasae curiositatis fame ac siti fessum et aestuantem, et inanibus phantasmatibus, tamquam pictis epulis, frustra refici satiarique cupientem: hoc vere liberali, et ingenuo ludo salubriter erudiamur. Si nos miracula spectaculorum, et pulchritudo delectat, illam desideremus videre Sapientiam, quae pertendit usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter. Quid enim mirabilius, vi incorporea mundum corporeum fabricante et administrante? aut quid pulchrius ordinante et ornante? 3. È nel quadro concettuale di tale concezione antropologica della novitas che deve quindi essere ricostruito il significato della definizione di poetica di Purg. XXIV 49-57: "Ma dì s'i' veggio qui colui che fore trasse le nove rime, cominciando Donne ch'avete intelletto d'amore". E io a lui: "I' mi son un che, quando Amor mi spira, noto, e a quel modo ch'e' ditta dentro vo significando". "O frate, issa vegg'io", diss'elli, "il nodo che 'l Notaro e Guittone e me ritenne di qua dal dolce stil novo ch'i' odo!". Lungi dal rappresentare semplicemente un modo diverso di fare letteratura, la novitas del "dolce stile" rappresenta la scoperta di una nuova mentalità ed una nuova antropologia, che puntano sul desiderio (l'amore che, suscitato dall'oggetto, spira dentro) per ricostruire la soggettività a partire dalla immanenza del suo stare al mondo, e nella apertura della mente umana agli stimoli del reale (le novità vagheggiate dall'io moderno), che la proiettano verso l'esterno nella vitale avventura della conoscenza dell'altro da sé, di cui la donna come oggetto sublimato e sublimante di desiderio è il paradigma estetico-trascendentale
11 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio La nozione poetico-antropologica di novitas è infatti il punto d'arrivo di una esplorazione ermeneutica condotta inizialmente sul piano delle passioni scatenate dall'eros, e che noi possiamo agevolmente ricostruire nei testi delle Rime e della Vita Nuova. Si osservi l'uso della nozione in Cavalcando l'altr'ier (10-12): e disse: 'Io vegno di lontana parte, ov'era lo tuo cor per mio volere, e recolo a servir novo piacere', e in Io sento sì d'amor la gran possanza (71-74): Io non la vidi tante volte ancora ch'io non trovasse in lei nova bellezza; onde Amor cresce in me la sua grandezza tanto quanto il piacer novo s'aggiugne. Nel primo caso la dialettica del desiderio investe l'esperienza esistenziale attraverso la necessità di superamento dell'oggetto femminile in favore di un nuovo oggetto. È lo stesso procedimento che Dante usa in Voi che intendendo per spiegare il passaggio da Beatrice alla "Donna gentile": Io vi dirò del cor la novitate (etc.). Nel secondo essa si manifesta all'interno della fenomenologia erotica di una stessa donna, che in ogni nuova percezione di essa manifesta all'io una "nova bellezza" che stimola un "piacer novo". Si badi a questa famelica onnipotenza del desiderio, che attraversa e spinge in avanti l'orizzonte dato dell'esperienza sia attraverso nuovi oggetti (donne diverse), sia attraverso forme distinte dello stesso oggetto (aspetti diversi di un'unica donna). La pura sessualità dell'eros viene ovviamente subito bruciata attraverso la sua promozione metafisica e teologica, e anche qui la novitas si impone come prima legge del desiderio. Si veda l'apertura metafisica di I' mi son pargoletta (11-14): Ciascuna stella ne li occhi mi piove del lume suo e de la sua vertute; 203
12 Tenzone nº le mie bellezze sono al mondo nove, però che di là su mi son venute, e i versi di Donne che avete, Dice di lei Amor: "Cosa mortale come esser pò sì adorna e sì pura?" Poi la reguarda, e fra se stesso giura che Dio ne 'ntenda di far cosa nova. In entrambi i casi la giustificazione teologica dell'oggetto di desiderio è resa possibile dalla novitas che accomuna le due donne ai nuovi amor in cui l'eterno amore non cessa di aprirsi ogni volta che interviene direttamente nel mondo creando immediate cioè "sanza mezzo" la creatura, che in questo modo riceve in dono dal creatore qualcosa della sua eternità e della sua libertà. Siamo ormai vicini all'idea di novitas come miracolo, quale appare non solo in sonetti come Tanto gentile ("e par che sia cosa venuta / da cielo in terra a miracol mostrare", versi che spiegano in cosa consista la 'novità' di Beatrice postulata in quelli ora citati di Donne che avete), ma soprattutto nella prosa del capitolo XXIX della Vita Nuova, in cui la novitas di Beatrice viene sillogizzata attraverso la numerologia del nove, che da una parte significa la temporalità delle cose del mondo (in Beatrice il tempo si manifesta come convergenza dei calendari dell'umanità) e dall'altra la miracolosità della sua epifania 14. La novitas di Beatrice (il suo esser nuova ed il suo essere "uno nove") è trascrizione mitica della esegesi erotica della trascendenza, il cui moderno significato consiste nella ricostruzione della soggettività umana attraverso un programma di cooperazione integrata delle sue funzioni psicofisiche (proiettate verso l'eternità sul versante intellettuale, immerse nella temporalità sul versante corporeo). La tensione dell'io in direzione del sacro, infatti, ed il suo conseguente sconfinamento estetico nel territorio della metafisica, vengono attratti nelle procedure normali del desiderio, che contempla il miracolo come il naturale, quotidiano darsi dei suoi oggetti. Comprendiamo bene la lucidità programmatica di questo progetto se accostiamo due accezioni diversissime del 204
13 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio superlativo novissimo, una tradizionalmente scritturale, che afferisce alla fine dei tempi, alla conclusione della storia (individuale o collettiva): Quali i beati al novissimo bando surgeran presti ognun di sua caverna, la revestita voce alleluiando; Purg. XXX l'altra originalmente poetica (e dantesca), che afferisce al radicale rinnovamento esistenziale che il desiderio produce nella soggettività individuale: A che fine ami tu questa tua donna, poi che tu non puoi sostenere la sua presenza? Dilloci, ché certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo... Vita Nuova, XVIII, 3 Bisogna però tener presente che in tale direzione poetico-esistenziale l'ermeneutica della novitas era già stata esperita da Guido Cavalcanti, e sullo stesso terreno ambiguamente sospeso fra sessualità e metafisica che si è visto ora in Dante, ad indicare, in entrambe le prospettive, la radicale trasformazione (e decostruzione) che il desiderio induce nel soggetto umano. Nova è la donna che scatena il desiderio, il piacer che essa suscita, la bellezza con cui seduce il poeta, la persona (cioè il fantasma) che lo ossessiona, la qualità della passione che lo angoscia, lo splendore metafisico che, paradossalmente e nonostante tutto, da lei promana: A me stesso di me pietate vène per la dolente angoscia ch'i' mi veggio: di molta debolezza quand'io seggio, l'anima sento ricoprir di pene. Tutto mi struggo, perch'io sento bene che d'ogni angoscia la mia vita è peggio; la nova donna cu' merzede cheggio questa battaglia di dolor' mantene. A me stesso di me,
14 Tenzone nº Veggio negli occhi de la donna mia un lume pien di spiriti d'amore, che porta uno piacer novo nel core, sì che vi desta d'allegrezza vita. Cosa m'aven, quand'i' le son presente, ch'i' no la posso a lo 'ntelletto dire: veder mi par de la sua labbia uscire una sì bella donna, che la mente comprender no la può, che 'mmantenente ne nasce un'altra di bellezza nova, da la qual par ch'una stella si mova e dica: "La salute tua è apparita". Veggio negli occhi, 1-12 Amor, che nasce di simil piacere, dentro lo cor si posa formando di disio nova persona; Quando di morte mi conven trar vita, La nova - qualità move sospiri, Donna me prega, 50 Posso degli occhi miei novella dire, la qual è tale che piace sì al core che di dolcezza ne sospir'amore. Questo novo plager che 'l meo cor sente fu tratto sol d'una donna veduta, la qual è sì gentil e avenente e tanto adorna, che 'l cor la saluta. Non è la sua biltate canosciuta da gente vile, ché lo suo colore chiama intelletto di troppo valore. Io veggio che negli occhi suoi risplende una vertù d'amor tanto gentile, ch'ogni dolce piacer vi si comprende; e move a loro un'anima sottile, respetto della quale ogn'altra è vile: e non si pò di lei giudicar fore 206
15 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio altro che dir: "Quest'è novo splendore". Posso degli occhi La parodia teologica di Cavalcanti consiste nell'interpretare in chiave pseudo religiosa gli effetti alienanti e distruttivi dell'amore eroico. Fedele alla nozione medica di herois, Guido ne approfondisce e radicalizza i sintomi di malattia fino a farli sconfinare nel territorio ideale del sacro, che il delirio della mente invade con i suoi fantasmi riscrivendone il significato interiore nei termini di un fatale destino di morte cui è preclusa ogni ipotesi di redenzione. La divinità e le sue figure vengono surrogate dalla donna e dalle sue epifanie interiori, che dominano la mente del poeta con un potere letale la cui inflessibilità è parodia del Dio giustiziere e vendicativo del Vecchio Testamento (con l'eccezione di alcune allucinate esperienze visionarie nelle quali il fantasma femminile acquista movenze salvifiche di tipo cristologico). L'analisi sistematica di tali effetti psichicamente devastanti procede al servizio di una lucida demistificazione del mito religioso (cui l'averroismo fornisce solidi fondamenti teorici). In effetti il razionalismo estremo di Guido (quale si manifesta in Donna me prega) è la faccia metaletteraria dell'irrazionalismo erotico che la sua poesia enuncia. In questo modo la percezione, per altro oscura e traumatica, del divino (la novitas, che egli intende come esperienza inaudita che "for di misura - di natura - torna") viene attratta nella dialettica perversa del desiderio, ed è realizzata così, nel contatto parodico delle due ideologie, quella ampia traducibilità di codici e linguaggi che caratterizza in modo così personale la sua poesia (sempre sorprendentemente in equilibrio fra espressione poetica e analisi filosofica). Già potenzialmente miracolosa, la "nova donna" di Guido deduce dalla sintomatologia di herois la sospensione del rapporto fra la mente ed il reale (la sua alienatio), e quindi la frattura del rapporto fra l'io e il mondo. Nasce così, negli anfratti residuali della psiche, nella percezione estrema del proprio essere agonizzante, il moderno soggetto espressivo, slegato dalle cose e dal loro significato, integramente assorbito dalla dolente coscienza di una fragile, eppur irriducibile, individualità, schiacciata da un mondo cui è stato malinconicamente sottratto ogni senso. 207
16 Tenzone nº La nuova transitabilità fra i territori del sacro e del profano (grazie al valore cristologico di cui il fantasma femminile si fa carico) contiene però anche, in modo certo preterintenzionale, la potenziale inversione di segno della novitas (dalla malattia alla salute, dall'averroismo al tomismo), impresa che porterà a termine il suo amico 15. La novità e il miracolo, pienamente integrati nella immanenza dell'umano in quanto moderni motori della sensibilità, divengono per Dante condizioni della fisiologica attività estetica del soggetto, quotidianamente esposto, in ogni momento della sua esistenza, alla seduzione redentiva del femminile e alla avventura espressiva e morale della ricostruzione del senso delle cose e del significato del mondo. 208
17 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio NOTE 1 Contra Gentiles, lib. 2 cap. 101 n. 2. In De Veritate q. 10 a. 2 Tommaso attribuisce all'intelletto la funzione di conservare gli intelligibili non attualmente considerati, e definisce come memoria tutto ciò che non è conosciuto per la prima volta ("omnis notitia non de novo accepta potest dici memoria"). Distingue così fra una considerazione continua dell'intelligibile ("quando consideratio secundum notitiam habitam non est intercisa, sed continua") ed una discontinua ("quando est intercisa"). Si osservi la ripresa, in Dante, del termine tecnico: intercisa. 2 Cfr. Mn. I iii 7: "Essentie tales species quedam sunt intellectuales et non aliud, et earum esse nichil est aliud quam intelligere: quod est sine interpolatione, aliter sempiterne non essent". Anche Tommaso distingue, naturalmente, tra la conoscenza degli angeli e quella degli uomini (S. T. Iª q. 79 a. 8): "Angeli, qui perfecte possident, secundum modum suae naturae, cognitionem intelligibilis veritatis, non habent necesse procedere de uno ad aliud; sed simpliciter et absque discursu veritatem rerum apprehendunt, ut Dionysius dicit, VII cap. de Div. Nom. Homines autem ad intelligibilem veritatem cognoscendam perveniunt, procedendo de uno ad aliud, ut ibidem dicitur, et ideo rationales dicuntur". 3 Sul merito della questione (S. T. Iª q. 46 a. 2: "Videtur quod mundum incoepisse non sit articulus fidei, sed conclusio demonstrabilis") la preoccupazione di Tommaso è piuttosto quella contraria, di dimostrare la indimostrabilità filosofica della "creazione ex nihilo" (che mette seriamente in discussione il meccanicismo dell'universo aristotelico). È chiaro però che qui Tommaso (e l'aristotelismo latino) devono fare i conti con un dogma non razionalizzabile: "Respondeo dicendum quod mundum non semper fuisse, sola fide tenetur, et demonstrative probari non potest, sicut et supra de mysterio Trinitatis dictum est. Et huius ratio est, quia novitas mundi non potest demonstrationem recipere ex parte ipsius mundi. Demonstrationis enim principium est quod quid est. Unumquodque autem, secundum rationem suae speciei, abstrahit ab hic et nunc, propter quod dicitur quod universalia sunt ubique et semper. Unde demonstrari non potest quod homo, aut caelum, aut lapis non semper fuit. Similiter etiam neque ex parte causae agentis, quae agit per voluntatem. Voluntas enim Dei ratione investigari non potest, nisi circa ea quae absolute necesse est Deum velle, talia autem non sunt quae circa creaturas vult, ut dictum est. Potest autem voluntas divina homini manifestari per revelationem, cui fides innititur. Unde mundum incoepisse est credibile, non autem demonstrabile vel scibile. Et hoc utile est ut consideretur, ne forte aliquis, quod fidei est demonstrare praesumens, rationes non necessarias inducat, quae praebeant materiam irridendi infidelibus, existimantibus nos propter huiusmodi rationes credere quae fidei sunt". Si veda anche Super Sent., lib. 2 d. 1 q. 1 a. 5 (sullo stesso problema): "Respondeo dicendum, quod circa hanc quaestionem est triplex positio. Prima est philosophorum, qui dixerunt, quod non solum Deus est ab aeterno, sed etiam aliae res; sed differenter: quia quidam ante Aristotelem posuerunt quod 209
18 Tenzone nº mundus est generabilis et corruptibilis, et quod ita est de toto universo sicut de aliquo particulari alicujus speciei, cujus unum individuum corrumpitur, et aliud generatur. Et haec fuit opinio Empedoclis. Alii dixerunt, quod res fuerunt quiescentes tempore infinito, et per intellectum coeperunt moveri, extrahentem et segregantem unum ab alio. Et haec fuit opinio Anaxagorae. Alii dixerunt, quod res ab aeterno movebantur motu inordinato, et postea reductae sunt ad ordinem, vel casu, sicut ponit Democritus, quod corpora indivisibilia ex se mobilia casu adunata sunt ad invicem, vel a creatore, et hoc ponit Plato, ut dicitur in 3 caeli et mundi. Alii dixerunt, quia res fuerunt ab aeterno secundum illum ordinem quo modo sunt; et ista est opinio Aristotelis, et omnium philosophorum sequentium ipsum; et haec opinio inter praedictas probabilior est: tamen omnes sunt falsae et haereticae. Secunda positio est dicentium, quod mundus incepit esse postquam non fuerat, et similiter omne quod est praeter Deum, et quod Deus non potuit mundum ab aeterno facere, non ex impotentia ejus, sed quia mundus ab aeterno fieri non potuit, cum sit creatus: volunt etiam quod mundum incepisse, non solum fide teneatur, sed etiam demonstratione probetur. Tertia positio est dicentium, quod omne quod est praeter Deum, incepit esse; sed tamen Deus potuit res ab aeterno produxisse; ita quod mundum incepisse non potuit demonstrari, sed per revelationem divinam esse habitum et creditum. Et haec positio innititur auctoritati Gregorii, qui dicit quod quaedam prophetia est de praeterito, sicut Moyses prophetizavit cum dixit Genes. 1: in principio creavit Deus caelum et terram. Et huic positioni consentio: quia non credo, quod a nobis possit sumi ratio demonstrativa ad hoc; sicut nec ad Trinitatem, quamvis Trinitatem non esse sit impossibile; et hoc ostendit debilitas rationum quae ad hoc inducuntur pro demonstrationibus, quae omnes a philosophis tenentibus aeternitatem mundi positae sunt et solutae: et ideo potius in derisionem quam in confirmationem fidei vertuntur si quis talibus rationibus innixus contra philosophos novitatem mundi probare intenderet. Dico ergo, quod ad neutram partem quaestionis sunt demonstrationes, sed probabiles vel sophisticae rationes ad utrumque". Si osservi invece la serena accettazione del dogma da parte di Dante ("s'aperse in nuovi amor l'eterno amore", cfr. infra), che non ha gli scrupoli di coerenza teorica di Tommaso, ed è mosso invece dalla evidente intenzione di proiettare sull'intero creato quel principio della novitas che ha intuito come legge, universalmente produttiva, dell'amore. 4 In Conv. II xiv 6, alla circolazione diurna del cielo stellato viene comparato il mondo fisico delle cose naturali, quelle che, appunto, sono oggetto della azione psichica della fantasia (che ne riceve le intenzioni): "[Il cristallino] per lo movimento nello quale ogni die si rivolve e fa nova circulazione di punto a punto, significa le cose naturali corruttibili, che cotidianamente compiono loro via, e la loro materia si muta di forma in forma: e di queste tratta la Fisica". Si osservi qui il rapporto analogico fra la "nova circulazione" (cioè il movimento celeste che si ripete quotidianamente ogni volta di nuovo), e il processo di corruzione che trasforma incessantemente le cose naturali. 5 Una volta identificati gli angeli con le intelligenze motrici dei cieli, e quindi con il decorso del tempo, è inaccettabile, in una prospettiva cristiana, la loro coeternità con Dio, 210
19 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio perché sarebbe indimostrabile la creazione del mondo (che per Aristotele è infatti eterno). Cfr. Agostino, De Civitate Dei, XII 15: "(angeli) etsi semper fuerunt, creati sunt, nec si semper fuerunt, ideo Creatori coaeterni sunt. Ille enim semper fuit aeternitate immutabili; isti autem facti sunt; sed ideo semper fuisse dicuntur, quia omni tempore fuerunt, sine quibus tempora nullo modo esse potuerunt; tempus autem quoniam mutabilitate transcurrit, aeternitati immutabili non potest esse coaeternum. Ac per hoc etiamsi immortalitas angelorum non transit in tempore, nec praeterita est quasi iam non sit, nec futura quasi nondum sit: tamen eorum motus, quibus tempora peraguntur, ex futuro in praeteritum transeunt, et ideo Creatori, in cuius motu dicendum non est vel fuisse quod iam non sit, vel futurum esse quod nondum sit, coaeterni esse non possunt". 6 Così riassume la posizione di Aritotele Sigieri di Brabante (In tertium De Anima, 2 7): "Cum igitur quaeritur utrum intellectus sit novum factum vel aeternum, per Aristotelem patet quid dicendum, scilicet quod intellectus factum est aeternum et non factum novum. Dicit enim Aristoteles quod omne factum immediate a Prima Causa non est novum factum, sed factum aeternum. <Propter> hoc enim posuit mundum esse aeternum, quia erat factum immediate a Prima Causa. Unde, si quaereretur ab Aristotele utrum intellectus sit factum novum vel sit factum aeternum, ipse iudicaret intellectum esse factum aeternum sicut mundum. Et intellectus, quod intellectus est motor humanae speciei, est unum factum aeternum, non multiplicatum multiplicatione individuali". Si osservi la traduzione di Dante: immediate = "sanza mezzo". 7 Cfr. XXVI, 69: "Vedi che del disio ver lei mi piego". 8 "Lo sommo desiderio di ciascuna cosa, e prima dalla natura dato, è lo ritornare allo suo principio. E però che Dio è principio delle nostre anime e fattore di quelle simili a sé (sì come è scritto: "Facciamo l'uomo ad imagine e simiglianza nostra"), essa anima massimamente desidera di tornare a quello. E sì come peregrino che va per una via per la quale mai non fue, che ogni casa che da lungi vede crede che sia l'albergo, e non trovando ciò essere, dirizza la credenza all'altra, e così di casa in casa, tanto che all'albergo viene; così l'anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto cammino di questa vita entra, dirizza li occhi al termine del suo sommo bene, e però, qualunque cosa vede che paia in sé avere alcuno bene, crede che sia esso. E perché la sua conoscenza prima è imperfetta per non essere esperta né dottrinata, piccioli beni le paiono grandi, e però da quelli comincia prima a desiderare. Onde vedemo li parvuli desiderare massimamente un pomo; e poi, più procedendo, desiderare uno augellino; e poi, più oltre, desiderare bel vestimento; e poi lo cavallo; e poi una donna; e poi ricchezza non grande, e poi grande, e poi più. E questo incontra perché in nulla di queste cose truova quella che va cercando, e credela trovare più oltre". 9 "Lo desiderio de la scienza non è sempre uno ma è molti, e finito l'uno, viene l'altro; sì che, propriamente parlando, non è crescere lo suo dilatare, ma successione di picciola cosa in grande cosa. Che se io desidero di sapere li principii de le cose naturali, incontanente che io so questi, è compiuto e terminato questo desiderio. E se poi io 211
20 Tenzone nº desidero di sapere che cosa e com'è ciascuno di questi principii, questo è un altro desiderio nuovo, né per l'avvenimento di questo non mi si toglie la perfezione a la quale mi condusse l'altro; e questo cotale dilatare non è cagione d'imperfezione, ma di perfezione maggiore". 10 Sulle origini accidioso-malinconiche della scienza moderna, e quindi sulla curiositas come idea modernamente fondazionale, si veda Blumenberg (1992: ): "La rassegnazione, espressa nell'idea di acedia, di fronte all'oggetto dell'assoluto per secoli corteggiato e lo scoraggiamento teologico-metafisico di fronte al Dio che con un arbitrio sovrano si sottrae quale deus absconditus determineranno la fine del Medioevo e il rovesciamento di valore, essenziale per la svolta epocale, della curiosità teoretica. Al vizio della provvisorietà disprezzata doveva subentrare la concezione -l'unica che rimanesse all'uomo- della sua forma d'esistenza teoretico-tecnica. Dalla malinconia dovuta all'irraggiungibilità delle riserve trascendenti della divinità sorgerà la decisa concorrenza dell'idea immanente di scienza, alla quale l'infinità della natura si apre come campo inesauribile di applicazione teoretica e che si amplia fino a diventare l'equivalente dell'infinità trascendente divina, divenuta incerta come idea di salvezza". È questo lo sfondo teoretico sul quale il desiderio (distillato dal complesso umorale tristitia-acedia) rivela la sua capitale funzione propulsiva nel processo di secolarizzazione della società europea. 11 [S. T. Iª-IIae q. 32 a. 8]: "Adipisci desiderata est delectabile, ut supra dictum est. Et ideo quanto alicuius rei amatae magis crescit desiderium, tanto magis per adeptionem crescit delectatio. Et etiam in ipso augmento desiderii fit augmentum delectationis, secundum quod fit etiam spes rei amatae; sicut supra dictum est quod ipsum desiderium ex spe est delectabile. Est autem admiratio desiderium quoddam sciendi, quod in homine contingit ex hoc quod videt effectum et ignorat causam, vel ex hoc quod causa talis effectus excedit cognitionem aut facultatem ipsius. Et ideo admiratio est causa delectationis inquantum habet adiunctam spem consequendi cognitionem eius quod scire desiderat. Et propter hoc omnia mirabilia sunt delectabilia, sicut quae sunt rara, et omnes repraesentationes rerum, etiam quae in se non sunt delectabiles; gaudet enim anima in collatione unius ad alterum, quia conferre unum alteri est proprius et connaturalis actus rationis, ut philosophus dicit in sua poetica. Et propter hoc etiam liberari a magnis periculis magis est delectabile, quia est admirabile, ut dicitur in I Rhetor.". 12 Molto più sfumato l'atteggiamento nei confronti della curiositas di Tommaso, che ammette una "virtuosa studiositas circa sensibilem cognitionem" (S. T. IIª-IIae q. 167 a. 2): "Si quis autem cognitioni sensibilium intendit ordinate, propter necessitatem sustentandae naturae, vel propter studium intelligendae veritatis, est virtuosa studiositas circa sensibilem cognitionem". 13 Rinvio per questi temi a Pinto 2002 e 2004b. 212
21 Raffaele PINTO Novitas e dialettica del desiderio 14 "Io dico che, secondo l'usanza d'arabia, l'anima sua nobilissima si partio ne la prima ora del nono giorno del mese; e secondo l'usanza di Siria, ella si partio nel nono mese de l'anno, però che lo primo mese è ivi Tisirin primo, lo quale a noi è Ottobre; e secondo l'usanza nostra, ella si partio in quello anno de la nostra indizione, cioè de li anni Domini, in cui lo perfetto numero nove volte era compiuto in quello centinaio nel quale in questo mondo ella fue posta, ed ella fue de li cristiani del terzodecimo centinaio. Perché questo numero fosse in tanto amico di lei, questa potrebbe essere una ragione: con ciò sia cosa che, secondo Tolomeo e secondo la cristiana veritade, nove siano li cieli che si muovono, e, secondo comune oppinione astrologa, li detti cieli adoperino qua giuso secondo la loro abitudine insieme, questo numero fue amico di lei per dare ad intendere che ne la sua generazione tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente s'aveano insieme. Questa è una ragione di ciò; ma più sottilmente pensando, e secondo la infallibile veritade, questo numero fue ella medesima; per similitudine dico, e ciò intendo così. Lo numero del tre è la radice del nove, però che, sanza numero altro alcuno, per se medesimo fa nove, sì come vedemo manifestamente che tre via tre fa nove. Dunque se lo tre è fattore per se medesimo del nove, e lo fattore per se medesimo de li miracoli è tre, cioè Padre e Figlio e Spirito Santo, li quali sono tre e uno, questa donna fue accompagnata da questo numero del nove a dare ad intendere ch'ella era uno nove, cioè uno miracolo, la cui radice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile Trinitade. Forse ancora per più sottile persona si vederebbe in ciò più sottile ragione; ma questa è quella ch'io ne veggio, e che più mi piace". 15 Sul rapporto fra le due poetiche, nella prospettiva dell'alternativa averroismo/tomismo, rinvio a Pinto (2004a). 213
22 Tenzone nº RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI BLUMENBERG, H. (1992): La legittimità dell età moderna, Genova, Marietti. PINTO, R. (2002): Gentucca e il paradigma poetico del dolce stil novo, in Tenzone, 3, pp PINTO, R. (2004a): La simiglianza come decostruzione/ricostruzione espressiva nel dialogo intertestuale fra Guido e Dante, in Guido Cavalcanti laico e le origini della poesia europea, nel 7º centenario della morte. Poesia, filosofia, scienza e ricezione, Atti del Convegno internazionale, Barcellona, ottobre 2001, a cura di R. Arqués, Alessandria, Edizioni dell Orso, pp PINTO, R. (2004b): Fingo ergo sum. Elementi di teoria poetica della modernità. Lettura del Canto XXVI del Purgatorio, in Tenzone, 5, pp
Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona) Novitas e dialettica del desiderio (Testo provvisorio)
 Raffaele Pinto () Novitas e dialettica del desiderio (Testo provvisorio) Sebbene il campo semantico della 'novità' (al quale mi riferisco con il latinismo novitas) abbia in Dante una estensione, come si
Raffaele Pinto () Novitas e dialettica del desiderio (Testo provvisorio) Sebbene il campo semantico della 'novità' (al quale mi riferisco con il latinismo novitas) abbia in Dante una estensione, come si
Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova ( )
 Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova (1293-1295) Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand ella altrui saluta, ch ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l ardiscon di
Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova (1293-1295) Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand ella altrui saluta, ch ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l ardiscon di
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
IL DOLCE STIL NOVO. Scuola TOSCANA: Area bolognese-fiorentina Classe 3 L Prof.ssa Cristina Salvi
 IL DOLCE STIL NOVO Scuola TOSCANA: Area bolognese-fiorentina 1280-1300 Classe 3 L Prof.ssa Cristina Salvi Il termine «Dolce Stil Novo»: Una definizione di Dante Dante Purg, XXIV Il poeta Bonagiunta Orbicciani:
IL DOLCE STIL NOVO Scuola TOSCANA: Area bolognese-fiorentina 1280-1300 Classe 3 L Prof.ssa Cristina Salvi Il termine «Dolce Stil Novo»: Una definizione di Dante Dante Purg, XXIV Il poeta Bonagiunta Orbicciani:
La fisica. Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto)
 La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Aspetti Epistemologici dell Informatica
 Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.
Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.
Parte IV. Sistematica
 Parte IV. Sistematica I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il Mistero di Dio nella Tradizione della Chiesa IV. Presentazione sistematica V. Conclusione: Maria e la
Parte IV. Sistematica I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il Mistero di Dio nella Tradizione della Chiesa IV. Presentazione sistematica V. Conclusione: Maria e la
Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva
 TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
amor cortese dolce stil novo
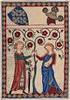 Lirica d amore Italiana 1230-1300 ca. nasce alla Corte di Federico II (scuola siciliana) deriva dall imitazione della Poesia provenzale Schema dell amor cortese= rapporto di sudditanza fra l amante e la
Lirica d amore Italiana 1230-1300 ca. nasce alla Corte di Federico II (scuola siciliana) deriva dall imitazione della Poesia provenzale Schema dell amor cortese= rapporto di sudditanza fra l amante e la
Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale?
 FEDE RAGIONE Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale? (3) C'è contraddizione tra fede e ragione? Percorso: Chiariamo
FEDE RAGIONE Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale? (3) C'è contraddizione tra fede e ragione? Percorso: Chiariamo
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
CREDO IN CREDO LA PROFESSO ASPETTO DIO PADRE UN SOLO CREATORE GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CHIESA
 DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista. Se Dio esista
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
Plotino. Ne risulta una sintesi che influenzerà il pensiero cristiano e moderno.
 Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e
Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e
L Enciclopedia delle scienze filosofiche
 L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel
L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel
Hegel. Il sistema hegeliano in sintesi
 Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell
Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell
Argomenti. Vita ed opere. La dottrina delle idee. La concezione dell'anima. Filosofia, amore, bellezza. Il pensiero politico.
 Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
Kierkegaard l esistenza come possibilità e fede
 l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
LA POESIA D ARTE DEL XIII SECOLO. Scuola siciliana, siculo toscana e dolce stil novo
 LA POESIA D ARTE DEL XIII SECOLO Scuola siciliana, siculo toscana e dolce stil novo La lirica d arte Poesia scritta con l intento di scrivere opere d arte Poeti impegnati ad usare uno stile e una lingua
LA POESIA D ARTE DEL XIII SECOLO Scuola siciliana, siculo toscana e dolce stil novo La lirica d arte Poesia scritta con l intento di scrivere opere d arte Poeti impegnati ad usare uno stile e una lingua
OMELIA : NOTTE DI NATALE
 OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza
OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza
notai Guido Guinizzelli
 IL DOLCE STIL NOVO La poesia dei notai Nella scuola siciliana i poeti erano notai della corte di Federico II di Svevia: dotti, ma portatori di una cultura laica Anche Guido Guinizzelli (1235-1275) è un
IL DOLCE STIL NOVO La poesia dei notai Nella scuola siciliana i poeti erano notai della corte di Federico II di Svevia: dotti, ma portatori di una cultura laica Anche Guido Guinizzelli (1235-1275) è un
Descartes Meditazioni Metafisiche. Schema
 Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Andrea Guarise. PROGETTO DIDATTICO CLASSE 3 a E scientifico
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina?
 Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara)
 APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
RELATIVISMO. OPINIONE Doxa. Sensi. Conoscenza. relativa. Molteplice varia nello Spazio RELATIVISMO. Impossibilità verità Universale e Immutabile
 RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
Schopenhauer Le radici del sistema
 Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale
Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale
GRAMSCI E IL SENSO COMUNE
 «Il senso comune è...la "filosofia dei non filosofi" cioè la concezione del mondo assorbita acriticamente dai vari ambienti sociali e culturali in cui si sviluppa l'individualità morale dell'uomo medio»
«Il senso comune è...la "filosofia dei non filosofi" cioè la concezione del mondo assorbita acriticamente dai vari ambienti sociali e culturali in cui si sviluppa l'individualità morale dell'uomo medio»
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015
 Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
SCIENZA E FEDE un dialogo possibile
 Le difficoltà del passato: La fede vedeva nella scienza la volontà dell uomo e della sua ragione di fare a meno Di Dio... SCIENZA E FEDE un dialogo possibile La scienza vedeva nella fede qualcosa di primitivo
Le difficoltà del passato: La fede vedeva nella scienza la volontà dell uomo e della sua ragione di fare a meno Di Dio... SCIENZA E FEDE un dialogo possibile La scienza vedeva nella fede qualcosa di primitivo
Leonardo Messinese. L apparire di Dio. Per una metafisica teologica. Edizioni ETS
 Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Esempio di documento di testo
 Esempio di documento di testo Indice generale Esempi di allineamenti...1 Allineamento a sinistra...1 Allineamento centrale...2 Allineamento a destra...2 Allineamento giustificato...3 Esempi di formato
Esempio di documento di testo Indice generale Esempi di allineamenti...1 Allineamento a sinistra...1 Allineamento centrale...2 Allineamento a destra...2 Allineamento giustificato...3 Esempi di formato
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
scienza. Quando si parla di scienza, il pensiero va immediatamente alla
 PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro - Mercoledì, 21 maggio 2014 I doni dello Spirito Santo: 5. La Scienza Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei mettere in luce un altro dono dello
PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro - Mercoledì, 21 maggio 2014 I doni dello Spirito Santo: 5. La Scienza Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei mettere in luce un altro dono dello
LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA
 JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
Il corpo, l anima, la persona. Elementi di antropologia filosofica
 Il corpo, l anima, la persona. Elementi di antropologia filosofica Luigi Alici I confini dell anima non li potrai mai trovare, per quanto tu percorra le sue vie, così profondo è il suo logos (Eraclito,
Il corpo, l anima, la persona. Elementi di antropologia filosofica Luigi Alici I confini dell anima non li potrai mai trovare, per quanto tu percorra le sue vie, così profondo è il suo logos (Eraclito,
Vita nova. Lezione quarta
 Vita nova Lezione quarta Calendario 21 settembre 19 ottobre: Lezioni introduttive. Esempio: Tanto gentile e tanto onesta pare. presentazioni 26 ottobre: A ciascun alma presa e gentil core 9 novembre: Piangete,
Vita nova Lezione quarta Calendario 21 settembre 19 ottobre: Lezioni introduttive. Esempio: Tanto gentile e tanto onesta pare. presentazioni 26 ottobre: A ciascun alma presa e gentil core 9 novembre: Piangete,
La rinascita dopo il Mille. prof. Polvere!i Emanuel" liceo scientifico Alessandro Volta
 La rinascita dopo il Mille prof. Polvere!i Emanuel" liceo scientifico Alessandro Volta Quadro di riferimento Svilupperemo questo tema, attraverso quattro linee trasversali, in modo da poter avere una chiave
La rinascita dopo il Mille prof. Polvere!i Emanuel" liceo scientifico Alessandro Volta Quadro di riferimento Svilupperemo questo tema, attraverso quattro linee trasversali, in modo da poter avere una chiave
lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 Declinazione)
 māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642)
 Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Traduzioni del testo da Saint Agostino, Il libero arbitrio, a cura di Rita Melillo (Roma: Città Nuova, 2011).
 De Libero Arbitrio AGIRE PER IL BENE (M215-14B) Traduzioni del testo da Saint Agostino, Il libero arbitrio, a cura di Rita Melillo (Roma: Città Nuova, 2011). Circostanze Conversazione fra Evodio e Agostino
De Libero Arbitrio AGIRE PER IL BENE (M215-14B) Traduzioni del testo da Saint Agostino, Il libero arbitrio, a cura di Rita Melillo (Roma: Città Nuova, 2011). Circostanze Conversazione fra Evodio e Agostino
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali
 S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
Francesco Petrarca ( )
 Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE
 PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
UNITA DIDATTICA. Conoscenze. 1 Il problema dell'esistenza di Dio 2 La questione dell'ateismo e l'approccio scientifico al problema di Dio.
 Titolo: La ricerca di Dio: ragione e fede. Codice: UD A6 1 Il problema dell'esistenza di Dio 2 La questione dell'ateismo e l'approccio scientifico al problema di Dio Interrogarsi sulla necessità di credere
Titolo: La ricerca di Dio: ragione e fede. Codice: UD A6 1 Il problema dell'esistenza di Dio 2 La questione dell'ateismo e l'approccio scientifico al problema di Dio Interrogarsi sulla necessità di credere
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag
 Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag. 176-178 Sulla superficie di un lago galleggiano dei fiori con le radici attaccate sul fondo - delle ninfee. Il fondo del lago è invisibile dalla superficie.
Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag. 176-178 Sulla superficie di un lago galleggiano dei fiori con le radici attaccate sul fondo - delle ninfee. Il fondo del lago è invisibile dalla superficie.
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio. L'amore di Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
Le origini della letteratura in volgare. sintesi
 Le origini della letteratura in volgare sintesi 1037: Constitutio de feudis (Corrado II) Perché nasce una letteratura nel secolo XI, ed in volgare? Quale tipo di letteratura? Valori: coraggio onore lealtà
Le origini della letteratura in volgare sintesi 1037: Constitutio de feudis (Corrado II) Perché nasce una letteratura nel secolo XI, ed in volgare? Quale tipo di letteratura? Valori: coraggio onore lealtà
LITANIE MARIANE DOMENICANE. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi
 LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
Autoritratto con cappello
 Autoritratto con cappello Arturo Checchi Leonardo Liguori Anno scolastico 2010/2011 Classe 5 D Indice 1. Schedatura opera principale= A.C., Autoritratto con cappello 2. Confronto con un opera dello stesso
Autoritratto con cappello Arturo Checchi Leonardo Liguori Anno scolastico 2010/2011 Classe 5 D Indice 1. Schedatura opera principale= A.C., Autoritratto con cappello 2. Confronto con un opera dello stesso
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi
 avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
Introduzione. - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare
 Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Iacopo da Lentini: Amor è uno desio
 Iacopo da Lentini: Amor è uno desio È un sonetto, di cui è protagonista la fenomenologia della genesi dell'amore N.b. Fenomenologia: descrizione del modo in cui si manifesta una realtà Fa parte di una
Iacopo da Lentini: Amor è uno desio È un sonetto, di cui è protagonista la fenomenologia della genesi dell'amore N.b. Fenomenologia: descrizione del modo in cui si manifesta una realtà Fa parte di una
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
La struttura dell opera: Meditazioni * metafisiche Meditationes de prima philosophia (1641)
 La struttura dell opera: Meditazioni * metafisiche Meditationes de prima philosophia (1641) Sottotitolo: In cui si dimostrano l esistenza di Dio e la distinzione dell anima dal corpo. I Delle cose che
La struttura dell opera: Meditazioni * metafisiche Meditationes de prima philosophia (1641) Sottotitolo: In cui si dimostrano l esistenza di Dio e la distinzione dell anima dal corpo. I Delle cose che
365 Volte NON TEMERE
 365 Volte NON TEMERE Cari lettori, è ormai da diverso tempo che scrivo per questa rubrica e spero che voi tutti ne stiate traendo dei benefici. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per il tempo che dedicate
365 Volte NON TEMERE Cari lettori, è ormai da diverso tempo che scrivo per questa rubrica e spero che voi tutti ne stiate traendo dei benefici. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per il tempo che dedicate
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
Karl Marx. La critica all Ideologia. La critica alla religione
 Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di
Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di
1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131
 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Caratteristiche della poesia ermetica
 Corrente ermetica È da inquadrare nel periodo che va più o meno dal 1915 al 1930. Si parla di corrente perché non ne sono definite le tecniche e gli autori non partecipano coscientemente ad un progetto
Corrente ermetica È da inquadrare nel periodo che va più o meno dal 1915 al 1930. Si parla di corrente perché non ne sono definite le tecniche e gli autori non partecipano coscientemente ad un progetto
Marco Barbiani. Larlun. Tracce di una via filosofica tra Oriente e Occidente
 Marco Barbiani Larlun Tracce di una via filosofica tra Oriente e Occidente ... proprio in questa perfezione della sapienza ci si deve addestrare ed esercitare Astasāhasrikā Prajñāpāramitā [1]... una vita
Marco Barbiani Larlun Tracce di una via filosofica tra Oriente e Occidente ... proprio in questa perfezione della sapienza ci si deve addestrare ed esercitare Astasāhasrikā Prajñāpāramitā [1]... una vita
La filosofia. Storia della filosofia contemporanea
 La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
PASSI BIBLICI DIFFICILI
 Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
 http://www.philolympia.org/ LA SCRITTURA FILOSOFICA IL TESTO ARGOMENTATIVO IL SAGGIO FILOSOFICO Un saggio filosofico consiste in una difesa ragionata di una determinata asserzione. Non può consistere nella
http://www.philolympia.org/ LA SCRITTURA FILOSOFICA IL TESTO ARGOMENTATIVO IL SAGGIO FILOSOFICO Un saggio filosofico consiste in una difesa ragionata di una determinata asserzione. Non può consistere nella
ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA DALL ETICA VITA SOCIALE VITA PRIVATA
 PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)
PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
 OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA. ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B
 PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA
 Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
L amicizia tra Dio e uomo prospettive a confronto
 TESI XVII Con il passaggio da un ontologia della sostanza ad un ontologia della relazione è possibile predicare una relazione essenziale di Dio con l uomo. L amicizia tra Dio e uomo prospettive a confronto
TESI XVII Con il passaggio da un ontologia della sostanza ad un ontologia della relazione è possibile predicare una relazione essenziale di Dio con l uomo. L amicizia tra Dio e uomo prospettive a confronto
Il tubo del tempo. Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica
 Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
Appunti di Storia della della Filosofia Greca. Aristotele
 Appunti di Storia della della Filosofia Greca Aristotele Contesto storico e cenni biografici Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.c. vive in un periodo di decadenza della civiltà greca, con il cittadino
Appunti di Storia della della Filosofia Greca Aristotele Contesto storico e cenni biografici Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.c. vive in un periodo di decadenza della civiltà greca, con il cittadino
Il Metodo. Assi Cartesiani. Mathesis Universalis:
 1596-1650 Indice Il Metodo; Il Dubbio Metodico e Iperbolico; Il Cogito Ergo Sum; Le Idee Contenute Nel Cogito; Dio garante di verità; Il Meccanicismo; Il Dualismo Cartesiano; La Ghiandola Pineale; La Morale
1596-1650 Indice Il Metodo; Il Dubbio Metodico e Iperbolico; Il Cogito Ergo Sum; Le Idee Contenute Nel Cogito; Dio garante di verità; Il Meccanicismo; Il Dualismo Cartesiano; La Ghiandola Pineale; La Morale
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A
 HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico
 Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO
 L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO Argomenti L'età ellenistica Lo Stoicismo Epicuro e l'epicureismo Lo scetticismo Plotino ed il neoplatonismo L'ETÀ ELLENISTICA Influssi della cultura orientale sul
L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO Argomenti L'età ellenistica Lo Stoicismo Epicuro e l'epicureismo Lo scetticismo Plotino ed il neoplatonismo L'ETÀ ELLENISTICA Influssi della cultura orientale sul
Umanesimo e Rinascimento
 Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia
Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL
 PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
La spiritualità dell animatore. Giacomo Prati
 + La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
+ La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
IL LIBRO DELL APOCALISSE LA CROCE DI CRISTO COME TRIONFO
 IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
LABORATORI CATECHISTICI
 LABORATORI CATECHISTICI 2011-2012 CREDO Niceno-Costantinopolitano Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
LABORATORI CATECHISTICI 2011-2012 CREDO Niceno-Costantinopolitano Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Esame scritto dell Opzione specifica. Filosofia + Pedagogia/Psicologia
 Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di Immanuel
Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di Immanuel
Il Romanticismo. In Europa e in Italia
 Il Romanticismo In Europa e in Italia Classici e Romantici Classicismo L arte è imitazione di modelli di perfezione sempre uguali; Ricerca equilibrio e armonia Romanticismo La vita è un eterno cambiamento:
Il Romanticismo In Europa e in Italia Classici e Romantici Classicismo L arte è imitazione di modelli di perfezione sempre uguali; Ricerca equilibrio e armonia Romanticismo La vita è un eterno cambiamento:
RIASSUNTO e RILANCIO Prof. Monti a.s
 RIASSUNTO e RILANCIO Abbiamo notato che la ricerca dell arché, cioè di qualcosa che possa fornire una spiegazione razionale del mondo e delle cose che lo compongono, procede lungo un percorso che conduce
RIASSUNTO e RILANCIO Abbiamo notato che la ricerca dell arché, cioè di qualcosa che possa fornire una spiegazione razionale del mondo e delle cose che lo compongono, procede lungo un percorso che conduce
Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Da quale poesia sono tratti i versi che aprono l animazione?
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Heidegger e Hölderlin Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Da quale poesia sono tratti i versi che aprono l animazione?
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele
 Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele eum x filosofia eum x 2006 eum edizioni università di macerata vicolo Tornabuoni, 58-62100 Macerata info.ceum@unimc.it http://ceum.unimc.it
Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele eum x filosofia eum x 2006 eum edizioni università di macerata vicolo Tornabuoni, 58-62100 Macerata info.ceum@unimc.it http://ceum.unimc.it
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA. I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche
 ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
Ascoltare. La musica interiore MUSICA
 MUSICA Roberta Pagani Mario Franchi 1 Ascoltare "E' più facile meditare utilizzando le orecchie che non gli occhi: è più facile in quanto le orecchie sono passive, non sono aggressive. Non possono far
MUSICA Roberta Pagani Mario Franchi 1 Ascoltare "E' più facile meditare utilizzando le orecchie che non gli occhi: è più facile in quanto le orecchie sono passive, non sono aggressive. Non possono far
Prof. Francesco Paparella, Università di Bergamo, corso di Storia della Filosofia Medievale, a.a
 De Trinitate IV, 1.3 2.4 Temi centrali sono 1) l indagine intorno alla relazione tra Logos e Parola nell'ambito della relazione delle persone della Trinità e 2) l attingimento del Vero da parte dell uomo
De Trinitate IV, 1.3 2.4 Temi centrali sono 1) l indagine intorno alla relazione tra Logos e Parola nell'ambito della relazione delle persone della Trinità e 2) l attingimento del Vero da parte dell uomo
QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE?
 QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE? Nel racconto del primo capitolo della Genesi (Gen 1-2,4a) il creatore del mondo non è una divinità pagana ma il Dio d Israele. Egli è il Dio di Abramo, di
QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE? Nel racconto del primo capitolo della Genesi (Gen 1-2,4a) il creatore del mondo non è una divinità pagana ma il Dio d Israele. Egli è il Dio di Abramo, di
La Vocazione. Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016
 Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
