Effetti e processori di segnali
|
|
|
- Donato Vigano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Effetti e processori di segnali Massimiliano Salfi salfi@dmi.unict.it
2 Nozioni generali Le apparecchiature utilizzate per elaborare i segnali audio per varie finalità si dividono in due categorie: gli effetti veri e propri; i processori di segnale.
3 Nozioni generali Alla prima categoria appartengono tutti i moduli che realizzano una manipolazione su una parte del segnale. All'interno il segnale viene separato in due: una parte raggiunge direttamente l'uscita, mentre l'altra passa attraverso il circuito per essere manipolata. All'uscita del modulo un miscelatore permette di riunire i due segnali, uno non manipolato (dry - asciutto) e uno manipolato (wet - bagnato). La caratteristica degli effetti consiste nel fatto che il segnale asciutto e quello bagnato vengono sommati in parallelo.
4 Nozioni generali Alla seconda categoria, invece, appartengono i moduli che realizzano una manipolazione sull'intero segnale. Un tipico schema di funzionamento è il seguente:
5 Nozioni generali Attualmente il mercato è praticamente sommerso da un'infinità di effetti diversi con le finalità più impensate. Tutti gli effetti citati in questa sezione possono essere realizzati attraverso: circuiti elettronici; circuiti digitali che applicano determinati algoritmi; emulazione software.
6 Nozioni generali I circuiti elettronici prelevano il segnale che viene loro fornito in ingresso e lo manipolano facendolo passare attraverso opportuni circuiti che ne modificano le caratteristiche (come ad esempio l'ampiezza o il contenuto in frequenza). La qualità del modulo realizzato, in questo caso, dipende dalla qualità dei singoli componenti elettronici (resistenze, condensatori, induttanze, connettori ecc.) e dalla qualità del progetto del circuito.
7 Nozioni generali Nei circuiti digitali il segnale in ingresso viene campionato e memorizzato in una memoria digitale (RAM). Successivamente un circuito digitale (composto da circuiti integrati) esegue operazioni matematiche sui dati memorizzati secondo un algoritmo che simula una situazione reale. L emulazione software prevede la scrittura di algoritmi implementati attraverso linguaggi di programmazione che, elaborando i campioni numerici che rappresentano il suono in ingresso, riproducono l effetto finale (sempre sotto forma numerica) da inviare alla scheda audio del PC per l ascolto dopo la conversione da segnale digitale in segnale analogico.
8 Effetti: il riverbero Per riverbero intendiamo il suono che rimane in un ambiente quando il segnale diretto si è esaurito. Per immaginarlo pensiamo ad un esempio macroscopico: un battito di mani all interno di una cattedrale. Dopo il battito, il suono diretto si esaurisce quasi subito, mentre il suono originato dalle riflessioni sulle superfici che incontra, va avanti per diversi secondi (potrebbe arrivare perfino ad una quarantina di secondi) estinguendosi lentamente.
9 Effetti: il riverbero Supponiamo dunque di sollecitare un ambiente riverberante con un segnale impulsivo e di acquisire il segnale presente, come conseguenza della sollecitazione prodotta, in corrispondenza di un punto nell ambiente (ad esempio mediante un microfono). La risposta dipenderà dalle posizioni relative della sorgente di segnale e del ricevitore. Un tipico esempio dell andamento nel tempo di una risposta impulsiva ambientale è illustrato nella seguente figura:
10 Effetti: il riverbero Dopo circa 7 ms, prima dei quali viene solamente registrato del rumore di fondo, arriva al punto di ricezione il segnale diretto. Successivamente cominciano ad arrivare le prime riflessioni provenienti dalle pareti riflettenti dell ambiente, non tutte di ampiezza necessariamente minore a quella dell impulso diretto. Con l avanzare del tempo, alle prime riflessioni si uniscono le riflessioni di ordine superiore o riflessioni successive che perdurano fino a quando le pareti dell ambiente e l attenuazione dell aria non riducono la potenza del segnale a un valore trascurabile.
11 Effetti: il riverbero La figura mostra l'ampiezza delle varie riflessioni e gli istanti di tempo in cui si verificano. Il primo suono che raggiunge l'ascoltatore è sempre il segnale diretto (Direct Signal) essendo questo il minimo percorso effettuato dal suono. Dopo una breve pausa denominata ritardo iniziale (pre-delay) arrivano le prime riflessioni (early reflections) che sono quelle che hanno incontrato una sola superficie prima di arrivare all'ascoltatore. Infine arrivano le ultime riflessioni (late reflections) che sono quelle che hanno incontrato più di una superficie. Queste arrivano sovrapponendosi l'una con l'altra generando un suono mediamente continuo.
12 Effetti: il riverbero Una misura particolarmente significativa delle caratteristiche riverberanti di un ambiente è il tempo di riverbero ai 60 db, denotato con RT 60, ovvero il tempo in secondi che trascorre affinché l inviluppo dell energia della risposta impulsiva ambientale si riduca di 60 db.
13 Percezione del riverbero E importante sottolineare il ruolo fondamentale del riverbero nella percezione degli eventi sonori in ambienti chiusi: ci si trovi in una piccola stanza o in una sala da concerto, l insieme delle risonanze e degli echi che accompagnano il suono puro influisce in modo fondamentale sulla nostra percezione del timbro e dell ambiente che ci circonda. Tuttavia, una registrazione condotta all interno di un ambiente riverberante risulta pessima nella maggioranza dei casi, soprattutto perchè non appena i musicisti diventano più di uno, fenomeni di cross talk tra uno strumento e l altro andranno a rimescolare le tracce registrate. Questo obbliga a rendere una sala di registrazione la più anecoica possibile ed a minimizzare l influenza sulla singola traccia di qualunque segnale esterno.
14 il volume del suono diretto; il colore del suono; il timbro; il tappeto acustico che si sovrappone al suono diretto, ovvero la percezione di uno sfondo al suono diretto; l insieme degli echi che vanno ad accodarsi al suono diretto. Percezione del riverbero Il riverbero contribuisce in modo fondamentale alla caratterizzazione di un evento sonoro. Le caratteristiche dell evento sonoro che maggiormente risentono del tipo di riverbero sono:
15 Percezione del riverbero Generalmente, si assume di suddividere la percezione temporale di un evento sonoro basandosi sulla costante di integrazione dell orecchio, di solito fissata in 80 ms (a seconda del soggetto può variare nell intervallo ms). In base a questo modello, valgono le seguenti considerazioni di principio: 1. a partire dall istante di percezione del segnale diretto, tutti gli echi che giungono all orecchio entro 80 ms vanno a caratterizzare volume, colore e timbro del suono; 2. le caratteristiche del tappeto acustico dipendono in larga parte dagli echi attenuati che giungono dopo 80 ms. Di fatto, durante l ascolto spesso il tappeto è mascherato dal segnale diretto, e viene perlopiù valutato durante le pause; 3. ripetizioni del segnale diretto, che giungono dopo un tempo superiore alla costante di integrazione dell orecchio, vengono percepite come eventi distinti, o echi veri e propri.
16 Riverbero a molla Il riverbero a molla (o "spring reverb") utilizza il movimento della vibrazione di una molla per convertire il segnale in energia elettrica. Per simulare l'effetto del riverbero, infatti, viene impiegata una molla all'interno di una cavità ai cui estremi vengono posti due trasduttori che applicano alla molla il segnale audio. Un microfono viene impiegato per la ripresa del suono così generato. I riverberi a molla sono le unità di riverbero più economiche che si possono trovare sul mercato e per anni sono stati il tipo di riverbero che si trovava generalmente sugli amplificatori per chitarra (ancora oggi alcuni modelli di tipo economico ne fanno largo uso). In essi, una manopola regola la quantità di ritorno del riverbero che viene sommato al segnale originale.
17 Riverbero a molla Oltre al fatto che non è una simulazione molto realistica, il problema più serio del riverbero a molla è che questo aggiunge spesso molto rumore al segnale e che può andare facilmente in sovraccarico. Il sovraccarico si manifesta quando un amplificatore che utilizza un riverbero a molla riceve un forte scossone, come ad esempio può capitare facilmente su un palco durante un live. Nel caso di amplificatori valvolari, ciò può far saltare le valvole.
18 Riverbero plate Il plate reverb utilizza una larga lamina d'acciaio sospesa verticalmente all'interno di un'intelaiatura. Su di essa vengono applicati due trasduttori: uno che trasmette il segnale di ingresso, l altro che preleva la vibrazione così generata. Posizionando in punti diversi i due trasduttori è possibile variare le caratteristiche dell'effetto.
19 Riverbero plate Il plate reverb ha una risposta più fedele del riverbero a molla, soprattutto alle alte frequenze, e genera un suono che ha la caratteristica di essere molto piacevole all'orecchio. Per questo motivo è ancora la forma di riverbero analogico preferita da molti musicisti professionisti. Il vero svantaggio del plate reverb sta nel suo costo e nel suo ingombro. I plate reverb possono misurare vari metri e devono essere perfettamente isolati. Ciò non è particolarmente pratico per la maggior parte degli studi e certamente non può essere preso in considerazione l'utilizzo del plate reverb in situazioni live, motivo per cui oggi ormai vengono utilizzati quasi esclusivamente sistemi digitali. Un tipo particolare di plate reverb è il cosiddetto "foil reverb", che si basa sugli stessi principi ma utilizza una sottile sfoglia d'oro al posto della lamina d'acciaio.
20 Riverbero digitale Fino all'avvento del riverbero digitale, la maggior parte degli ingegneri del suono si preoccupavano ben poco (nel senso che non potevano modificarlo più di tanto) del modo in cui il riverbero modificava l'inviluppo del suono originale. In effetti, il parametro utile era uno solo: il riverbero utilizzato, o piaceva o non piaceva. Dopo la rivoluzione digitale, invece, gli ingegneri sono stati praticamente costretti a studiare le relazioni tra il suono "pulito" originale e le pareti riflettenti (virtuali). Le unità di riverbero dell'ultima generazione, infatti, praticamente sono tutte digitali impiegando algoritmi di simulazione molto sofisticati (la cui realizzazione è resa possibile grazie al continuo aumento della potenza di calcolo disponibile).
21 Riverbero digitale Di seguito viene riportata una lista dei controlli fondamentali: Pre Delay: consente di modificare il tempo del Pre Delay. Early Reflections: durata delle prime riflessioni. Decay: durata del decadimento delle ultime riflessioni. Mix: la percentuale tra segnale asciutto e bagnato. Dimensioni della stanza: spesso i valori sono riferiti alle forme-dimensioni degli ambienti (hall, room, chamber, cathedral, spring/plate). HF Ratio: le alte frequenze sono le prime ad essere attenuate durante le riflessioni. Questo controllo permette di simulare le capacità di assorbimento delle superfici. Stereo width: allarga o restringe l'immagine stereo del riverbero.
22 Riverbero digitale Alcune unità permettono di definire un tempo di decadimento diverso a seconda della frequenza. In alcune unità molto sofisticate è perfino possibile decidere il posizionamento dei microfoni all interno della stanza simulata.
23 Cenni sugli algoritmi utilizzati Le unità di riverbero realizzate al giorno d'oggi utilizzano algoritmi piuttosto complessi per i quali non scenderemo oltremodo nei dettagli. In questo contesto, ci limiteremo ad analizzare un esempio molto elementare il quale dà l'idea su come funzionino le unità più semplici. I primi algoritmi di riverbero digitali cercavano di imitare le riverberazioni naturali di una stanza utilizzando due tipi di filtri a risposta di impulso infinita ("infinite impulse response", o IIR), in modo che l'output andasse a scemare gradualmente. Uno di questi filtri è il cosiddetto "comb filter", il quale deve il nome alla particolare risposta in frequenza, che ricorda quella di un impulso che rimbalza tra due pareti. L'altro filtro principale utilizzato è un "allpass filter", che incide solo sulla fase del segnale.
24 Cenni sugli algoritmi utilizzati Il primo a realizzare unità di riverbero digitali fu Schroeder e una delle sue famose unità di riverbero utilizza quattro comb filters e due allpass filters, come è possibile vedere nel diagramma mostrato di seguito, estremamente primitivo, ma che fornisce un'idea schematica su come possa funzionare una unità di riverbero.
25 Effetti: il delay Un delay aggiunge repliche del segnale distanziate nel tempo, generando un 'effetto eco'. La linea di ritardo deve assicurare un ritardo non inferiore agli 80 ms, tempo al di sotto del quale non è assicurata la percezione distinta di due suoni identici. Inizialmente veniva generato utilizzando un registratore analogico, sfruttando la distanza tra la testina di riproduzione e quella di registrazione: mandando l'uscita del canale sinistro all'ingresso del canale destro e viceversa, e lavorando sulla velocità del nastro, si riusciva a ottenere un effetto delay versatile e, per l'epoca, rivoluzionario. L'era digitale ha semplificato molto la realizzazione di questo effetto, consentendo inoltre di introdurre innovazioni interessanti come il ping pong delay (le repliche sono alternate sui canali destro e sinistro) e il multi-tap (le repliche si susseguoni con tempi diversi creando effetti di dissolvenza).
26 Effetti: il delay Nella pratica musicale il tempo di delay viene spesso posto pari al tempo di una battuta. In questo modo le repliche vanno a tempo con la musica, creando un effetto che contribuisce a riempire il suono. Per calcolare il tempo di delay (in millisecondi) necessario per un pezzo di n battute al minuto (o bmp - beats per minute) possiamo ricorrere alla seguente formula: tempo di delay (ms)=60000 (ms) / n (bpm)
27 Il delay raffigurato produce una singola ripetizione distinta dell'input, per cui in questo caso si parla di "slapback echo". Il tempo di ritardo che consente di udire una ripetizione distinta, ossia come echo e non come riverbero, è in genere tra i 30 e i 100 millisecondi, a seconda dell'ascoltatore (spesso maggiore). Un tempo medio che si applica alla maggior parte delle persone, e che viene in genere preferito dagli ingegneri in studio, è di circa 80 ms. Cenni sugli algoritmi utilizzati Echo slapback Un delay prende un segnale audio e lo riproduce dopo il tempo di delay. Il tempo di delay può variare tra alcuni millisecondi e alcuni secondi:
28 Cenni sugli algoritmi utilizzati Feedback delay Avere l'effetto di un singolo echo può essere limitante, per cui le unità di delay spesso hanno anche un controllo di "feedback" (a volte detto "regeneration") che prende l'output del delay e lo manda indietro all'input, come è possibile vedere nel seguente diagramma: In questo modo è possibile far ripetere il suono varie volte di seguito, diminuendone il volume ogni volta che questo viene riprodotto (se il valore di "gain" del feedback è minore di 1) o lasciandolo invariato all infinito (se il feedback gain è pari a 1). La maggior parte dei delay non lasciano la possibilità di impostare il feedback gain ad 1, ma solo a valori minori.
29 Cenni sugli algoritmi utilizzati Ping-pong delay Il ping-pong delay produce un suono rimbalzante, dove i rimbalzi tipicamente avvengono tra il canale destro e il canale sinistro di un segnale stereofonico. Il ping-pong delay utilizza due delay distinti, ognuno con il proprio input (naturalmente si può inviare il medesimo segnale a entrambi gli input). Invece di reinviare l'output all input corrispondente, la linea di feedback di ogni delay manda il segnale al canale opposto, prima del modulo di delay. I due segnali di output, creano così il classico effetto di "rimbalzo" del suono.
30 Effetti: il phaser Questo effetto combina il segnale originario e una sua versione ritardata in cui il ritardo viene modulato (ciò significa che varia continuamente e l'andamento della variazione è definito da una funzione come per esempio una sinusoide). Vediamo cosa succede in una tale situazione, considerando due armoniche di un segnale arbitrario:
31 Effetti: il phaser La seconda forma d'onda è identica alla precedente, ma ha un ritardo variabile che al massimo è pari a mezza semionda. Dunque immaginiamo la seconda forma d'onda oscillare sull'asse orizzontale tra 0 e la posizione in cui si trova in figura. Quando si trova sullo 0, le due forme d'onda sono in fase e riscontriamo un rinforzo di tutte le frequenze componenti il segnale. Quando si trova nella posizione ritardata, notiamo una cancellazione della prima armonica e un rinforzo della seconda. Dunque il contenuto in frequenza del segnale originario è stato modificato. Tutte le posizioni intermedie agiscono in misura diversa sia sulla prima che sulla seconda armonica. Riassumendo, l'effetto phasing consiste nel sommare al segnale originario una sua replica ritardata in cui il tempo di ritardo è modulato secondo una determinata forma d'onda.
32 Effetti: il phaser Possiamo simulare l'effetto phasing utilizzando due microfoni per prelevare lo stesso segnale. Tenendo un microfono fisso mentre l'altro viene ciclicamente avvicinato e poi allontanato dalla sorgente sonora otteniamo due copie dello stesso segnale una ritardata rispetto all'altra. Il movimento avanti e indietro del secondo microfono simula l'operazione di modulazione del tempo di ritardo. La figura seguente mostra lo schema logico di un phaser:
33 Effetti: il phaser Il segnale di ingresso viene diviso in due parti: la prima raggiunge l'uscita senza essere manipolata, mentre la seconda viene fatta passare attraverso un delay e poi miscelata al segnale di ingresso. Il tempo di delay è controllato da un circuito LFO (Low Frequency Oscillator - Oscillatore a bassa frequenza). Tale circuito consiste in un oscillatore in grado di generare forme d'onda (generalmente sinusoidali) a bassa frequenza (1 Hz o anche meno). Tali oscillatori vengono di solito impiegati per controllare i parametri di altri effetti come nel presente caso in cui il LFO modula il tempo di ritardo (per esempio modulando con una sinusoide di 1Hz i due segnali rientrano in fase ogni secondo) tra i due segnali. Possiamo notare che una parte del segnale destinato all'uscita viene prelevata e rispedita in ingresso. Questo artificio viene impiegato in tanti altri tipi di effetti e ha il risultato di amplificare ulteriormente l'effetto applicato.
34 Effetti: il phaser I controlli tipici di cui viene dotato un effetto phaser sono i seguenti: Rate: la velocità di variazione del tempo di delay (è la frequenza del modulatore LFO - la velocità con cui si sposta un microfono rispetto all'altro). Mix: miscela il segnale originario e quello manipolato. Feedback: controlla la quantità di phasing applicata.
35 Effetti: il flanger Estende l'effetto phasing aggiungendo anche un pitch shifter, ossia un circuito in grado di aumentare o diminuire la tonalità del segnale (l'esempio classico di pitch shifting è quello in cui si accelera o si rallenta lo scorrimento di un nastro magnetico). Per dare una spiegazione pratica di questo fenomeno pensiamo ad una sinusoide avente una certa frequenza, registrata su di un nastro magnetico. Aumentando la velocità del nastro avremo come risultato che la sinusoide viene riprodotta più velocemente e ciò equivale alla generazione di una sinusoide a frequenza maggiore.
36 Effetti: il flanger Lo schema logico è illustrato nella figura seguente: In esso si nota che il LFO pilota sia il modulo delay che quello pitch shifter.
37 Effetti: il chorus Può essere pensato come una estensione rispetto al Flanger, aggiungendo un modulo che introduce variazioni di ampiezza sul segnale manipolato:
38 Cenni sugli algoritmi utilizzati Così come un coro in un gruppo di cantanti, l'effetto di "chorus" fa in modo che un singolo strumento suoni come se in realtà ci fossero vari strumenti suonati insieme. Il chorus rende in genere un suono più ricco e più presente. L'algoritmo su cui è basato il chorus è molto semplice: così come due cantanti in realtà non cantano mai veramente all'unisono, nel chorus viene generato un ritardo tra il suono originario e alcune sue copie. In aggiunta, il pitch viene leggermente modificato in modo da dare maggiore ricchezza all'insieme, e ancora una volta donando maggiore naturalezza all'effetto generato.
39 Tipicamente, per un chorus standard al suono originale viene aggiunta una replica ritardata di un valore intorno ai 5 ms. Per rendere più verosimile l effetto, nel tempo sono state aggiunte delle varianti all algoritmo descritto affinché venisse variata anche l ampiezza (dal momento che in un coro, un gruppo di cantanti oltre a non cantare perfettamente all unisono e con la stessa intonazione, non hanno mai la stessa intensità). Cenni sugli algoritmi utilizzati Il delay viene generato semplicemente tramite una linea di delay. L'effetto di "detune" viene generato trasformando la semplice linea di delay in una linea di delay a lunghezza variabile. "Lunghezza variabile" significa che il delay time cambia nel tempo. Per far sì che il delay time cambi nel tempo, viene utilizzato un filtro LFO che fa variare una forma d'onda sinusoidale, la quale controlla il suono del chorus:
40 Effetti: il tremolo ed il vibrato Tremolo Applica al segnale di ingresso modulazioni di ampiezza. Un LFO controlla la modulazione. La frequenza del LFO controlla la rapidità della modulazione, l'ampiezza controlla l'escursione di volume applicata. Vibrato Applica al segnale di ingresso modulazioni di tono (frequenza). In questo caso un LFO modula la frequenza del segnale.
41 Processori: il distorsore Ogni amplificatore possiede una soglia massima consentita per il segnale di ingresso, superata la quale si incorre nel fenomeno chiamato saturazione. Questo significa che quando il segnale di ingresso è minore della soglia, l'amplificatore funziona correttamente e riproduce in uscita la forma d'onda amplificata, quando però il segnale di ingresso supera tale soglia, l'amplificatore ha raggiunto il suo massimo e non è in grado di amplificare ulteriormente la forma d'onda. Ciò si traduce in un'uscita costante pari al massimo consentito per l'amplificazione per tutto il tempo che il segnale di ingresso rimane al di sopra della soglia. Non appena il segnale di ingresso ridiscende al di sotto della soglia, l'amplificatore ricomincia a funzionare correttamente.
42 Processori: il distorsore La figura seguente illustra la curva di amplificazione di un amplificatore e la sua azione su un segnale di ingresso di tipo sinusoidale che presenta dei massimi al di sopra della soglia.
43 Processori: il distorsore In uscita abbiamo, quindi, un segnale 'saturato'. La saturazione introduce una brusca variazione del segnale che non segue più il suo andamento sinusoidale naturale e questo significa che il nuovo segnale contiene nuove frequenze più alte di quella originaria. Infatti abbiamo detto più volte che qualsiasi segnale complesso è riconducibile alla somma di sinusoidi a diverse frequenze (e fasi). Più brusche sono le transizioni presentate dal segnale, più frequenze sono necessarie per riprodurlo in termini di sinusoidi. Guardando ora la sinusoide saturata di figura, ci accorgiamo che sono state introdotte delle brusche transizioni e dunque nello spettro devono essere comparse delle nuove frequenze e sono queste che generano il suono tipico della distorsione.
44 Processori: il distorsore Dunque la distorsione allo stato puro si ottiene alzando il guadagno di un preamplificatore in modo che parte del segnale che poi andrà all'amplificatore finale superi in alcuni punti il proprio valore di soglia. Un amplificatore valvolare, ad esempio, è in grado di generare un bellissimo suono di distorsione. Tuttavia in commercio esistono diverse unità che simulano la saturazione, anche se la qualità dell'effetto sarà diversa.
45 Processori: l exciter Questo processore introduce leggere saturazioni sul segnale di ingresso. Come detto, una saturazione genera nuove armoniche dipendenti dal contenuto in frequenza del segnale di ingresso. Quindi l'exciter è in grado di generare alte frequenze a partire da segnali che ne difettano. E quello che succede, ad esempio, con alcune voci che, per quanto intonate, in fase di missaggio mancano di 'mordente'. Il processore è in grado di conferire a queste voci caratteristiche come la brillantezza e la definizione. A volte un exciter viene impiegato su un intero mix al fine di equilibrarne il contenuto in frequenza. Un altro utilizzo è nel campo radio-televisivo: talvolta le pubblicità vengono trattate con un exciter in modo da risaltare maggiormente l audio rispetto ai suoni della normale programmazione.
46 Processori: il wah-wah Questo processore viene applicato principalmente alle chitarre elettriche e acustiche. Consiste in un filtro passa basso che presenta un picco in corrispondenza della frequenza di taglio.
47 Processori: il wah-wah Di solito la frequenza di taglio viene modificata grazie ad un pedale il quale aziona un potenziometro, ma talvolta viene modulata mediante un LFO o addirittura dall'ampiezza del segnale di ingresso. In quest ultimo caso, quando una corda viene pizzicata, il segnale si trova nella fase di attacco e dunque ha l'ampiezza maggiore. Ciò si traduce in una frequenza di taglio elevata. Man mano che l'inviluppo del suono decade, diminuisce anche la frequenza di taglio. Questa traslazione della frequenza di taglio genera il suono tipico del Wah- Wah.
48 Processori: il compressore È sicuramente il processore più importante. Il compressore agisce sulla dinamica del segnale di ingresso, riducendone l'ampiezza quando questa supera una certa soglia. La riduzione viene espressa con un rapporto, per esempio 3:1. Ciò significa che quando il segnale supera la soglia, la parte di segnale al di sopra di questa viene ridotta a 1/3:
49 Processori: il compressore Nella figura precedente la linea verde sulla sinistra rappresenta il segnale che si presenta all'ingresso del compressore. Le ampiezze di riferimento sono misurate in db u e possiamo notare che il segnale ha una dinamica di 50 db. La figura mostra anche la soglia scelta per l'azione del compressore e cioè -20 db. Nella figura di destra vediamo il risultato di una compressione 3:1. La parte di segnale al di sotto della soglia è rimasta invariata, mentre la parte superiore (vedi linea verde) è stata ridotta a 1/3 e dunque la parte di dinamica superiore alla soglia che era di 30 db si è ridotta a 10 db. La dinamica complessiva è dunque stata ridotta da 50 db a 30 db.
50 Processori: il compressore Vediamo ora nel dettaglio i controlli del compressore: 1. Threshold (Soglia): Questo valore è espresso in db e determina la soglia oltre la quale il compressore entra in azione. 2. Ratio (Rapporto): Quantifica la riduzione di ampiezza del segnale al di sopra della soglia. Alcuni rapporti tipici sono: 1:1 - Assenza di compressione, il segnale di uscita è lo stesso del segnale di ingresso. 2:1 - Il segnale al di sopra della soglia viene dimezzato. Se il segnale supera la soglia di 10 db il suo valore verrà ridotto a 5 db sopra la soglia. Altri valori sono 3:1, 4:1 ecc. Per valori superiori a 10:1 il compressore si comporta praticamente come un limitatore.
51 Processori: il compressore Nella figura seguente viene mostrata la curva di compressione di un compressore per diversi valori del rapporto di compressione:
52 Processori: il compressore 3. Attack time (Tempo di attacco): Indica il tempo impiegato dal compressore per entrare in azione dopo che il segnale ha superato la soglia e viene indicato in millisecondi. Nella figura seguente vengono paragonate due situazioni con tempo di attacco corto e lungo: Lasciare un tempo di attacco lungo significa che il segnale che ha superato la soglia, finché non è passato il tempo di attacco, non viene compresso. Esaurito il tempo di attacco, il compressore riduce l'ampiezza del segnale: questo ha la conseguenza di evidenziare la parte iniziale dei suoni.
53 Processori: il compressore 4. Release time (Tempo di rilascio): è identico al precedente, ma si riferisce al tempo impiegato dal compressore per disinserirsi. In alcuni modelli questi due parametri vengono tarati in fase di costruzione e non è possibile modificarli. 5. Gain (guadagno): tra i parametri disponibili, spesso esiste anche una regolazione di gain (o gain-adjust) per adeguare il volume dopo la compressione. Infatti, usando una compressione abbastanza alta, il livello d uscita potrebbe diventare molto basso. In questo caso sarebbe assurdo alzare il volume del canale del mixer.
54 Processori: il compressore In definitiva per regolare in maniera efficace un compressore, si lavora sul parametro gain per portare a un livello udibile le parti molto soft. A questo punto per non far distorcere le parti più "heavy", si setta la soglia dalla quale si vuole iniziare a comprimere (dipende dalle esigenze) con il relativo rapporto. Per un rullante o una cassa, che un buon batterista in genere impara a suonare a un livello omogeneo nel corso del pezzo, si dovrà intervenire poco sui parametri di threshold e ratio, mentre bisogna settare il tempo di attacco a un valore basso (circa 10/20 ms) perché i suoni percussivi sono immediati per natura. Evitare di settare il tempo di attacco ad un valore più basso, altrimenti si comprimerà anche l attacco iniziale, col risultato di privare il colpo della sua parte più importante. Per comprimere la voce di un cantante (che alterna parti soft e parti forti), bisognerà aumentare i tempi di attacco e release (per dare un andamento più naturale), ed incrementare la ratio di compressione. Tutto dipende dalla differenza fra le parti extrasoft e quelle fortissime: maggiore é questa differenza, maggiore sarà il lavoro del compressore per livellare il tutto.
DELAY ECO, DELAY, FLANGER, CHORUS, FILTRI COMB, FILTRI ALLPASS, PHASER
 ECO,, FLANGER, CHORUS, FILTRI COMB, FILTRI ALLPASS, PHASER Tommaso Rosati 2 Delay E il ritardo che applico a un suono in entrata. Da origine alla maggior parte degli effetti che oggi conosciamo. Filtri
ECO,, FLANGER, CHORUS, FILTRI COMB, FILTRI ALLPASS, PHASER Tommaso Rosati 2 Delay E il ritardo che applico a un suono in entrata. Da origine alla maggior parte degli effetti che oggi conosciamo. Filtri
PROCESSORI DI DINAMICA ENVELOPE FOLLOWER COMPRESSORI LIMITER ESPANSORI GATE
 PROCESSORI DI DINAMICA ENVELOPE FOLLOWER COMPRESSORI LIMITER ESPANSORI GATE Tommaso Rosati 2 PROCESSORI DI DINAMICA I processori di dinamica sono dispositivi che incidono sul parametro ampiezza di un suono
PROCESSORI DI DINAMICA ENVELOPE FOLLOWER COMPRESSORI LIMITER ESPANSORI GATE Tommaso Rosati 2 PROCESSORI DI DINAMICA I processori di dinamica sono dispositivi che incidono sul parametro ampiezza di un suono
Le modulazioni impulsive
 Le modulazioni impulsive a cura di Francesco Galgani (www.galgani.it) Indice 1 Introduzione 2 2 La modulazione PAM 3 2.1 Cenni teorici....................................... 3 2.2 Simulazione con il computer
Le modulazioni impulsive a cura di Francesco Galgani (www.galgani.it) Indice 1 Introduzione 2 2 La modulazione PAM 3 2.1 Cenni teorici....................................... 3 2.2 Simulazione con il computer
Un filtro Passa-Basso consente alle frequenze che precedono il punto chiamato frequenza di taglio f c (cutoff frequency) di passare attraverso di
 I filtri I filtri vengono utilizzati per eliminare delle bande di frequenze dal segnale originario. Generalmente vengono realizzati con una circuiteria passiva, sono identificati da una frequenza di taglio
I filtri I filtri vengono utilizzati per eliminare delle bande di frequenze dal segnale originario. Generalmente vengono realizzati con una circuiteria passiva, sono identificati da una frequenza di taglio
LA SCALA LOGARITMICA
 Decibel e suono LA SCALA LOGARITMICA Una scala descrive il rapporto tra due grandezze. La scala logaritmica si differenzia dalla scala lineare per il fatto che la proporzionalità tra le due grandezze non
Decibel e suono LA SCALA LOGARITMICA Una scala descrive il rapporto tra due grandezze. La scala logaritmica si differenzia dalla scala lineare per il fatto che la proporzionalità tra le due grandezze non
Curva caratteristica del transistor
 Curva caratteristica del transistor 1 AMPLIFICATORI Si dice amplificatore un circuito in grado di aumentare l'ampiezza del segnale di ingresso. Un buon amplificatore deve essere lineare, nel senso che
Curva caratteristica del transistor 1 AMPLIFICATORI Si dice amplificatore un circuito in grado di aumentare l'ampiezza del segnale di ingresso. Un buon amplificatore deve essere lineare, nel senso che
L A B O R A T O R I O D I I N F O R M A T I C A M U S I C A L E
 L A B O R A T O R I O D I I N F O R M A T I C A M U S I C A L E MANIPOLAZIO NE DEL SE GNALE AUDIO E MU SI C INFOR MA TI ON R E TR IE VA L G.PRESTI - 21/03/2016 - LE ZI ON E 5 1. LINEE DI RITARDO Una linea
L A B O R A T O R I O D I I N F O R M A T I C A M U S I C A L E MANIPOLAZIO NE DEL SE GNALE AUDIO E MU SI C INFOR MA TI ON R E TR IE VA L G.PRESTI - 21/03/2016 - LE ZI ON E 5 1. LINEE DI RITARDO Una linea
Il suono: periodo e frequenza
 Il suono: periodo e frequenza Effetti di risonanza e interferenza Un video Clic Analisi di suoni semplici e complessi Un altro video Clic IL DIAPASON (I) ll diapason è un oscillatore armonico. Il valore
Il suono: periodo e frequenza Effetti di risonanza e interferenza Un video Clic Analisi di suoni semplici e complessi Un altro video Clic IL DIAPASON (I) ll diapason è un oscillatore armonico. Il valore
Laboratorio di Tecnologie Informatiche per il Suono e la Musica. Esercitazione 3. Dott. Patrizio Barbini
 Laboratorio di Tecnologie Informatiche per il Suono e la Musica Esercitazione 3 Dott. Patrizio Barbini Wahwah Effetti Wahwah: applica al segnale un filtro passa-banda che oscilla (secondo la frequenza
Laboratorio di Tecnologie Informatiche per il Suono e la Musica Esercitazione 3 Dott. Patrizio Barbini Wahwah Effetti Wahwah: applica al segnale un filtro passa-banda che oscilla (secondo la frequenza
Rappresentazione digitale del suono
 Rappresentazione digitale del suono Perché rappresentazione del suono Trasmettere a distanza nel tempo e nello spazio un suono Registrazione e riproduzione per tutti Elaborazione del segnale audio per
Rappresentazione digitale del suono Perché rappresentazione del suono Trasmettere a distanza nel tempo e nello spazio un suono Registrazione e riproduzione per tutti Elaborazione del segnale audio per
Elementi di informatica musicale Conservatorio G. Tartini a.a Sintesi del suono. Sintesi del suono
 Elementi di informatica musicale Conservatorio G. Tartini a.a. 2001-2002 Sintesi del suono Ing. Antonio Rodà Sintesi del suono E neccessaria una tecnica di sintesi, ossia un particolare procedimento per
Elementi di informatica musicale Conservatorio G. Tartini a.a. 2001-2002 Sintesi del suono Ing. Antonio Rodà Sintesi del suono E neccessaria una tecnica di sintesi, ossia un particolare procedimento per
Principi di acustica
 26 Maggio 2016 Principi di acustica Cos è il suono? Cos è il suono? Il suono è un fenomeno fisico oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico. È il risultato di una perturbazione ondulatoria che viene
26 Maggio 2016 Principi di acustica Cos è il suono? Cos è il suono? Il suono è un fenomeno fisico oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico. È il risultato di una perturbazione ondulatoria che viene
valore v u = v i / 2 V u /V i = 1/ 2
 I Filtri Il filtro è un circuito che ricevendo in ingresso segnali di frequenze diverse è in grado di trasferire in uscita solo i segnali delle frequenze volute, in pratica seleziona le frequenze che si
I Filtri Il filtro è un circuito che ricevendo in ingresso segnali di frequenze diverse è in grado di trasferire in uscita solo i segnali delle frequenze volute, in pratica seleziona le frequenze che si
a.a. 2014/2015 Docente: Stefano Bifaretti
 a.a. 2014/2015 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore
a.a. 2014/2015 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Gli schemi circuitali impiegati per la realizzazione dei convertitori statici sono molteplici. Infatti, la struttura del convertitore
Amplificatori Ottici
 Amplificatori Ottici Amplificazione ottica (1/2) Per controbilanciare l attenuazione della fibra, sono utili gli amplificatori ottici E () t = GE () t + n() t out in Rumore ottico generato dall amplificatore
Amplificatori Ottici Amplificazione ottica (1/2) Per controbilanciare l attenuazione della fibra, sono utili gli amplificatori ottici E () t = GE () t + n() t out in Rumore ottico generato dall amplificatore
INTERAZIONE ELETTROMAGNETICA. Una corrente che passa in un conduttore genera un campo magnetico intorno al conduttore stesso.
 INTERAZIONE ELETTROMAGNETICA Una corrente che passa in un conduttore genera un campo magnetico intorno al conduttore stesso. INTERAZIONE ELETTROMAGNETICA L'intensità del campo magnetico è proporzionale
INTERAZIONE ELETTROMAGNETICA Una corrente che passa in un conduttore genera un campo magnetico intorno al conduttore stesso. INTERAZIONE ELETTROMAGNETICA L'intensità del campo magnetico è proporzionale
Montaggio audio ed editing in Adobe Première
 Montaggio audio ed editing in Adobe Première Per rendere più agevole ed efficace le operazioni di montaggio ed editing audio in Première, vi sono alcune configurazioni nel settaggio che vanno impostate:
Montaggio audio ed editing in Adobe Première Per rendere più agevole ed efficace le operazioni di montaggio ed editing audio in Première, vi sono alcune configurazioni nel settaggio che vanno impostate:
Audio pr p of o. Ro R b o e b r e to o Ca C r a lo o Giuse u p se p p e p e T i T rel e il
 Audio prof. Roberto Carlo Giuseppe Tirelli File Audio I file audio si possono ridurre a due categorie: 1. file di campionamento (*.wav) 1. File MIDI (*.mid) Campionatura La registrazione digitale si basa
Audio prof. Roberto Carlo Giuseppe Tirelli File Audio I file audio si possono ridurre a due categorie: 1. file di campionamento (*.wav) 1. File MIDI (*.mid) Campionatura La registrazione digitale si basa
INTO THE MUSIC by GAGGERO
 INTO THE MUSIC by GAGGERO CORSO BASE PER LA COMPOSIZIONE DI MUSICA ELETTRONICA Finalità Il corso vuole preparare al ruolo di compositore e programmatore musicale attraverso l'uso di strumentazione analogica
INTO THE MUSIC by GAGGERO CORSO BASE PER LA COMPOSIZIONE DI MUSICA ELETTRONICA Finalità Il corso vuole preparare al ruolo di compositore e programmatore musicale attraverso l'uso di strumentazione analogica
SENSORE PER LA MISURA DEL RUMORE (IL FONOMETRO)
 SENSORE PER LA MISURA DEL RUMORE (IL FONOMETRO) Il fonometro è un dispositivo elettroacustico per la misura del livello di pressione sonora. La sua funzione principale p è quella di convertire un segnale
SENSORE PER LA MISURA DEL RUMORE (IL FONOMETRO) Il fonometro è un dispositivo elettroacustico per la misura del livello di pressione sonora. La sua funzione principale p è quella di convertire un segnale
Le caratteristiche del SUONO 1 / 22
 Le caratteristiche del SUONO 1 / 22 Nella vita di ogni giorno siamo continuamente circondati da SUONI e da RUMORI. Ma di che cosa si tratta concretamente? Sia i suoni che i rumori sono EVENTI SONORI ossia
Le caratteristiche del SUONO 1 / 22 Nella vita di ogni giorno siamo continuamente circondati da SUONI e da RUMORI. Ma di che cosa si tratta concretamente? Sia i suoni che i rumori sono EVENTI SONORI ossia
SIGNAL PROCESSING. Progetto alternanza scuola lavoro Svolto da : Victor Bianconi, Federico Ranocchia, Pietro Bordellini, Romani Tommaso
 SIGNAL PROCESSING Progetto alternanza scuola lavoro Svolto da : Victor Bianconi, Federico Ranocchia, Pietro Bordellini, Romani Tommaso Tutoraggio interno di : Fabrizio Frescura e Giuseppe Baruffa OBIETTIVI
SIGNAL PROCESSING Progetto alternanza scuola lavoro Svolto da : Victor Bianconi, Federico Ranocchia, Pietro Bordellini, Romani Tommaso Tutoraggio interno di : Fabrizio Frescura e Giuseppe Baruffa OBIETTIVI
Le misure di tempo e frequenza
 Le misure di tempo e frequenza Le misure di tempo e frequenza costituiscono un importante branca delle misure elettriche ed elettroniche ed in generale delle misure di grandezze fisiche. E possibile raggiungere
Le misure di tempo e frequenza Le misure di tempo e frequenza costituiscono un importante branca delle misure elettriche ed elettroniche ed in generale delle misure di grandezze fisiche. E possibile raggiungere
1.3d: La Codifica Digitale dei Suoni
 1.3d: La Codifica Digitale dei Suoni 2 Bibliografia Curtin, 10.4 (vecchie edizioni) Curtin, 9.4 (nuova edizione) CR pag. 18-20 Questi lucidi 3 Il Suono Se pizzichiamo la corda di una chitarra ci accorgiamo
1.3d: La Codifica Digitale dei Suoni 2 Bibliografia Curtin, 10.4 (vecchie edizioni) Curtin, 9.4 (nuova edizione) CR pag. 18-20 Questi lucidi 3 Il Suono Se pizzichiamo la corda di una chitarra ci accorgiamo
Il tema proposto può essere risolto seguendo due ipotesi:
 Per la trattazione delle tecniche TDM, PM e Trasmissione dati si rimanda alle schede 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del libro Le Telecomunicazioni del Prof. F. Dell Aquila. Il tema proposto può essere
Per la trattazione delle tecniche TDM, PM e Trasmissione dati si rimanda alle schede 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del libro Le Telecomunicazioni del Prof. F. Dell Aquila. Il tema proposto può essere
CAMPIONAMENTO CATENA ELETTROACUSTICA DIGITALE, CAMPIONAMENTO, QUANTIZZAZIONE
 CAMPIONAMENTO CATENA ELETTROACUSTICA DIGITALE, CAMPIONAMENTO, QUANTIZZAZIONE Catena elettroacustica DIGITALE 2 Compressione/ Rarefazione dell aria Compressione/ Rarefazione dell aria ADC DAC Segnale elettrico
CAMPIONAMENTO CATENA ELETTROACUSTICA DIGITALE, CAMPIONAMENTO, QUANTIZZAZIONE Catena elettroacustica DIGITALE 2 Compressione/ Rarefazione dell aria Compressione/ Rarefazione dell aria ADC DAC Segnale elettrico
CORSO%DI%% A.A.% % Sezione%03c% SPETTRO ACUSTICO FISICA%TECNICA%AMBIENTALE%
 1 CORSO%DI%% FISICA%TECNICA%AMBIENTALE% A.A.%201352014% Sezione%03c%!! Prof. Ing. Sergio Montelpare! Dipartimento INGEO! Università G. d Annunzio Chieti-Pescara" 2 Le caratteristiche fondamentali del suono"
1 CORSO%DI%% FISICA%TECNICA%AMBIENTALE% A.A.%201352014% Sezione%03c%!! Prof. Ing. Sergio Montelpare! Dipartimento INGEO! Università G. d Annunzio Chieti-Pescara" 2 Le caratteristiche fondamentali del suono"
Filtri passivi Risposta in frequenza dei circuiti RC-RL-RLC
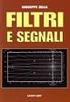 23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
23. Guadagno di un quadripolo Filtri passivi isposta in frequenza dei circuiti C-L-LC In un quadripolo generico (fig. ) si definisce guadagno G il rapporto tra il valore d uscita e quello d ingresso della
Filtro attivo per la compensazione delle armoniche
 SEI SISTEMI S.R.L. Via Calamelli, 40-40026 IMOLA - BO Tel. 0542 640245 - Fax 0542 641018 E - mail: siei@sieisistemi.it Filtro attivo per la compensazione delle armoniche (SAF Shunt Active Filter) SEI SISTEMI
SEI SISTEMI S.R.L. Via Calamelli, 40-40026 IMOLA - BO Tel. 0542 640245 - Fax 0542 641018 E - mail: siei@sieisistemi.it Filtro attivo per la compensazione delle armoniche (SAF Shunt Active Filter) SEI SISTEMI
Audio. D. I. Box. Processore di suono BBE. Serie Sonic Maximizer. Serie Sonic Maximizer ,00 01/09/2008 DI-50X 118,00
 BBE Audio Processore di suono 362 140,00 D D. I. Box DI-50X 118,00 2 Canali con controlli accoppiati - Ingressi e uscite sbilanciati Jack 1/4" - Livello di uscita max:+16dbu - Rapporto segnale/rumore:+108db
BBE Audio Processore di suono 362 140,00 D D. I. Box DI-50X 118,00 2 Canali con controlli accoppiati - Ingressi e uscite sbilanciati Jack 1/4" - Livello di uscita max:+16dbu - Rapporto segnale/rumore:+108db
La codifica dei suoni
 La codifica dei suoni I suoni costituiscono un tipo di informazione con cui siamo costantemente a contatto (linguaggio parlato, musica, rumori) Anche i suoni possono essere rappresentati in forma digitale
La codifica dei suoni I suoni costituiscono un tipo di informazione con cui siamo costantemente a contatto (linguaggio parlato, musica, rumori) Anche i suoni possono essere rappresentati in forma digitale
SEGNALI STAZIONARI: ANALISI SPETTRALE
 SEGNALI STAZIONARI: ANALISI SPETTRALE Analisi spettrale: rappresentazione delle componenti in frequenza di un segnale (ampiezza vs. frequenza). Fornisce maggiori dettagli rispetto all analisi temporale
SEGNALI STAZIONARI: ANALISI SPETTRALE Analisi spettrale: rappresentazione delle componenti in frequenza di un segnale (ampiezza vs. frequenza). Fornisce maggiori dettagli rispetto all analisi temporale
Quanto bene conosciamo i Segnali Sismici?
 Quanto bene conosciamo i Segnali Sismici? In generale, quello registrato non è esattamente il moto del suolo ma la risposta dell apparato strumentale a questo movimento In pratica, lo strumento provoca
Quanto bene conosciamo i Segnali Sismici? In generale, quello registrato non è esattamente il moto del suolo ma la risposta dell apparato strumentale a questo movimento In pratica, lo strumento provoca
In elettronica un filtro elettronico è un sistema o dispositivo che realizza
 Filtri V.Russo Cos è un Filtro? In elettronica un filtro elettronico è un sistema o dispositivo che realizza delle funzioni di trasformazione o elaborazione (processing) di segnali posti al suo ingresso.
Filtri V.Russo Cos è un Filtro? In elettronica un filtro elettronico è un sistema o dispositivo che realizza delle funzioni di trasformazione o elaborazione (processing) di segnali posti al suo ingresso.
RELAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI ITIS Vobarno Titolo: Oscillatori sinusoidali
 RELAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI ITIS Vobarno Titolo: Oscillatori sinusoidali Nome: Samuele Sandrini 4AT 7/3/5 Gli oscillatori sinusoidali sono circuiti che producono un segnale sinusoidale di ampiezza e
RELAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI ITIS Vobarno Titolo: Oscillatori sinusoidali Nome: Samuele Sandrini 4AT 7/3/5 Gli oscillatori sinusoidali sono circuiti che producono un segnale sinusoidale di ampiezza e
1.3c: La Codifica Digitale dei Suoni
 Prof. Alberto Postiglione Dipartimento di Scienze della Comunicazione Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno 1.3c: La Codifica Digitale dei Suoni Informatica Generale (Corso di
Prof. Alberto Postiglione Dipartimento di Scienze della Comunicazione Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno 1.3c: La Codifica Digitale dei Suoni Informatica Generale (Corso di
ANALISI DI FREQUENZA
 Giada Grosoli matr. 1391 Lezione del 19/1/ ora 8:3-1:3 ANALISI DI FREQUENZA Nello studio dell acustica è molto importante l analisi di frequenza del suono. E fondamentale infatti valutare, oltre al livello
Giada Grosoli matr. 1391 Lezione del 19/1/ ora 8:3-1:3 ANALISI DI FREQUENZA Nello studio dell acustica è molto importante l analisi di frequenza del suono. E fondamentale infatti valutare, oltre al livello
ABBINAMENTI AMPLIFICATORE - CASSA - IMPEDENZE
 ABBINAMENTI AMPLIFICATORE - CASSA - IMPEDENZE Abbinare un amplificatore ad una coppia di casse è una cosa abbastanza semplice da realizzare, basta qualche nozione facile. Che potenza serve? Chiariamo innanzitutto
ABBINAMENTI AMPLIFICATORE - CASSA - IMPEDENZE Abbinare un amplificatore ad una coppia di casse è una cosa abbastanza semplice da realizzare, basta qualche nozione facile. Che potenza serve? Chiariamo innanzitutto
Banda passante e sviluppo in serie di Fourier
 CONTROLLI AUTOMATICI Ingegneria Meccanica e Ingegneria del Veicolo http://www.dii.unimore.it/~lbiagiotti/controlliautomatici.html Banda passante e sviluppo in serie di Fourier Ing. e-mail: luigi.biagiotti@unimore.it
CONTROLLI AUTOMATICI Ingegneria Meccanica e Ingegneria del Veicolo http://www.dii.unimore.it/~lbiagiotti/controlliautomatici.html Banda passante e sviluppo in serie di Fourier Ing. e-mail: luigi.biagiotti@unimore.it
Liceo Statale Sandro Pertini sezione: Liceo Musicale Dipartimento di Musica Programmazione didattica. Tecnologie Musicali
 Liceo Statale Sandro Pertini sezione: Liceo Musicale Dipartimento di Musica Programmazione didattica Tecnologie Musicali Tecnologie Musicali I anno Lo studente acquisisce le conoscenze di base per l utilizzo
Liceo Statale Sandro Pertini sezione: Liceo Musicale Dipartimento di Musica Programmazione didattica Tecnologie Musicali Tecnologie Musicali I anno Lo studente acquisisce le conoscenze di base per l utilizzo
Metodi di analisi della risposta acustica di ambienti chiusi
 26 Maggio 2016 Metodi di analisi della risposta acustica di ambienti chiusi Introduzione L Allegoria dei cinque sensi L uomo comunica e scambia informazioni col mondo esterno attraverso i sensi: vista,
26 Maggio 2016 Metodi di analisi della risposta acustica di ambienti chiusi Introduzione L Allegoria dei cinque sensi L uomo comunica e scambia informazioni col mondo esterno attraverso i sensi: vista,
Capitolo 12. Moto oscillatorio
 Moto oscillatorio INTRODUZIONE Quando la forza che agisce su un corpo è proporzionale al suo spostamento dalla posizione di equilibrio ne risulta un particolare tipo di moto. Se la forza agisce sempre
Moto oscillatorio INTRODUZIONE Quando la forza che agisce su un corpo è proporzionale al suo spostamento dalla posizione di equilibrio ne risulta un particolare tipo di moto. Se la forza agisce sempre
Esercitazione Misure su circuiti magnetici. 3 - Rilievo del ciclo di isteresi dinamico di un nucleo magnetico
 Esercitazione Misure su circuiti magnetici - 1 Esercitazione Misure su circuiti magnetici 1 - Oggetto Caratterizzazione di materiali magnetici. Strumento virtuale per il rilievo del ciclo di isteresi dinamico.
Esercitazione Misure su circuiti magnetici - 1 Esercitazione Misure su circuiti magnetici 1 - Oggetto Caratterizzazione di materiali magnetici. Strumento virtuale per il rilievo del ciclo di isteresi dinamico.
Lezione 2: Amplificatori operazionali. Prof. Mario Angelo Giordano
 Lezione 2: Amplificatori operazionali Prof. Mario Angelo Giordano L'amplificatore operazionale come circuito integrato è uno dei circuiti lineari maggiormente usati. L'amplificatore operazionale è un amplificatore
Lezione 2: Amplificatori operazionali Prof. Mario Angelo Giordano L'amplificatore operazionale come circuito integrato è uno dei circuiti lineari maggiormente usati. L'amplificatore operazionale è un amplificatore
Convertitori Tensione / Frequenza. Author: Ing. Sebastiano Giannitto (ITIS M.BARTOLO PACHINO)
 Convertitori Tensione / Frequenza Author: Ing. Sebastiano Giannitto (ITIS M.BARTOLO PACHINO) I convertitori tensione-frequenza (VFC: voltage to frequency converter) sono circuiti elettronici che forniscono
Convertitori Tensione / Frequenza Author: Ing. Sebastiano Giannitto (ITIS M.BARTOLO PACHINO) I convertitori tensione-frequenza (VFC: voltage to frequency converter) sono circuiti elettronici che forniscono
Reti di Calcolatori a.a
 Analogico e digitale 2 Corso di laurea in Informatica Reti di Calcolatori a.a. 2007-2008 Prof. Roberto De Prisco Capitolo 3 Dati e segnali Per essere trasmessi i dati devono essere trasformati in segnali
Analogico e digitale 2 Corso di laurea in Informatica Reti di Calcolatori a.a. 2007-2008 Prof. Roberto De Prisco Capitolo 3 Dati e segnali Per essere trasmessi i dati devono essere trasformati in segnali
Corso di Componenti e sistemi elettroacustici
 Corso di Componenti e sistemi elettroacustici Lezione 8 - Gli outboards Gli outboards sono rappresentati da tutta quella serie di apparecchi che completa l elaborazione del segnale audio aggiungendo effetti
Corso di Componenti e sistemi elettroacustici Lezione 8 - Gli outboards Gli outboards sono rappresentati da tutta quella serie di apparecchi che completa l elaborazione del segnale audio aggiungendo effetti
MULTIVIBRATORI NE 555
 MULTIVIBRATORI Si dice multivibratore un circuito in grado di generare in uscita una forma d'onda di tipo rettangolare. Vi sono tre tipi di multivibratori. Multivibratore monostabile, multivibratore bistabile,
MULTIVIBRATORI Si dice multivibratore un circuito in grado di generare in uscita una forma d'onda di tipo rettangolare. Vi sono tre tipi di multivibratori. Multivibratore monostabile, multivibratore bistabile,
Generatore. Generatore. Un sistema a raggi-x consiste di: Tubo a raggi-x. Sistema di rilevazione
 Generatore Un sistema a raggi-x consiste di: Tubo a raggi-x Sistema di rilevazione Generatore Il generatore trasferisce la potenza elettrica P (KW) al tubo a raggi-x I parametri U (KV) e I (ma) vengono
Generatore Un sistema a raggi-x consiste di: Tubo a raggi-x Sistema di rilevazione Generatore Il generatore trasferisce la potenza elettrica P (KW) al tubo a raggi-x I parametri U (KV) e I (ma) vengono
Gli alimentatori stabilizzati
 Gli alimentatori stabilizzati Scopo di un alimentatore stabilizzato è di fornire una tensione di alimentazione continua ( cioè costante nel tempo), necessaria per poter alimentare un dispositivo elettronico
Gli alimentatori stabilizzati Scopo di un alimentatore stabilizzato è di fornire una tensione di alimentazione continua ( cioè costante nel tempo), necessaria per poter alimentare un dispositivo elettronico
Dispense del corso di Fonia e Tecnico del Suono. anno accademico 2013/2014. Sesta lezione. Microfoni e speaker
 Dispense del corso di Fonia e Tecnico del Suono anno accademico 2013/2014 Sesta lezione Microfoni e speaker Legge di Faraday Intorno 1820 il fisico danese Hans Christian Ørsted scopri che una corrente
Dispense del corso di Fonia e Tecnico del Suono anno accademico 2013/2014 Sesta lezione Microfoni e speaker Legge di Faraday Intorno 1820 il fisico danese Hans Christian Ørsted scopri che una corrente
Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico. Laura Vallone
 Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico Laura Vallone Strumentazione a banda stretta Un misuratore di campo EM a banda stretta si compone di varie parti: o Sistema di ricezione
Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico Laura Vallone Strumentazione a banda stretta Un misuratore di campo EM a banda stretta si compone di varie parti: o Sistema di ricezione
I CIRCUITI DELLA CHITARRA ELETTRICA
 I CIRCUITI DELLA CHITARRA ELETTRICA 1 Principio di funzionamento Il principio di funzionamento di una chitarra elettrica si basa sulla Legge dell induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann-Lenz, secondo
I CIRCUITI DELLA CHITARRA ELETTRICA 1 Principio di funzionamento Il principio di funzionamento di una chitarra elettrica si basa sulla Legge dell induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann-Lenz, secondo
MISURA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA DI UN TUBO SONORO
 MISURA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA DI UN TUBO SONORO Scopo dell esperienza è lo studio della propagazione delle onde sonore all interno di un tubo, aperto o chiuso, contenete aria o altri gas. Si verificherà
MISURA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA DI UN TUBO SONORO Scopo dell esperienza è lo studio della propagazione delle onde sonore all interno di un tubo, aperto o chiuso, contenete aria o altri gas. Si verificherà
FAT VCO Rev 0 - Thermidor Technologies - Pagina 1. Il VCO del sintetizzatore FATMAN PAiA
 FAT VCO Rev 0 - Thermidor Technologies - Pagina 1 Il VCO del sintetizzatore FATMAN PAiA FAT VCO Rev 0 - Thermidor Technologies - Pagina 1 Indice INDICE INDICE... 1 1. INTRODUZIONE... 2 2. VCO PAiA... 3
FAT VCO Rev 0 - Thermidor Technologies - Pagina 1 Il VCO del sintetizzatore FATMAN PAiA FAT VCO Rev 0 - Thermidor Technologies - Pagina 1 Indice INDICE INDICE... 1 1. INTRODUZIONE... 2 2. VCO PAiA... 3
Un semplice multivibratore astabile si può realizzare con le porte logiche, come nel seguente circuito:
 Pagina 1 di 8 MULTIVIBRATORI Si dice multivibratore un circuito in grado di generare in uscita una forma d'onda di tipo rettangolare. Vi sono tre tipi di multivibratori. Multivibratore monostabile, multivibratore
Pagina 1 di 8 MULTIVIBRATORI Si dice multivibratore un circuito in grado di generare in uscita una forma d'onda di tipo rettangolare. Vi sono tre tipi di multivibratori. Multivibratore monostabile, multivibratore
Elaborazione di Immagini e Suoni / Riconoscimento e Visioni Artificiali 12 c.f.u. I suoni Rappresentazione digitale
 Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Informatica Elaborazione di Immagini e Suoni / Riconoscimento e Visioni Artificiali 12 c.f.u. Anno Accademico 2008/2009 Docente: ing. Salvatore
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Informatica Elaborazione di Immagini e Suoni / Riconoscimento e Visioni Artificiali 12 c.f.u. Anno Accademico 2008/2009 Docente: ing. Salvatore
Modulazione a larghezza di impulso ( PWM )
 Modulazione a larghezza di impulso ( PWM ) La tecnica denominata P.W.M. ( pulse width modulation ) consta essenzialmente nel trasmettere l informazione attraverso un segnale impulsivo mediante la larghezza
Modulazione a larghezza di impulso ( PWM ) La tecnica denominata P.W.M. ( pulse width modulation ) consta essenzialmente nel trasmettere l informazione attraverso un segnale impulsivo mediante la larghezza
Segnale Analogico. Forma d onda continua
 Segnale Analogico Forma d onda continua Rumore Segnale Analogico + Rumore Il rumore si sovrappone al segnale e lo altera, impossibile separare il segnale dal rumore Segnale Digitale Ideale Segnale discreto,
Segnale Analogico Forma d onda continua Rumore Segnale Analogico + Rumore Il rumore si sovrappone al segnale e lo altera, impossibile separare il segnale dal rumore Segnale Digitale Ideale Segnale discreto,
USO DELL OSCILLOSCOPIO PER LA MISURA DELLA VELOCITA' DEL SUONO NELL ARIA
 USO DELL OSCILLOSCOPIO PER LA MISURA DELLA VELOCITA' DEL SUONO NELL ARIA B. Cottalasso R. Ferrando AIF PLS Corso Estivo di Fisica Genova 2009 1 Scopo dell esperimento Ci si propone di misurare la velocità
USO DELL OSCILLOSCOPIO PER LA MISURA DELLA VELOCITA' DEL SUONO NELL ARIA B. Cottalasso R. Ferrando AIF PLS Corso Estivo di Fisica Genova 2009 1 Scopo dell esperimento Ci si propone di misurare la velocità
Il suono è dovuto alla vibrazione di un corpo elastico Le vibrazioni sono rapidi movimenti di oscillazione del corpo intorno ad una posizione di
 IL SUONO Il suono è dovuto alla vibrazione di un corpo elastico Le vibrazioni sono rapidi movimenti di oscillazione del corpo intorno ad una posizione di equilibrio Un corpo elastico è un corpo che può
IL SUONO Il suono è dovuto alla vibrazione di un corpo elastico Le vibrazioni sono rapidi movimenti di oscillazione del corpo intorno ad una posizione di equilibrio Un corpo elastico è un corpo che può
Amplificatori alle alte frequenze
 mplificatori alle alte frequenze lle alte frequenze, le capacità parassite dei dispositivi non sono più trascurabili ed esse provocano una diminuzione più o meno rapida del guadagno; noi studieremo, a
mplificatori alle alte frequenze lle alte frequenze, le capacità parassite dei dispositivi non sono più trascurabili ed esse provocano una diminuzione più o meno rapida del guadagno; noi studieremo, a
Elettronica Analogica. Luxx Luca Carabetta
 Elettronica Analogica Luxx Luca Carabetta Diodi Raddrizzatori Alimentatori Diodi Il nome sta a ricordare la struttura di questo componente, che è formato da due morsetti, anodo e katodo. La versione che
Elettronica Analogica Luxx Luca Carabetta Diodi Raddrizzatori Alimentatori Diodi Il nome sta a ricordare la struttura di questo componente, che è formato da due morsetti, anodo e katodo. La versione che
I SUONI. I suoni Il campionamento File Wave e Midi
 I SUONI I suoni Il campionamento File Wave e Midi IL SUONO I suoni consistono in vibrazioni che formano un onda, la cui ampiezza misura l altezza dell onda e il periodo è la distanza tra due onde. AMPIEZZA
I SUONI I suoni Il campionamento File Wave e Midi IL SUONO I suoni consistono in vibrazioni che formano un onda, la cui ampiezza misura l altezza dell onda e il periodo è la distanza tra due onde. AMPIEZZA
PRESSIONE SONORA. p 2 p
 II suono è un fenomeno acustico causato da perturbazioni di carattere oscillatorio che si propagano in un mezzo elastico (sia questo gassoso, liquido o solido) sotto forma di variazioni di pressione. II
II suono è un fenomeno acustico causato da perturbazioni di carattere oscillatorio che si propagano in un mezzo elastico (sia questo gassoso, liquido o solido) sotto forma di variazioni di pressione. II
L A B O R A T O R I O D I I N F O R M A T I C A M U S I C A L E
 L A B O R A T O R I O D I I N F O R M A T I C A M U S I C A L E MANIPOLAZIO NE DEL SE GNALE AUDIO E MU SI C INFOR MA TI ON R E TR IE VA L G.PRESTI - 09/03/2016 - LE ZI ON E 2 1. CONVERSIONE DA ANALOGICO
L A B O R A T O R I O D I I N F O R M A T I C A M U S I C A L E MANIPOLAZIO NE DEL SE GNALE AUDIO E MU SI C INFOR MA TI ON R E TR IE VA L G.PRESTI - 09/03/2016 - LE ZI ON E 2 1. CONVERSIONE DA ANALOGICO
Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA AC2. Circuiti in corrente alternata
 Scopo dell'esperienza: Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA AC2 Circuiti in corrente alternata. Uso di un generatore di funzioni (onda quadra e sinusoidale); 2.
Scopo dell'esperienza: Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA AC2 Circuiti in corrente alternata. Uso di un generatore di funzioni (onda quadra e sinusoidale); 2.
AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE
 AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE Per amplificatore differenziale si intende un circuito in grado di amplificare la differenza tra due segnali applicati in ingresso. Gli ingressi sono due: un primo ingresso
AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE Per amplificatore differenziale si intende un circuito in grado di amplificare la differenza tra due segnali applicati in ingresso. Gli ingressi sono due: un primo ingresso
13. Effetti. Tipo di effetto
 13. Effetti Lo strumento incorpora due processori digitali di effetti. Questo capitolo descrive le pagine di selezione e programmazione degli effetti contenute in ogni modo operativo. Ci sono 47 effetti,
13. Effetti Lo strumento incorpora due processori digitali di effetti. Questo capitolo descrive le pagine di selezione e programmazione degli effetti contenute in ogni modo operativo. Ci sono 47 effetti,
Primi metodi di misura delle vibrazioni
 Primi metodi di misura delle vibrazioni A causa dell assenza di strumenti opportuni, le vibrazioni venivano valutate semplicemente toccando la macchina; il trasferimento del segnale di vibrazione dalla
Primi metodi di misura delle vibrazioni A causa dell assenza di strumenti opportuni, le vibrazioni venivano valutate semplicemente toccando la macchina; il trasferimento del segnale di vibrazione dalla
La codifica dei suoni
 La codifica dei suoni I suoni costituiscono un tipo di informazione con cui siamo costantemente a contatto (linguaggio parlato, musica, rumori) Anche i suoni possono essere rappresentati in forma digitale
La codifica dei suoni I suoni costituiscono un tipo di informazione con cui siamo costantemente a contatto (linguaggio parlato, musica, rumori) Anche i suoni possono essere rappresentati in forma digitale
I.I.S.S. G. GALILEI A. SANI -ELETTRONICA Classe:5 - A\EN Data : 19\09\15 Elettronica - Gruppo n 4 : Salzillo_Pinna- Luogo: IISS GalileiSani -LT
 NOME: Marco COGNOME: Salzillo TITOLO: AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NON INVERTENTE OBBIETTIVO: REALIZZARE UN CIRCUITO OPERAZIONALE NON INVERTENTE CHE AMPLIFICA DI 11,7dB CIRCUITO TEORICO: CIRCUITO APPLICATIVO:
NOME: Marco COGNOME: Salzillo TITOLO: AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NON INVERTENTE OBBIETTIVO: REALIZZARE UN CIRCUITO OPERAZIONALE NON INVERTENTE CHE AMPLIFICA DI 11,7dB CIRCUITO TEORICO: CIRCUITO APPLICATIVO:
CORSO DI FONIA E TECNICO DEL SUONO PROGRAMMA 2014/2015
 CORSO DI FONIA E TECNICO DEL SUONO PROGRAMMA 2014/2015 MODULO 1 ELEMENTI DI ACUSTICA E PSICOACUSTICA Argomenti: Le caratteristiche fisiche del suono La propagazione del suono Fisiologia dell'apparato uditivo
CORSO DI FONIA E TECNICO DEL SUONO PROGRAMMA 2014/2015 MODULO 1 ELEMENTI DI ACUSTICA E PSICOACUSTICA Argomenti: Le caratteristiche fisiche del suono La propagazione del suono Fisiologia dell'apparato uditivo
INTRODUZIONE AL CONTROLLO DIGITALE
 INTRODUZIONE AL CONTROLLO DIGITALE Prima della rivoluzione digitale l implementazione hardware degli elementi di controllo e dei trasduttori era basata sull uso di componenti idraulici, pneumatici e di
INTRODUZIONE AL CONTROLLO DIGITALE Prima della rivoluzione digitale l implementazione hardware degli elementi di controllo e dei trasduttori era basata sull uso di componenti idraulici, pneumatici e di
Le onde. Definizione e classificazione
 Le onde Definizione e classificazione Onda: perturbazione che si propaga nello spazio, trasportando energia e quantità di moto, ma senza trasporto di materia Onde trasversali La vibrazione avviene perpendicolarmente
Le onde Definizione e classificazione Onda: perturbazione che si propaga nello spazio, trasportando energia e quantità di moto, ma senza trasporto di materia Onde trasversali La vibrazione avviene perpendicolarmente
Descrizione sintetica dell attività
 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI GONIOMETRICHE Prerequisiti: conoscenza della misura degli angoli in gradi e radianti conoscenza delle funzioni goniometriche concetto di funzione inversa conoscenza
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI GONIOMETRICHE Prerequisiti: conoscenza della misura degli angoli in gradi e radianti conoscenza delle funzioni goniometriche concetto di funzione inversa conoscenza
percorso 4 Estensione on line lezione 2 I fattori della produzione e le forme di mercato La produttività La produzione
 Estensione on line percorso 4 I fattori della produzione e le forme di mercato lezione 2 a produzione a produttività Una volta reperiti i fattori produttivi necessari l imprenditore dovrà decidere come
Estensione on line percorso 4 I fattori della produzione e le forme di mercato lezione 2 a produzione a produttività Una volta reperiti i fattori produttivi necessari l imprenditore dovrà decidere come
TECNOLOGIE MUSICALI. Liceo Musicale Chris Cappell
 TECNOLOGIE MUSICALI Liceo Musicale Chris Cappell PARAMETRI E PERCEZIONE TEST DI FONOSIMBOLISMO 1. LOCK / LICK quale delle 2 indica oggetto di forma sferica? 2. MIDREF / BUDREF quale delle 2 indica oggetto
TECNOLOGIE MUSICALI Liceo Musicale Chris Cappell PARAMETRI E PERCEZIONE TEST DI FONOSIMBOLISMO 1. LOCK / LICK quale delle 2 indica oggetto di forma sferica? 2. MIDREF / BUDREF quale delle 2 indica oggetto
Indice: Introduzione 2. L'onda (La sinusoide del nostro segnale) 3. Adsr 4. I cavi 6. Tipo di connettori 7. Gli alimentatori 9. L'amplificatore 11
 Indice: Introduzione 2 L'onda (La sinusoide del nostro segnale) 3 Adsr 4 I cavi 6 Tipo di connettori 7 Gli alimentatori 9 L'amplificatore 11 Le valvole 15 I trasduttori elettroacustici 16 Il compressore
Indice: Introduzione 2 L'onda (La sinusoide del nostro segnale) 3 Adsr 4 I cavi 6 Tipo di connettori 7 Gli alimentatori 9 L'amplificatore 11 Le valvole 15 I trasduttori elettroacustici 16 Il compressore
Lampade fluorescenti Generalità sulle lampade fluorescenti:
 Lampade fluorescenti Generalità sulle lampade fluorescenti: Le lampade fluorescenti sono lampade a scarica, cioè è il meccanismo della scarica elettrica in un gas a determinare l emissione luminosa, direttamente
Lampade fluorescenti Generalità sulle lampade fluorescenti: Le lampade fluorescenti sono lampade a scarica, cioè è il meccanismo della scarica elettrica in un gas a determinare l emissione luminosa, direttamente
I SISTEMI AUTOMATICI
 I SISTEMI AUTOMATICI GENERALITA I sistemi automatici trovano la più ampia diffusione in tutti i settori: dalle linee di produzione; ai mezzi di trasporto; alle applicazioni civili;... CARATTERISTICHE RICHIESTE
I SISTEMI AUTOMATICI GENERALITA I sistemi automatici trovano la più ampia diffusione in tutti i settori: dalle linee di produzione; ai mezzi di trasporto; alle applicazioni civili;... CARATTERISTICHE RICHIESTE
Analizzatore di spettro. Generalità sull analisi spettrale. Analizzatori a scansione. Analizzatori a doppia conversione. Analizzatore di spettro
 Analizzatore di spettro Analizzatore di spettro Analizzatori a scansione Analizzatori a doppia conversione 2 2006 Politecnico di Torino 1 Obiettivi della lezione Metodologici come eseguire l analisi spettrale
Analizzatore di spettro Analizzatore di spettro Analizzatori a scansione Analizzatori a doppia conversione 2 2006 Politecnico di Torino 1 Obiettivi della lezione Metodologici come eseguire l analisi spettrale
Seconda esercitazione per il corso di Sistemi di Telecom. 1 AA 07 08
 Seconda esercitazione per il corso di Sistemi di Telecom. AA 7 8 3th October 27 Abstract Scopo dell esercitazione Scopo dell esercitazione è la scrittura di una funzione Matlab per la decodifica di un
Seconda esercitazione per il corso di Sistemi di Telecom. AA 7 8 3th October 27 Abstract Scopo dell esercitazione Scopo dell esercitazione è la scrittura di una funzione Matlab per la decodifica di un
La natura fisica del suono
 Cenni di acustica La natura del suono La natura fisica del suono Vibrazione Onda disturbo che viaggia lontano dalla sorgente in tutte le direzioni (onde sull acqua) Vibrazione e onda un onda non trasporta
Cenni di acustica La natura del suono La natura fisica del suono Vibrazione Onda disturbo che viaggia lontano dalla sorgente in tutte le direzioni (onde sull acqua) Vibrazione e onda un onda non trasporta
STUDIO DELLE RIFLESSIONI SONORE NELLE STANZE D'ASCOLTO
 STUDIO DELLE RIFLESSIONI SONORE NELLE STANZE D'ASCOLTO 36 Convegno Associazione Italiana Acustica - Torino 2009 L. Rizzi F. Nastasi Studio Ingegneria Acustica Rizzi - Lecco Contesto: - Ascoltiamo quotidianamente
STUDIO DELLE RIFLESSIONI SONORE NELLE STANZE D'ASCOLTO 36 Convegno Associazione Italiana Acustica - Torino 2009 L. Rizzi F. Nastasi Studio Ingegneria Acustica Rizzi - Lecco Contesto: - Ascoltiamo quotidianamente
Amplificatori a retroazione negativa
 I.T.I.S. "Antonio Meucci" di Roma Amplificatori a retroazione negativa a cura del Prof. Mauro Perotti Anno Scolastico 2011-2012 Sommario 1. Schemi a blocchi...3 1.1. Caratteristiche degli schemi a blocchi...
I.T.I.S. "Antonio Meucci" di Roma Amplificatori a retroazione negativa a cura del Prof. Mauro Perotti Anno Scolastico 2011-2012 Sommario 1. Schemi a blocchi...3 1.1. Caratteristiche degli schemi a blocchi...
Sistemi Web per il turismo - lezione 3 -
 Sistemi Web per il turismo - lezione 3 - Software Si definisce software il complesso di comandi che fanno eseguire al computer delle operazioni. Il termine si contrappone ad hardware, che invece designa
Sistemi Web per il turismo - lezione 3 - Software Si definisce software il complesso di comandi che fanno eseguire al computer delle operazioni. Il termine si contrappone ad hardware, che invece designa
La sintesi sonora Elementi di un suono Ogni tipo di suono tre e la variazione Altezza ( Pitch, Frequenza Timbro ( Tone Volume Oscillatori Mixer
 La sintesi sonora Elementi di un suono Per capire come un sintetizzatore genera un suono è importante conoscere le componenti che costituiscono il suono stesso. L unico modo in cui un suono può essere
La sintesi sonora Elementi di un suono Per capire come un sintetizzatore genera un suono è importante conoscere le componenti che costituiscono il suono stesso. L unico modo in cui un suono può essere
BOCCHIGLIERO Sistema di comunicazione ---- Materia: Telecomunicazioni. Serafini Rossella. prof. Ing. Zumpano Luigi
 I.P.S.I.A. Di BOCCHIGLIERO a.s. 2010/2011 -classe III- Materia: Telecomunicazioni ---- Sistema di comunicazione ---- alunna Serafini Rossella prof. Ing. Zumpano Luigi Sistema di comunicazione Messaggi
I.P.S.I.A. Di BOCCHIGLIERO a.s. 2010/2011 -classe III- Materia: Telecomunicazioni ---- Sistema di comunicazione ---- alunna Serafini Rossella prof. Ing. Zumpano Luigi Sistema di comunicazione Messaggi
Signal Processing. Studenti presso Liceo Scientifico Galeazzo Alessi: De Paola Vairo Gallea Danilo Postini Dennis Ragni Federico
 Signal Processing Studenti presso Liceo Scientifico Galeazzo Alessi: De Paola Vairo Gallea Danilo Postini Dennis Ragni Federico Tutor esterno: Prof. Fabrizio Frescura Tutor interno : Prof.ssa Claudia Zampolini
Signal Processing Studenti presso Liceo Scientifico Galeazzo Alessi: De Paola Vairo Gallea Danilo Postini Dennis Ragni Federico Tutor esterno: Prof. Fabrizio Frescura Tutor interno : Prof.ssa Claudia Zampolini
5. Amplificatori. Corso di Fondamenti di Elettronica Fausto Fantini a.a
 5. Amplificatori Corso di Fondamenti di Elettronica Fausto Fantini a.a. 2010-2011 Amplificazione Amplificare un segnale significa produrre un segnale in uscita (output) con la stessa forma d onda del segnale
5. Amplificatori Corso di Fondamenti di Elettronica Fausto Fantini a.a. 2010-2011 Amplificazione Amplificare un segnale significa produrre un segnale in uscita (output) con la stessa forma d onda del segnale
DAE Digital Audio Experience
 DAE Digital Audio Experience Carmine Ruffino (a.k.a. ) Premesse: Non è un corso di informatica musicale Vuole essere una panoramica sulle problematiche e strumenti usati nel trattamento digitale del suono
DAE Digital Audio Experience Carmine Ruffino (a.k.a. ) Premesse: Non è un corso di informatica musicale Vuole essere una panoramica sulle problematiche e strumenti usati nel trattamento digitale del suono
Onde Stazionarie
 Onde Stazionarie www.lepla.eu Obiettivo L'obiettivo di questo esperimento è analizzare l'impulso sonoro che si genera battendo, per esempio con un dito, un tubo di cartone. Cosa accade? quali sono le sue
Onde Stazionarie www.lepla.eu Obiettivo L'obiettivo di questo esperimento è analizzare l'impulso sonoro che si genera battendo, per esempio con un dito, un tubo di cartone. Cosa accade? quali sono le sue
Modulazione PAM Multilivello, BPSK e QPSK
 Modulazione PAM Multilivello, BPSK e QPSK P. Lombardo DIET, Univ. di Roma La Sapienza Modulazioni PAM Multilivello, BPSK e QPSK - 1 Rappresentazione analitica del segnale Sia {b(n)} una qualsiasi sequenza
Modulazione PAM Multilivello, BPSK e QPSK P. Lombardo DIET, Univ. di Roma La Sapienza Modulazioni PAM Multilivello, BPSK e QPSK - 1 Rappresentazione analitica del segnale Sia {b(n)} una qualsiasi sequenza
Un convertitore D/A o digitale/analogico è un dispositivo che ha lo scopo di
 Convertitore D/A Un convertitore D/A o digitale/analogico è un dispositivo che ha lo scopo di trasformare un dato digitale in una grandezza analogica, in generale una tensione. Naturalmente vi deve essere
Convertitore D/A Un convertitore D/A o digitale/analogico è un dispositivo che ha lo scopo di trasformare un dato digitale in una grandezza analogica, in generale una tensione. Naturalmente vi deve essere
GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI
 Elettronica & Telecomunicazioni GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI Alunni Marcone Luigina Martire Settimio Classe V B Anno Scolastico 1999/2000 GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI Alunni: Marcone Luigina, Martire
Elettronica & Telecomunicazioni GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI Alunni Marcone Luigina Martire Settimio Classe V B Anno Scolastico 1999/2000 GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI Alunni: Marcone Luigina, Martire
Risposta in frequenza degli amplificatori RC
 Risposta in frequenza degli amplificatori RC Abbiamo già avuto occasione di vedere che, al variare della frequenza, l'amplificatore RC si comporta come un filtro passa banda a causa del taglio alle basse
Risposta in frequenza degli amplificatori RC Abbiamo già avuto occasione di vedere che, al variare della frequenza, l'amplificatore RC si comporta come un filtro passa banda a causa del taglio alle basse
I convertitori c.a.-c.a. possono essere suddivisi in tre categorie: convertitori a controllo di fase, cicloconvertitori, convertitori a matrice.
 Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della
Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della
Corso di ELETTRONICA INDUSTRIALE INVERTITORI MONOFASE A TENSIONE IMPRESSA
 1 Corso di LTTRONICA INDUSTRIAL INVRTITORI MONOFAS A TNSION IMPRSSA 0. 2 Principi di funzionamento di invertitori monofase a tensione impressa 0. 3 Principi di funzionamento di invertitori monofase a tensione
1 Corso di LTTRONICA INDUSTRIAL INVRTITORI MONOFAS A TNSION IMPRSSA 0. 2 Principi di funzionamento di invertitori monofase a tensione impressa 0. 3 Principi di funzionamento di invertitori monofase a tensione
SISTEMI DI CONTROLLO Ingegneria Meccanica e Ingegneria del Veicolo.
 SISTEMI DI CONTROLLO Ingegneria Meccanica e Ingegneria del Veicolo http://www.dii.unimore.it/~lbiagiotti/sistemicontrollo.html Banda passante e sviluppo in serie di Fourier Ing. Luigi Biagiotti e-mail:
SISTEMI DI CONTROLLO Ingegneria Meccanica e Ingegneria del Veicolo http://www.dii.unimore.it/~lbiagiotti/sistemicontrollo.html Banda passante e sviluppo in serie di Fourier Ing. Luigi Biagiotti e-mail:
