Le nuove norme sul capitale nel periodo transitorio
|
|
|
- Aureliana Molinari
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le nuove norme sul capitale nel periodo transitorio Relazione sull analisi d impatto 1. Introduzione Il phasing-in delle norme sul capitale Le opzioni normative Gli impatti patrimoniali stimati Una valutazione complessiva Applicazione della disciplina dei buffer alle SIM Natura e finalità dei buffer Valutazioni d impatto... 9 Ottobre
2 1. Introduzione La presente analisi d impatto della regolamentazione (AIR) accompagna il documento di consultazione della Banca d Italia in materia di esercizio delle discrezionalità previste nel periodo transitorio (phasing-in) dalla nuova disciplina europea sul capitale delle banche e delle imprese di investimento (CRD4-CRR) 1. L analisi, condotta secondo i criteri della Circolare n. 277 del 2010 ( Linee guida per l analisi d impatto della regolamentazione ), mira a fornire utili elementi di valutazione in merito alle diverse opzioni regolamentari prese in considerazione nel processo normativo. Il documento è articolato come segue. Nel paragrafo 2 si riporta l AIR sulle opzioni normative relative alle regole per le banche. Il paragrafo 3 contiene l analisi condotta sulla possibilità di esentare le SIM di minore dimensione dall applicazione del capital conservation buffer e del countercyclical buffer. 2. Il phasing-in delle norme sul capitale In analogia a quanto avviene nelle informative periodiche prodotte dal Comitato di Basilea e dall EBA, si fa nel seguito riferimento alla nozione di shortfall (o a sue varianti) 2, quale principale metrica per la misurazione degli impatti patrimoniali della nuova disciplina sul capitale delle banche. Tale misura rappresenta un fondamentale input per la produzione di più complesse stime del potenziale impatto economico delle scelte normative, che tengano in considerazione ad esempio l effetto che esse potrebbero avere sul costo e sulla disponibilità del credito. 3 Appare dunque chiaro come tale impostazione, in larga parte imposta dalla disponibilità di dati e dall esigenza di limitare la complessità dell analisi, consenta di stimare i costi della regolamentazione e non anche i potenziali benefici. La quantificazione monetaria di questi ultimi (legati principalmente alla creazione di un sistema finanziario più solido e meno esposto a crisi di portata 1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/ Lo shortfall rappresenta l incremento del numeratore del ratio patrimoniale necessario a raggiungere il livello minimo del requisito. Ipotizzando un requisito in termini di CET1 ratio pari al 7%, esso può dunque immediatamente convertirsi in una equivalente riduzione degli RWA (moltiplicando per 100/7; 1 euro di shortfall può essere colmato aumentando il CET1 di 1 euro o riducendo gli RWA di 14,3 euro). Va tuttavia fatto presente che un aumento unitario del CET1 (che rappresenta il patrimonio al netto di tutte le deduzioni) può essere ottenuto con un aumento di capitale di importo inferiore a 1. Il beneficio patrimoniale conseguente a un aumento di capitale è infatti maggiore dell aumento stesso ogni volta che le soglie del 10/15 % risultino vincolanti. Una misura alternativa di esigenze di capitale risponde quindi alla necessità di stimare l aumento di capitale che si renderebbe necessario a raggiungere il requisito minimo; tale esigenza è in tutti i casi inferiore o al più uguale allo shortfall. Un aumento del capitale versato modifica le quantità di riferimento per il calcolo delle soglie rispetto alle quali operare le deduzioni (es. DTA, investimenti finanziati significativi), inducendo quindi un beneficio patrimoniale superiore all importo dell aumento stesso. 3 Si veda per esempio Macroeconomic Assessment Group (2010), Assessing the macroeconomic impact of stronger capital and liquidity requirements ( 2
3 sistemica) rimane pertanto, ai fini della presente analisi, surrogata da considerazioni di natura prettamente qualitiva Le opzioni normative Sulla base del testo finale della CRD4-CRR, e a seguito di una fase di preconsultazione che ha coinvolto le principali associazioni di categoria del settore bancario, sono state individuate 3 opzioni ai fini dell AIR; le prime due sono contenute nel documento normativo di consultazione. Alcune scelte fondamentali sono comuni a tutte le opzioni: a) il pieno mantenimento in vigore del filtro prudenziale su utili e perdite non realizzate relativi a esposizioni verso Amministrazioni centrali UE classificate nel portafoglio AFS fino al previsto emendamento dell attuale IAS39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement), tuttora incerto nei tempi; b) la rimozione graduale (5 anni) del filtro attualmente appostato a mitigazione degli impatti negativi sul patrimonio di vigilanza derivanti dalla recente modifica della disciplina contabile in materia di fondi pensione (IAS19); c) la previsione di un trattamento alternativo alla deduzione (i.e. ponderazione al 370%) per le partecipazioni assicurative significative che non superino il 15% del capitale partecipato.( 4 ) A partire da tali comuni elementi, le opzioni si articolano come segue: i) Opzione 1: improntata al maggior rigore, prevede la piena l applicazione fin dal 1 gennaio 2014 della disciplina del capitale e del capital conservation buffer (CCB) a regime (CET1 4,5%; CCB 2,5%; T1 6%); ii) Opzione 2: condivide con l opzione 1 l immediata imposizione dei livelli massimi di capitale (con l eccezione del T1 fissato al 5,5% per il 2014) differenziandosene per il graduale phasing-in previsto per le deduzioni. In particolare, per la generalità delle deduzioni applicabili al CET1, con l eccezione degli avviamenti, delle altre attività immateriali degli investimenti in azioni proprie e delle partecipazioni incrociate, viene previsto un phasing-in su 4 anni, esteso a 9 anni per le DTA che derivano da sfasamenti temporali la cui realizzazione dipende dalla redditività futura della banca e che non sono coperte dal decreto cd. Milleproroghe.( 5 ) Il regime transitorio si applica inoltre agli utili e alle perdite non realizzate del portafoglio AFS, anche per gli strumenti diversi da titoli di stato UE; iii) Opzione 3: prevede l esercizio di tutte le discrezionalità nella misura più favorevole, con l eccezione dei livelli di capitale, superiori ai minimi consentiti dalla CRR ma caratterizzati da una graduale introduzione del CCB.( 6 ) 4 Il CRR consente l applicazione di trattamenti alternativi alla deduzione (i.e. ponderazione al 370%) per le partecipazioni assicurative significative inferiori al 15% del capitale della partecipata. 5 Tale disposizione è da ritenersi applicabile alle sole DTA esistenti alla data del 1 gennaio 2014, mentre per quelle future varrà il phasing-in su 4anni. 6 Sarebbero previsti i seguenti livelli: CET1 4,5% e CCB 0,625% a partire dal 2014 (il CRR consentirebbe un CET1 pari al 4% e un CCB pari allo 0,625% a partire dal 2016). La scelta di fissare un livello complessivo di CET1 (5,125%) più elevato del minimo consentito (4%) dipende dal fatto che il trigger 3
4 In tutti i casi è stata considerata l applicazione del cd. SME supporting factor, che non ha natura di discrezionalità nazionale Gli impatti patrimoniali stimati I dati utilizzati nell analisi, riferiti al 30 giugno 2013, sono stati raccolti nell ambito del monitoraggio periodico di Basilea 3 (QIS). Il campione è composto da 15 gruppi bancari di media e grande dimensione, rappresentativi di oltre il 70 percento dell attivo del sistema bancario italiano. Le informazioni così raccolte sono state integrate con ulteriori dati forniti dagli intermediari (ad esempio, importo delle plus/minusvalenze rinvenienti da attività classificate nel portafoglio AFS ed eventualmente sterilizzate ai sensi del provvedimento BdI del 18 maggio 2010; dati gestionali sulla classificazione delle controparti ai fini dell applicazione dello SME supporting factor) o provenienti dalle segnalazioni consolidate. 7 Per ciascuna delle opzioni illustrate nel paragrafo precedente sono state calcolate le seguenti misure, sia a livello aggregato sia per singola banca: i) esigenza di CET1 (paid-in capital); ii) shortfall di CET1 (in analogia alle informative sul monitoraggio di Basilea 3); 8 iii) shortfall di AT1 (calcolato assumendo che le esigenze di CET1 siano integralmente soddisfatte); Le eventuali azioni di capital management realizzate successivamente alla data di riferimento non sono state considerate nell analisi. Analogamente, gli shortfall e le esigenze di capitale calcolate per gli anni successivi al 2014 non tengono conto di future azioni di capital management che potrebbe essere necessario realizzare. La simulazione ha riguardato il periodo : la proposta normativa prevede infatti, nella maggior parte dei casi, un phasing-in articolato su 4 anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), seppure con alcune importanti eccezioni (es. norme transitorie su partecipazioni in assicurazioni, filtro prudenziale su titoli di stato, grandfathering degli strumenti di capitale non più computabili). La disciplina sui buffer entrerà invece pienamente in vigore a partire dal 1 gennaio Il Grafico 1 fornisce evidenza delle complessive esigenze patrimoniali che l adozione di ciascuna opzione determinerebbe nell arco del periodo transitorio: event che determina la conversione in CET1 degli strumenti computabili nell Additional tier 1 è fissato, anche per il periodo transitorio, a un CET1 ratio del 5,125%. Di conseguenza, per emettere tali strumenti senza che vengano immediatamente convertiti, le banche dovranno avere un CET1 non inferiore alla soglia del trigger event. 7 In particolare: deduzioni derivanti da cartolarizzazioni, deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP, plusvalenze e minusvalenze implicite. 8 Nell applicare il corresponding approach si è tenuto conto dello slittamento verso il CET1 delle deduzioni eventualmente inapplicabili agli strati subordinati per l incapienza di questi ultimi. 4
5 Grafico 1. Esigenze complessive di CET1 per l intero campione (15 gruppi). 3.0 Monti bonds in CET1 Monti bonds in AT Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 In tutti i casi esaminati le esigenze complessive esigenze patrimoniali stimate per il 2014 sarebbero inferiori a 0,6 mld di euro. Tali esigenze sarebbero massime nell opzione 1 e nulle nell opzione 3. La conclusione del periodo di grandfathering previsto per gli aiuti di stato determinerebbe, a partire dal 1 gennaio 2018, un marcato cliff-effect. La Tavola 1 riporta le complessive esigenze di capitale per gli aggregati patrimoniali di riferimento. Per il CET1 sono riportate, oltre allo shortfall, anche le esigenze di capitale. Tavola 1. Esigenze di capitale e shortfall per il campione (15 gruppi). Banca Anno Dato QIS Esigenza CET Shortfall CET Shortfall AT1* Esigenza CET Shortfall CET Shortfall AT1* Esigenza CET Shortfall CET Shortfall AT1* Esigenza CET Shortfall CET Shortfall AT1* Esigenza CET Shortfall CET Shortfall AT1* * shortfall residuo ipotizzando il soddisfacimento delle esigenze patrimoniali relative agli strati precedenti Opzione Per la maggior parte degli intermediari del campione le differenze fra le opzioni risultano contenute. Ciò dipende anche dalla generale esiguità degli strati patrimoniali /mld 5
6 subordinati, che non consente in molti casi il pieno conseguimento dei benefici associati a una maggiore gradualità nell entrata in vigore delle deduzioni Una valutazione complessiva La Tavola 2 sintetizza i principali benefici e costi associati alle opzioni esaminate. Tavola 2. Potenziali benefici, onerosità e limiti delle opzioni proposte 9 Le deduzioni non applicate al CET1 per effetto del phasing-in vengono infatti di norma rinviate agli strati patrimoniali subordinati. Laddove questi ultimi risultino incapienti esse incidono tuttavia infine sul CET1. 6
7 Opzione Potenziali benefici Onerosità e limiti Coerente con le aspettative del mercato; - Trasparente e credibile nel confronto internazionale - Minimizza la potenziale divergenza tra i requisiti prudenziali imposti alle banche soggette alla Racc. EBA vs. altri intermediari - Impone contenute esigenze di CET1, limitate a casi specifici - Evita il rilascio delle risorse raccolte nell ultimo biennio - Imponendo qualità del capitale crescente nel tempo favorisce il soddisfacimento graduale delle esigenze patrimoniali evidenziate a regime. - Contiene le possibili distorsioni competitive derivanti dall applicazione di differenti definizioni di capitale ai fini dell esercizio AQR. - Consente la massima gradualità nel soddisfacimento delle esigenze patrimoniali a regime - Imposizione di esigenze di AT1 per più intermediari - A seconda delle scelte adottate negli altri paesi europei può implicare un trattamento più rigoroso per le banche italiane, penalizzando l attività dei gruppi attivi cross-border - Possibile signalling negativo per la durata troppo lunga del regime transitorio - Differenzia de facto il trattamento delle cinque banche soggette alla Raccomandazione EBA vs. altre banche (a meno di esenzione per tutte le banche italiane) - Può rendere meno agevole la capacità delle banche più solide di comunicare credibilmente al mercato la propria posizione patrimoniale - I benefici conseguibili in termini di minor impegno patrimoniale nel breve termine sono molto esigui a fronte della divergenza rispetto alle attese del mercato - Livelli di patrimonializzazione inferiori al 7 percento potrebbero pregiudicare la capacità degli intermediari di emettere strumenti di contingent capital (i.e. AT1) a condizioni economicamente convenienti. - Consente il rilascio delle risorse patrimoniali raccolte nell ultimo biennio (almeno per le banche non soggette alla Raccomandazione EBA). - Massimizza la differenza di trattamento tra le cinque banche soggette alla Raccomandazione EBA e le altre banche in caso di mancata esenzione delle prime. 3. Applicazione della disciplina dei buffer alle SIM Il rafforzamento quantitativo e qualitativo della dotazione di capitale degli intermediari rappresenta l architrave della riforma introdotta dalla CRD4-CRR. I nuovi requisiti patrimoniali minimi obbligatori sono affiancati da un insieme strutturato di buffer di capitale, volti a introdurre seppur con numerose differenze una prospettiva macroprudenziale nella regolamentazione bancaria Natura e finalità dei buffer Tutti i buffer introdotti dalla riforma Capital Conservation Buffer (CBB), Countercyclical Buffer (CB), Global Systemically Important Institutions (G-SIIs) buffer, Other Systemically Important Institutions (O-SIIs) buffer, Systemic Risk buffer (SRB) - condividono 7
8 la finalità di dotare gli intermediari di risorse di capitale aggiuntive, utilizzabili in periodi di tensione e che consentano il mantenimento di un regolare flusso di credito all economia. Al tempo stesso, ciascuno strumento assolve anche un proprio obiettivo specifico (come mostrato nella Tavola 3). Tavola 3. I buffer di capitale nella CRD4-CRR. Problema Strumento Obiettivo finale Obiettivi intermedi Assenza di capital cushion a presidio del minimo regolamentare Capital conservation buffer (CCB) Preservare i requisiti nei periodi di stress Prociclicità requisisti capitale Countercyclical buffer (CB) Fronteggiare la componente ciclica di rischio sistemico Accumulare risorse nelle fasi di espansione da usare nelle fasi di crisi Presenza di esternalità causate da banche a rilevanza sistemica globale e/o locale Global (Other) systemically important institution buffer (G/O- SII) Internalizzare esternalità negative banche sistemiche Diminuire PD intermediari sistemici Presenza rischio sistemico non ciclico (es. peso del sistema bancario sull economia del Paese) Systemic risk buffer (SRB) Fronteggiare la componente non ciclica di rischio sistemico Aumentare dotazione patrimoniale su alcune esposizioni; diminuire la PD di alcuni intermediari La combinazione dei diversi buffer determina il combined buffer requirement, la cui infrazione determina conseguenze in termini di distribuzione di dividendi e di restrizioni all erogazione di bonus. 10 La Direttiva prevede che i buffer siano destinati alle banche e alle imprese di investimento; in Italia queste ultime sono rappresentate dalle Società di intermediazione mobiliare (SIM). 11 Tuttavia, la Direttiva prevede anche la possibilità di esonerare queste ultime dall applicazione del capital conservation buffer (art. 129) e del countercyclical capital buffer (art. 130) nei casi in cui: 10 Peraltro, la restrizione alla distribuzione dei dividendi è solo una delle leve a disposizione della Vigilanza nei confronti di una banca che non rispettasse il requisito combinato. Qualora tali restrizioni non siano sufficienti al miglioramento del CET1 le autorità competenti potranno adottare misure addizionali (art.64 Direttiva). 11 A fine 2012, in Italia operavano 19 gruppi di SIM e 101 SIM individuali; di queste ultime, solo 68 non facevano parte di gruppi bancari (n. 9) o gruppi di SIM (n. 24). Si veda Banca d'italia, Relazione Annuale, anno 2012, cap
9 a) si tratti di SIM di medio-piccola dimensione (ai sensi della Raccomandazione della Commissione UE (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 sulla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese); b) l esenzione in questione non comporti rischi per la stabilità finanziaria dello Stato membro Valutazioni d impatto I costi e benefici associati all esenzione in questione possono essere analizzati sia sul piano teorico sia sul piano empirico. In primo luogo, l assenza di erogazione di credito tra le attività svolte dalle SIM riduce notevolmente l efficacia di uno strumento come il countercyclical buffer, il cui obiettivo finale è quello di preservare un flusso costante di credito all economia, evitando contrazioni dell offerta nelle fasi di recessione. Per quanto concerne il capital conservation buffer, in linea di principio esso presenta le caratteristiche tipiche di strumento di capital cushioning, preservando il requisito minimo di capitale in momenti di particolare tensione di mercato, grazie all accantonamento di risorse patrimoniali durante i periodi non avversi. Pertanto, l applicazione del capital conservation buffer alle SIM ridurrebbe la loro probabilità di insolvenza. Tuttavia, l analisi empirica della capitalizzazione di questi operatori riduce fortemente la portata di questo beneficio potenziale. Infatti, le SIM presentano mediamente un elevato grado di patrimonializzazione: a fine 2012, il rapporto tra patrimonio di vigilanza e requisito complessivo era pari a 4,8 (4,5 nel 2011). Inoltre, il patrimonio di vigilanza delle SIM è costituito quasi esclusivamente da elementi di qualità primaria (capitale e riserve); nel corso del 2012, è aumentato del 4 per cento rispetto al In presenza di buffer volontari notevolmente al di sopra dei requisiti minimi regolamentari, i benefici legati all introduzione di uno strumento come il capital conservation buffer si riducono notevolmente. Le considerazioni fin qui esposte, insieme alla limitata rilevanza sistemica delle SIM, il cui attivo totale alla fine del 2012 non superava i 2 miliardi di euro, non evidenziano particolari controindicazioni all applicazione dell esenzione consentita per gli intermediari di minore dimensione. In proposito, è stato stimato che gran parte delle SIM italiane rientrerebbe nella fattispecie di esenzione (15 gruppi di SIM su 19 e 91 SIM individuali su 99). I soggetti esentati, seppure numericamente rilevanti, contribuirebbero comunque a una frazione contenuta dell attività totali delle SIM italiane. In sintesi, i benefici derivanti dall eventuale applicazione dei buffer sarebbero estremamente contenuti, a fronte di costi potenzialmente elevati, soprattutto per gli operatori di minore dimensione. In primo luogo, la complessità e la diversità dei vari buffer implicano costi di compliance per assicurare il corretto funzionamento tecnico degli strumenti (es. monitoraggio delle esposizioni su base geografica); parallelamente, l autorità di vigilanza dovrebbe sostenere elevati costi diretti, legati alla verifica dell applicazione dei nuovi strumenti introdotti. 12 Si veda Banca d Italia, Relazione Annuale, anno 2012, cap
FIDITALIA S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2. Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2012
 FIDITALIA S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2 Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2012 INTRODUZIONE La normativa prudenziale per gli Intermediari Finanziari è disciplinata
FIDITALIA S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2 Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2012 INTRODUZIONE La normativa prudenziale per gli Intermediari Finanziari è disciplinata
LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI DI VIGILANZA
 LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI DI VIGILANZA IL PERCHÉ DELLA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA La ragione fondante della regolamentazione risiede nella circostanza di prevenire, ed eventualmente gestire situazioni
LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI DI VIGILANZA IL PERCHÉ DELLA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA La ragione fondante della regolamentazione risiede nella circostanza di prevenire, ed eventualmente gestire situazioni
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.
 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio
(SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO)
 ANALISI D IMPATTO DELLE INNOVAZIONI SEGNALETICHE CIRC. 155-14 AGGIORNAMENTO (SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO) Indice 1. Introduzione... 2 2. Gli obiettivi del regolatore... 2 3. Le opzioni
ANALISI D IMPATTO DELLE INNOVAZIONI SEGNALETICHE CIRC. 155-14 AGGIORNAMENTO (SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO) Indice 1. Introduzione... 2 2. Gli obiettivi del regolatore... 2 3. Le opzioni
COMUNICATO STAMPA. Risultati dello stress test europeo 2010
 COMUNICATO STAMPA Risultati dello stress test europeo 2010 Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ( UBI Banca ) ha partecipato allo stress test europeo 2010 coordinato dal Comitato europeo dei supervisori
COMUNICATO STAMPA Risultati dello stress test europeo 2010 Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ( UBI Banca ) ha partecipato allo stress test europeo 2010 coordinato dal Comitato europeo dei supervisori
Il rischio di concentrazione: regole, implicazioni gestionali e questioni aperte
 Il rischio di concentrazione: regole, implicazioni gestionali e questioni aperte Lucia Gibilaro Facoltà di Economia Università di Bergamo Indice Introduzione Le regole Le implicazioni gestionali Le questioni
Il rischio di concentrazione: regole, implicazioni gestionali e questioni aperte Lucia Gibilaro Facoltà di Economia Università di Bergamo Indice Introduzione Le regole Le implicazioni gestionali Le questioni
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale. Aggiornamento al 31 marzo 2012 * * *
 Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 31 marzo 2012 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 31 marzo 2012 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale. Aggiornamento al 30 giugno 2013 * * *
 Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 30 giugno 2013 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 30 giugno 2013 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale. Aggiornamento al 30 giugno 2012 * * *
 Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 30 giugno 2012 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 30 giugno 2012 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
INFORMATIVA AL PUBBLICO
 INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31.12.2008 Pagina 1/7 INDICE Premessa... 3 Note... 4 Elenco delle tavole informative... 5 Tavola 3: Composizione del patrimonio di vigilanza...5 Tavola 4: Adeguatezza patrimoniale...7
INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31.12.2008 Pagina 1/7 INDICE Premessa... 3 Note... 4 Elenco delle tavole informative... 5 Tavola 3: Composizione del patrimonio di vigilanza...5 Tavola 4: Adeguatezza patrimoniale...7
Corso di Asset and liability management (profili economico-aziendali) Basilea 3
 Università degli Studi di Parma Corso di Asset and liability management (profili economico-aziendali) Basilea 3 Prof.ssa Paola Schwizer Anno accademico 2010-2011 I punti critici di Basilea 2 Qualità e
Università degli Studi di Parma Corso di Asset and liability management (profili economico-aziendali) Basilea 3 Prof.ssa Paola Schwizer Anno accademico 2010-2011 I punti critici di Basilea 2 Qualità e
Il sistema IAS-IFRS e la gestione del rischio di credito
 Il sistema IAS-IFRS e la gestione del rischio di credito Peculiarità nel settore del Consumer Finance Roma, 22 Giugno 2016 Agenda Introduzione: il nuovo approccio IFRS 9 La divisione del portafoglio crediti
Il sistema IAS-IFRS e la gestione del rischio di credito Peculiarità nel settore del Consumer Finance Roma, 22 Giugno 2016 Agenda Introduzione: il nuovo approccio IFRS 9 La divisione del portafoglio crediti
Terzo Pilastro di Basilea 2. Informativa al pubblico al 30 settembre 2009
 Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico al 30 settembre 2009 Questo documento contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management Intesa Sanpaolo in merito ad eventi
Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico al 30 settembre 2009 Questo documento contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management Intesa Sanpaolo in merito ad eventi
Il Comprehensive Assessment
 Il Comprehensive Assessment L esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE Ø La valutazione approfondita prevista dal regolamento sull MVU per i 130 enti creditizi che, secondo le aspettative,
Il Comprehensive Assessment L esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE Ø La valutazione approfondita prevista dal regolamento sull MVU per i 130 enti creditizi che, secondo le aspettative,
Agenda dell intervento
 Agenda dell intervento - La vigilanza prudenziale e l accordo di Basilea del 1988 - I principi guida del nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2) - L evoluzione della disciplina di Basilea sul rischio di credito
Agenda dell intervento - La vigilanza prudenziale e l accordo di Basilea del 1988 - I principi guida del nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2) - L evoluzione della disciplina di Basilea sul rischio di credito
Indice. 2 La struttura finanziaria dell economia 15. xiii. Presentazione
 Indice Presentazione xiii 1 Le funzioni del sistema finanziario 1 1.1 Che cos è il sistema finanziario 2 1.2 La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari 2 1.3 Quali funzioni svolge il sistema
Indice Presentazione xiii 1 Le funzioni del sistema finanziario 1 1.1 Che cos è il sistema finanziario 2 1.2 La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari 2 1.3 Quali funzioni svolge il sistema
Informativa al Pubblico
 Informativa al Pubblico Pillar 3 al 31 marzo 2015 1 Società cooperativa per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia
Informativa al Pubblico Pillar 3 al 31 marzo 2015 1 Società cooperativa per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia
Università degli Studi di Bergamo. Facoltà di Economia
 Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Economia La concessione del credito bancario dopo gli accordi di Basilea 2: il ruolo del business plan di Fabio Rapizza Relatore: Giovanna Galizzi A. A. 2008-2009
Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Economia La concessione del credito bancario dopo gli accordi di Basilea 2: il ruolo del business plan di Fabio Rapizza Relatore: Giovanna Galizzi A. A. 2008-2009
Informativa al Pubblico Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale sulle Banche
 Informativa al Pubblico Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale sulle Banche (Circolare Banca d Italia n. 285/2013 PARTE PRIMA TITOLO III CAPITOLO 2) Situazione riferita al 31 Dicembre 2014
Informativa al Pubblico Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale sulle Banche (Circolare Banca d Italia n. 285/2013 PARTE PRIMA TITOLO III CAPITOLO 2) Situazione riferita al 31 Dicembre 2014
1 Direzione Contabile Amministrativa
 SINTESI DEI RISULTATI DELLA BANCA NEL 2015 Di seguito il prospetto di conto economico riclassificato che evidenzia le variazioni registrate per le diverse componenti reddituali. VOCE DI Conto economico
SINTESI DEI RISULTATI DELLA BANCA NEL 2015 Di seguito il prospetto di conto economico riclassificato che evidenzia le variazioni registrate per le diverse componenti reddituali. VOCE DI Conto economico
BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.
 BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. 30 GIUGNO 2015 1 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (importi in euro) Voci dell'attivo 30/06/2015 31/12/2014 10. Cassa e disponibilità liquide 21.333.341
BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. 30 GIUGNO 2015 1 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (importi in euro) Voci dell'attivo 30/06/2015 31/12/2014 10. Cassa e disponibilità liquide 21.333.341
Indice XIII. Presentazione di Roberto Nicastro XVII. Introduzione di Franco Tutino, Giuliana Birindelli e Paola Ferretti
 Presentazione di Roberto Nicastro Introduzione di Franco Tutino, Giuliana Birindelli e Paola Ferretti XIII XVII 1 Basilea 3: contenuti e finalità 1 di Giuliana Birindelli e Paola Ferretti 1.1 Il capitale:
Presentazione di Roberto Nicastro Introduzione di Franco Tutino, Giuliana Birindelli e Paola Ferretti XIII XVII 1 Basilea 3: contenuti e finalità 1 di Giuliana Birindelli e Paola Ferretti 1.1 Il capitale:
BASILEA Le novità regolamentari, i passi chiave di oggi, gli scenari di domani. Le novità sull informativa al pubblico (Pillar 3)
 BASILEA 3 2011 Le novità regolamentari, i passi chiave di oggi, gli scenari di domani. Le novità sull informativa al pubblico (Pillar 3) Roma, 21 giugno 2011 Andrea Caponera Ufficio Tributario, Bilancio
BASILEA 3 2011 Le novità regolamentari, i passi chiave di oggi, gli scenari di domani. Le novità sull informativa al pubblico (Pillar 3) Roma, 21 giugno 2011 Andrea Caponera Ufficio Tributario, Bilancio
Rischio di mercato Quantitativa No. Rischio di cambio Quantitativa No. Rischio di concentrazione Qualitativa Sì
 Tavola 1 Adeguatezza patrimoniale al 30/06/2015 (valori in unità di euro) qualitativa (a) Descrizione dell informazione Sintetica descrizione del metodo adottato dall intermediario nella valutazione dell
Tavola 1 Adeguatezza patrimoniale al 30/06/2015 (valori in unità di euro) qualitativa (a) Descrizione dell informazione Sintetica descrizione del metodo adottato dall intermediario nella valutazione dell
AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2014. del 14 marzo 2014
 AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2014 del 14 marzo 2014 1) Trattamento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia nei bilanci dei partecipanti 2) Banca d Italia: pubblicata la
AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2014 del 14 marzo 2014 1) Trattamento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia nei bilanci dei partecipanti 2) Banca d Italia: pubblicata la
ORIENTAMENTI SU TEST, VERIFICHE O ESERCIZI CHE POSSONO PORTARE A MISURE DI SOSTEGNO ABE/GL/2014/ settembre 2014
 ABE/GL/2014/09 22 settembre 2014 Orientamenti sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva
ABE/GL/2014/09 22 settembre 2014 Orientamenti sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva
Cfr peraltro l art. 4, comma 1, della CRR, che circoscrive il novero delle imprese di investimento destinatarie della disciplina CRR/CRD4.
 Gli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Terzo Pilastro Avv. Vincenzo M. Dispinzeri Come noto, con il recepimento della direttiva 2006/48/CE (CRD) sono stati introdotti nell UE, insieme al
Gli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Terzo Pilastro Avv. Vincenzo M. Dispinzeri Come noto, con il recepimento della direttiva 2006/48/CE (CRD) sono stati introdotti nell UE, insieme al
La riforma della disciplina prudenziale in sede internazionale: impatti sulla direttiva CRD
 La riforma della disciplina prudenziale in sede internazionale: impatti sulla direttiva CRD 5 maggio 2010 Mario Marangoni Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Agenda Le modifiche alla normativa
La riforma della disciplina prudenziale in sede internazionale: impatti sulla direttiva CRD 5 maggio 2010 Mario Marangoni Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Agenda Le modifiche alla normativa
I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS
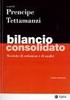 I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS 1 Schemi di bilancio 2 I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS Nel marzo del 2004 è stato emesso dallo IASB l IFRS 4 Il principio contabile internazionale
I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS 1 Schemi di bilancio 2 I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS Nel marzo del 2004 è stato emesso dallo IASB l IFRS 4 Il principio contabile internazionale
Le funzioni del sistema finanziario
 Le funzioni del sistema finanziario 1 1.1 Che cos è il sistema finanziario 1.2 La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari 1.3 Quali funzioni svolge il sistema finanziario 1.3.1 L offerta
Le funzioni del sistema finanziario 1 1.1 Che cos è il sistema finanziario 1.2 La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari 1.3 Quali funzioni svolge il sistema finanziario 1.3.1 L offerta
APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ
 APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ Articolo a 2, par. 2 Autorità Liquidity Coverage Requirement Deroga all applicazione
APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ Articolo a 2, par. 2 Autorità Liquidity Coverage Requirement Deroga all applicazione
Informativa al pubblico. Terzo pilastro di Basilea 2 al 31 dicembre 2012
 Informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 2 al 31 dicembre 2012 Le disposizioni emanate dalla Banca d Italia, in applicazione della normativa europea in materia di convergenza internazionale della
Informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 2 al 31 dicembre 2012 Le disposizioni emanate dalla Banca d Italia, in applicazione della normativa europea in materia di convergenza internazionale della
Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico Aggiornamento al 30 settembre 2009
 Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico Aggiornamento al 30 settembre 2009 TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 AL 30 GIUGNO 2008 2 NOTA Per le parti dell informativa al pubblico non riportate in questo
Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico Aggiornamento al 30 settembre 2009 TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 AL 30 GIUGNO 2008 2 NOTA Per le parti dell informativa al pubblico non riportate in questo
Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2017
 Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2017 TOTALE DELLE MASSE AMMINISTRATE RAGGIUNGE IL LIVELLO RECORD DI 202,9 MILIARDI, SUPERANDO PER LA PRIMA
Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2017 TOTALE DELLE MASSE AMMINISTRATE RAGGIUNGE IL LIVELLO RECORD DI 202,9 MILIARDI, SUPERANDO PER LA PRIMA
Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico anno 2008
 Serfactoring Basilea 2 Terzo Pilastro al Pubblico anno 2008 SERFACTORING S.p.A. Sede Legale in San Donato Milanese (MI), Via Maastricht, 1 Capitale Sociale Euro 5.160.000 i. v. Registro Imprese di Milano
Serfactoring Basilea 2 Terzo Pilastro al Pubblico anno 2008 SERFACTORING S.p.A. Sede Legale in San Donato Milanese (MI), Via Maastricht, 1 Capitale Sociale Euro 5.160.000 i. v. Registro Imprese di Milano
L impairment dei crediti: l evoluzione dei principi contabili e le loro implicazioni gestionali
 Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative L impairment dei crediti: l evoluzione dei principi contabili e le loro implicazioni gestionali Prof. Andrea Lionzo 14 ottobre 2016 Indice 1. Problemi
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative L impairment dei crediti: l evoluzione dei principi contabili e le loro implicazioni gestionali Prof. Andrea Lionzo 14 ottobre 2016 Indice 1. Problemi
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e adeguatezza patrimoniale. Aggiornamento al 30 settembre 2011 * * *
 Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 30 settembre 2011 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e adeguatezza patrimoniale Aggiornamento al 30 settembre 2011 * * * Terzo pilastro dell accordo di Basilea II Banca Nazionale
BASILEA Le novità regolamentari, i passi chiave di oggi, gli scenari di domani. DTA, azioni di risparmio e bail in. Roma, 20 giugno 2011
 BASILEA 3 2011 Le novità regolamentari, i passi chiave di oggi, gli scenari di domani. DTA, azioni di risparmio e bail in Roma, 20 giugno 2011 Luca Giannini Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
BASILEA 3 2011 Le novità regolamentari, i passi chiave di oggi, gli scenari di domani. DTA, azioni di risparmio e bail in Roma, 20 giugno 2011 Luca Giannini Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli
 6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza 2 Le altre normative per l'incremento dei requisiti
6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza 2 Le altre normative per l'incremento dei requisiti
BAIL-IN. Alcuni criteri di analisi e simulazione del rischio sul sistema bancario
 BAIL-IN Alcuni criteri di analisi e simulazione del rischio sul sistema bancario Alcuni indicatori di solidità delle banche CET1: misura il rapporto tra il core equity tier 1 ed i RWA Deve essere superiore
BAIL-IN Alcuni criteri di analisi e simulazione del rischio sul sistema bancario Alcuni indicatori di solidità delle banche CET1: misura il rapporto tra il core equity tier 1 ed i RWA Deve essere superiore
La rimozione degli ostacoli regolamentari: opportunità di economie di scala e di scopo
 La rimozione degli ostacoli regolamentari: opportunità di economie di scala e di scopo Roma, 21 giugno 2011 Francesca Passamonti Indice 1. Introduzione 2. Excursus del processo di armonizzazione: verso
La rimozione degli ostacoli regolamentari: opportunità di economie di scala e di scopo Roma, 21 giugno 2011 Francesca Passamonti Indice 1. Introduzione 2. Excursus del processo di armonizzazione: verso
Regolamentazione del sistema finanziario
 Regolamentazione del sistema finanziario Prof. Domenico Curcio Cattedra di Mercati e investimenti finanziari 2 Perché regolare il sistema finanziario? Tre motivazioni essenziali: Centralità del sistema
Regolamentazione del sistema finanziario Prof. Domenico Curcio Cattedra di Mercati e investimenti finanziari 2 Perché regolare il sistema finanziario? Tre motivazioni essenziali: Centralità del sistema
Il Sistema dei Controlli Interni e il Governo Societario nella prospettiva della nuova Vigilanza Bancaria Europea. Valerio Pesic
 Il Sistema dei Controlli Interni e il Governo Societario nella prospettiva della nuova Vigilanza Bancaria Europea Valerio Pesic Una visione di sintesi Il Sistema dei Controlli Interni di Il Governo Societario
Il Sistema dei Controlli Interni e il Governo Societario nella prospettiva della nuova Vigilanza Bancaria Europea Valerio Pesic Una visione di sintesi Il Sistema dei Controlli Interni di Il Governo Societario
Milano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla
 Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011, D.L. 216/2011 convertito il 15 febbraio 2012, D.L. 2 del 2012
Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011, D.L. 216/2011 convertito il 15 febbraio 2012, D.L. 2 del 2012
INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006)
 Deutsche Bank S.p.A. INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) al 31 dicembre 2009 Banca d Italia, sulla base
Deutsche Bank S.p.A. INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) al 31 dicembre 2009 Banca d Italia, sulla base
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)
 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro) ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 Crediti verso clientela 28.110,6 30.892,7-2.782,1-9,0% Crediti verso banche 2.254,9 2.794,0-539,1-19,3% Attività
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro) ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 Crediti verso clientela 28.110,6 30.892,7-2.782,1-9,0% Crediti verso banche 2.254,9 2.794,0-539,1-19,3% Attività
La riforma della disciplina degli intermediari finanziari non bancari: obiettivi e linee direttrici
 La riforma della disciplina degli intermediari finanziari non bancari: obiettivi e linee direttrici Mario Marangoni Divisione Regolamentazione II SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE Gli
La riforma della disciplina degli intermediari finanziari non bancari: obiettivi e linee direttrici Mario Marangoni Divisione Regolamentazione II SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE Gli
Comunicato stampa IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA FIDEURAM HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DELL ESERCIZIO 2010
 Comunicato stampa IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA FIDEURAM HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DELL ESERCIZIO 2010 Raccolta netta di risparmio gestito a 4,2 miliardi ( 2,9 miliardi nel 2009);
Comunicato stampa IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA FIDEURAM HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DELL ESERCIZIO 2010 Raccolta netta di risparmio gestito a 4,2 miliardi ( 2,9 miliardi nel 2009);
REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH
 REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI
REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI
POLITICA DI VOTO. Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti
 POLITICA DI VOTO Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti 1 INDICE PRINCIPI GENERALI... 3 PERIMETRO DI RIFERIMENTO... 3 MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SOCIETARI
POLITICA DI VOTO Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti 1 INDICE PRINCIPI GENERALI... 3 PERIMETRO DI RIFERIMENTO... 3 MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SOCIETARI
POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE
 POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2015 INDICE 1. PREMESSA...1 2. CARATTERISTICHE DELLE METODOLOGIE
POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2015 INDICE 1. PREMESSA...1 2. CARATTERISTICHE DELLE METODOLOGIE
La gestione dei rischi nelle banche
 La gestione dei rischi nelle banche ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI I RISCHI BANCARI 1. Rischi di controparte Rischio di credito Rischio di regolamento 2. Rischi di mercato Rischio di interesse
La gestione dei rischi nelle banche ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI I RISCHI BANCARI 1. Rischi di controparte Rischio di credito Rischio di regolamento 2. Rischi di mercato Rischio di interesse
L applicazione degli IFRS in Italia
 Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale L applicazione degli IFRS in Italia di 1 Il regolamento 1606/2002 Il regolamento
Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale L applicazione degli IFRS in Italia di 1 Il regolamento 1606/2002 Il regolamento
TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa A fronte dei principali rischi connessi con l'attività bancaria (di
TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa A fronte dei principali rischi connessi con l'attività bancaria (di
Tecnica bancaria programma II modulo
 Tecnica bancaria programma II modulo Università degli Studi di Trieste Facoltà di Economia e Commercio Deams Dipartimento di Economia Aziendale Matematica e Statistica Tecnica Bancaria 520EC Marco Galdiolo
Tecnica bancaria programma II modulo Università degli Studi di Trieste Facoltà di Economia e Commercio Deams Dipartimento di Economia Aziendale Matematica e Statistica Tecnica Bancaria 520EC Marco Galdiolo
REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART.
 REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. 118-BIS DEL TUF) DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 2 marzo 2007 Le osservazioni al presente
REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. 118-BIS DEL TUF) DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 2 marzo 2007 Le osservazioni al presente
CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2014
 CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2014 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel.
CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2014 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel.
Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi
 Risk and Accounting Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi Marco Venuti 2017 Agenda Stato dell arte Definizione strumento finanziario Strumenti derivati impliciti Contratti e rischi
Risk and Accounting Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi Marco Venuti 2017 Agenda Stato dell arte Definizione strumento finanziario Strumenti derivati impliciti Contratti e rischi
INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IAS 2 - RIMANENZE
 INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1.1. Premessa pag. 3 1.2. Finalità e definizioni pag. 4 1.2.1. Confronto con i Principi italiani pag. 5 1.3. Componenti del bilancio di esercizio
INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1.1. Premessa pag. 3 1.2. Finalità e definizioni pag. 4 1.2.1. Confronto con i Principi italiani pag. 5 1.3. Componenti del bilancio di esercizio
Informativa al Pubblico
 Informativa al Pubblico Pillar 3 al 30 settembre 2015 1 Società per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia 74 Aderente
Informativa al Pubblico Pillar 3 al 30 settembre 2015 1 Società per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia 74 Aderente
INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 1
 INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 1 DISCIPLINA DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall art. 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 1 DISCIPLINA DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall art. 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
Internazionalizzazione e servizi SACE per le imprese
 Internazionalizzazione e servizi SACE per le imprese Giorgio Tellini Amministratore Delegato SACE Forum Internazionalizzazione Roma, 26 giugno 2006 I cambiamenti del mercato dell assicurazione ai finanziamenti
Internazionalizzazione e servizi SACE per le imprese Giorgio Tellini Amministratore Delegato SACE Forum Internazionalizzazione Roma, 26 giugno 2006 I cambiamenti del mercato dell assicurazione ai finanziamenti
Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD
 base al rischio delle banche consorziate al FITD Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD Roma, Giugno 2017 2 Indice Parte I - SEGNALAZIONI
base al rischio delle banche consorziate al FITD Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD Roma, Giugno 2017 2 Indice Parte I - SEGNALAZIONI
Informazioni sull andamento della gestione (Informazioni aggiornate al 31 dicembre 2013)
 Sicurezza Informazioni sull andamento della gestione (Informazioni aggiornate al 31 dicembre 2013) Data di avvio dell operatività del comparto: 02/08/2005 Patrimonio netto al 31.12.2013 (in euro): 149.893.039,460
Sicurezza Informazioni sull andamento della gestione (Informazioni aggiornate al 31 dicembre 2013) Data di avvio dell operatività del comparto: 02/08/2005 Patrimonio netto al 31.12.2013 (in euro): 149.893.039,460
ECB Regulation on reporting of supervisory financial information : risposta alla comunicazione della Banca d Italia del 23 ottobre 2014
 Roma, 4 dicembre 2014 Prot. UTR/UAE/UAG/003082 Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale Divisione Bilanci e Segnalazioni Banca d Italia Via Milano, 53 00184 Roma ECB Regulation on reporting
Roma, 4 dicembre 2014 Prot. UTR/UAE/UAG/003082 Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale Divisione Bilanci e Segnalazioni Banca d Italia Via Milano, 53 00184 Roma ECB Regulation on reporting
Bilanci: dal 2016 nuove regole con la direttiva 2013/34/UE
 Bilanci: dal 2016 nuove regole con la direttiva 2013/34/UE Il D.Lgs. n. 136/2015 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni
Bilanci: dal 2016 nuove regole con la direttiva 2013/34/UE Il D.Lgs. n. 136/2015 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
 TITOLO III Capitolo 2 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Titolo III - Capitolo 2 CONCESSIONE
TITOLO III Capitolo 2 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Titolo III - Capitolo 2 CONCESSIONE
La struttura del mercato dei confidi 107 e le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d Italia
 La struttura del mercato dei confidi 107 e le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d Italia Marco Troiani Banca d Italia Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Milano 13 febbraio 2012
La struttura del mercato dei confidi 107 e le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d Italia Marco Troiani Banca d Italia Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Milano 13 febbraio 2012
IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
 IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare
IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare
REGOLAMENTO IVASS N. 21 DEL 10 MAGGIO 2016 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
 REGOLAMENTO IVASS N. 21 DEL 10 MAGGIO 2016 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI QUANTITATIVE PERIODICHE DA TRASMETTERE ALL IVASS AI FINI DI STABILITÀ FINANZIARIA E DI VIGILANZA MACROPRUDENZIALE E RELATIVI
REGOLAMENTO IVASS N. 21 DEL 10 MAGGIO 2016 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI QUANTITATIVE PERIODICHE DA TRASMETTERE ALL IVASS AI FINI DI STABILITÀ FINANZIARIA E DI VIGILANZA MACROPRUDENZIALE E RELATIVI
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INFORMATIVA AL PUBBLICO Terzo pilastro di Basilea 3 Al 31 dicembre 2014 (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013) 1 Informativa al pubblico Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INFORMATIVA AL PUBBLICO Terzo pilastro di Basilea 3 Al 31 dicembre 2014 (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013) 1 Informativa al pubblico Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova
Informativa al Pubblico
 Informativa al Pubblico Pillar 3 al 31 marzo 2017 1 Società per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia 74 Aderente
Informativa al Pubblico Pillar 3 al 31 marzo 2017 1 Società per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia 74 Aderente
RISPOSTA DELL ABI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/65/CE
 RISPOSTA DELL ABI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/65/CE e 2003/51/CE E SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELL ORGANISMO ITALIANO
RISPOSTA DELL ABI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/65/CE e 2003/51/CE E SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELL ORGANISMO ITALIANO
La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte
 La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte 50011 - Scienza delle Finanze CLMG Università Bocconi a.a. 2012/2013 Le slides riguardano solo alcune parti del programma e non sostituiscono il libro
La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte 50011 - Scienza delle Finanze CLMG Università Bocconi a.a. 2012/2013 Le slides riguardano solo alcune parti del programma e non sostituiscono il libro
Allegato 1 Possibile ambito di applicazione del giudizio del revisore ANIA
 Allegato 1 Possibile ambito di applicazione del giudizio del revisore ANIA ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO/ OPZIONI Vantaggi Svantaggi Soluzione preferita (una sola soluzione consentita) Motivazione della
Allegato 1 Possibile ambito di applicazione del giudizio del revisore ANIA ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO/ OPZIONI Vantaggi Svantaggi Soluzione preferita (una sola soluzione consentita) Motivazione della
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE
 DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389
Indice. 2 Elementi di teoria dell intermediazione finanziaria Introduzione 3
 parte I Prefazione Attribuzioni Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XIII XVI XVIII XIX Introduzione e panoramica dei mercati finanziari 1 1 Introduzione 3 1.1 Perché uno studio su mercati e
parte I Prefazione Attribuzioni Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XIII XVI XVIII XIX Introduzione e panoramica dei mercati finanziari 1 1 Introduzione 3 1.1 Perché uno studio su mercati e
Informativa al pubblico
 Informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 3 al 30 giugno 2015 Introduzione A partire dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina per le banche e le imprese di investimento che ha impatti
Informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 3 al 30 giugno 2015 Introduzione A partire dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina per le banche e le imprese di investimento che ha impatti
Tassazione delle Attività Finanziarie (parte I)
 Tassazione delle Attività Finanziarie (parte I) 50011 - Scienza delle Finanze CLMG Università Bocconi a.a. 2011/2012 Problemi Tradizionali Difficoltà di accertamento Tutela del risparmio Riforma del 1974
Tassazione delle Attività Finanziarie (parte I) 50011 - Scienza delle Finanze CLMG Università Bocconi a.a. 2011/2012 Problemi Tradizionali Difficoltà di accertamento Tutela del risparmio Riforma del 1974
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
 PARTE TERZA Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
PARTE TERZA Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006)
 Deutsche Bank S.p.A. INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) al 31 dicembre 2011 Banca d Italia, sulla base
Deutsche Bank S.p.A. INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006) al 31 dicembre 2011 Banca d Italia, sulla base
CASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
 CASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA ESERCIZIO 2014 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 1 Nell'esercizio finanziario 1 gennaio - 31 dicembre 2014 la Cassa ufficiali,
CASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA ESERCIZIO 2014 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 1 Nell'esercizio finanziario 1 gennaio - 31 dicembre 2014 la Cassa ufficiali,
L equilibrio finanziario
 L equilibrio finanziario Il bilancio secondo i principi contabili internazionali Analisi Economico-Finanziaria delle P.M.I. Prof. Andrea Calabrò E-mail: andrea.calabro@uniroma2.it Le finalità e il contenuto
L equilibrio finanziario Il bilancio secondo i principi contabili internazionali Analisi Economico-Finanziaria delle P.M.I. Prof. Andrea Calabrò E-mail: andrea.calabro@uniroma2.it Le finalità e il contenuto
Direzione Generale SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
 Direzione Generale SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2011 LINEE GUIDA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Direzione Generale SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2011 LINEE GUIDA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Informativa al pubblico
 Informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 3 al 31 dicembre 2014 Introduzione A partire dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina per le banche e le imprese di investimento che
Informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 3 al 31 dicembre 2014 Introduzione A partire dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina per le banche e le imprese di investimento che
REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016
 REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 REGOLAMENTO CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA
REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 REGOLAMENTO CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA
La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte
 La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte 30018 - Scienza delle Finanze CLEAM Lidia Ceriani Università Bocconi a.a. 2011/2012 Problemi Tradizionali Difficoltà di accertamento Tutela del risparmio
La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte 30018 - Scienza delle Finanze CLEAM Lidia Ceriani Università Bocconi a.a. 2011/2012 Problemi Tradizionali Difficoltà di accertamento Tutela del risparmio
19. Crediti e Altre attività correnti
 Pubblicata su Bilancio consolidato - Gruppo Fiat (http://annualreport.fiatspa.com) 4 Home > PDF Printer-friendly 19. Crediti e Altre attività correnti La composizione dei Crediti e delle Altre attività
Pubblicata su Bilancio consolidato - Gruppo Fiat (http://annualreport.fiatspa.com) 4 Home > PDF Printer-friendly 19. Crediti e Altre attività correnti La composizione dei Crediti e delle Altre attività
RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146) RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146) RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
1.3 RISCHIO DI LIQUIDITA
 1.3 RISCHIO DI LIQUIDITA INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità Si definisce rischio di liquidità il rischio che la
1.3 RISCHIO DI LIQUIDITA INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità Si definisce rischio di liquidità il rischio che la
Fondi propri regolamentari computabili - Trasferimento valori di bilancio
 Fondi propri regolamentari computabili - Trasferimento valori di bilancio Bilancio 31.12.2014 31.12.2013 in migliaia di CHF in migliaia di CHF Riferimento 1 Attivi Liquidità 9'218'851 7'018'627 Crediti
Fondi propri regolamentari computabili - Trasferimento valori di bilancio Bilancio 31.12.2014 31.12.2013 in migliaia di CHF in migliaia di CHF Riferimento 1 Attivi Liquidità 9'218'851 7'018'627 Crediti
Informativa al Pubblico
 Informativa al Pubblico Pillar 3 al 31 marzo 2016 1 Società per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia 74 Aderente
Informativa al Pubblico Pillar 3 al 31 marzo 2016 1 Società per azioni Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia 74 Aderente
Politiche Passive del Lavoro in Europa. Scheda Paese DANIMARCA
 Politiche Passive del Lavoro in Europa Scheda Paese DANIMARCA BENCHMARKING SULLE POLITICHE PASSIVE IN EUROPA SOMMARIO 1. TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE E SOSTEGNO AL REDDITO DEI DISOCCUPATI... 3 2. PREPENSIONAMENTO...
Politiche Passive del Lavoro in Europa Scheda Paese DANIMARCA BENCHMARKING SULLE POLITICHE PASSIVE IN EUROPA SOMMARIO 1. TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE E SOSTEGNO AL REDDITO DEI DISOCCUPATI... 3 2. PREPENSIONAMENTO...
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia
 Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro
Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione dei crediti
 La valutazione dei crediti 1 Crediti Caratteri economico aziendali Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati Distinzioni: in base alla natura economica
La valutazione dei crediti 1 Crediti Caratteri economico aziendali Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati Distinzioni: in base alla natura economica
CASSE PROFESSIONALI: GOVERNANCE E RUOLO NELL ECONOMIA
 CASSE PROFESSIONALI: GOVERNANCE E RUOLO NELL ECONOMIA DEL SISTEMA PAESE FRANCESCO MASSICCI Presidente f.f. Giornata Nazionale della Previdenza Napoli, 10 Maggio 2016 Gli enti previdenziali di diritto privato:
CASSE PROFESSIONALI: GOVERNANCE E RUOLO NELL ECONOMIA DEL SISTEMA PAESE FRANCESCO MASSICCI Presidente f.f. Giornata Nazionale della Previdenza Napoli, 10 Maggio 2016 Gli enti previdenziali di diritto privato:
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE
 DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE sull operazione di finanziamento erogato da Lapo Elkann, azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE sull operazione di finanziamento erogato da Lapo Elkann, azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che abroga la decisione 2010/286/UE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia
 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.5.2013 COM(2013) 385 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2010/286/UE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia IT IT Raccomandazione
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.5.2013 COM(2013) 385 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2010/286/UE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia IT IT Raccomandazione
Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria. Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013
 Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013 INDICE Pilastri Banking Union e Obiettivi framework europeo di supervisione bancaria (SSM)
Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013 INDICE Pilastri Banking Union e Obiettivi framework europeo di supervisione bancaria (SSM)
Programma formazione factoring Catalogo dei corsi per l anno 2011
 formazione factoring Catalogo dei corsi per l anno 2011 Il programma FS-Academy è un iniziativa sorta con l obiettivo di recuperare competenze ed esperienze per metterle al servizio di un progetto di formazione
formazione factoring Catalogo dei corsi per l anno 2011 Il programma FS-Academy è un iniziativa sorta con l obiettivo di recuperare competenze ed esperienze per metterle al servizio di un progetto di formazione
