Ingegneria delle Reazioni Chimiche. Prontuario. Corso di Laurea in Biotecnologie
|
|
|
- Cosimo Rizzo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ingegneria delle Reazioni Chimiche Prontuario Corso di Laurea in Biotecnologie
2 1 SIMBOLI UNITA' DI MISURA Esercizi PROPRIETÀ DEI GAS Esercizi PORTATA FLUSSO CONCENTRAZIONI Portata Flusso Concentrazione Esercizi ENERGIA ENTALPIA Entalpia Capacità termica Risoluzione attraverso Media aritmetica Risoluzione attraverso Interpolazione lineare Risoluzione attraverso Polinomiale
3 1 SIMBOLI Figure 1 Alfabeto Greco
4 2 UNITA' DI MISURA QUANTITY OR "DIMENSION SI UNIT SI UNIT SYMBOL Base quantity or "dimension" Lenght Meter m Mass Kilogram kg Time Second s Electric current Ampere A Thermodynamic Kelvin K temperature Amount of Substance Mole mol Luminous Intensity Candela cd Supplementary quantity or "dimension" Plane angle Radian rad Solid Angle steradian sr Tabella 1 Unità di misura del sistema internazionale 1
5 MULTIPLICATION FACTOR PREFIX SYMBOL = exa E = peta P = tera T = 10 9 giga G = 10 6 mega M = 10 3 kilo k 100 = 10 2 hecto h 10 = 10 1 deka da 0.1 =10-1 deci d 0.01 = 10-2 centi c = 10-3 milli m = 10-6 micro µ = 10-9 nano n = pico p =10-15 femto f = atto a Tabella 2 Prefissi unità di misura 2
6 Figura 1 Schema unità di misura derivate 3
7 Tabella 3 Unità dimensionali misure derivate 4
8 Tabella 4 Unità dimensionali misure derivate - 2 5
9 Tabella 5 Legenda unità di misura 6
10 Tabella 6 Fattori di conversione TEMPERATURE EQUIVALENT VALUES 1 Centigrade or Celsius degree 1.8 Fahrenheit degree Temperature, Kelvin T C Temperature, Rankine T F Temperature, Fahrenheit 9/5T C + 32 Temperature, centigrade or Celsius 5/9 (T F - 32) Temperature, Rankine 1.8 T K Tabella 7 Fattori di conversione della temperatura 7
11 Tabella 8 Valore della costante della legge dei gas ideali, r 8
12 2.1 ESERCIZI a) Sia data la seguente formula X = dgh Dove: i. d = densità espressa in kg m -3 ; ii. g= accelerazione di gravità espressa in ms -2 iii. h= altezza espressa in m Definire le unità della grandezza fisica X. Identificare la grandezza fisica X. b) Sia data la seguente formula X = dv ' Dove: i. d = densità espressa in kg m -3 ii. v = velocità espressa come ms -1 Definire le unità della grandezza fisica X. Identificare la grandezza fisica X. c) Sia G = 6, N m 2 kg 2, determinare le dimensioni e calcolare la grandezza di F, nei seguenti casi: F = G m +m ' R ' i. m 1 = 7, kg, m 2 = 5, kg, R = 3, m; ii. m 1 = 1, kg, m 2 = 9, kg, R = 0, m; iii. nel caso i. convertire la massa in libre e la lunghezza in miglia. d) Calcolare l ordine di grandezza e le dimensioni di r e raggio classico dell elettrone, r. = e ' 4πɛ 4 m. c ' Dove: i. e = 1, C la carica elettrica dell elettrone; 9
13 ii. ɛ 0 = 8, C 2 s 2 m 3 kg 1 la costante dielettrica del vuoto; iii. m e = kg la massa dell elettrone; iv. c = ms 1 la velocità della luce nel vuoto; v. π = 3, e) Calcolare l ordine di grandezza e le dimensioni della pressione P, Dove: P = N 8kT V i. k = 1, NmK 1 la costante di Boltzmann; ii. iii. iv. NA = 6, mol 1 (numero di Avogadro); T = 300 K (temperatura ambiente); V = 22, m 3 mol 1 (volume molare). 10
14 3 PROPRIETÀ DEI GAS Tra le numerosissime e talvolta peculiari proprietà e parametri per mezzo dei quali possiamo descrivere un dato gas, a parte quelle di natura propriamente chimica (specie chimica e numero di moli), ricordiamo: Pressione. Volume. Temperatura critica, che rappresenta la temperatura al di sopra della quale non è più possibile effettuare una transizione di stato da gas a liquido per semplice aumento della pressione, come invece avviene per i vapori. Velocità di effusione, che si riferisce alla naturale tendenza da parte di un aeriforme di occupare, seppur non istantaneamente, l intero volume del contenitore ermetico nel quale esso è posto. Vicinanza al comportamento del gas ideale. Le caratteristiche di un gas ideale possono essere così sintetizzate: Le singole particelle (atomi o molecole che siano) hanno natura puntiforme, ovvero sono così infinitamente piccole da poter essere considerate adimensionali rispetto al volume da loro occupato; Le forze attrattive tra le particelle sono nulle per cui ogni particella è indipendente dalle altre; Le collisioni tra le particelle del gas o tra le particelle del gas e le pareti del recipiente sono perfettamente elastiche; L energia cinetica media delle particelle aumenta all aumentare della temperatura assoluta del gas. Un gas reale può quindi avvicinarsi di più o di meno al comportamento del gas ideale (tendenza all idealità), dando di conseguenza la possibilità di studiarne e prevederne il comportamento secondo le equazioni semplificate sviluppare per il caso del gas ideale. In generale il comportamento sarò tanto più ideale quanto più il gas si trova ad una temperatura elevata (rispetto al suo punto di ebollizione) ed in uno stato di rarefazione, ovvero a pressione ridotta. 11
15 I gas ideali seguono l equazione seguente: PV = nrt Dove: P, esprime la pressione; V, indica la temperatura; n è il numero di moli; T indica la temperatura; R è la costante universale dei gas che può assumere diversi valori a seconda delle unità di misura utilizzate. Valore della costante dei gas, R Unità di Misura J K -1 mol L atm K -1 mol m 3 atm K -1 mol cm 3 MPa K -1 mol L kpa K -1 mol m 3 Pa K -1 mol m 3 Pa K -1 kmol L mmhg K -1 mol L Torr K -1 mol L mbar K -1 mol -1 Tabella 9Valore della costante dei gas, R In condizioni di temperatura e pressione vicine a quelle ambientali la maggior parte dei gas segue con buona approssimazione l'equazione di stato dei gas perfetti. Alle alte pressioni e alle basse temperature si manifestano invece deviazioni più o meno marcate da tale legge, in quanto il volume proprio posseduto dalle molecole e le forze di attrazione reciproche tra le molecole e tra le molecole e il recipiente non si possono più considerare trascurabili. 12
16 Per tener conto di questi fattori, sono state introdotte varie equazioni di stato, modificate per i gas reali; tra queste si segnala quella proposta attorno al 1881 dal fisico olandese J.D. van der Waals ( ), detta equazione di van der Waals per i gas reali, che si esprime nella forma: P + a V ' V b = RT dove a e b sono due costanti, caratteristiche di ogni gas, ricavate sperimentalmente. Queste leggi verranno utilizzate nel corso di Ingegneria delle reazioni chimiche soprattutto per effettuare cambi di volume/portata con la variazione di temperatura. In tal senso capiteranno esercizi in cui i valori sono espressi in condizioni normali, ovvero condizioni di temperatura pari a 0 C (273.15K) ed 1atm ( kPa). Un esempio di scrittura è: 125Nm 3 Oppure 125m 3 n E importante non confondere le condizioni di normalità appena descritte con le condizioni standard che vengono riferite di volta in volta. 13
17 3.1 ESERCIZI a) Calcolare il peso di 1Nm 3 di Metano. b) Calcolare il volume occupato da 10Nm 3 di Metano a 175 C. c) Calcolare il volume occupato a 200 C e 20bar da un gas che a 25 C e bar occupa 100l. 14
18 4 PORTATA FLUSSO CONCENTRAZIONI 4.1 PORTATA Per portata si intende la quantità di sostanza (solido, gas o liquido) che si muove attraverso un condotto in un determinato periodo di tempo (minuti, ore, giorni, anni ). In dipendenza dalla dimensione con cui ci calcola la quantità di sostanza, esistono tre differenti tipologie di portata: Ø Portata Volumetrica se espressa in unità di Volume/tempo [Q]; Ø Portata Massica se espressa in unità di Massa/tempo [W]; Ø Portata Molare se espressa in unità di Moli/tempo. [N]; ESEMPIO Un fluido ha la portata di 250 m 3 /h [portata volumetrica]; Un fluido ha la portata di 250 l/d [portata volumetrica]; Un gas ha la portata di 600 mol/sec [portata molare]; Un gas ha la portata di 500 kg/min [portata massica]. Vi è spesso la necessità di convertire le unità tra portata volumetrica <-> portata massica: la conversione deve essere effettuata utilizzando la densità, ovvero: ρ = massa volume Ø Per i gas si può utilizzare la Legge dei gas Ideali conoscendo il peso molecolare della sostanza; Ø Per i liquidi si ricava la densità da tabelle riportate in manuali di termodinamica/proprietà termo chimiche. 15
19 4.2 FLUSSO In fisica, il significato originario del termine è quello di volume di un fluido che passa, nell unità di tempo attraverso una superficie. Volendo generalizzare la definizione, è possibile definire il flusso come una determinata quantità di materia che passa nell unità di tempo attraverso una superficie. Come per la portata, a seconda della grandezza riferita alla quantità, il flusso può essere espresso con differenti equazioni dimensionali: Ø Il flusso di massa può essere espresso come Kg/m 2 s; Ø Il flusso di energia può essere espresso come J/m 2 h; Ø. NOTA Non confondiamo flusso e portata! 4.3 CONCENTRAZIONE La concentrazione è la grandezza che esprime il rapporto tra la quantità di un componente rispetto alla quantità di tutti i componenti della miscela, ed in alcuni casi, del componente più abbondante. A seconda di come si sceglie di esprimente le quantità del componente rispetto alla miscela, la concentrazione può essere espressa come: Ø X w frazione (percentuale) in peso FGHHG I.J KLFMLN.NO. PQ.HPFL FGHHG I.JJG FPHK.JG Ø X v frazione (percentuale) in volume ULJVF. I.J KLFMLN.NO. PQ.HPFL ULJVF. I.JJG FPHK.JG Ø M Molarità FLJP I.J KLFMLN.NO. PQ.HPFL ULJVF. I.JJG FPHK.JG (J) Ø m Molalità Ø X A Frazione molare FLJP I.J KLFMLN.NO. PQHPFL M.HL I.JJG FPHK.JG (Y) FLJP I.J KLFMLN.NO. PQHPFL FLJP I.JJG FPHK.JG 100 Quando si sommano due portate massiche, la portata risultante è la somma delle due: W + + W ' = W [ Questo non è valido per le concentrazioni e per le portate volumetriche! X + + X ' X [ 16
20 Q + + Q ' Q [ 4.4 ESERCIZI a) Calcolare la portata volumetrica di un fluido uscente da un condotto a sezione ovale con sezione pari a 1.5 m 2. e velocità di 1.5 ft/h. Se il fluido è acqua determinare la portata massica b) La portata di un fluido è 125 kg/h e la sua densità corrisponde a g/cm 3 : calcolare la portata volumetrica esprimendola in galloni al secondo. c) La portata dell aria in un condotto di aereazione è di 30m 3 n/h: calcolare la portata massica a temperatura 35 C ed 1 atm. 17
21 5 ENERGIA ENTALPIA 5.1 ENTALPIA L entalpia è una funzione di stato di un sistema ed esprime la quantità di energia che esso può scambiare con l ambiente. La formula generica è: H = U + pv Dove U rappresenta l energia interna del sistema; p la pressione; V il volume. Essendo l entalpia una forma di energia, l unità di misura adottata nel Sistema Internazionale (SI) è il Joule (J); il sistema tecnico (ST) utilizza la caloria (cal). La variazione netta di Entalpia [H fin H iniz ] risultante dalle reazioni chimiche è definita calore di reazione: se tale valore è negativo, la reazione avviene con sviluppo di calore [reazione esotermica]; viceversa, se il valore è positivo la reazione necessità di calore [reazione endotermica]. Il ragionamento posto alla base di ciò è il postulato fondamentale di Lavoiser: Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Infatti, se l energia dei reagenti non è uguale a quella dei prodotti, la differenza tra i due valori deve essere fornita rilasciata dall ambiente all ambiente. Nel caso specifico delle reazioni esotermiche, l energia dei reagenti è maggiore di quella dei prodotti: la quantità mancante, che non può scomparire nel nulla, viene ceduta sotto forma di energia termica. Caso contrario avviene per le reazioni endotermiche, dove l energia dei prodotti è maggiore rispetto a quella fornita dai reagenti: affinché la reazione possa avvenire vi è la necessità di fornire energia termica. Il calore è la differenza di entalpia tra due stati del sistema. Per calore sensibile si intende la variazione entalpica, ovvero l energia necessaria affinché si verifichi un aumento della temperatura della sostanza. Il calore latente è la quantità di energia necessaria per lo svolgimento di una transizione di fase (es. calore latente di fusione, calore latente di sublimazione e calore latente di sublimazione). Esso non comporta e non è associato a variazioni di temperatura del sistema in passaggio di fase. 18
22 ESEMPIO Calcolare la quantità di energia necessaria affinché l acqua passi da 25 C a 200 C. q = ΔH +44 d 'e d + H fgm + ΔH '44 d +44 d E sbagliato: q = ΔH '44 d 'e d 5.2 CAPACITÀ TERMICA A composizione costante, l entalpia può essere espressa in funzione di temperatura e pressione come segue: dh = δh δt h dt Per i gas ideali, solidi e liquidi al di fuori della regione critica, è possibile sostituire: δh δt h = C M Dove C P indica la capacità termica a pressione, ovvero la variazione infinitesimale di entalpia rispetto alla variazione infinitesimale della temperatura a pressione costante. Quindi la formula diviene: dh = C M dt dh = m d(c M T) 1 Moltiplico e divido per ΔT dh = m j k j l C M dt dh = m j k C M dt j l ΔT ΔT 19
23 Dove m j k C M dt j l ΔT = C MF Quindi dh = C MF ΔT Dove C p è la capacità termica della sostanza e C pm è il calore specifico. Il calore specifico è espresso come la capacità termica per quantità di massa ed una proprietà specifica per ogni materiale/sostanza: esso è dipendente dalla temperatura con una funzionalità non lineare. Esistono tabelle in cui questo valore è già calcolato per singoli composti a determinate temperature. Tali valori sono puntuali e vanno utilizzati con cautela quando si deve calcolare il calore, ovvero l entalpia scambiata tra due stadi. Il calcolo della differenza di entalpia si imposta quindi integrando l equazione 1. Per il calcolo del C pm si vedano i paragrafi successivi Risoluzione attraverso Media aritmetica Un primo, semplice metodo è il calcolo attraverso una media aritmetica. E possibile utilizzare queste formule quando si ha a disposizione o i valori delle entalpie alle varie temperature o il valore del C p medio della sostanza. C MF = C M (j+) (j') + C M 2 ESEMPIO a) Calcolare l entalpia dell acqua che passa da 25 C a 65 C. La formula per il calcolo dell entalpia è: dh = C MF ΔT 20
24 Per calcolare il C pm utilizzo la media aritmetica, quindi: Da valori tabellari sappiamo che: C MF = C M ('e d) (pe d) + C M 2 C M 'e d = kcal kg C C M (pe d) = 1.00 kcal kg C Quindi C MF = kcal kg C Infine: dh = (65 25) Risoluzione attraverso Interpolazione lineare x x + x ' x + = y y + y ' y + Dove i simboli con il pedice sono valori i valori noti tabellari. ESEMPIO Stesso esercizio di prima ma utilizziamo il metodo dell interpolazione lineare C MF C N 'e C pe 'e MF C MF = T
25 5.2.3 Risoluzione attraverso Polinomiale Considerato che la capacità termica non è una funzione lineare, per il suo calcolo si utilizzano formule matematiche con constanti e variabili combinate tra loro: espressioni polinomiali. Tra le più utilizzate sono le seguenti: C M = a + bt + ct ' + dt [ Oppure C M R = a + bt + ct' + d T [ dove i termini a, b, c, d sono tabellati. Le formule differiscono tra loro per le unità dimensionali di C p : solitamente dove vengono reperiti i valori dei termini noti, vi è anche nell intestazione della tabella la formula da utilizzare e le unità di misura di C p! 22
GAS IDEALI (o gas perfetti )
 GAS IDEALI (o gas perfetti ) TEORIA CINETICA DEI GAS (modello di gas ideale ) molecole puntiformi moto rettilineo ed urti elastici forze attrattive - repulsive intermolecolari nulle PARAMETRI DELLO STATO
GAS IDEALI (o gas perfetti ) TEORIA CINETICA DEI GAS (modello di gas ideale ) molecole puntiformi moto rettilineo ed urti elastici forze attrattive - repulsive intermolecolari nulle PARAMETRI DELLO STATO
GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. Lo stato gassoso
 GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA Lo stato gassoso Classificazione della materia MATERIA Composizione Struttura Proprietà Trasformazioni 3 STATI DI AGGREGAZIONE SOLIDO (volume e forma propri) LIQUIDO
GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA Lo stato gassoso Classificazione della materia MATERIA Composizione Struttura Proprietà Trasformazioni 3 STATI DI AGGREGAZIONE SOLIDO (volume e forma propri) LIQUIDO
Lo stato gassoso e le sue proprietà
 Lo stato gassoso e le sue proprietà Dr. Gabriella Giulia Pulcini Ph.D. Student, Development of new approaches to teaching and learning Natural and Environmental Sciences University of Camerino, ITALY 1
Lo stato gassoso e le sue proprietà Dr. Gabriella Giulia Pulcini Ph.D. Student, Development of new approaches to teaching and learning Natural and Environmental Sciences University of Camerino, ITALY 1
LA MATERIA ED I SUOI STATI
 LA MATERIA ED I SUOI STATI GAS COMPOSIZIONE DELL ARIA 1. I gas ideali e la teoria cineticomolecolare Nel modello del gas ideale le particelle 1. l energia cinetica media delle particelle è proporzionale
LA MATERIA ED I SUOI STATI GAS COMPOSIZIONE DELL ARIA 1. I gas ideali e la teoria cineticomolecolare Nel modello del gas ideale le particelle 1. l energia cinetica media delle particelle è proporzionale
Un modello per il gas ideale
 Un modello per il gas ideale Un gas ideale consiste di particelle (atomi o molecole) che hanno le seguenti proprietà 1. Il volume proprio delle particelle è trascurabile rispetto al volume occupato dal
Un modello per il gas ideale Un gas ideale consiste di particelle (atomi o molecole) che hanno le seguenti proprietà 1. Il volume proprio delle particelle è trascurabile rispetto al volume occupato dal
Alcune informazioni utili
 Alcune informazioni utili DATE 12 incontri 10-17-24 ottobre 2016 7-14-21-28 novembre 2016 5-12-19 dicembre 2016 9-16 gennaio 2017 ogni lunedì ORARIO dalle 8.30 alle 10.30 Aula VM1 Dove trovarmi E-mail:
Alcune informazioni utili DATE 12 incontri 10-17-24 ottobre 2016 7-14-21-28 novembre 2016 5-12-19 dicembre 2016 9-16 gennaio 2017 ogni lunedì ORARIO dalle 8.30 alle 10.30 Aula VM1 Dove trovarmi E-mail:
Le dimensioni rappresentano il concetto di misura fondamentali: lunghezza, tempo, massa, temperatura,
 Dimensioni e unità Le dimensioni rappresentano il concetto di misura fondamentali: lunghezza, tempo, massa, temperatura, derivate: energia, forza, velocità, pressione, Le unità sono i mezzi utilizzati
Dimensioni e unità Le dimensioni rappresentano il concetto di misura fondamentali: lunghezza, tempo, massa, temperatura, derivate: energia, forza, velocità, pressione, Le unità sono i mezzi utilizzati
Dipartimento di Scienze Chimiche. Ambiente. Sistema
 Descrizione macroscopica dei sistemi materiali Sistema: materia compresa entro una superficie chiusa (ad esempio la superficie interna di un contenitore, ma può essere anche una superficie matematica,
Descrizione macroscopica dei sistemi materiali Sistema: materia compresa entro una superficie chiusa (ad esempio la superficie interna di un contenitore, ma può essere anche una superficie matematica,
Ultima verifica pentamestre. 1)definizione di miscuglio, soluzione, composto, elemento, molecola ( definizione importantissima!!!!!!!!
 Ultima verifica pentamestre 1)definizione di miscuglio, soluzione, composto, elemento, molecola ( definizione importantissima!!!!!!!!) 2) gruppi dal IV al VIII 3) differenza tra massa atomica e massa atomica
Ultima verifica pentamestre 1)definizione di miscuglio, soluzione, composto, elemento, molecola ( definizione importantissima!!!!!!!!) 2) gruppi dal IV al VIII 3) differenza tra massa atomica e massa atomica
Calcoli applicati alla chimica analitica. Unità di misura del Sistema Internazionale
 Calcoli applicati alla chimica analitica Unità di misura del Sistema Internazionale Soluzioni e loro concentrazioni Stechiometria chimica 1 Unità di misura SI Il Sistema Internazionale delle Unità (SI)
Calcoli applicati alla chimica analitica Unità di misura del Sistema Internazionale Soluzioni e loro concentrazioni Stechiometria chimica 1 Unità di misura SI Il Sistema Internazionale delle Unità (SI)
Leggi dei gas Equazione di stato dei gas perfetti
 Le leggi dei gas Quale descrizione fisico-matematica si può usare per i diversi stati di aggregazione della materia? Essa è tanto più semplice (equazioni) quanto meno interagenti sono fra loro le particelle
Le leggi dei gas Quale descrizione fisico-matematica si può usare per i diversi stati di aggregazione della materia? Essa è tanto più semplice (equazioni) quanto meno interagenti sono fra loro le particelle
Proprietà volumetriche delle sostanze pure. Principi di Ingegneria Chimica Ambientale
 Proprietà volumetriche delle sostanze pure Principi di Ingegneria Chimica Ambientale le fasi di una specie pura Una sostanza la cui composizione chimica non varia in tutta la massa presa in considerazione
Proprietà volumetriche delle sostanze pure Principi di Ingegneria Chimica Ambientale le fasi di una specie pura Una sostanza la cui composizione chimica non varia in tutta la massa presa in considerazione
Proprietà volumetriche delle sostanze pure. Termodinamica dell Ingegneria Chimica
 Proprietà volumetriche delle sostanze pure Termodinamica dell Ingegneria Chimica le fasi di una specie pura Una sostanza la cui composizione chimica non varia in tutta la massa presa in considerazione
Proprietà volumetriche delle sostanze pure Termodinamica dell Ingegneria Chimica le fasi di una specie pura Una sostanza la cui composizione chimica non varia in tutta la massa presa in considerazione
Il Gas Ideale. Il gas ideale é un'astrazione
 Il Gas Ideale a) le particelle sono animate da moto perenne, ed occupano omogeneamente tutto lo spazio a loro disposizione b) il movimento delle particelle è casuale c) le particelle hanno volume proprio
Il Gas Ideale a) le particelle sono animate da moto perenne, ed occupano omogeneamente tutto lo spazio a loro disposizione b) il movimento delle particelle è casuale c) le particelle hanno volume proprio
delle curve isoterme dell anidride carbonica
 COMPORTAMENTO DEI GAS REALI l andamento delle curve isoterme dell anidride carbonica mostra che: a temperature elevate le isoterme assomigliano a quelle di un gas perfetto Diagramma di Andrews a temperature
COMPORTAMENTO DEI GAS REALI l andamento delle curve isoterme dell anidride carbonica mostra che: a temperature elevate le isoterme assomigliano a quelle di un gas perfetto Diagramma di Andrews a temperature
1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione dei gas 4. La legge di Boyle o legge isoterma 5.
 Unità n 6 Le leggi dei gas 1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione dei gas 4. La legge di Boyle o legge isoterma 5. La legge di Gay-Lussac o legge
Unità n 6 Le leggi dei gas 1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione dei gas 4. La legge di Boyle o legge isoterma 5. La legge di Gay-Lussac o legge
Fisicaa Applicata, Area Tecnica, M. Ruspa. GRANDEZZE FISICHE e MISURA DI GRANDEZZE FISICHE
 GRANDEZZE FISICHE e MISURA DI GRANDEZZE FISICHE 1 LA FISICA COME SCIENZA SPERIMENTALE OSSERVAZIONI SPERIMENTALI Studio di un fenomeno MISURA DI GRANDEZZE FISICHE IPOTESI VERIFICA LEGGI FISICHE Relazioni
GRANDEZZE FISICHE e MISURA DI GRANDEZZE FISICHE 1 LA FISICA COME SCIENZA SPERIMENTALE OSSERVAZIONI SPERIMENTALI Studio di un fenomeno MISURA DI GRANDEZZE FISICHE IPOTESI VERIFICA LEGGI FISICHE Relazioni
LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE. Prof Giovanni Ianne
 LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE Prof Giovanni Ianne Il metodo scientifico La Fisica studia i fenomeni naturali per: fornire una descrizione accurata di tali fenomeni interpretare le relazioni fra di
LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE Prof Giovanni Ianne Il metodo scientifico La Fisica studia i fenomeni naturali per: fornire una descrizione accurata di tali fenomeni interpretare le relazioni fra di
Il prodotto della pressione per il volume di una determinata massa gassosa è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta: PV = KT
 ESERCITAZIONE 5 LEGGI DEI GAS Le leggi che governano i rapporti che si stabiliscono tra massa, volume, temperatura e pressione di un gas, sono leggi limite, riferite cioè ad un comportamento ideale, cui
ESERCITAZIONE 5 LEGGI DEI GAS Le leggi che governano i rapporti che si stabiliscono tra massa, volume, temperatura e pressione di un gas, sono leggi limite, riferite cioè ad un comportamento ideale, cui
GAS. Forze di legame intermolecolari ridotte Stato altamente disordinato
 I GAS PERFETTI GAS Forze di legame intermolecolari ridotte Stato altamente disordinato Principali caratteristiche: Bassa viscosità Assenza di volume e forma propri Comprimibilità Miscibilità Pressione:
I GAS PERFETTI GAS Forze di legame intermolecolari ridotte Stato altamente disordinato Principali caratteristiche: Bassa viscosità Assenza di volume e forma propri Comprimibilità Miscibilità Pressione:
La Termodinamica è la disciplina che si occupa dello studio degli scambi di energia e di materia nei processi fisici e chimici
 La Termodinamica è la disciplina che si occupa dello studio degli scambi di energia e di materia nei processi fisici e chimici Materia = tutto ciò che possiede una massa ed occupa uno spazio Energia =
La Termodinamica è la disciplina che si occupa dello studio degli scambi di energia e di materia nei processi fisici e chimici Materia = tutto ciò che possiede una massa ed occupa uno spazio Energia =
Misure e Unità di Misura
 2. La Mole Misure e Unità di Misura L Incertezza delle Misure - come utilizzare le cifre significative nel calcolo Le Quantità Chimiche - la MOLE - la MASSA MOLARE - la misura dei composti La Determinazione
2. La Mole Misure e Unità di Misura L Incertezza delle Misure - come utilizzare le cifre significative nel calcolo Le Quantità Chimiche - la MOLE - la MASSA MOLARE - la misura dei composti La Determinazione
CORSO DI CHIMICA. Esercitazione del 7 Giugno 2016
 CORSO DI CHIMICA Esercitazione del 7 Giugno 2016 25 ml di una miscela di CO e CO 2 diffondono attraverso un foro in 38 s. Un volume uguale di O 2 diffonde nelle stesse condizioni in 34,3 s. Quale è la
CORSO DI CHIMICA Esercitazione del 7 Giugno 2016 25 ml di una miscela di CO e CO 2 diffondono attraverso un foro in 38 s. Un volume uguale di O 2 diffonde nelle stesse condizioni in 34,3 s. Quale è la
Il metodo scientifico
 Il metodo scientifico n La Fisica studia i fenomeni naturali per: n fornire una descrizione accurata di tali fenomeni n interpretare le relazioni fra di essi n Il metodo scientifico: n osservazione sperimentale
Il metodo scientifico n La Fisica studia i fenomeni naturali per: n fornire una descrizione accurata di tali fenomeni n interpretare le relazioni fra di essi n Il metodo scientifico: n osservazione sperimentale
Lo stato liquido. i liquidi molecolari con legami a idrogeno: le interazioni tra le molecole si stabiliscono soprattutto attraverso legami a idrogeno
 Lo stato liquido Le particelle sono in continuo movimento, anche se questo risulta più limitato rispetto al caso dei gas. Il movimento caratteristico a zig-zag delle particelle è chiamato moto Browniano.
Lo stato liquido Le particelle sono in continuo movimento, anche se questo risulta più limitato rispetto al caso dei gas. Il movimento caratteristico a zig-zag delle particelle è chiamato moto Browniano.
PROBLEMI E QUESITI DI TERMOLOGIA (SOLUZIONI)
 1 PROBLEMI E QUESITI DI TERMOLOGIA (SOLUZIONI) Qui di seguito viene riportata la risoluzione dei problemi presentati nel file Unità omonimo (enunciati). Si raccomanda di prestare molta attenzione ai ragionamenti
1 PROBLEMI E QUESITI DI TERMOLOGIA (SOLUZIONI) Qui di seguito viene riportata la risoluzione dei problemi presentati nel file Unità omonimo (enunciati). Si raccomanda di prestare molta attenzione ai ragionamenti
I gas e loro proprietà Cap , 9-12, 15-24, 27-28, 31-33, 37-40, 52, 93-96
 2016 2017 CCS - Biologia CCS Scienze Geologiche 1 I gas e loro proprietà Cap 11. 1-7, 9-12, 15-24, 27-28, 31-33, 37-40, 52, 93-96 2 Proprietà Generali dei Gas I gas possono essere espansi all infinito.
2016 2017 CCS - Biologia CCS Scienze Geologiche 1 I gas e loro proprietà Cap 11. 1-7, 9-12, 15-24, 27-28, 31-33, 37-40, 52, 93-96 2 Proprietà Generali dei Gas I gas possono essere espansi all infinito.
Stati di aggregazione della materia
 Stati di aggregazione della materia A seconda della natura dei legami tra gli atomi o delle forze tra le molecole si possono avere diversi stati di aggregazione della materia SOLIDO LIQUIDO GAS PLASMA
Stati di aggregazione della materia A seconda della natura dei legami tra gli atomi o delle forze tra le molecole si possono avere diversi stati di aggregazione della materia SOLIDO LIQUIDO GAS PLASMA
Gli stati di aggregazione della materia.
 Gli stati di aggregazione della materia. Stati di aggregazione della materia: Solido, liquido, gassoso Passaggi di stato: Solido Liquido (fusione) e liquido solido (solidificazione); Liquido aeriforme
Gli stati di aggregazione della materia. Stati di aggregazione della materia: Solido, liquido, gassoso Passaggi di stato: Solido Liquido (fusione) e liquido solido (solidificazione); Liquido aeriforme
UNITA di MISURA e DIMENSIONI delle OSSERVABILI FISICHE. UdM 1
 UNITA di MISURA e DIMENSIONI delle OSSERVABILI FISICHE UdM 1 Lo studio dei fenomeni naturali si basa sulle osservazioni sperimentali e richiede la misura di certe grandezze fisiche. Ai fini della misurazione
UNITA di MISURA e DIMENSIONI delle OSSERVABILI FISICHE UdM 1 Lo studio dei fenomeni naturali si basa sulle osservazioni sperimentali e richiede la misura di certe grandezze fisiche. Ai fini della misurazione
Unità didattica 1. Prima unità didattica (Fisica) 1. Corso integrato di Matematica e Fisica per il Corso di Farmacia
 Unità didattica 1 Unità di misura Cinematica Posizione e sistema di riferimento....... 3 La velocità e il moto rettilineo uniforme..... 4 La velocità istantanea... 5 L accelerazione 6 Grafici temporali.
Unità didattica 1 Unità di misura Cinematica Posizione e sistema di riferimento....... 3 La velocità e il moto rettilineo uniforme..... 4 La velocità istantanea... 5 L accelerazione 6 Grafici temporali.
Corso di Fisica Tecnica EA - a.a. 2005/06 27 febbraio 2006
 1 Unità di misura La misura è una tecnica mediante la quale a una grandezza fisica (ad esempio le proprietà come definite nel testo) si associa un numero, risultato di una procedura che prevede un confronto
1 Unità di misura La misura è una tecnica mediante la quale a una grandezza fisica (ad esempio le proprietà come definite nel testo) si associa un numero, risultato di una procedura che prevede un confronto
Termodinamica e termochimica
 Termodinamica e termochimica La termodinamica è una scienza che studia proprietà macroscopiche della materia e prevede quali processi chimici e fisici siano possibili, in quali condizioni e con quali energie
Termodinamica e termochimica La termodinamica è una scienza che studia proprietà macroscopiche della materia e prevede quali processi chimici e fisici siano possibili, in quali condizioni e con quali energie
Termodinamica e termochimica
 Termodinamica e termochimica La termodinamica è una scienza che studia proprietà macroscopiche della materia e prevede quali processi chimici e fisici siano possibili, in quali condizioni e con quali energie
Termodinamica e termochimica La termodinamica è una scienza che studia proprietà macroscopiche della materia e prevede quali processi chimici e fisici siano possibili, in quali condizioni e con quali energie
Sistemi Gassosi. GAS = specie che occupa tutto lo spazio disponibile. VOLUME = spazio occupato si misura in: m 3, L (1L = 1dm 3 )
 Sistemi Gassosi GAS = specie che occupa tutto lo spazio disponibile VOLUME = spazio occupato si misura in: m 3, L (1L = 1dm 3 ) PRESSIONE = forza per unità di superficie Unità di misura: Forza Newton (N)
Sistemi Gassosi GAS = specie che occupa tutto lo spazio disponibile VOLUME = spazio occupato si misura in: m 3, L (1L = 1dm 3 ) PRESSIONE = forza per unità di superficie Unità di misura: Forza Newton (N)
Le idee della chimica
 G. Valitutti A.Tifi A.Gentile Seconda edizione Copyright 2009 Zanichelli editore Capitolo 6 Le leggi dei gas 1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione
G. Valitutti A.Tifi A.Gentile Seconda edizione Copyright 2009 Zanichelli editore Capitolo 6 Le leggi dei gas 1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione
Soluzioni unità 3, modulo D del libro
 Soluzioni unità 3, modulo D del libro SOLUZIONE: miscela omogenea di 2 o più sostanze Particelle dei componenti di dimensioni molecolari Componenti distribuiti in maniera caotica Se manca uno di questi
Soluzioni unità 3, modulo D del libro SOLUZIONE: miscela omogenea di 2 o più sostanze Particelle dei componenti di dimensioni molecolari Componenti distribuiti in maniera caotica Se manca uno di questi
Calorimetria. Principio zero Trasformazioni termodinamiche Lavoro termodinamico
 Calorimetria Principio zero Trasformazioni termodinamiche Lavoro termodinamico Stato di un sistema In Meccanica: lo stato di una particella è definito quando per ogni istante siano note, la posizione (x,
Calorimetria Principio zero Trasformazioni termodinamiche Lavoro termodinamico Stato di un sistema In Meccanica: lo stato di una particella è definito quando per ogni istante siano note, la posizione (x,
Stati della materia. Esempio. Fusione e solidificazione. Esempio. Stati di aggregazione della materia
 Stati della materia STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E GAS PERFETTI Cosa sono gli stati della materia? Gli stati della materia sono come si presenta la materia nell universo fisico e dipendono dalla
Stati della materia STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E GAS PERFETTI Cosa sono gli stati della materia? Gli stati della materia sono come si presenta la materia nell universo fisico e dipendono dalla
Corso di Chimica Generale CL Biotecnologie
 Corso di Chimica Generale CL Biotecnologie STATI DELLA MATERIA Prof. Manuel Sergi MATERIA ALLO STATO GASSOSO MOLECOLE AD ALTA ENERGIA CINETICA GRANDE DISTANZA TRA LE MOLECOLE LEGAMI INTERMOLECOLARI DEBOLI
Corso di Chimica Generale CL Biotecnologie STATI DELLA MATERIA Prof. Manuel Sergi MATERIA ALLO STATO GASSOSO MOLECOLE AD ALTA ENERGIA CINETICA GRANDE DISTANZA TRA LE MOLECOLE LEGAMI INTERMOLECOLARI DEBOLI
Soluzioni degli esercizi
 Soluzioni degli esercizi Compito 1. Formula risolutiva: Q = (Q 1 +Q 2 +Q 3 +Q 4 +Q 5 )/5 Valor medio della quantità di calore = 0.556E+02 J Formula risolutiva: C = Q/ΔT con ΔT = variazione temperatura
Soluzioni degli esercizi Compito 1. Formula risolutiva: Q = (Q 1 +Q 2 +Q 3 +Q 4 +Q 5 )/5 Valor medio della quantità di calore = 0.556E+02 J Formula risolutiva: C = Q/ΔT con ΔT = variazione temperatura
Esploriamo la chimica
 1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 6 Le leggi dei gas 1. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 2. La pressione dei gas 3.
1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 6 Le leggi dei gas 1. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 2. La pressione dei gas 3.
Termodinamica. Scienza che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia coinvolte in un processo fisico o chimico
 Termodinamica Scienza che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia coinvolte in un processo fisico o chimico La termodinamica fa uso di modelli astratti per rappresentare sistemi e
Termodinamica Scienza che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia coinvolte in un processo fisico o chimico La termodinamica fa uso di modelli astratti per rappresentare sistemi e
Tutte le altre grandezze fisiche derivano da queste e sono dette grandezze DERIVATE (es. la superficie e il volume).
 Grandezze fisiche e misure La fisica studia i fenomeni del mondo che ci circonda e ci aiuta a capirli. Tutte le grandezze che caratterizzano un fenomeno e che possono essere misurate sono dette GRANDEZZE
Grandezze fisiche e misure La fisica studia i fenomeni del mondo che ci circonda e ci aiuta a capirli. Tutte le grandezze che caratterizzano un fenomeno e che possono essere misurate sono dette GRANDEZZE
Queste proprietà derivano dalla grande distanza che separa le molecole che compongono un gas.
 Stato Gassoso Lo stato gassoso I gas hanno tre proprietà caratteristiche: 1.sono facilmente comprimibili 2. si espandono per riempire il loro contenitore 3. occupano molto più spazio dei solidi e liquidi
Stato Gassoso Lo stato gassoso I gas hanno tre proprietà caratteristiche: 1.sono facilmente comprimibili 2. si espandono per riempire il loro contenitore 3. occupano molto più spazio dei solidi e liquidi
i tre stati di aggregazione
 Temperatura e Calore -temperatura -calore e calore specifico -lavoro in termodinamica -trasformazioni termodinamiche -trasformazioni di stato -energia interna 1 i tre stati di aggregazione solido Ordine
Temperatura e Calore -temperatura -calore e calore specifico -lavoro in termodinamica -trasformazioni termodinamiche -trasformazioni di stato -energia interna 1 i tre stati di aggregazione solido Ordine
Dinamica delle reazioni chimiche (attenzione: mancano i disegni)
 Dinamica delle reazioni chimiche (attenzione: mancano i disegni) Primo principio della termodinamica L energia non si può creare o distruggere, ma solo convertire da una forma all altra. Questo significa
Dinamica delle reazioni chimiche (attenzione: mancano i disegni) Primo principio della termodinamica L energia non si può creare o distruggere, ma solo convertire da una forma all altra. Questo significa
Soluzioni degli esercizi
 Soluzioni degli esercizi Compito 1. Formula risolutiva: t = V ρ g h / W con V = volume pozza, ρ = densità assoluta dell'acqua, h = altezza, W = potenza pompa Tempo = 0.1490E+03 s Formula risolutiva: c
Soluzioni degli esercizi Compito 1. Formula risolutiva: t = V ρ g h / W con V = volume pozza, ρ = densità assoluta dell'acqua, h = altezza, W = potenza pompa Tempo = 0.1490E+03 s Formula risolutiva: c
b) Essendo p A V A = p C V C ne risulta T C = T A = 300 K.
 2.00 moli di un gas perfetto di volume V 1 = 3.50 m 3 e T 1 = 300 K possono espandersi fino a V 2 = 7.00 m 3 e T 2 = 300 K. Il processo è compiuto isotermicamente. Determinare: a) Il lavoro fatto dal gas;
2.00 moli di un gas perfetto di volume V 1 = 3.50 m 3 e T 1 = 300 K possono espandersi fino a V 2 = 7.00 m 3 e T 2 = 300 K. Il processo è compiuto isotermicamente. Determinare: a) Il lavoro fatto dal gas;
Fondamenti di Meteorologia e Climatologia
 Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Prof. Dino Zardi Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Fondamenti di Meteorologia
Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Prof. Dino Zardi Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Fondamenti di Meteorologia
Sistemi di unità di Misura
 Sistemi di unità di Misura Costruzione di un sistema di unità di misura: 1) Scegliere un particolare gruppo ( 4) di grandezze fisiche (lunghezza, tempo, massa, velocità, accelerazione, energia, potenza,
Sistemi di unità di Misura Costruzione di un sistema di unità di misura: 1) Scegliere un particolare gruppo ( 4) di grandezze fisiche (lunghezza, tempo, massa, velocità, accelerazione, energia, potenza,
Stati di aggregazione della materia. GAS Volume e forma indefiniti LIQUIDO Volume definito, forma indefinita SOLIDO Volume e forma definiti
 9. I Gas Farmacia Stati di aggregazione della materia GAS Volume e forma indefiniti LIQUIDO Volume definito, forma indefinita SOLIDO Volume e forma definiti Stato solido Nello stato solido l energia di
9. I Gas Farmacia Stati di aggregazione della materia GAS Volume e forma indefiniti LIQUIDO Volume definito, forma indefinita SOLIDO Volume e forma definiti Stato solido Nello stato solido l energia di
Passaggi di stato. P = costante
 Passaggi di stato P costante Diagramma isobaro di riscaldamento, relativo ai passaggi di stato Solido Liquido vapore. Si noti che la diversa lunghezza dei tratti FG e EV vuol mettere in evidenza, qualitativamente,
Passaggi di stato P costante Diagramma isobaro di riscaldamento, relativo ai passaggi di stato Solido Liquido vapore. Si noti che la diversa lunghezza dei tratti FG e EV vuol mettere in evidenza, qualitativamente,
SCALA TERMOMETRICA CELSIUS
 TERMOLOGIA TEMPERATURA LA TEMPERATURA E UN INDICE DELLA SENSAZIONE FISIOLOGICA DI CALDO/FREDDO. A LIVELLO MICROSCOPICO E INDICE DELLO STATO DI AGITAZIONE TERMICA MOLECOLARE, ESSENDO PROPORZIONALE ALLA
TERMOLOGIA TEMPERATURA LA TEMPERATURA E UN INDICE DELLA SENSAZIONE FISIOLOGICA DI CALDO/FREDDO. A LIVELLO MICROSCOPICO E INDICE DELLO STATO DI AGITAZIONE TERMICA MOLECOLARE, ESSENDO PROPORZIONALE ALLA
Gradi di libertà negli sta/ di aggregazione della materia
 Gradi di libertà negli sta/ di aggregazione della materia I solidi cristallini sono cara-erizza0 da un ordine nelle posizioni e nelle orientazioni. Gradi di libertà negli sta/ di aggregazione della materia
Gradi di libertà negli sta/ di aggregazione della materia I solidi cristallini sono cara-erizza0 da un ordine nelle posizioni e nelle orientazioni. Gradi di libertà negli sta/ di aggregazione della materia
Forze Intermolecolari. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
 Forze Intermolecolari Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 1 Forze Intermolecolari Le Forze Intermolecolari sono forze attrattive fra molecole. Le
Forze Intermolecolari Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 1 Forze Intermolecolari Le Forze Intermolecolari sono forze attrattive fra molecole. Le
GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. Lo stato gassoso
 GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA Lo stato gassoso Classificazione della materia MATERIA Composizione Struttura Proprietà Trasformazioni 3 STATI DI AGGREGAZIONE SOLIDO (volume e forma propri) LIQUIDO
GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA Lo stato gassoso Classificazione della materia MATERIA Composizione Struttura Proprietà Trasformazioni 3 STATI DI AGGREGAZIONE SOLIDO (volume e forma propri) LIQUIDO
14 Gas reali. Potenziali termodinamici
 4 Gas reali. Potenziali termodinamici (9 problemi, difficoltà 62, soglia 43) Formulario Equazione di van der Waals per i gas reali per mol p + a v 2 (v b) RT, dove a e b sono due costanti diverse da gas
4 Gas reali. Potenziali termodinamici (9 problemi, difficoltà 62, soglia 43) Formulario Equazione di van der Waals per i gas reali per mol p + a v 2 (v b) RT, dove a e b sono due costanti diverse da gas
Fisica per scienze ed ingegneria
 Serway, Jewett Fisica per scienze ed ingegneria Capitolo 19 Temperatura e principio zero della termodinamica I nostri sensi non sono affidabili per definire lo stato termico dei corpi. Ocorre un metodo
Serway, Jewett Fisica per scienze ed ingegneria Capitolo 19 Temperatura e principio zero della termodinamica I nostri sensi non sono affidabili per definire lo stato termico dei corpi. Ocorre un metodo
ESERCIZI ESERCIZI. 1) L equazione di stato valida per i gas perfetti è: a. PV = costante b. PV = nrt c. PV = znrt d. RT = npv Soluzione
 ESERCIZI 1) L equazione di stato valida per i gas perfetti è: a. PV = costante b. PV = nrt c. PV = znrt d. RT = npv 2) In genere, un gas si comporta idealmente: a. ad elevate pressioni e temperature b.
ESERCIZI 1) L equazione di stato valida per i gas perfetti è: a. PV = costante b. PV = nrt c. PV = znrt d. RT = npv 2) In genere, un gas si comporta idealmente: a. ad elevate pressioni e temperature b.
PASSAGGI DI STATO. sublimazione fusione ebollizione. solidificazione. condensazione. brinamento. Calore. Scrittura in formule:
 PASSAGGI DI STATO sublimazione fusione ebollizione S solidificazione L condensazione V brinamento Calore Scrittura in formule: - H O (s) H 2 2 O (l) fusione - H O (l) H 2 2 O (g) evaporazione - H O (s)
PASSAGGI DI STATO sublimazione fusione ebollizione S solidificazione L condensazione V brinamento Calore Scrittura in formule: - H O (s) H 2 2 O (l) fusione - H O (l) H 2 2 O (g) evaporazione - H O (s)
Calore, lavoro e trasformazioni termodinamiche (1)
 Calore, lavoro e trasformazioni termodinamiche (1) Attraverso scambi di calore un sistema scambia energia con l ambiente. Tuttavia si scambia energia anche quando le forze (esterne e interne al sistema)
Calore, lavoro e trasformazioni termodinamiche (1) Attraverso scambi di calore un sistema scambia energia con l ambiente. Tuttavia si scambia energia anche quando le forze (esterne e interne al sistema)
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA. Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta
 INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
Introduzione alla Chimica. Paolo Mazza
 Introduzione alla Chimica Paolo Mazza 2 aprile 2013 Indice 1 Introduzione 2 2 Le teorie della materia 4 2.1 Teoria atomica.................................... 4 2.2 Teoria cinetica.....................................
Introduzione alla Chimica Paolo Mazza 2 aprile 2013 Indice 1 Introduzione 2 2 Le teorie della materia 4 2.1 Teoria atomica.................................... 4 2.2 Teoria cinetica.....................................
fenomeni na- turali grandezze fisiche principi leggi metodo scientifico modello
 La fisica è la scienza che studia i fenomeni naturali (ossia tutti gli eventi che possono essere descritti, o quantificati, attraverso grandezze fisiche opportune) al fine di stabilire principi e leggi
La fisica è la scienza che studia i fenomeni naturali (ossia tutti gli eventi che possono essere descritti, o quantificati, attraverso grandezze fisiche opportune) al fine di stabilire principi e leggi
FISICA per SCIENZE BIOLOGICHE, A.A. 2007/2008 Appello straordinario del 28 maggio 2008
 FISIC per SCIENZE BIOLOGICHE,.. 2007/2008 ppello straordinario del 28 maggio 2008 1) Un corpo di massa m = 40 g, fissato ad una fune di lunghezza L = 1m si muove di moto circolare (in senso antiorario)
FISIC per SCIENZE BIOLOGICHE,.. 2007/2008 ppello straordinario del 28 maggio 2008 1) Un corpo di massa m = 40 g, fissato ad una fune di lunghezza L = 1m si muove di moto circolare (in senso antiorario)
Capitolo 16 L energia si trasferisce
 Capitolo 16 L energia si trasferisce 1. L «ABC» dei trasferimenti energetici 2. Le reazioni scambiano energia con l ambiente 3. Durante le reazioni varia l energia chimica del sistema 4. L energia chimica
Capitolo 16 L energia si trasferisce 1. L «ABC» dei trasferimenti energetici 2. Le reazioni scambiano energia con l ambiente 3. Durante le reazioni varia l energia chimica del sistema 4. L energia chimica
GLI STATI DELLA MATERIA
 GLI STATI DELLA MATERIA E LE SOLUZIONI Stati di aggregazione della materia Cambiamenti di stato La temperatura del cubetto di ghiaccio aumenta fino a raggiungere un valore detto PUNTO (O TEMPERATURA) DI
GLI STATI DELLA MATERIA E LE SOLUZIONI Stati di aggregazione della materia Cambiamenti di stato La temperatura del cubetto di ghiaccio aumenta fino a raggiungere un valore detto PUNTO (O TEMPERATURA) DI
Richiami di matematica per lo studio delle discipline scientifiche
 Richiami di matematica per lo studio delle discipline scientifiche La misura in chimica : Misurare significa confrontare una grandezza in rapporto con un altra ad essa omogenea, scelta come campione.i
Richiami di matematica per lo studio delle discipline scientifiche La misura in chimica : Misurare significa confrontare una grandezza in rapporto con un altra ad essa omogenea, scelta come campione.i
Gas ideale: velocità delle particelle e pressione (1)
 Gas ideale: velocità delle particelle e pressione (1) In un gas ideale le particelle sono considerate puntiformi e risentono di forze solo durante gli urti (perfettamente elastici) con le pareti del recipiente.
Gas ideale: velocità delle particelle e pressione (1) In un gas ideale le particelle sono considerate puntiformi e risentono di forze solo durante gli urti (perfettamente elastici) con le pareti del recipiente.
Le Grandezze e il Sistema Internazionale di misura
 Le Grandezze e il Sistema Internazionale di misura Si dice GRANDEZZA tutto ciò ce si può misurare. Esempio L altezza di una torre, il volume di una stanza, la superficie di un muro, l ampiezza di un angolo,
Le Grandezze e il Sistema Internazionale di misura Si dice GRANDEZZA tutto ciò ce si può misurare. Esempio L altezza di una torre, il volume di una stanza, la superficie di un muro, l ampiezza di un angolo,
Unità di misura e formule utili. Lezione 6
 Unità di misura e formule utili Lezione 6 Unità di misura Il Sistema Internazionale di unità di misura (SI) nasce dall'esigenza di utilizzare comuni unità di misura per la quantificazione e la misura delle
Unità di misura e formule utili Lezione 6 Unità di misura Il Sistema Internazionale di unità di misura (SI) nasce dall'esigenza di utilizzare comuni unità di misura per la quantificazione e la misura delle
ENERGIA E CALORE energia Joule (J) KJ (Kilojoule). Kilowattora (KWh) calore Caloria (Cal o KCal) Caloria calore British Thermal Unit (Btu)
 ENERGIA E CALORE Unità di misura dell'energia: Joule (J), unità troppo piccola; comunemente si usa il suo multiplo, il KJ (Kilojoule). Importante è anche il Kilowattora (KWh), unità usata nella misura
ENERGIA E CALORE Unità di misura dell'energia: Joule (J), unità troppo piccola; comunemente si usa il suo multiplo, il KJ (Kilojoule). Importante è anche il Kilowattora (KWh), unità usata nella misura
L equilibrio dei gas. Lo stato di equilibrio di una data massa di gas è caratterizzato da un volume, una pressione e una temperatura
 Termodinamica 1. L equilibrio dei gas 2. L effetto della temperatura sui gas 3. La teoria cinetica dei gas 4. Lavoro e calore 5. Il rendimento delle macchine termiche 6. Il secondo principio della termodinamica
Termodinamica 1. L equilibrio dei gas 2. L effetto della temperatura sui gas 3. La teoria cinetica dei gas 4. Lavoro e calore 5. Il rendimento delle macchine termiche 6. Il secondo principio della termodinamica
Elettronica Grandezze elettriche e unità di misura
 Elettronica Grandezze elettriche e unità di misura Valentino Liberali Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano valentino.liberali@unimi.it Elettronica Grandezze elettriche e unità di misura
Elettronica Grandezze elettriche e unità di misura Valentino Liberali Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano valentino.liberali@unimi.it Elettronica Grandezze elettriche e unità di misura
LE GRANDEZZE FISICHE. Sono proprietà dei corpi per le quali è possibile eseguire operazioni di misura
 La misura LE GRANDEZZE FISICHE Sono proprietà dei corpi per le quali è possibile eseguire operazioni di misura n sono grandezze fisiche : la massa, il tempo, la lunghezza, l altezza ecc. La misura n Misurare
La misura LE GRANDEZZE FISICHE Sono proprietà dei corpi per le quali è possibile eseguire operazioni di misura n sono grandezze fisiche : la massa, il tempo, la lunghezza, l altezza ecc. La misura n Misurare
APPUNTI delle lezioni prof. Celino PARTE 1
 APPUNTI delle lezioni prof. Celino PARTE 1 PREREQUISITI MATEMATICI per lo studio della fisica e della chimica... 2 NOTAZIONE SCIENTIFICA... 2 APPROSSIMAZIONE DEI NUMERI DECIMALI... 2 MULTIPLI e SOTTOMULTIPLI...
APPUNTI delle lezioni prof. Celino PARTE 1 PREREQUISITI MATEMATICI per lo studio della fisica e della chimica... 2 NOTAZIONE SCIENTIFICA... 2 APPROSSIMAZIONE DEI NUMERI DECIMALI... 2 MULTIPLI e SOTTOMULTIPLI...
14. Transizioni di Fase_a.a. 2009/2010 TRANSIZIONI DI FASE
 TRANSIZIONI DI FASE Fase: qualsiasi parte di un sistema omogenea, di composizione chimica costante e in un determinato stato fisico. Una fase può avere le stesse variabili intensive (P, T etc) ma ha diverse
TRANSIZIONI DI FASE Fase: qualsiasi parte di un sistema omogenea, di composizione chimica costante e in un determinato stato fisico. Una fase può avere le stesse variabili intensive (P, T etc) ma ha diverse
SISTEMA INTERNAZIONALE (S.I.) Le grandezze che si possono misurare sono dette grandezze fisiche.
 1. GRANDEZZE FONDAMENTALI SISTEMA INTERNAZIONALE (S.I.) Le grandezze che si possono misurare sono dette grandezze fisiche. Secondo il Sistema Internazionale (SI) ci sono sette grandezze fondamentali. 2.
1. GRANDEZZE FONDAMENTALI SISTEMA INTERNAZIONALE (S.I.) Le grandezze che si possono misurare sono dette grandezze fisiche. Secondo il Sistema Internazionale (SI) ci sono sette grandezze fondamentali. 2.
TERMODINAMICA. Studia le trasformazioni dei sistemi in relazione agli scambi di calore e lavoro. GENERALITÀ SUI SISTEMI TERMODINAMICI
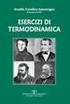 TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
CORSO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) CLASSE DI CONCORSO A033 ANNO ACCADEMICO 2014/15 PROF. GIUSEPPE NATALE
 CORSO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) CLASSE DI CONCORSO A033 METODOLOGIE DIDATTICHE PER L INSEGNAMENTO DELLA TECNOLOGIA ANNO ACCADEMICO 2014/15 PROF. GIUSEPPE NATALE La misura delle grandezze fisiche
CORSO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) CLASSE DI CONCORSO A033 METODOLOGIE DIDATTICHE PER L INSEGNAMENTO DELLA TECNOLOGIA ANNO ACCADEMICO 2014/15 PROF. GIUSEPPE NATALE La misura delle grandezze fisiche
Elementi che esistono come gas a 25 0 C and 1 atmosfera 5.1
 I gas Capitolo 5 Elementi che esistono come gas a 25 0 C and 1 atmosfera 5.1 Tabella 5.1 Alcune sostanze che si trovano allo stato gassoso a 1 atm e 25 C Elementi H 2 (idrogeno molecolare) N 2 (azoto molecolare)
I gas Capitolo 5 Elementi che esistono come gas a 25 0 C and 1 atmosfera 5.1 Tabella 5.1 Alcune sostanze che si trovano allo stato gassoso a 1 atm e 25 C Elementi H 2 (idrogeno molecolare) N 2 (azoto molecolare)
Il I principio della termodinamica. Calore, lavoro ed energia interna
 Il I principio della termodinamica Calore, lavoro ed energia interna Riassunto Sistemi termodinamici Un sistema termodinamico è una porzione di materia descritto da funzioni di stato che ne caratterizzano
Il I principio della termodinamica Calore, lavoro ed energia interna Riassunto Sistemi termodinamici Un sistema termodinamico è una porzione di materia descritto da funzioni di stato che ne caratterizzano
TERMODINAMICA CHIMICA
 TERMODINAMICA CHIMICA Si definisce FUNZIONE DI STATO una variabile il cui valore dipende solo dallo stato iniziale e finale del sistema e non dal cammino percorso nella trasformazione effettuata Sono funzioni
TERMODINAMICA CHIMICA Si definisce FUNZIONE DI STATO una variabile il cui valore dipende solo dallo stato iniziale e finale del sistema e non dal cammino percorso nella trasformazione effettuata Sono funzioni
Corso di Meccanica, Macchine e Impianti Termici CAPITOLO 5 TERMODINAMICA
 Anno Scolastico 2009/2010 Corso di Meccanica, Macchine e Impianti Termici CAPITOLO 5 TERMODINAMICA Prof. Matteo Intermite 1 5.1 LEGGE DEI GAS I gas sono delle sostanze che in determinate condizioni di
Anno Scolastico 2009/2010 Corso di Meccanica, Macchine e Impianti Termici CAPITOLO 5 TERMODINAMICA Prof. Matteo Intermite 1 5.1 LEGGE DEI GAS I gas sono delle sostanze che in determinate condizioni di
Termodinamica dell atmosfera
 Fondamenti di Fisica dell Atmosfera e del Clima Trento, 3 Marzo 2016 Sistema termodinamico Sistema termodinamico: porzione di materia che occupa una determinata regione dello spazio e puó scambiare massa
Fondamenti di Fisica dell Atmosfera e del Clima Trento, 3 Marzo 2016 Sistema termodinamico Sistema termodinamico: porzione di materia che occupa una determinata regione dello spazio e puó scambiare massa
Capitolo 1 Misure e grandezze
 Capitolo 1 Misure e grandezze 1. Il Sistema Internazionale di Unità di misura 2. Grandezze estensive e grandezze intensive 3. Energia, lavoro e calore 4. Temperatura e calore 5. Misure precise e misure
Capitolo 1 Misure e grandezze 1. Il Sistema Internazionale di Unità di misura 2. Grandezze estensive e grandezze intensive 3. Energia, lavoro e calore 4. Temperatura e calore 5. Misure precise e misure
-GAS IDEALI- Le particelle che costituiscono un gas ideale:
 -GAS IDEALI- Le particelle che costituiscono un gas ideale: sono in movimento continuo e casuale hanno un volume trascurabile rispetto al volume totale a disposizione del gas non interagiscono fra loro
-GAS IDEALI- Le particelle che costituiscono un gas ideale: sono in movimento continuo e casuale hanno un volume trascurabile rispetto al volume totale a disposizione del gas non interagiscono fra loro
Ripasso sulla temperatura, i gas perfetti e il calore
 Ripasso sulla temperatura, i gas perfetti e il calore Prof. Daniele Ippolito Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia La temperatura Fenomeni non interpretabili con le leggi della meccanica Dilatazione
Ripasso sulla temperatura, i gas perfetti e il calore Prof. Daniele Ippolito Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia La temperatura Fenomeni non interpretabili con le leggi della meccanica Dilatazione
ATOMI E MOLECOLE. ATOMO= unità più piccola di un elemento che ne mantiene le caratteristiche chimiche.
 1 ATOMI E MOLECOLE ATOMO= unità più piccola di un elemento che ne mantiene le caratteristiche chimiche. SIMBOLO ATOMICO= 1 o 2 lettere che identificano elemento A= numero di massa (protoni+neutroni) Z=
1 ATOMI E MOLECOLE ATOMO= unità più piccola di un elemento che ne mantiene le caratteristiche chimiche. SIMBOLO ATOMICO= 1 o 2 lettere che identificano elemento A= numero di massa (protoni+neutroni) Z=
Grandezze Fisiche dirette
 Grandezze Fisiche dirette Una grandezza fisica ha significato se e solo se è possibile misurarla. Pertanto occorre definire: un campione un metodo di misura per confrontare la grandezza con il campione.
Grandezze Fisiche dirette Una grandezza fisica ha significato se e solo se è possibile misurarla. Pertanto occorre definire: un campione un metodo di misura per confrontare la grandezza con il campione.
Università degli Studi di Milano. Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
 Università degli Studi di Milano Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Corsi di Laurea in: Informatica ed Informatica per le Telecomunicazioni Anno accademico 2010/11, Laurea Triennale, Edizione
Università degli Studi di Milano Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Corsi di Laurea in: Informatica ed Informatica per le Telecomunicazioni Anno accademico 2010/11, Laurea Triennale, Edizione
LEGAMI INTERMOLECOLARI LEGAMI INTERMOLECOLARI
 I legami (o forze) intermolecolari sono le forze attrattive tra particelle: molecola - molecola, molecola - ione, ione - ione In assenza di queste interazioni tutti i composti sarebbero gassosi NB: attenzione
I legami (o forze) intermolecolari sono le forze attrattive tra particelle: molecola - molecola, molecola - ione, ione - ione In assenza di queste interazioni tutti i composti sarebbero gassosi NB: attenzione
relazioni tra il calore e le altre forme di energia.
 Termodinamica i Termodinamica: ramo della scienza che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia. Sistema e ambiente sistema: zona dello spazio all interno della quale studiamo i fenomeni
Termodinamica i Termodinamica: ramo della scienza che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia. Sistema e ambiente sistema: zona dello spazio all interno della quale studiamo i fenomeni
La legge dei gas perfetti
 La legge dei gas perfetti In condizioni normali l aria ambiente secca contiene approssimativamente 78,08% di azoto (N2), 20,94% di ossigeno (O2), 0,93% di argon (Ar), 0,04% di biossido di carbonio (CO2)
La legge dei gas perfetti In condizioni normali l aria ambiente secca contiene approssimativamente 78,08% di azoto (N2), 20,94% di ossigeno (O2), 0,93% di argon (Ar), 0,04% di biossido di carbonio (CO2)
NUMERI. Per contare le caramelle. 0, 1, 2,3, 4,.. Numeri naturali
 NUMERI Per contare le caramelle. 0, 1, 2,3, 4,.. Numeri naturali N NUMERI Per contare i soldi del proprio conto in banca! 0,+1, 1,+2, 2,+3, 3,... Numeri interi Z NUMERI Per tagliare le torte! 0,1,-1,1/2,-1/2,2,-2,1/3,-1/3,2/3.-2/3,...
NUMERI Per contare le caramelle. 0, 1, 2,3, 4,.. Numeri naturali N NUMERI Per contare i soldi del proprio conto in banca! 0,+1, 1,+2, 2,+3, 3,... Numeri interi Z NUMERI Per tagliare le torte! 0,1,-1,1/2,-1/2,2,-2,1/3,-1/3,2/3.-2/3,...
Testi Consigliati. I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani CHIMICA, Zanichelli. Qualsiasi altro testo che tratti gli argomenti elencati nel programma
 Chimica Generale ed Inorganica Testi Consigliati I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani CHIMICA, Zanichelli Chimica Organica Hart-Craine Introduzione alla Chimica Organica Zanichelli. Qualsiasi altro testo che
Chimica Generale ed Inorganica Testi Consigliati I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani CHIMICA, Zanichelli Chimica Organica Hart-Craine Introduzione alla Chimica Organica Zanichelli. Qualsiasi altro testo che
 TABELLE DELLE PROPRIETÀ E DIAGRAMMI 1. TABELLA A.1 Massa molare, costante dei gas e proprietà di punto critico. 2. TABELLA A.4 Acqua satura: tabella in temperatura. 3. TABELLA A.5 Acqua satura: tabella
TABELLE DELLE PROPRIETÀ E DIAGRAMMI 1. TABELLA A.1 Massa molare, costante dei gas e proprietà di punto critico. 2. TABELLA A.4 Acqua satura: tabella in temperatura. 3. TABELLA A.5 Acqua satura: tabella
Corso: Chimica Fisica
 Docente: Gianni ROMEO Corso: Chimica Fisica pagina 1 di 6 TEST N. 3 (IL CORRETTORE DEL TEST È A PAGINA 2 ) DATA: 07.01.2010 Argomenti (Moduli 1 e 2): Materia ed Energia; le Unità di Misura e l Analisi
Docente: Gianni ROMEO Corso: Chimica Fisica pagina 1 di 6 TEST N. 3 (IL CORRETTORE DEL TEST È A PAGINA 2 ) DATA: 07.01.2010 Argomenti (Moduli 1 e 2): Materia ed Energia; le Unità di Misura e l Analisi
Espressioni di concentrazione di una soluzione
 SOLUZIONI Una soluzione è un sistema fisicamente omogeneo costituito da due o più componenti: il solvente e il soluto (o i soluti. Il solvente è il componente presente, in genere ma non di regola, in maggior
SOLUZIONI Una soluzione è un sistema fisicamente omogeneo costituito da due o più componenti: il solvente e il soluto (o i soluti. Il solvente è il componente presente, in genere ma non di regola, in maggior
