La riunione si apre con gli interventi di alcuni membri del gruppo di ricerca.
|
|
|
- Miranda Evelina Cappelli
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Riunione del gruppo di ricerca del 22 maggio 2015 Crisi dell'eurocentrismo e futuro dell'umanesimo europeo: prospettive storico-culturali, religiose, giuridiche ed economico-sociali La riunione si apre con gli interventi di alcuni membri del gruppo di ricerca. Intervento del professor Michele Grillo Secondo la prospettiva dell economia politica, il «nucleo» stesso dell umanesimo europeo è ravvisabile nel percorso effettuato dalla cultura europea dal «collettivo» all «individuale», il quale costituisce un unicum nel panorama mondiale. Il mercato è certamente la forma istituzionale dell interazione sociale che si è spinta più lontano nel percorso dal «collettivo» all «individuale». Nella sua tensione ideale, il mercato congiunge il massimo di socialità con la massima esaltazione dell individuo: (1) nel mercato si realizza al meglio la divisione sociale del lavoro e una società è tanto più «ricca» quanto più la divisione del lavoro è «efficiente»; (2) al contempo, quanto meglio è organizzata la divisione del lavoro, tanto meno ciascuno svolge la propria attività per sé e tanto più la svolge per gli altri. Ciò che può risultare intellettualmente scioccante è che la teoria predice che il mercato realizza il massimo di socialità in quanto realizza un mondo di «monadi». Il mercato concorrenziale è infatti «perfetto» quando ogni soggetto è price-taker, ovvero quando il suo comportamento incide solo sul suo benessere, ma non sul benessere di alcun altro soggetto sociale; quando questa condizione è soddisfatta, non può esistere, per John Stuart Mill (On Liberty, 1859), alcuna giustificazione etica alla restrizione della libertà civile. Il mercato ha molti meriti. Tra questi la cultura europea ha senz altro sottolineato il suo essere inclusivo: chiunque, infatti, è ben accolto nel «mercato» e la diversità è considerata un valore che esalta i benefici della divisione sociale del lavoro. Il mercato «ideale» è una stella polare per il disegno istituzionale: le istituzioni politiche hanno il compito di adeguare l ambiente nel quale i soggetti sociali entrano in relazione, approssimando quanto più possibile il contesto reale al contesto ideale. Tuttavia, al difuori del contesto ideale, una società deve comunque prendere decisioni «collettive», non «decentrabili». In questo spazio politico la cultura occidentale vede la democrazia intesa come il principio ispiratore delle istituzioni preposte alla presa delle decisioni collettive come l immagine del mercato nell arena delle decisioni collettive. In generale la democrazia è considerata un sistema istituzionale inclusivo, in quanto la libertà di espressione è il presupposto necessario per il pubblico dibattito attraverso il quale è possibile formare la decisione collettiva. Peraltro, la libertà di espressione è il regno della libertà civile per lo stesso J. S. Mill, poiché nell esprimersi liberamente nessun soggetto è in grado di incidere sul benessere di alcun altro soggetto sociale. Tuttavia, in una prospettiva differente, la democrazia non è «inclusiva». Il marchese di Condorcet a metà del 700 mostrò che se ci sono tre soggetti che devono prendere una decisione collettiva scegliendo una delle tre alternative A, B o C, sulle quali hanno ordinamenti di preferenze individuali diversi (il primo preferisce A a B e B a C, il secondo preferisce B a C e C ad A e il terzo preferisce C ad A e A a B) e decidono di scegliere collettivamente mettendo a votazione a maggioranza le alternative di scelta, accade che A vince B a maggioranza, B vince C a maggioranza e C vince A a maggioranza e dunque è impossibile prendere una decisione collettiva. La teoria economica si è interrogata per circa duecento anni su questo paradosso, ricercando meccanismi, più sofisticati del principio di maggioranza semplice descritto nell esempio di Condercet, in grado di portare a decisioni collettive. 1
2 Nel 1951, tuttavia, il «teorema di impossibilità» di Kenneth Arrow (formulato in Social Choice and Individual Values) dimostrò che il problema non ammetteva soluzione (almeno nel senso atteso e desiderato). Un corollario cruciale del «teorema di impossibilità» è la dimostrazione che la democrazia NON è inclusiva. Arrow ha infatti dimostrato che non può esistere alcun meccanismo con cui una società possa prendere decisioni collettive che soddisfi simultaneamente cinque condizioni: (i) non dittatorialità: la scelta collettiva tra alternative non dipende unicamente dalle preferenze di una stessa persona; (ii) efficienza paretiana: se tutti preferiscono «X a Y», il meccanismo di decisione collettiva non può produrre Y; (iii) transitività dell ordinamento di preferenze collettivo: se il meccanismo di decisione collettiva produce X nella scelta tra X e Y e, assieme, produce Y nella scelta tra Y e Z, non può produrre Z nella scelta tra X e Z; (iv) dominio non ristretto: il meccanismo di decisione collettiva deve operare a partire da qualsiasi profilo di ordinamento di preferenze dei singoli individui; (v) indipendenza dalle alternative irrilevanti: se un determinato profilo di preferenze individuali tra X e Y produce X nella scelta tra X e Y, questa scelta non può modificarsi quando si modifica (soltanto) il profilo di preferenze individuali tra alternative entrambe diverse (per esempio, Z e W) da X e da Y. Con la teoria economica della democrazia, gli economisti si sono allora chiesti come funzionano i meccanismi democratici per arrivare a scelte collettive. Più specificamente, quale tra le cinque condizioni viene fatta cadere? Il risultato cui è pervenuta la teoria economica è stato che il meccanismo democratico sfugge al teorema di impossibilità di Arrow in quanto rinuncia alla condizione di dominio non ristretto: condizione necessaria per essere sempre in grado di arrivare a prendere decisioni collettive è che nel dibattito pubblico l attenzione sia ristretta ai soli ordinamenti di preferenza individuali che hanno previamente superato un «test di ammissione al club». La democrazia, in altre parole, NON è inclusiva e dunque non può essere vista come lo specchio del mercato nell arena politica. Un ultima riflessione su come, dal punto di vista dell economista, si può descrivere la sfida posta oggi dalla «crisi dell eurocentrismo». Nella prospettiva dell economia, il contatto con altre culture pone oggi la seguente sfida all umanesimo europeo: è davvero necessario spingersi il più lontano possibile nel percorso dal «collettivo» all «individuale» sforzandosi di essere il più possibile inclusivi per organizzare in modo efficiente la divisione sociale del lavoro? In questi vent anni di globalizzazione i Paesi che ne hanno tratto maggiore vantaggio hanno sistemi politici non democratici; la democrazia, in questo senso, è un ostacolo alla crescita economica? Dobbiamo abbandonare l ideale democratico, così congenito con la cultura dell umanesimo europeo? A mio avviso, una delle difficoltà a rispondere adeguatamente a questa domanda è legata al fatto che le istituzioni politiche dell Occidente diversamente dall idea che pretendono di dare di sé - non sono l immagine del mercato inclusivo. Un esempio è offerto dai meccanismi istituzionali per prendere decisioni collettive tra Paesi nella «globalizzazione»: il WTO ha imposto a tutti i Paesi di accogliere il diritto antitrust nella propria legislazione nazionale come «condizione minima comune» di «iscrizione al club». Il punto è ovviamente che una cultura politica non inclusiva ha difficoltà a proporre alle altre culture con le quali entra in rapporto il senso di un percorso dal «collettivo» all «individuale» che, per altro verso, rappresenta il «nucleo» stesso dell umanesimo europeo. Dunque il quesito di fondo, tuttora aperto nella prospettiva della teoria economica, è se sia possibile e che possa significare nel concreto una democrazia inclusiva. 2
3 Intervento della professoressa Franca Landucci Prendendo le mosse da quanto discusso in occasione dell incontro del gruppo di ricerca svoltosi in data 20 marzo 2015, ritengo doveroso evitare che la nostra analisi si appiattisca alla mera contemporaneità. Per comprendere la crisi dell eurocentrismo è necessario volgere lo sguardo alla Storia antica. Ciò che in tempi recenti ha permesso alla società occidentale di raggiungere un certo grado di supremazia è stato lo sviluppo tecnologico, sconosciuto alle altre culture, e la capacità di costruire istituzioni politiche (si pensi ad es. alle Nazioni Unite e al WTO) create a somiglianza del mondo occidentale. Tuttavia, le società non occidentali non hanno seguito il lungo e faticoso percorso di conquista della democrazia e di valorizzazione della persona; un percorso che, per quanto accidentato, in Occidente non ha mai rinnegato l idea che la persona avesse un importanza intrinseca. L errore del mondo occidentale, oggi, è invece quello di credere che le proprie istituzioni politiche ed economiche abbiano un carattere universale e che dunque possano essere pienamente comprese e recepite anche altrove (la c.d. esportazione della democrazia). Uno dei fattori che ha permesso la nascita dell eurocentrimo (o, meglio, dell espansionismo europeo) è la grave e irreversibile crisi dell Impero ottomano nel corso del XIX e XX secolo. Tuttavia, non è superfluo ricordare che la storia del mondo non sia certo nata nella seconda metà del Settecento: si tratta di una presunzione che l Occidente rischia di pagare molto caramente (ad es., la dialettica tra individuo e collettività è un problema antico). Il recupero di una visione storica più ampia e che attinga alle esperienze di crisi nel mondo antico può arricchire l analisi e contribuire a una miglior comprensione dell oggetto di ricerca. Intervento del dottor Marco Rainini Vorrei proporre innanzitutto una considerazione a partire dal titolo dell iniziativa, per cui prendiamo qui atto di una «crisi dell Eurocentrismo», e ci interroghiamo sul «futuro dell umanesimo europeo». Se non mi inganno, un problema centrale che si pone è allora questo: quale ruolo per l Europa nel nuovo scenario mondiale? Quale contributo può dare l Europa o meglio: l Europa ha ancora qualcosa di importante da trasmettere al nuovo scenario? 1. Parto da due suggestioni. Premetto fin d ora che lo scenario in cui mi muovo è evidentemente molto ampio, e non vorrei dare l impressione di banalizzare o affrontare i problema in modo grossolano. Si tratta però di cogliere alcuni nodi dato anche il tempo ristretto. (i) L assassino il boia che appare in diversi video che riprendono l uccisione dei prigionieri dell Isis (ad es. il giornalista americano James Foley, agosto 2014), colui che in essi compie il gesto nelle consuete modalità efferate, è un laureato in informatica: Mohamed Emwazi, di origini kuwaitiane, aveva frequentato un università facoltà inglese (Westminster University). (cfr. Potremmo dire, sulla scorta di questa immagine molto forte, e soprattutto a fronte delle modalità di propaganda che la sostengono, che razionalità tecnica e radicalismo integralista appaiono tutt altro che incompatibili. (ii) Ancora oggi, l inizio del mese del «Ramadan» per i credenti islamici viene dichiarato solo dopo che il primo credente ha visto comparire la luna, nel corrispondente ciclo lunare. Non basta la data calendariale: sebbene fin dai primi secoli la cultura islamica abbai prodotto conoscenze astronomiche tali per cui le stelle portano spesso nomi arabi, in realtà per il pensiero islamico tutto 3
4 dipende immediatamente dalla volontà divina, e, se è possibile fare previsioni, è necessario attendere sempre la conferma dei fatti. Questo perché tutto dipende immediatamente da un atto della volontà divina, che è sovranamente libera, e che potrebbe così mutare. Tutto dipende dal decreto divino, senza mediazioni: il concetto di causa secunda per usare un termine scolastico è di fatto svuotato. 2. Nel mondo occidentale è ravvisabile uno snodo, a cavallo tra XI e XII secolo, in cui l idea di causa secunda emerge in modo sempre più forte e definito. In questo senso sono emblematiche due figure, quella di Pier Damiani ( ) e quella di Guglielmo di Conches ( ). Pier Damiani è vicino a un disinteresse nei confronti delle causae; egli, polemizzando con chi cerca le cause nella natura, scrive: «E perciò, la potenza divina spesso distrugge i sillogismi schierati dai dialettici e le loro astuzie, e confonde le argomentazioni di tutti i filosofi, che loro considerano necessarie e inevitabile. Ascolta il sillogismo: se il legno arde, certamente si consuma. Ma ecco che Mosè vede un roveto che arde e non si consuma [Ex 3,3]. Ancora: se un legno è reciso, non fruttifica. Ma ecco la verga di Aronne, che, contro l ordine della natura [contra naturae ordinem], viene trovata nel tabernacolo che fruttifica [Num 17,8]. [ ] Per che motivo, direi, tutte queste cose, se non per confondere i frivoli argomenti dei sapienti di questo mondo, e contro la consuetudine della natura [contra naturae consuetudinem] rivelare ai mortali la gloria della potenza divina? Vengano i dialettici, o piuttosto, come sono ritenuti, eretici, e vedranno essi stessi» (Petri Damiani De divina omnipotentia, XI) Questa prospettiva non sembra dunque lontana da quella dell ortodossia islamica contemporanea: se non nega la causalità secondaria in modo diretto, certo svaluta la ricerca che la pone al centro. Pochi anni dopo, in polemica con la posizione di Pier Damiani, si rinviene il pensiero elaborato da Guglielmo di Conches: Come si deve intendere: Divise le acque che sono sotto il firmamento [Gen 1,7]. Ma so già che cosa diranno: Noi non sappiamo in che modo questo possa essere, ma sappiamo che Dio lo può fare. Miseri! Che cosa può esserci di più misero, che dire questo? Poiché Dio può farlo, né vedere se le cose stiano proprio così, né cercare la ragione per cui stiano in questo modo, né mostrare l utilità per cui ciò proprio in questo modo è ordinato. Ma Dio non fa tutto ciò che potrebbe fare! Per usare parole da contadino: Dio può far nascere un vitello da un tronco; forse che lo faccia?» (<ps-.>honorii Augustodunensis <scil. Guillelmi de Conchis> Philosophia mundi, II, 3, PL 172, col 58C) Ciò che qui sta emergendo è il concetto di «natura», che delimita un ambito della realtà riconoscibile a prescindere dalla rivelazione, e sul quale è possibile interagire, per quanto attiene anche alla conoscenza delle cause, con chiunque: con l uomo al di qua delle sue convinzioni religiose. È uno spazio di dialogo, ma soprattutto di costruzione di realtà comuni e condivise. Questo spazio di natura è fondamentale, ed è il luogo proprio di esercizio della ratio. Ora, il problema è: nel mondo islamico ciò è possibile? Senza la pretesa di dare una risposta definitiva, è quantomeno ravvisabile una significativa criticità. Vorrei inoltre sottolineare come, negli stessi anni, si sviluppa anche il luogo proprio di sviluppo di questa razionalità, che è bene sottolinearlo è una razionalità innanzitutto teoretica, nel senso originario del termine: di pura contemplazione del problema, e speculazione sui suoi diversi aspetti. 4
5 Le scuole dei maestri e studenti delle universitates non sono luoghi di formazione professionale o tecnica, ma i luoghi della quaestio e della disputatio. Queste scuole non sono organizzate per dare accesso a una professione almeno non originariamente, nella fase più creativa, e comunque mai direttamente. Riporto a riguardo un passo del medievista tedesco Herbert Grundmann: «All incirca cinquecento anni fa (aprile 1455), in occasione dell inaugurazione dell Università di Friburgo in Brisgovia, il suo primo rettore tenne un sermone sul proverbio di Salomone Sapientia aedificavit sibi domum [Pro 9,1] [ ]. Nessuna frase è più adatta di questa per servire di motto a tutta la storia universitaria. Senza dubbio, molte mani hanno collaborato all edificazione dell Università, anche quelle dello Stato, della Chiesa, e della Società, e molti l abitano, e la frequentano per molteplici ragioni. Ma essa non esisterebbe, se l amore per la scienza, la ricerca della verità e della conoscenza, non ne fossero stati il fondamento, e perciò essa continuerà ad esistere solo fin quando questo amore e queste comuni aspirazioni non verranno meno nella storia» (Herbert Grundmann, La genesi dell Università nel medioevo, in Le origini dell Università, a c. di G. Arnaldi, Bologna 1974, p. 94) Mi sembra allora che per l Europa si proponga così non solo un elemento forte da trasmettere allo scenario più ampio che si apre, ma anche lo strumento attraverso cui operare questo passaggio sempre che esso venga riproposto, seppur in modi nuovi, secondo questa sua vocazione originaria. Intervento del Professor Potestà Il cristianesimo ha certamente compiuto un lungo percorso; e l Islam? Quanto descritto dal dottor Rainini non pareva iscritto nel patrimonio cromosomico del Cristianesimo dell XI secolo; si veda, ad esempio, l azione di Papa Gregorio VII coevo ai pensatori citati. Il percorso storico di acquisizione della natura e della ragione è stato faticoso: forse il Cristianesimo aveva in sé le premesse affinché ciò accadesse. Inoltre, natura e ragione non sono svincolate dalla cosmologia medievale e il modello di ragione di Guglielmo di Conches non è certamente quello di cui oggi ci avvaliamo e che ha avuto origine nell Ottocento; il modello medievale di ragione ha certamente pagato dei pesantissimi prezzi, si pensi alla drammatica divaricazione tra teologia cristiana e moderna interpretazione della bibbia. Intervento della professoressa Elena Riva La presentazione è intitolata La storia nella rete Saperi umanistici e web. L incontro tra il sapere tradizionale e l informatica nella totalità delle sue applicazioni sta acquisendo oggi tutto il sapore del passaggio paradigmatico, sia nelle modalità della ricerca umanistica che in quelle della didattica: se da un lato si profila sempre più la necessità scientifica di comprendere come rispettare lo statuto epistemologico delle diverse discipline che compongono il variegato campo delle scienze umanistiche nel loro rapporto con la tecnologia e col web, dall altro si profila la necessità didattica di approcciarsi in modo positivo e partecipativo ai nuovi linguaggi dell era digitale, senza per questo perdere di vista anche le implicazioni negative che l uso di nuovi linguaggi e nuovi strumenti comporta nell epistemologia delle diverse discipline. I devices, nella loro multiformità, sono ormai diventati oggetti che vivono con noi, scandiscono spesso i tempi della nostra vita e condizionano il nostro modo di comunicare e la rete si è trasformata, secondo la nota affermazione di Pierre Lévy, in un computer «potenzialmente infinito il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo», ricalcando una delle più famose definizioni filosofiche di Dio. Si riflette poco, infatti, sul fatto che internet produce cultura e quindi modelli di riferimento e che 5
6 proprio per questo è potente. Si tratta di un problema culturale e sociale che, in qualità di studiosi e formatori di area umanistica, ci riguarda profondamente, anche perché, a parte poche eccezioni, gli umanisti non sono più al centro dei processi di diffusione della cultura come in passato e da vari punti di vista. Per molto tempo le istituzioni culturali e, in primis, le università hanno garantito, attraverso patti sociali e culturali, un determinato livello di accesso alla cultura e alla formazione, lavorando sulla memoria, sull eredità culturale, sul patrimonio culturale, il cosiddetto heritage che ha contribuito alla creazione della nostra identità di italiani e di europei in modo determinante come complesso di valori e di pratiche e relazioni sociali riconosciuti pubblicamente, in sostanza alla creazione della cittadinanza e di un romanzo nazionale, che la scuola a lungo ha contribuito a trasmettere da una generazione all altra secondo modalità standardizzate che hanno reso riconoscibile e familiare un intero patrimonio culturale. Per molto tempo, le istituzioni culturali e, tra queste, scuole e università, hanno quindi mantenuto il controllo delle fonti narrative collettive e hanno determinato i canoni della trasmissione del sapere. Oggi non è più così, perché gli spazi in cui questo heritage si trasmette e viene comunicato stanno velocemente mutando, moltiplicandosi in modo esponenziale. Internet si è ormai trasformato in uno spazio collettivo in cui si discute e si costruiscono opinioni, la cui formazione prevede un uso pubblico della storia secondo forme inedite. La storia che si usa non è generalmente quella raccontata dai libri, frutto di lunghe e complesse ricerche, ma è spesso quella che si è auto generata dalla rete, le cui fonti, ad esempio, sono quelle prodotte dalla rete stessa, come, ad esempio, Wikipedia. Ciò non può non avere conseguenze non solo sul lungo, ma anche sul breve periodo, perché il processo è divenuto ormai inarrestabile. Infatti il mare magnum che compare sui motori di ricerca trasforma i risultati della ricerca in fonti stesse e ciò, unito alla facilità di accesso ai materiali e alla verifica immediata del sapere, convince tutti di poter produrre un autoformazione con scarso senso critico, senza che si sia in grado di saper valutare le fonti, capire i rischi e comprendere la natura dei contenuti. L effetto più evidente di tale processo è nella formazione scolastica, ossia l implosione del tradizionale rapporto tra ricerca (per lo più accademica) e docenza, basato sull accumulo progressivo di contenuti seguito dal loro rilascio controllato. Tale rapporto è ormai saltato, per cui una ricerca e una didattica tradizionali si stanno improvvisamente rivelando improponibili alla società perché ritenute obsolete. È evidente che sono gli studenti e i giovani in generale quelli più a rischio: possedere delle grandi competenze tecniche, che indubbiamente le nuove generazioni hanno più degli adulti, non significa avere un adeguato livello di competenza critica sui contenuti. Il mito del fai da te in parte implicito nella Rete pone numerose problematiche che riguardano non solo il controllo, ma soprattutto la responsabilità dei contenuti offerti da quel supermercato della conoscenza che è internet. Nell ambito di questo progetto Crisi dell Eurocentrismo appare interessante riflettere sulle modalità utili a salvaguardare i tradizionali sistemi di racconto della memoria collettiva in cui si sono riconosciute intere generazioni, e al tempo stesso ragionare sugli strumenti con cui traghettare questa memoria nel futuro, come salvaguardare l'eredità della cultura europea dalla frammentazione e dalla banalizzazione della rete, nel momento in cui la formazione e la costruzione dei saperi e il loro rilascio non è più compito unico della scuola, in primis dell'università. Che fine fa, quindi, l eredità dell Umanesimo europeo di fronte a una realtà come quella della rete, nella quale esistono pacchetti di informazioni già organizzate che, per esigenze di comunicazione ed economiche, devono produrre contenuti semplici e spesso semplicistici, la cui lettura richieda l impiego di un tempo breve? Che tipo di letture produce la rete della storia europea a uso e consumo di culture non europee? Un primo spunto di riflessione è stato offerto dall analisi del progetto Pantheon creato dal Mit di Boston all interno del gruppo Macro Connection guidato da un fisico cileno, Cesar H. Hidalgo, creatore anche dell Osservatorio di complessità economica, sempre del MIT, ATLAS. Lo scopo che si prefiggono è quello di misurare l influenza dei personaggi storici, all interno, però, di un progetto ben più ampio e articolato che è quello di mappare e misurare i dati della produzione 6
7 storico culturale. Collective memory is formed from the information that our species imbues in both humans and objects. We encode this information as order within physical systems such as media technologies, which allows us to transmit and preserve collective memory to our posterity. We use the biographies of 11,341 memorable people that comprise the Pantheon dataset to study how changes in the systems used to store information affect the quantity and composition of our species' collective memory. We find that changes in media technology such as the printing press, the industrial revolution, the telegraph, and television mark milestones within the evolution of the composition of our collective memory; composition that is directly affected by the predominant communication technology of the time. We also find that these milestones mark changes in the quantity of information from each period that makes up our collective memory. ( Sono stati calcolati dei rankings incrociando le pagine on line di Wikipedia in tutte le lingue (a partire dal maggio 2013) e il volume di Charles Murray Human Accomplishment: the Pursuit of Excellence in the Art and Science, 800 b.c. to 1950, all interno del quale vi sono liste di personaggi storici divisi per settore. I progettisti utilizzano poi anche data base di dati open access, perché la disponibilità a tutti è una delle caratteristiche fondamentali per formare le categorie. I personaggi storici catalogati sono presenti su Wikipedia dal maggio del Intervento del professor Guido Lucarno La presentazione è intitolata La crisi dell eurocentrismo nell evoluzione geopolitica del continente. L eurocentrismo si basa su tre premesse storiche e geopolitiche, la dissoluzione dell Impero Romano, la frammentazione politica del mondo feudale e la riaggregazione politica sotto le spinte nazionaliste. Seguendo l approccio funzionale (si veda, ad esempio, la teoria di Hartshorne ), lo Stato è definito come uno spazio organizzato politicamente che funziona efficacemente (essendo in grado di superare le forze centrifughe); lo Stato, dunque, esiste fino a quando le forze centripete superano quelle centrifughe: il sistema statale, altrimenti, si disintegra come accaduto nel caso del Pakistan, della Jugoslavia e dell URSS. Oggetto della Geografia politica è lo studio del complesso delle forze centripete, ovvero quelle consentono ad uno Stato di esistere e di funzionare. In Europa, dopo il medioevo, lo Stato si è evoluto dalla sua forma feudale alla forma moderna. Lo Stato feudale era caratterizzato da una rete amministrativa debole, un sistema legislativo privato, un potere basato sulla ricchezza e sull alleanza con la nobiltà minore e, infine, da una scarsa coesione tra le entità di livello gerarchicamente inferiore. Prendendo in considerazione la nascita dello Stato moderno in Europa si nota come da un lato la tendenza alla frammentazione feudale si inverta e, al contempo, dopo la Pace di Vestfalia (1648) i popoli trasferiscano la fedeltà dalla persona del sovrano allo Stato: il nuovo sistema degli Stati supera i vecchi sistemi del tribalismo, del feudalesimo e dell assolutismo; con il nazionalismo, poi, nascono gli Stati nazionali basati su una cultura comune. Comincia a così ad emergere l idea di Stato in cui il popolo è aggregato attorno alla volontà di essere o di diventare artefice politico della propria storia, idea che costituisce la premessa per la nascita del nazionalismo e di gruppi nazionali più o meno capaci di autodeterminazione. Accanto a frammenti geopolitici della vecchia Europa che sono stati definitivamente superati attraverso la debellatio o tramite annessione, sopravvivono alcune entità: Sopravvivenza temporanea di vecchie strutture (es. Condominio di Moresnet, 1919); Sopravvivenza stabile di Ministati e Microstati (Lussemburgo, San Marino, Andorra, ecc.); Sopravvivenza di anacronismi territoriali (exclaves, Monte Athos, Isole del Canale). Nel corso del Novecento, e in particolare nel periodo tra le due guerre mondiali, sono state favorite le spinte all unificazione di tipo federativo dei vecchi Stati (quali il Benelux e la CEE poi divenuta 7
8 UE). Per contro, il lungo periodo di pace, la fine della Guerra Fredda e la perdita di egemonia delle Grandi Potenze hanno fatto rinascere spinte centrifughe e nuove pulsioni nazionaliste, indebolendo ulteriormente il prestigio dell eurocentrismo tanto da far intravvedere una nuova inversione di tendenza, foriera di un processo di ri-frammentazione politica che ha portato a discutere gli studiosi di diverse discipline di crisi dell europeismo e incremento dell euroscetticismo. Ne sono esempi: Nuovi stati derivanti dalla decolonizzazione (Malta, Cipro); Dissoluzione di modelli egemonici del Secondo Mondo (URSS, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Transdnistria); Stati soggetti a spinte nazionaliste centrifughe (Belgio); Aumento dei separatismi e irredentismi a matrice nazionalista (Südtirol, Scozia, Bretagna, Padania ). Oggi si sta procedendo incontro a un esasperazione del processo di frammentazione, tanto che sembra legittimo chiedersi se ci si stia dirigendo verso una nuova feudalizzazione dell Europa. I fattori che inducono a ipotizzarlo sono: L aumento delle prerogative sovrane di unità amministrative di livello inferiore (Gibilterra); La sopravvivenza dei microstati basata sulla loro posizione fuori dalle regole di convivenza internazionali (es. paradisi fiscali, Stati canaglia ); La pretesa riesumazione di antichi organismi geopolitici (es. Principato di Seborga); La nascita di nuove entità geopolitiche che si avvalgono di falle nel diritto del mare (Principato di Sealand, Repubblica delle Rose); Zone d ombra, residui dei processi di dissoluzione di organismi statali di maggiori dimensioni (Transdnistria, Liberland). Al contempo sono ravvisabili i principali motivi della tolleranza nei confronti di questo processo di neo feudalizzazione del continente, quali: Il vuoto di potere dovuto al declino delle Grandi Potenze; La crisi delle alleanze tradizionali e delle unioni economico-politiche; La sopravvivenza di interessi, spesso occulti, trasversali a una molteplicità di Stati; L incapacità dei governi nazionali di concordare politiche comuni di intervento per frenare gli abusi; L individualismo delle nazioni, acuito dopo lo scoppio di varie crisi politiche ed economiche mondiali; Il favore dell opinione pubblica, che spesso percepisce in maniera oppressiva la presenza dell autorità degli Stati tradizionali. Da questo ragionamento emergono diversi argomenti di ricerca che potrebbero essere approfonditi e potrebbero essere ricondotti alle sequenti questioni: Ci troviamo di fronte a una nuova dissoluzione dei centri di autorità geopolitici mondiali? Ciò accade solo in Europa o anche nel resto del mondo? Il successivo incontro è fissato in data 17 giugno 2015; in tale data i partecipanti al gruppo di ricerca presenteranno le iniziative che intendono attuare nel corso del primo anno di progetto. 8
Crisi dell eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo: una prospettiva «economica» Michele Grillo Dipartimento di Economia e Finanza
 Crisi dell eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo: una prospettiva «economica» Michele Grillo Dipartimento di Economia e Finanza 1 Una premessa Sono consapevole di accingermi a uno sforzo temerario:
Crisi dell eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo: una prospettiva «economica» Michele Grillo Dipartimento di Economia e Finanza 1 Una premessa Sono consapevole di accingermi a uno sforzo temerario:
I primi strumenti e il fuoco
 Di Alessia Caprio I primi strumenti e il fuoco Nellapreistoria, le tappe della storia della tecnologia hanno coinciso con quelle dell evoluzione del genere umano e sono state al servizio delle attività
Di Alessia Caprio I primi strumenti e il fuoco Nellapreistoria, le tappe della storia della tecnologia hanno coinciso con quelle dell evoluzione del genere umano e sono state al servizio delle attività
STORIA E GEOGRAFIA LINEE GENERALI E COMPETENZE. Storia. Geografia
 STORIA E GEOGRAFIA LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del corso di studi lo studente dovrà conoscere i principali eventi della storia di Europa e dell Italia dall antichità al XIII secolo, esser consapevole
STORIA E GEOGRAFIA LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del corso di studi lo studente dovrà conoscere i principali eventi della storia di Europa e dell Italia dall antichità al XIII secolo, esser consapevole
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE QUANTE EDUCAZIONI NELLA SCUOLA ITALIANA? Alla legalità Alle pari opportunità Alla differenza di genere Alla pace Alla salute (droghe, fumo ) Alla mondialità Alla cooperazione
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE QUANTE EDUCAZIONI NELLA SCUOLA ITALIANA? Alla legalità Alle pari opportunità Alla differenza di genere Alla pace Alla salute (droghe, fumo ) Alla mondialità Alla cooperazione
Il termine web nasce dalla contrazione di world wide web (ampia ragnatela mondiale). Questa piattaforma consente a tutti di accedere a informazioni,
 Il termine web nasce dalla contrazione di world wide web (ampia ragnatela mondiale). Questa piattaforma consente a tutti di accedere a informazioni, consultare innumerevoli contenuti ecc. Sintetizziamo
Il termine web nasce dalla contrazione di world wide web (ampia ragnatela mondiale). Questa piattaforma consente a tutti di accedere a informazioni, consultare innumerevoli contenuti ecc. Sintetizziamo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI. Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
NUOVE PRATICHE FORMATIVE: LA COMUNITA DI PRATICA NELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI 26 FEBBRAIO 2010
 NUOVE PRATICHE FORMATIVE: LA COMUNITA DI PRATICA NELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI 26 FEBBRAIO 2010 Il contesto di riferimento Nel 2008 l AUSL di Aosta ha avviato un progetto di benchmarking della formazione
NUOVE PRATICHE FORMATIVE: LA COMUNITA DI PRATICA NELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI 26 FEBBRAIO 2010 Il contesto di riferimento Nel 2008 l AUSL di Aosta ha avviato un progetto di benchmarking della formazione
SNADIR. Corso di formazione Sviluppo sociale
 SNADIR Corso di formazione Sviluppo sociale SVILUPPO SOCIALE by Donatello Barone Piergiorgio Barone E un ambito estremamente variegato e ampio per cui non esiste una definizione onnicomprensiva ma possiamo
SNADIR Corso di formazione Sviluppo sociale SVILUPPO SOCIALE by Donatello Barone Piergiorgio Barone E un ambito estremamente variegato e ampio per cui non esiste una definizione onnicomprensiva ma possiamo
GEOGRAFIA ECONOMICA PRIMO QUADRIMESTRE
 GEOGRAFIA ECONOMICA PRIMO QUADRIMESTRE Modulo 1: La globalizzazione del mondo moderno: Geopolitica del mondo attuale Conoscere e comprendere i fattori della globalizzazione Sapere fare una analisi geopolitica
GEOGRAFIA ECONOMICA PRIMO QUADRIMESTRE Modulo 1: La globalizzazione del mondo moderno: Geopolitica del mondo attuale Conoscere e comprendere i fattori della globalizzazione Sapere fare una analisi geopolitica
Rassegna Stampa 04.03.2013
 Rassegna Stampa 04.03.2013 Rubrica Assonime Sommario Rassegna Stampa Pagina Testata Data Titolo Pag. Affari&Finanza (La Repubblica) 04/03/2013 RIFORMARE LE ISTITUZIONI O L'ITALIA NON CE LA FARA' (S.Micossi)
Rassegna Stampa 04.03.2013 Rubrica Assonime Sommario Rassegna Stampa Pagina Testata Data Titolo Pag. Affari&Finanza (La Repubblica) 04/03/2013 RIFORMARE LE ISTITUZIONI O L'ITALIA NON CE LA FARA' (S.Micossi)
12 Il mercato del lavoro dei politici
 INTroDUzIoNE La figura del politico e quella dell elettore sono alla base del concetto di democrazia rappresentativa. Ma chi è il politico? Ed è giusto considerare quella del politico una professione come
INTroDUzIoNE La figura del politico e quella dell elettore sono alla base del concetto di democrazia rappresentativa. Ma chi è il politico? Ed è giusto considerare quella del politico una professione come
Economia Politica e Istituzione Economiche
 Economia Politica e Istituzione Economiche Barbara Pancino Lezione 8 Il modello IS-LM in economia aperta Economia aperta Economia aperta applicata a: mercati dei beni: l opportunità per i consumatori e
Economia Politica e Istituzione Economiche Barbara Pancino Lezione 8 Il modello IS-LM in economia aperta Economia aperta Economia aperta applicata a: mercati dei beni: l opportunità per i consumatori e
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
 LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa D ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE ) L alunno comprende oralmente
LINGUA COMUNITARIA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d Europa D ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE ) L alunno comprende oralmente
Il pensiero di Norberto Bobbio nelle nostre ricerche. SMS Norberto Bobbio Torino Classe 3 D
 Il pensiero di Norberto Bobbio nelle nostre ricerche SMS Norberto Bobbio Torino Classe 3 D Diritto e rovescio I ragazzi vivono immersi in alcuni diritti fondamentali della cui esistenza non si accorgono.
Il pensiero di Norberto Bobbio nelle nostre ricerche SMS Norberto Bobbio Torino Classe 3 D Diritto e rovescio I ragazzi vivono immersi in alcuni diritti fondamentali della cui esistenza non si accorgono.
L ALBERO DELLE REGOLE
 L ALBERO DELLE REGOLE Progetto realizzato nell'ambito del Curricolo Verticale di Educazione alla Cittadinanza Bambino oggi, cittadino domani nelle classi prime della Scuola Primaria plesso L. Illuminati
L ALBERO DELLE REGOLE Progetto realizzato nell'ambito del Curricolo Verticale di Educazione alla Cittadinanza Bambino oggi, cittadino domani nelle classi prime della Scuola Primaria plesso L. Illuminati
LE TEORIE DELL ASSISTENZA INFERMIERISTICA
 Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea in Infermieristica LE TEORIE DELL ASSISTENZA Piera Bergomi Obiettivi della materia Obiettivo generale Portare lo studente a conoscere, analizzare e saper
Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea in Infermieristica LE TEORIE DELL ASSISTENZA Piera Bergomi Obiettivi della materia Obiettivo generale Portare lo studente a conoscere, analizzare e saper
La storia della Fantascienza
 La Fantascienza I racconti di fantascienza prendono spunto da dati scientifici per narrare eventi fantastici al limite dell incredibile ma non necessariamente impossibili La storia della Fantascienza La
La Fantascienza I racconti di fantascienza prendono spunto da dati scientifici per narrare eventi fantastici al limite dell incredibile ma non necessariamente impossibili La storia della Fantascienza La
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
IL LAVORO DEI CITTADINI STRANIERI
 IL LAVORO DEI CITTADINI STRANIERI Roma e provincia nel 2014 Indice I numeri più significativi... 2 Le conseguenze della Crisi economica... 3 Il contesto nazionale... 3 I numeri di Roma: la condizione occupazionale...
IL LAVORO DEI CITTADINI STRANIERI Roma e provincia nel 2014 Indice I numeri più significativi... 2 Le conseguenze della Crisi economica... 3 Il contesto nazionale... 3 I numeri di Roma: la condizione occupazionale...
P.N.S.D. Liceo F. De Andrè
 P.N.S.D Liceo F. De Andrè P N iano azionale S D cuola igitale L idea forte del Piano: la tecnologia al servizio degli apprendimenti per rispondere all esigenza di costruire una nuova visione della formazione
P.N.S.D Liceo F. De Andrè P N iano azionale S D cuola igitale L idea forte del Piano: la tecnologia al servizio degli apprendimenti per rispondere all esigenza di costruire una nuova visione della formazione
Progetto DSA: Guida al metodo di studio
 Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
Progetto DSA: Guida al metodo di studio CESPD - Centro Studi e Ricerche per la Disabilità Scuola di Psicologia Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Scuola di Ingegneria Dipartimento di
Istituto Comprensivo Alba Adriatica Via Duca D Aosta, 13 64011 Alba Adriatica (TE) a.s. 2014-15 Dirigente Scolastico: Prof.ssa SABRINA DEL GAONE
 Progettazione delle Attività di Continuità e Istituto Comprensivo Alba Adriatica Via Duca D Aosta, 13 64011 Alba Adriatica (TE) a.s. 2014-15 Dirigente Scolastico: Prof.ssa SABRINA DEL GAONE Referente Continuità:
Progettazione delle Attività di Continuità e Istituto Comprensivo Alba Adriatica Via Duca D Aosta, 13 64011 Alba Adriatica (TE) a.s. 2014-15 Dirigente Scolastico: Prof.ssa SABRINA DEL GAONE Referente Continuità:
APPRENDIMENTO PER INSIGHT
 APPRENDIMENTO PER INSIGHT NON SOLO PERCEZIONE NON SOLO PERCEZIONE Gli studi di psicologia animale di Köhler hanno riproposto il problema dell atto mentale che si esprime nella visione mentale della soluzione
APPRENDIMENTO PER INSIGHT NON SOLO PERCEZIONE NON SOLO PERCEZIONE Gli studi di psicologia animale di Köhler hanno riproposto il problema dell atto mentale che si esprime nella visione mentale della soluzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEBELLO VICENTINO
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEBELLO VICENTINO Scuola Secondaria di primo grado Disciplina: STORIA Traguardi per lo sviluppo delle competenze al fine del primo ciclo L'alunno si informa in modo autonomo
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEBELLO VICENTINO Scuola Secondaria di primo grado Disciplina: STORIA Traguardi per lo sviluppo delle competenze al fine del primo ciclo L'alunno si informa in modo autonomo
TRATTO DA: DARIO I., CAMEROTTI S. (2005), IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROGETTO DI VITA, TRENTO, ERICKSON
 TRATTO DA: DARIO I., CAMEROTTI S. (2005), IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROGETTO DI VITA, TRENTO, ERICKSON SINTESI ED ADATTAMENTO DEL SECONDO CAPITOLO: IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E IL PROGETTO
TRATTO DA: DARIO I., CAMEROTTI S. (2005), IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROGETTO DI VITA, TRENTO, ERICKSON SINTESI ED ADATTAMENTO DEL SECONDO CAPITOLO: IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E IL PROGETTO
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA
 LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA Contesto della politica Dati internazionali mostrano che le
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA Contesto della politica Dati internazionali mostrano che le
DEI DELITTI E DELLE PENE
 DEI DELITTI E DELLE PENE Cesare Beccaria Lavoro di filosofia fatto da Gabriele Gatti, Antonino Curcio e Alessio Caputo di 4 CS CESARE BECCARIA E IL SUO DEI DELITTI E DELLE PENE L opera è frutto dello slancio
DEI DELITTI E DELLE PENE Cesare Beccaria Lavoro di filosofia fatto da Gabriele Gatti, Antonino Curcio e Alessio Caputo di 4 CS CESARE BECCARIA E IL SUO DEI DELITTI E DELLE PENE L opera è frutto dello slancio
Una vita per la meccanica quantistica. Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G
 Una vita per la meccanica quantistica Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G Introduzione Vita Quali meriti? Meccanica quantistica Il principio di indeterminazione Implicazioni filosofiche Nuovo
Una vita per la meccanica quantistica Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G Introduzione Vita Quali meriti? Meccanica quantistica Il principio di indeterminazione Implicazioni filosofiche Nuovo
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16
 CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze
DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI PROCESSI E DELLE RELAZIONI
 Consulenza e Formazione DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI PROCESSI E DELLE RELAZIONI. LA PROPOSTA DI VALORE TECNOLINK PER REALIZZARE IL MODELLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE TECNOLINK S.r.l.
Consulenza e Formazione DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI PROCESSI E DELLE RELAZIONI. LA PROPOSTA DI VALORE TECNOLINK PER REALIZZARE IL MODELLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE TECNOLINK S.r.l.
CORSO DI ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. Gianni Maria Strada
 CORSO DI ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Gianni Maria Strada 1 Che cosa mettere nello zainetto Anno Accademico 2013-2014 2014 Sistemi organizzativi 2 Quali competenze? Gestione del personale Relazioni
CORSO DI ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Gianni Maria Strada 1 Che cosa mettere nello zainetto Anno Accademico 2013-2014 2014 Sistemi organizzativi 2 Quali competenze? Gestione del personale Relazioni
LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO
 LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO La Fenomenologia dello Spirito di Hegel Gadamer, un grande filosofo contemporaneo, riflette sul passaggio dalla coscienza all autocoscienza La Fenomenologia dello Spirito di
LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO La Fenomenologia dello Spirito di Hegel Gadamer, un grande filosofo contemporaneo, riflette sul passaggio dalla coscienza all autocoscienza La Fenomenologia dello Spirito di
Di cosa ci occuperemo nel corso?
 Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche Università degli studi G. D Annunzio Chieti Pescara Corso di Laurea in Economia Aziendale Lezione n. 1 Le Amministrazioni Pubbliche Economia delle
Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche Università degli studi G. D Annunzio Chieti Pescara Corso di Laurea in Economia Aziendale Lezione n. 1 Le Amministrazioni Pubbliche Economia delle
Aspettative e motivazioni degli utenti dei corsi di formazione del Comune di Milano: un indagine conoscitiva
 Aspettative e motivazioni degli utenti dei corsi di formazione del Comune di Milano: un indagine conoscitiva Introduzione La ricerca è stata realizzata nei primi 7 mesi del 2007, attraverso un questionario,
Aspettative e motivazioni degli utenti dei corsi di formazione del Comune di Milano: un indagine conoscitiva Introduzione La ricerca è stata realizzata nei primi 7 mesi del 2007, attraverso un questionario,
Materiale per gli alunni
 Testi semplificati di storia Materiale per gli alunni LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: A2- B1 SI RIVOLGE A: studenti della scuola secondaria di I grado al 3 anno Prerequisiti: Gli alunni sanno
Testi semplificati di storia Materiale per gli alunni LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: A2- B1 SI RIVOLGE A: studenti della scuola secondaria di I grado al 3 anno Prerequisiti: Gli alunni sanno
Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone
 Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone Difficoltà ad identificare una definizione sufficientemente articolata e sintetica: - complessità del campo di pertinenza della psicologia sociale;
Che cos è la Psicologia sociale? Dott.ssa Daniela Cipollone Difficoltà ad identificare una definizione sufficientemente articolata e sintetica: - complessità del campo di pertinenza della psicologia sociale;
Alberto Franco Pozzolo. La globalizzazione: meglio accelerare o frenare?
 Cosa significa globalizzazione? Globalizzazioneè una parola relativamente recente, il cui significato non è univoco: the development of an increasingly integrated global economymarked especially by free
Cosa significa globalizzazione? Globalizzazioneè una parola relativamente recente, il cui significato non è univoco: the development of an increasingly integrated global economymarked especially by free
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGROTTO TERME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DISCIPLINA: STORIA - CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA L'alunno si informa in modo guidato su fatti e problemi storici anche mediante l uso di risorse digitali. Comprende testi storici e inizia a rielaborarli. Espone oralmente
PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA L'alunno si informa in modo guidato su fatti e problemi storici anche mediante l uso di risorse digitali. Comprende testi storici e inizia a rielaborarli. Espone oralmente
Introduzione alla storia lezione n. 2. Prof. Marco Bartoli
 Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
 RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
Istituto Comprensivo Statale G. Garibaldi Subbiano-Capolona. Laboratorio del Sapere Scientifico
 Istituto Comprensivo Statale G. Garibaldi Subbiano-Capolona Laboratorio del Sapere Scientifico Scuola Primaria G. Tortelli di Capolona Anno scolastico 2014/2015 Classi VA e VB Dalle INDICAZIONI NAZIONALI
Istituto Comprensivo Statale G. Garibaldi Subbiano-Capolona Laboratorio del Sapere Scientifico Scuola Primaria G. Tortelli di Capolona Anno scolastico 2014/2015 Classi VA e VB Dalle INDICAZIONI NAZIONALI
Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti
 Facoltà di Scienze Politiche Università di Bari Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti Modulo 5 Due approfondimenti: Vernon e la dinamica del commercio; Porter e il vantaggio competitivo
Facoltà di Scienze Politiche Università di Bari Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti Modulo 5 Due approfondimenti: Vernon e la dinamica del commercio; Porter e il vantaggio competitivo
DOV È LA RIPRESA ANNUNCIATA DAL MINISTRO DELL ECONOMIA?
 226 DOV È LA RIPRESA ANNUNCIATA DAL MINISTRO DELL ECONOMIA? 4 luglio 2013 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente INDICE 2 Le dichiarazioni
226 DOV È LA RIPRESA ANNUNCIATA DAL MINISTRO DELL ECONOMIA? 4 luglio 2013 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente INDICE 2 Le dichiarazioni
Indice. Presentazione del Presidente. Introduzione
 Indice Presentazione del Presidente Introduzione 1. federambiente 1.1 Forma giuridica ed obiettivi 1.2 Servizi agli associati e rapporti con le altre federazioni 1.3 Struttura interna 1.4 Principali dati
Indice Presentazione del Presidente Introduzione 1. federambiente 1.1 Forma giuridica ed obiettivi 1.2 Servizi agli associati e rapporti con le altre federazioni 1.3 Struttura interna 1.4 Principali dati
Scienze della Mediazione Linguistica
 ALLEGATO - B - Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica Percorso in Governo delle Amministrazioni, Internazionalizzazione e Sicurezza. CLASSE DI LAUREA L -12 - D. M. 270/2004 DM del 12/03/2010
ALLEGATO - B - Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica Percorso in Governo delle Amministrazioni, Internazionalizzazione e Sicurezza. CLASSE DI LAUREA L -12 - D. M. 270/2004 DM del 12/03/2010
I incontro: IL FONDO STRAORDINARIO DIOCESANO: UN SEGNO DI SOLIDARIETA NON SOLO ECONOMICA
 I incontro: IL FONDO STRAORDINARIO DIOCESANO: UN SEGNO DI SOLIDARIETA NON SOLO ECONOMICA Il percorso formativo giovedì 12 settembre ore 18.00-20.00 IL FONDO STRAORDINARIO DIOCESANO: UN SEGNO DI SOLIDARIETÀ
I incontro: IL FONDO STRAORDINARIO DIOCESANO: UN SEGNO DI SOLIDARIETA NON SOLO ECONOMICA Il percorso formativo giovedì 12 settembre ore 18.00-20.00 IL FONDO STRAORDINARIO DIOCESANO: UN SEGNO DI SOLIDARIETÀ
Liceo Marie Curie (Meda) Scientifico Classico Linguistico PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
 Liceo Marie Curie (Meda) Scientifico Classico Linguistico PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE a.s. 2015/16 CLASSE 2^ ASA Indirizzo di studio Liceo scientifico Scienze Applicate Docente Disciplina
Liceo Marie Curie (Meda) Scientifico Classico Linguistico PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE a.s. 2015/16 CLASSE 2^ ASA Indirizzo di studio Liceo scientifico Scienze Applicate Docente Disciplina
LE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI
 Trento, 11 marzo 2010 LE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI ARGOMENTI: 1. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 2. IL TRATTATO DI LISBONA 3. IL QUADRO ISTITUZIONALE
Trento, 11 marzo 2010 LE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI ARGOMENTI: 1. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 2. IL TRATTATO DI LISBONA 3. IL QUADRO ISTITUZIONALE
ESERCITAZIONI TATTICHE PER LA SCUOLA CALCIO DALL 1>1 AL 4>2+1
 SCUOLA CALCIO Maurizio Bruni- Allenatore Giovani Calciatori - Allenatore di Base UEFA B - SAURORISPESCIA Istruttore CONI ESERCITAZIONI TATTICHE PER LA SCUOLA CALCIO DALL 1>1 AL 4>2+1 In considerazione
SCUOLA CALCIO Maurizio Bruni- Allenatore Giovani Calciatori - Allenatore di Base UEFA B - SAURORISPESCIA Istruttore CONI ESERCITAZIONI TATTICHE PER LA SCUOLA CALCIO DALL 1>1 AL 4>2+1 In considerazione
2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale
 133 2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 2.1 Indicazioni generali Dove devo tassare la mia pensione derivante da lavoro frontaliero? La pensione viene tassata quasi sempre nel
133 2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 2.1 Indicazioni generali Dove devo tassare la mia pensione derivante da lavoro frontaliero? La pensione viene tassata quasi sempre nel
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
DIDATTICA PER PROGETTI
 DIDATTICA PER PROGETTI La vera novità per la scuola: compito di individuare accertare una competenza certificare provarne l esistenza e documentarla. ( Nuove Indicazioni Nazionali Primo Ciclo - Obbligo
DIDATTICA PER PROGETTI La vera novità per la scuola: compito di individuare accertare una competenza certificare provarne l esistenza e documentarla. ( Nuove Indicazioni Nazionali Primo Ciclo - Obbligo
La trasformazione digitale: competenze, strumenti e modalità.
 Stefano Tazzi: Opportunità da bandi e incentivi workshop La trasformazione digitale: competenze, strumenti e modalità. Pavia, 10 marzo 2016 - Fondazione Comunitaria Della Provincia Di Pavia Onlus Stefano
Stefano Tazzi: Opportunità da bandi e incentivi workshop La trasformazione digitale: competenze, strumenti e modalità. Pavia, 10 marzo 2016 - Fondazione Comunitaria Della Provincia Di Pavia Onlus Stefano
Formare per competenze Ciclo di Apprendimento Esperienziale
 Formare per competenze Ciclo di Apprendimento Esperienziale Esperienza in classe: i dati impliciti o inutili saper ricavare le informazioni da un testo Classe seconda scuola primaria di Mazzè Docenti:
Formare per competenze Ciclo di Apprendimento Esperienziale Esperienza in classe: i dati impliciti o inutili saper ricavare le informazioni da un testo Classe seconda scuola primaria di Mazzè Docenti:
RELIGIONE MODULI OPERATIVI:
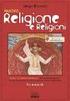 RELIGIONE INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla conoscenza della realtà religiosa del territorio ed degli elementi essenziali del linguaggio religioso per costruire un sapere che evidenzi la dimensione
RELIGIONE INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla conoscenza della realtà religiosa del territorio ed degli elementi essenziali del linguaggio religioso per costruire un sapere che evidenzi la dimensione
Udine Fiere dal 23 al 26 gennaio Orario 9.30/ pag. 1/6 segue >>
 Udine Fiere dal 23 al 26 gennaio 2014 Orario 9.30/18.30 pag. 1/6 segue >> L edizione di Agriest con focus su territorio e tutela dell ambiente Interazione tra paesaggio urbano e extraurbano Tutela dell
Udine Fiere dal 23 al 26 gennaio 2014 Orario 9.30/18.30 pag. 1/6 segue >> L edizione di Agriest con focus su territorio e tutela dell ambiente Interazione tra paesaggio urbano e extraurbano Tutela dell
UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA. Uff. VIII^ - Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola
 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA Uff. VIII^ - Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola Incontri di formazione per Docenti della Scuola secondaria Disturbi specifici di apprendimento Morbegno
UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA Uff. VIII^ - Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola Incontri di formazione per Docenti della Scuola secondaria Disturbi specifici di apprendimento Morbegno
Mariella Spinosi L Aquila, 15 ottobre 2013
 Scuola elementare, scuola primaria, primo ciclo d istruzione Mariella Spinosi L Aquila, 15 ottobre 2013 Della scuola primaria generalmente si parla bene (specialmente prima delle prove Invalsi). Molti
Scuola elementare, scuola primaria, primo ciclo d istruzione Mariella Spinosi L Aquila, 15 ottobre 2013 Della scuola primaria generalmente si parla bene (specialmente prima delle prove Invalsi). Molti
Tecniche di Vendita 17 Giugno 2013
 Tecniche di Vendita 17 Giugno 2013 AGENDA le tecniche di vendita La tua strategia di vendita 2 Le slide di questo corso puoi scaricarle nel sito: www.wearelab.com www.brunobruni.it 3 BREVE RIEPILOGO Cambio
Tecniche di Vendita 17 Giugno 2013 AGENDA le tecniche di vendita La tua strategia di vendita 2 Le slide di questo corso puoi scaricarle nel sito: www.wearelab.com www.brunobruni.it 3 BREVE RIEPILOGO Cambio
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE. - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni
 CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez.
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
NORD. Mare del Nord. Regione. germanica. Regione. Regione. italiana. Mar Mediterraneo SUD
 Le Regioni europee NORD nordica OCEANO ATLANTICO OVEST britannica Mare del Nord russa EST francese germanica centro- orientale iberica italiana balcanica Mar Nero Mar Mediterraneo L Europa è formata da
Le Regioni europee NORD nordica OCEANO ATLANTICO OVEST britannica Mare del Nord russa EST francese germanica centro- orientale iberica italiana balcanica Mar Nero Mar Mediterraneo L Europa è formata da
ARRIVI A DESTINAZIONE PIÙ
 CON TOMTOM TRAFFIC ARRIVI A DESTINAZIONE PIÙ VELOCEMENTE TomTom è un provider di servizi di informazioni sul traffico leader del settore. TomTom monitora, elabora e fornisce informazioni sul traffico tramite
CON TOMTOM TRAFFIC ARRIVI A DESTINAZIONE PIÙ VELOCEMENTE TomTom è un provider di servizi di informazioni sul traffico leader del settore. TomTom monitora, elabora e fornisce informazioni sul traffico tramite
UNITA DI APPRENDIMENTO N.1
 TITOLO: Oh, che bel castello! UNITA DI APPRENDIMENTO N.1 TIPOLOGIA DELL UA:disciplinare ANNO SCOLASTICO:2011/2012 DESTINATARI:classe I E DATI IDENTIFICATIVI fase preattiva ARTICOLAZIONE DELL UNITA DI APPRENDIMENTO
TITOLO: Oh, che bel castello! UNITA DI APPRENDIMENTO N.1 TIPOLOGIA DELL UA:disciplinare ANNO SCOLASTICO:2011/2012 DESTINATARI:classe I E DATI IDENTIFICATIVI fase preattiva ARTICOLAZIONE DELL UNITA DI APPRENDIMENTO
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 47 11.03.2016 CU 2016: rettifiche e sanzioni In caso di dati omessi o errati si ha tempo fino a lunedì 14 marzo per reinoltrare
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 47 11.03.2016 CU 2016: rettifiche e sanzioni In caso di dati omessi o errati si ha tempo fino a lunedì 14 marzo per reinoltrare
ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CICLO ECONOMICO
 Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2009/2010 ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CICLO ECONOMICO Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@univpm.it
Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2009/2010 ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CICLO ECONOMICO Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@univpm.it
Illuminismo. scaricato da
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Orizzontali 4. Quello di alcuni sovrani europei era "illuminato" 7. Raccolta sistematica del sapere moderno 10. L' si batte per la felicità e per l'... Verticali 1. Sostiene che i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Orizzontali 4. Quello di alcuni sovrani europei era "illuminato" 7. Raccolta sistematica del sapere moderno 10. L' si batte per la felicità e per l'... Verticali 1. Sostiene che i
PROTOCOLLO PER LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI
 PROTOCOLLO PER LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
PROTOCOLLO PER LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
Sito web Telefono (Carmine)
 Vespasiano Carmine BASE Totocalcio2012 Tutorial I tutorials totocalcio precedenti sono disponibili gratis alla pagina web. http://vecasoft.it/download_vecasoft.htm BASE Totocalcio v3.0.0.32 TotoQuote Totocalcio
Vespasiano Carmine BASE Totocalcio2012 Tutorial I tutorials totocalcio precedenti sono disponibili gratis alla pagina web. http://vecasoft.it/download_vecasoft.htm BASE Totocalcio v3.0.0.32 TotoQuote Totocalcio
Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali
 Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati individuali, la data di nascita di un individuo è: Un dato
Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati individuali, la data di nascita di un individuo è: Un dato
Il comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32, citato dal comma 5, recita che:
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI Modalità formative degli Ingegneri ed Architetti responsabili del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (Approfondimenti dell Area tematica
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI Modalità formative degli Ingegneri ed Architetti responsabili del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (Approfondimenti dell Area tematica
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA CONTINUITÀ
 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA CONTINUITÀ Uno degli obiettivi principali della nostra Scuola è garantire la gradualità e la personalizzazione del percorso formativo di ogni bambino. La scuola dell infanzia,
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA CONTINUITÀ Uno degli obiettivi principali della nostra Scuola è garantire la gradualità e la personalizzazione del percorso formativo di ogni bambino. La scuola dell infanzia,
Parallelamente si conduce un attento lavoro sulla creazione e trasmissione di un sistema di regole individuali e di gruppo, che da un lato garantiscan
 LABORATORIO DI TEATRO Coordinatore MARCO COLOMBO BOLLA OBIETTIVI Un laboratorio teatrale collocato in ambito scolastico mira a creare percorsi che consentano agli allievi di esplorare due territori: quello
LABORATORIO DI TEATRO Coordinatore MARCO COLOMBO BOLLA OBIETTIVI Un laboratorio teatrale collocato in ambito scolastico mira a creare percorsi che consentano agli allievi di esplorare due territori: quello
LE CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUINTA
 Nell Anno Scolastico 2014/2015 è entrato in vigore il Nuovo Ordinamento Il DPR 263 in vigore dal 25/02/2013 ha dato l avvio alla riforma dei CPIA e dei corsi serali attivi nelle scuola secondarie superiori.
Nell Anno Scolastico 2014/2015 è entrato in vigore il Nuovo Ordinamento Il DPR 263 in vigore dal 25/02/2013 ha dato l avvio alla riforma dei CPIA e dei corsi serali attivi nelle scuola secondarie superiori.
A scuola di scienza: il progetto Tutti pazzi per la chimica!
 A scuola di scienza: il progetto Tutti pazzi per la chimica! Il sistema scolastico lombardo SCUOLE STATALI SCUOLE PARITARIE ALUNNI SCUOLE STATALI ALUNNI S. PARITARIE DOCENTI SCUOLE STATALI DOCENTI S. PARITARIE
A scuola di scienza: il progetto Tutti pazzi per la chimica! Il sistema scolastico lombardo SCUOLE STATALI SCUOLE PARITARIE ALUNNI SCUOLE STATALI ALUNNI S. PARITARIE DOCENTI SCUOLE STATALI DOCENTI S. PARITARIE
Il Luccio muore di esperienza e di abitudine.
 OPEN SOURCE MANAGEMENT Costruirsi un futuro oltre la crisi! Slides su www.maxcalore.it area download 3 OPEN SOURCE MANAGEMENT Il Luccio muore di esperienza e di abitudine. 4 5 Spunti per costruirsi un
OPEN SOURCE MANAGEMENT Costruirsi un futuro oltre la crisi! Slides su www.maxcalore.it area download 3 OPEN SOURCE MANAGEMENT Il Luccio muore di esperienza e di abitudine. 4 5 Spunti per costruirsi un
STATI GENERALI DEL WELFARE LOCALE DI TRADATE
 1 STATI GENERALI DEL WELFARE LOCALE DI TRADATE Assessore ai servizi sociali dott. Luigi Luce Responsabile del servizio dott.ssa Mariella Luciani WELFARE LOCALE Riteniamo che il BENESSERE SOCIALE dipenda
1 STATI GENERALI DEL WELFARE LOCALE DI TRADATE Assessore ai servizi sociali dott. Luigi Luce Responsabile del servizio dott.ssa Mariella Luciani WELFARE LOCALE Riteniamo che il BENESSERE SOCIALE dipenda
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia
 Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia Istitituti Comprensivi 15 e 17 di Bologna a.s. 2015-2016 Ins. Cice Maria Rosa Le attività in ordine all insegnamento della Religione Cattolica, per coloro
Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia Istitituti Comprensivi 15 e 17 di Bologna a.s. 2015-2016 Ins. Cice Maria Rosa Le attività in ordine all insegnamento della Religione Cattolica, per coloro
Aspetti psicologici ed emotivi dell infertilità!
 Aspetti psicologici ed emotivi dell infertilità! L infertilità è una vera e propria patologia che può avere importanti ripercussioni psicologiche ed emotive sia sui singoli individui che sulle coppie.
Aspetti psicologici ed emotivi dell infertilità! L infertilità è una vera e propria patologia che può avere importanti ripercussioni psicologiche ed emotive sia sui singoli individui che sulle coppie.
Livello A2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue)
 Livello A2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona
Livello A2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona
Infografica C O S È U N I N F O G R A F I C A E P E R C H É È U T I L E
 Infografica C O S È U N I N F O G R A F I C A E P E R C H É È U T I L E Infografica L'infografica (anche nota con termini inglesi "information design", information graphic o infographic) è l'informazione
Infografica C O S È U N I N F O G R A F I C A E P E R C H É È U T I L E Infografica L'infografica (anche nota con termini inglesi "information design", information graphic o infographic) è l'informazione
La lingua dell autonomia e del successo
 La lingua dell autonomia e del successo Le ricerche sull educazione bilingue hanno dimostrato che L apprendimento della madrelingua in ambito scolastico sia come strumento veicolare sia come materia facoltativa
La lingua dell autonomia e del successo Le ricerche sull educazione bilingue hanno dimostrato che L apprendimento della madrelingua in ambito scolastico sia come strumento veicolare sia come materia facoltativa
CREARE UN IMPRESA DI SUCCESSO SI PUO FARE!
 CREARE UN IMPRESA DI SUCCESSO SI PUO FARE! METTERSI IN PROPRIO Una opportunità. PRIMA DI PARTIRE MOTIVAZIONE ENTUSIASMO COMPETENZE (tecniche, gestionali, commerciali) ATTITUDINE AL CAMBIAMENTO E AL RISCHIO
CREARE UN IMPRESA DI SUCCESSO SI PUO FARE! METTERSI IN PROPRIO Una opportunità. PRIMA DI PARTIRE MOTIVAZIONE ENTUSIASMO COMPETENZE (tecniche, gestionali, commerciali) ATTITUDINE AL CAMBIAMENTO E AL RISCHIO
A PALMA AVERE GLI SPARRING ERA UN PROBLEMA. MA NON ERA UN PROBLEMA COSI GRANDE SE RAFAEL E DIVENTATO IL NUMERO 1
 IO INTENDO IL GIOCO DEL TENNIS COME TUTTO LO SPORT IN MODO SEMPLICE PERCHE LO SPORT NON E UNA COSA DIFFICILE A PALMA AVERE GLI SPARRING ERA UN PROBLEMA. MA NON ERA UN PROBLEMA COSI GRANDE SE RAFAEL E DIVENTATO
IO INTENDO IL GIOCO DEL TENNIS COME TUTTO LO SPORT IN MODO SEMPLICE PERCHE LO SPORT NON E UNA COSA DIFFICILE A PALMA AVERE GLI SPARRING ERA UN PROBLEMA. MA NON ERA UN PROBLEMA COSI GRANDE SE RAFAEL E DIVENTATO
I DIECI PRINCIPI DELL ECONOMIA
 Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2011/2012 I DIECI PRINCIPI Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@unimc.it Web: http://docenti.unimc.it/docenti/fabio-clementi
Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2011/2012 I DIECI PRINCIPI Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@unimc.it Web: http://docenti.unimc.it/docenti/fabio-clementi
ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA L. R. D.M. n 900 DEL 15/GIUGNO/1998
 IL DIRETTORE - VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro
IL DIRETTORE - VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro
BIANCO E NERO IL CASTORO CINEMA CIAK
 BIANCO E NERO DESCRIZIONE: Mensile con articoli sulla storia del cinema, sulla teoria e sull'estetica cinematografica, approfondite analisi su generi, autori e cinematografie. Ogni mese Cineforum riporta
BIANCO E NERO DESCRIZIONE: Mensile con articoli sulla storia del cinema, sulla teoria e sull'estetica cinematografica, approfondite analisi su generi, autori e cinematografie. Ogni mese Cineforum riporta
Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia Salerno. Programmazione Disciplinare: Diritto ed Economia Classi prime
 Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia Salerno Programmazione Disciplinare: Diritto ed Economia Classi prime Finalità della Disciplina: L'insegnamento del diritto e dell'economia nei bienni della
Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia Salerno Programmazione Disciplinare: Diritto ed Economia Classi prime Finalità della Disciplina: L'insegnamento del diritto e dell'economia nei bienni della
NUCLEI FONDANTI COMPETENZE CONTENUTI ABILITA METODOLOGIE E STRUMENTI METODO SCIENTIFICO VEDERE
 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE CONTENUTI ABILITA METODOLOGIE E STRUMENTI METODO SCIENTIFICO VEDERE OSSERVARE COMPARARE CLASSIFICARE FORMULARE E VERIFICARE IPOTESI UTILIZZANDO SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI Relazione
NUCLEI FONDANTI COMPETENZE CONTENUTI ABILITA METODOLOGIE E STRUMENTI METODO SCIENTIFICO VEDERE OSSERVARE COMPARARE CLASSIFICARE FORMULARE E VERIFICARE IPOTESI UTILIZZANDO SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI Relazione
Le azienda pubbliche locali:
 Le azienda pubbliche locali: sviluppo o declino Il caso acqua e rifiuti solidi urbani Vicenza, 24 novembre 2012 Premessa 1 Si è mai sentito qualcuno che di fronte alla domanda «sei per lo sviluppo o per
Le azienda pubbliche locali: sviluppo o declino Il caso acqua e rifiuti solidi urbani Vicenza, 24 novembre 2012 Premessa 1 Si è mai sentito qualcuno che di fronte alla domanda «sei per lo sviluppo o per
5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone
 di Gianluca Alparone 5.1 Premessa Redatto il progetto di bilancio a cura dell organo amministrativo, tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che superano i limiti parametrici
di Gianluca Alparone 5.1 Premessa Redatto il progetto di bilancio a cura dell organo amministrativo, tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che superano i limiti parametrici
riflessioni e scambi attorno al tema dei problemi a parole e problemi con variazione SEI Gorillante e scuola primaria D. Alighieri I Problemi
 riflessioni e scambi attorno al tema dei problemi a parole e problemi con variazione SEI Gorillante e scuola primaria D. Alighieri I Problemi Dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculo La matematica
riflessioni e scambi attorno al tema dei problemi a parole e problemi con variazione SEI Gorillante e scuola primaria D. Alighieri I Problemi Dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculo La matematica
La procedura di nomina tratterà esclusivamente le domande convalidate.
 ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI REGIONALI A partire dagli esami di Stato 2012, le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI REGIONALI A partire dagli esami di Stato 2012, le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli
P.O.I. : scelta post-diploma PROFILO ORIENTATIVO INDIVIDUALE
 P.O.I. : scelta post-diploma PROFILO ORIENTATIVO INDIVIDUALE 1. Mi sento sicuro di me stesso/a 2. Sono sempre pronto/a dare una mano a chi ha bisogno 3. Mi concentro fino alla fine su quello che sto facendo
P.O.I. : scelta post-diploma PROFILO ORIENTATIVO INDIVIDUALE 1. Mi sento sicuro di me stesso/a 2. Sono sempre pronto/a dare una mano a chi ha bisogno 3. Mi concentro fino alla fine su quello che sto facendo
Progetto Job Club Orientativo affidato con Delibera N. 223 del 23.12.2003 1 RELAZIONE JOB CLUB ORIENTATIVO
 1 RELAZIONE Nel mese di Aprile u.s., con lo slogan Vuoi realizzare il tuo progetto professionale? Fai un salto al Comune, è stato organizzato dall Assessorato alle politiche giovanili del Comune di San
1 RELAZIONE Nel mese di Aprile u.s., con lo slogan Vuoi realizzare il tuo progetto professionale? Fai un salto al Comune, è stato organizzato dall Assessorato alle politiche giovanili del Comune di San
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. E M. MONTANI
 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. E M. MONTANI PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO PER COMPETENZE ED ABILITÀ DOCENTE: ALFREDO VITELLOZZI MATERIA: GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA CLASSE: 1ME A Anno scolastico:
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. E M. MONTANI PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO PER COMPETENZE ED ABILITÀ DOCENTE: ALFREDO VITELLOZZI MATERIA: GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA CLASSE: 1ME A Anno scolastico:
JOE ROSS - TRADING EDUCATORS www.tradingeducators.education Esempi di trade con la tecniche DAYTRADING in diversi mercati e intervalli temporali
 JOE ROSS - TRADING EDUCATORS www.tradingeducators.education Esempi di trade con la tecniche DAYTRADING in diversi mercati e intervalli temporali Esempio 1: Future Crude Oil con grafico a 5 minuti! Data
JOE ROSS - TRADING EDUCATORS www.tradingeducators.education Esempi di trade con la tecniche DAYTRADING in diversi mercati e intervalli temporali Esempio 1: Future Crude Oil con grafico a 5 minuti! Data
