Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete
|
|
|
- Alessio Massaro
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete
2 PREMESSA Il Manifesto dei diritti della persona con diabete viene firmato in Senato il 9 luglio 2009 da Diabete Italia e dall Associazione parlamentare per la tutela e promozione del diritto alla prevenzione. Già questa prima stesura ha visto coinvolte le Associazioni di Volontariato delle persone con diabete (AGD Italia, AID, ANIAD, Diabete Forum, FAND, FDG, JDRF oggi A.R.D.I,, SOStegno70) oltre le Società Scientifiche di diabetologia (AMD e SID) e OSDI (Operatori Sanitari In Diabetologia). E stato formulato tenendo conto: della Dichiarazione dei diritti dell uomo; della Costituzione italiana; della Carta europea dei diritti del malato (promossa da ACN, rete europea di cittadinanzattiva); dei risultati dello Studio DAWN. L obiettivo era di trasformare i principi generali in diritti concreti e di indicare le strade da intraprendere. Il primo Documento era formato da 11 sezioni: diritti della persona con diabete, aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei familiari, educazione continua della persona con diabete, dialogo medicopersona con diabete, controllo del diabete, prevenzione del diabete, impegno nella ricerca, associazionismo responsabile, diabete in gravidanza, diabete in età evolutiva, immigrazione e diabete. Il Manifesto dei diritti della persona con diabete ha avuto una larga eco: molte associazioni lo hanno pubblicizzato; è stato frequentemente utilizzato come strumento da usare nel dialogo con le Istituzioni. Si è cercato di farlo recepire dalle Regioni o dalle ASL, sperando di poter richiamare poi l Istituzione all impegno preso. in realtà con scarso successo. Richiamandosi ai diritti della persona, il Manifesto implicitamente richiedeva l uniformità su tutto il territorio italiano delle azioni in esso indicate e candidava le associazioni a un ruolo di controllore di queste azioni. Il Manifesto, così aderente alla realtà culturale, sociale e assistenziale italiana, è per sua natura un documento destinato a evolversi nel tempo e pertanto anche in considerazione che il contesto negli anni è mutato. I promotori (Diabete Italia, il Comitato per i diritti delle persone con diabete, Italian Barometer Diabetes Obsevatory Foundation) hanno così deciso di procedere a un suo aggiornamento e rilancio che ha portato al recepimento da parte della Conferenza Stato Regioni, prima, e delle singole Regioni, dopo, del Piano Nazionale Diabete. Il 13 aprile del 2015 viene presentato il Manifesto dei diritti e doveri delle persone con Diabete con i 13 articoli che lo caratterizzano anche oggi; sono stati aggiunti il diabete nell anziano e Territorio e Diabete (due ambiti rilevanti anche dal punto di vista sociale). Ma la differenza sostanziale sta già nel titolo Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete infatti, la nuova versione rappresenta un momento di auto-verifica per le associazioni e un punto di partenza per il dialogo con l Istituzione facendo superare all associazionismo la logica di rivendicazione sindacale per assumere il ruolo di rappresentanza efficace a livello delle Istituzioni; ruolo peraltro sottolineato dal Piano Nazionale della Malattia Diabetica. Il 4 marzo 2019 un gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente dell Hub for International Health Research e composto da tutte le associazioni dei pazienti rappresentate a livello nazionale con in aggiunta tutti i rappresentanti delle associazioni pazienti coinvolti nella stesura del Manifesto nel 2009, si è riunito in occasione dei 10 anni del Documento e ne ha riapprovato i 13 punti, apportando minimi aggiornamenti per renderlo ancora più coerente alla situazione attuale. Oggi il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete rappresenta uno strumento di advocacy per tutte le associazioni di volontariato che operano nel mondo del diabete: questo è il significato che Diabete Italia da al Manifesto nel Al gruppo di lavoro hanno preso parte: Diabete Italia, FAND, FDG, ANIAD, AID, AGD Italia, Diabete Forum, A.R.D.I. Italia, CLAD Lombardia, SOStegno 70, Federdiabete Lazio, Cittadinanzattiva, Ministero della Salute, Federazione Diabete Toscana, Comitato Nazionale per i diritti della persona con diabete.
3 Indice 1. Diritti della persona con diabete 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari 3. Associazionismo responsabile 4. Prevenzione del diabete 5. Controllo del diabete 6. Impegno nella ricerca 7. Educazione continua della persona con diabete 8. Dialogo medico-persona con diabete 9. Diabete in gravidanza 10. Diabete in età evolutiva 11. Diabete nell anziano fragile 12. Immigrazione e diabete 13. Territorio e diabete La Carta Europea dei diritti del malato, promossa da ACN - rete europea di Cittadinanzattiva, è parte integrante del presente Manifesto.
4 1. Diritti della persona con diabete I diritti di coloro che hanno il diabete sono gli stessi diritti umani e sociali delle persone senza diabete. I diritti comprendono, fra gli altri, la parità di accesso all informazione, alla prevenzione, all educazione terapeutica, al trattamento del diabete e alla diagnosi e cura delle complicanze. Il sistema sanitario deve garantire alla persona con diabete l accesso a metodi diagnostici e terapeutici appropriati, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il diritto delle persone con diabete a vivere una vita sociale, educativa, lavorativa al pari delle persone senza diabete deve essere considerato un obiettivo delle azioni di Governo. 1. Affermare che avere il diabete non preclude la possibilità di perseguire (con successo) gli obiettivi personali, familiari, lavorativi, sportivi e sociali. 2. Aumentare la consapevolezza sociale nel mondo della scuola, in quello del lavoro, nei luoghi in cui si pratica attività sportiva, nelle strutture sanitarie e nella società in generale per evitare discriminazioni e preclusioni personali e professionali. 3. Sostenere la persona con diabete e i familiari nel superare gli ostacoli, i pregiudizi e le diffidenze attraverso l impiego di strumenti informativi, formativi, educativi e sociali con la responsabilizzazione e il concorso attivo delle istituzioni, del sistema socio-sanitario, delle società scientifiche e delle associazioni di volontariato delle persone con diabete. 4. Garantire alle persone con diabete uniformità di accesso al sistema sanitario su tutto il territorio nazionale in modo da promuovere con equità la migliore qualità di cura e di vita, la prevenzione e il trattamento delle complicanze, ricorrendo quando possibile a PDTA specifici e soprattutto ricorrendo a specialisti con competenze specifiche. 5. Istruire gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e gli istruttori sportivi e sensibilizzare i colleghi di lavoro su come prevenire, riconoscere e trattare le eventuali situazioni che necessitino di interventi urgenti. 6. Promuovere in tutte le regioni la garanzia di una diagnosi precoce di intolleranza glucidica e di diabete mellito per tutti i soggetti a rischio. 7. Istituire in tutte le regioni un tavolo che faciliti l interazione e lo scambio tra i diversi soggetti e sistemi (mondo delle associazioni, il sistema sanitario, il sistema scolastico, il sistema sportivo e del lavoro) attraverso il quale indirizzare nel modo corretto e semplice le varie richieste e istanze. 8. Garantire la fornitura di ortesi specifiche per la prevenzione delle amputazioni nei pazienti con neuropatia diabetica.
5 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei familiari La persona con diabete e/o i familiari non sono sempre al corrente del percorso assistenziale e degli obiettivi del trattamento farmacologico, nutrizionale e comportamentale a lungo termine, come definiti dalle attuali linee guida assistenziali. La persona con diabete e i familiari possono credere erroneamente che la situazione sia sotto controllo a causa della mancanza di sintomi e sospendere le adeguate terapie o modificarle in modo incongruo. La persona con diabete e i familiari devono ricevere una corretta informazione sulle cause di scompenso e sui fattori di rischio per lo sviluppo di complicanze, affinché siano consapevoli dell importanza di condurre uno stile di vita sano, in linea con le proprie possibilità e i propri bisogni. 1. Educare la persona con diabete e i familiari affinché possano soddisfare le proprie aspirazioni di vita. 2. Aiutare le famiglie a gestire il diabete facendo formazione continua e fornendo informazioni, strumenti e servizi che tengano conto delle necessità delle singole persone. 3. Stimolare gli operatori sanitari (specialisti, medici di base infermieri, psicologi, nutrizionisti, podologi, ecc..) ad ascoltare attivamente e per un tempo congruo la persona con diabete e i familiari per conoscerne i bisogni, le aspirazioni e le aspettative. 4. Assicurare che gli operatori sanitari spieghino in modo esaustivo gli obiettivi terapeutici, verificandone sempre la comprensione, e consiglino schemi di cura personalizzati e condivisi (prescritti in forma sia scritta che orale) per il trattamento abituale e per eventuali situazioni di urgenza. 5. Invitare tutti gli operatori socio-sanitari a prendersi cura degli aspetti psicologici e sociali della persona con diabete e dei familiari. 6. Richiedere alle persone con diabete di rispettare la corretta aderenza alle terapie prescritte, le modalità di controllo del diabete e le indicazioni sullo stile di vita fornite dagli operatori sanitari, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi terapeutici programmati nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal sistema sanitario.
6 3. Associazionismo responsabile L associazionismo volontario no profit nel campo del diabete in Italia in passato ha contribuito a raggiungere traguardi di assoluto rilievo, come ad esempio l approvazione della legge di iniziativa popolare 115/87 e la Dichiarazione di Saint Vincent. Il raggiungimento di risultati legislativi e regolatori, a livello internazionale, nazionale e locale, appare condizione qualificante dell azione delle associazioni impegnate a promuovere il diabete quale area prioritaria di intervento. Appare altrettanto insostituibile il ruolo di collegamento esercitato dalle Associazioni tra il sistema sanitario, le persone con diabete, i familiari e la società. 1. Considerare l associazionismo una risorsa e una componente importante nelle strategie di tutela della persona con diabete facilitando, di conseguenza, la collaborazione tra le associazioni, le organizzazioni di cittadinanza, le istituzioni e la comunità scientifica. 2. Prevedere la formazione certificata e l accreditamento specifico delle associazioni di volontariato delle persone con diabete e loro familiari e delle associazioni civiche in linea con le politiche nazionali sulla salute. 3. Considerare l associazionismo e le organizzazioni civiche, attraverso persone formate allo scopo, di diversa provenienza etnica e culturale, quale parte attiva nei percorsi di informazione e formazione su diritti e tutela sociale delle persone con diabete. 4. Avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato delle persone con diabete e loro familiari e delle organizzazioni civiche nelle attività di prevenzione del diabete. 5. Sostenere l azione di volontariato attraverso strumenti legislativi e regolatori. 6. Definire un codice etico di autoregolamentazione e delle caratteristiche comuni che costituiscano un modello di riferimento per le associazioni. 7. Valorizzare nei rapporti tra operatore sanitario e persona con diabete e suoi familiari l attività delle associazioni, consigliando di partecipare alla vita associativa. 8. Rendere l associazionismo garante del rispetto di un modello di cura che ponga la persona con diabete, con i suoi desideri, bisogni, valori e la sua situazione familiare e sociale (oltre che per le sue necessità cliniche), al centro delle scelte mediche in modo da superare eventuali barriere ad un assistenza corretta, efficace e condivisa. 9. Stimolare l aggregazione a livello regionale di Federazioni delle Associazioni di volontariato al fine di costituire un interlocutore univoco nei rapporti con le Istituzioni.
7 4. Prevenzione del diabete Vi sono efficaci misure preventive che possono essere attuate nei confronti della popolazione generale per ridurre l insorgenza del diabete mellito contenendone l enorme impatto personale e sociale. A tale scopo è necessaria una stretta collaborazione fra le istituzioni e le associazioni di volontariato delle persone con diabete e loro familiari, le società scientifiche e le organizzazioni civiche. Attività di comunicazione sistematiche e continuative possono favorire la prevenzione e la diagnosi precoce del diabete consentendone il trattamento tempestivo e la riduzione di tutte le sue conseguenze. 1. Richiedere alle istituzioni locali e nazionali l attuazione di efficaci strategie per la prevenzione del diabete. 2. Informare la popolazione che l insorgenza del diabete tipo 2 può essere ridotta nelle persone a rischio (adulti e bambini) adottando stili di vita salutari. 3. Convincere le istituzioni a destinare risorse adeguate per la prevenzione e la diagnosi precoce del diabete attraverso una comunicazione continua e coordinata con le associazioni scientifiche, le associazioni di volontariato delle persone con diabete e loro familiari e le organizzazioni civiche. 4. Considerare la famiglia, la scuola, i posti di lavoro e quelli per le attività ricreative i luoghi privilegiati per l educazione ad un corretto stile di vita. 5. Realizzare programmi d informazione e educazione sanitaria presso la scuola, le associazioni sportive, i centri residenziali per anziani e in generale tutti gli ambienti di vita e di lavoro coinvolgendo le istituzioni sanitarie, i gruppi multidisciplinari e le associazioni di volontariato delle persone con diabete e loro familiari, là dove formate a tale scopo.
8 5. Controllo del diabete La persona con diabete deve essere consapevole che la sua è una condizione cronica, che può essere asintomatica o presentare sintomi di gravità variabile, e deve essere messa in grado di gestire la propria cura. Una corretta gestione del proprio diabete permette una vita scolastica, lavorativa, affettiva, sportiva e relazionale come quella della persona senza diabete. 1. Richiedere la conoscenza della persona con diabete e dei familiari sulle terapie appropriate alle diverse condizioni cliniche, selezionate in base alle necessità e alle capacità del singolo soggetto. 2. Garantire nelle situazioni di ricovero in reparti non specifici, il coinvolgimento del diabetologo (specialista con competenze specifiche) nelle scelte terapeutiche, se possibile, o una assistenza diabetologica qua-lificata. 3. Facilitare l iter burocratico e le modalità prescrittive per garantire l accesso alle nuove tecnologie (per il monitoraggio della glicemia e per la somministrazione dell insulina). 4. Rendere la persona consapevole che il buon controllo del diabete dipende anche dall autocontrollo glicemico domiciliare, da un attività fisica regolare, da una corretta alimentazione, da un peso corporeo nella norma nonché dal controllo di altri fattori quali, ad esempio, la pressione arteriosa e la dislipidemia. 5. Favorire l utilizzo di palestre e di centri specializzati dove poter praticare regolare esercizio fisico adeguatamente prescritto dal diabetologo avvalendosi di convenzioni. 6. Promuovere programmi di appropriatezza terapeutica per favorire una migliore attuazione dei protocolli clinici affinché la cura della persona con diabete avvenga anche in un ottica di sostenibilità del sistema sanitario. 7. Garantire (per iter burocratico e modalità prescrittive) l accesso alle terapie farmacologiche innovative.
9 6. impegno nella ricerca Investire nella ricerca da parte di università, istituzioni sanitarie, industria, enti pubblici e società scientifiche rappresenta un fattore fondamentale per la comprensione, prevenzione e gestione del diabete. È importante che la ricerca risponda alle reali necessità delle persone con diabete e sia potenziata nel campo dell epidemiologia, dell educazione e dell innovazione tecnologica. Grazie ai progressi delle conoscenze sul diabete e sul suo trattamento si potrà migliorare la qualità della vita e prevenire l insorgenza delle complicanze, ridurre i ricoveri ospedalieri e conseguentemente i costi sanitari. 1. Promuovere la collaborazione tra enti di ricerca e associazioni di volontariato delle persone con diabete e loro familiari al fine favorire la miglior comprensione delle reali necessità della persona con diabete e indirizzare di conseguenza le risorse a disposizione. 2. Incrementare le risorse disponibili per investimenti nella ricerca scientifica, di base, clinica ed epidemiologica, nell innovazione e nella formazione. 3. Promuovere studi che abbiano come obiettivo il cambiamento della storia naturale della malattia e il miglioramento della qualità della vita della persona con diabete. 4. Investire nella ricerca e nella applicazione di metodologie e mezzi di comunicazione che permettano di trasmettere in modo efficace informazioni rigorose relative alle innovazioni scientifiche (su prevenzione e gestione integrata del diabete) e che promuovano una corretta rappresentazione sociale della persona con diabete.
10 7. Educazione continua della persona con diabete L educazione continua della persona con diabete, dei familiari e del contesto socio-relazionale è uno strumento indispensabile per raggiungere una piena autonomia nelle gestione quotidiana del diabete e prevenire e riconoscere eventuali complicanze. È importante riconoscere alla terapia educazionale un ruolo centrale prevedendo corsi strutturati. 1. Assicurare uniformità di accesso alla terapia educazionale su tutto il territorio nazionale. 2. Formare il personale sanitario all educazione terapeutica e le organizzazioni di volontariato all educazione sanitaria della persona con diabete e dei familiari, in funzione delle loro specifiche esigenze cliniche e socio-culturali. 3. Avvalersi di un gruppo multidisciplinare con competenze specifiche (mediche, psicologiche, nutrizionali, infermieristiche, sociali) utili a rimuovere le barriere a una corretta gestione del diabete. 3. Condividere e concordare, dopo adeguata informazione, gli obiettivi e le scelte terapeutiche individualizzate, sia per quanto riguarda i farmaci, che l alimentazione e l attività fisica al fine di facilitare la gestione del diabete nella vita quotidiana.
11 8. Dialogo medico-persona con diabete Per realizzare un efficace gestione del diabete è indispensabile che il medico curante e il gruppo multidisciplinare di riferimento conoscano non solo gli aspetti bio-medici ma anche quelli psicologici, relazionali e sociali della persona, le sue percezioni, le sue aspettative, i suoi bisogni, gli ostacoli e integrino tali elementi nel piano assistenziale. A tale fine deve essere garantito un contesto nell ambito del quale la persona con diabete possa esprimere le proprie opinioni e fornire le necessarie informazioni circa la propria condizione. 1. Garantire che gli operatori sanitari stabiliscano una vera e propria alleanza terapeutica con la persona con diabete e i familiari che comprenda l ascolto attivo, una comunicazione empatica, un dialogo aperto e la regolare verifica non solo dello stato di salute ma anche della qualità del servizio erogato. 2. Invitare gli operatori sanitari a sostenere la persona con diabete nell acquisizione di una piena consapevolezza della propria condizione e della propria cura. 3. Analizzare le abitudini e le dinamiche individuali e familiari che possono rappresentare comportamenti a rischio. 4. Facilitare quanto più possibile, la continuità assistenziale anche all interno dei centri specialistici. 5. Aumentare le possibilità e la frequenza di contatti con operatori sanitari anche attraverso l uso dei moderni mezzi di comunicazione telematica.
12 9. Diabete in gravidanza La gravidanza nella donna affetta da diabete o con diabete gestazionale deve essere tutelata con adeguate procedure di screening, con un attenta programmazione e con interventi di educazione terapeutica e di assistenza sanitaria specifici al fine di garantire sia alla gestante che al feto una condizione clinica ottimale nel corso della gestazione, del parto e del periodo perinatale Informare la donna con diabete sull importanza di programmare la gravidanza affinché il concepimento avvenga nella condizione migliore per la formazione dell embrione e per lo sviluppo fetale. 2. Rendere obbligatori gli accertamenti per la diagnosi del diabete gestazionale e i controlli successivi al parto. 3. Garantire che l assistenza e il monitoraggio delle donne sia con diabete pregravidico che gestazionale avvenga da parte di un gruppo multidisciplinare composto da diabetologo, ginecologo, ostetrica, infermiere e pediatra. 4. Accogliere le gestanti in strutture ospedaliere idonee a gestire le gravidanze a rischio e in cui sia prevista durante tutto il ricovero l assistenza diabetologica. 5. Incrementare l aderenza delle donne con pregresso Diabete Gestazionale al follow-up della tolleranza ai carboidrati, con curva glicemica dopo 6 settimane dal parto, al fine di prevenire lo sviluppo del diabete mellito tipo Sensibilizzare le donne con diabete pregestazionale o con diabete gestazionale all importanza dell allattamento al seno del neonato anche al fine di ridurre la probabilità di sviluppare il diabete tipo 2 nella mamma e nel bambino.
13 10. Diabete in età evolutiva Il bambino e l adolescente con diabete hanno diritto, nell ambito dell area pediatrica, alle più adeguate prestazioni sanitarie senza alcuna distinzione di sesso, etnia, religione e condizione sociale. È doveroso prendersi cura del bambino e dell adolescente con diabete prestando particolare attenzione a momenti delicati come l inserimento scolastico e il passaggio alla assistenza dell età adulta, che andranno gestiti con interventi specifici. 1. Garantire il migliore iter diagnostico al fine di identificare con precisione la tipologia di diabete e le strategie terapeutiche adatte alle diverse condizioni cliniche. 2. Favorire la conoscenza dei sintomi per la diagnosi precoce del diabete tipo 1 al fine di evitare i gravissimi rischi di una diagnosi tardiva. 3. Garantire l accesso alle cure più appropriate, innovative e meno invasive. 4. Promuovere l inserimento nell ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) dei campi scuola per i giovani al fine di facilitare il processo di responsabilizzazione e l autogestione del diabete. 5. Incentivare l attività motoria, compresa quella sportiva, nelle migliori condizioni possibili e senza alcun tipo di limitazione. 6. Sostenere i familiari nella gestione del bambino e dell adolescente con diabete. 7. Garantire al bambino e all adolescente una vita scolastica, sportiva, relazionale e sociale identica ai propri coetanei senza diabete. 8. Adottare un linguaggio comprensibile, adeguato all età e alla cultura del bambino e dei familiari. 9. Garantire ambienti ospedalieri e ambulatoriali accoglienti, adatti all infanzia e all adolescenza nei quali siano presenti gruppi multidisciplinari dedicati e specializzati nella cura del diabete in questa fascia d età e nell assistenza ai familiari. 10. Assicurare che nei Centri Specializzati sia mantenuta la continuità nell assistenza al bambino e ai familiari. 11. Assicurare l aggiornamento permanente del personale sanitario al fine di migliorarne costantemente le competenze scientifiche, tecniche e comunicative. 12. Favorire l azione di rete sul territorio tra centri di diabetologia pediatrica di riferimento regionale, centri periferici e pediatri di libera scelta. 13. Facilitare la transizione dell adolescente dal diabetologo pediatra al diabetologo dell adulto affinché si garantisca la continuità della cura e il processo avvenga in modo graduale, attraverso la condivisione degli obiettivi e delle scelte terapeutiche.
14 11. Diabete nell anziano fragile L anziano fragile con diabete ha diritto alle migliori prestazioni sanitarie senza alcuna discriminazione sociale e culturale, affinché possa continuare ad avere un ruolo attivo nella vita comunitaria. È doveroso prendersi cura dell anziano fragile con diabete prestando particolare attenzione alla condizioni di salute generali, a quelle cognitive, alle patologie concomitanti, al contesto in cui vive al fine di disegnare terapie personalizzate, facilmente applicabili, e di educare all autocontrollo glicemico domiciliare costante, se necessario, e all adozione di stili di vita corretti. 1. Garantire strutture dedicate che tengano presente i bisogni specifici dell anziano fragile con diabete (sale con presidi dedicati, tempi di attesa contenuti e tempi di visita sufficienti per un adeguata informazione e formazione, operatori sanitari specificatamente preparati). 2. Adottare un linguaggio, scritto e orale, chiaro e comprensibile adeguato alla cultura dell anziano fragile con diabete e dei familiari. 3. Sensibilizzare l anziano fragile con diabete e i familiari sui rischi cardiovascolari che comporta l instabilità glicemica e l iperglicemia postprandiale e in generale sulle complicanze connesse alla patologia (retinopatia, nefropatia e piede diabetico). 4. Istruire l anziano fragile con diabete e i familiari sui segni premonitori dell ipoglicemia (insonnia, deficit dell attenzione, di memoria, problemi di vertigine, riduzione delle capacità cognitive) e dei rischi ad essa connessa, nonché del suo impatto sulla qualità della vita affinché possa riferirli al proprio medico curante così da stabilire protocolli terapeutici specifici. 5. Favorire gli interventi domiciliari e il ruolo dei presidi territoriali di prossimità nella gestione dell anziano fragile con diabete così da garantire la continuità assistenziale da parte di un team multifunzionale e multiprofessionale. 6. Sostenere le famiglie con una formazione adeguata, che le prepari e le renda autonome nella gestione della cura dell anziano/soggetto fragile con diabete non autosufficiente, e con un supporto idoneo a sostenerle anche sotto il profilo psico-emotivo.
15 12. Immigrazione e diabete La persona con diabete non deve essere discriminata in base alla lingua, all etnia, alla provenienza geografica, alla religione e allo status. 1. Facilitare all immigrato affetto da o a rischio di diabete l accesso al sistema sanitario su tutto il territorio nazionale attraverso servizi di mediazione linguistica. 2. Adattare ove possibile, i programmi di cura della persona con diabete alle usanze dettate dalle tradizioni culturali e religiose se non in contrasto con i diritti dell uomo e con i bisogni terapeutici. 3. Offrire corsi di educazione continua tenuti da gruppi multidisciplinari, supportati da personale anche delle associazioni di volontariato delle persone con diabete e loro familiari in grado di effettuare una comunicazione multilingue presso tutti gli ambienti di vita e di lavoro.
16 13. Territorio e diabete L analisi e il monitoraggio continuo dei dati sul diabete permettono di individuare strategie a breve, medio e lungo termine che possono determinare cambiamenti gestionali e contribuire a diffondere la cultura della prevenzione come strumento di riduzione dell incidenza del diabete sulla popolazione e dei costi sociali ed economici derivanti dalla cura delle sue complicanze. Attraverso studi specifici condotti a livello territoriale e nazionale è possibile comprendere le caratteristiche geografiche e culturali che possono determinare l insorgenza del diabete, aumentare la sensibilità socio-politica ed elevare e uniformare gli standard di trattamento su tutto il territorio nazionale per rispondere efficacemente ai bisogni di cura. 1. Favorire l attuazione del Piano Sanitario Nazionale per la Malattia Diabetica a livello regionale attraverso politiche di intervento specifiche. 2. Sostenere gli osservatori locali e nazionali sul diabete nella loro attività di raccolta e analisi dei dati, necessaria alla comprensione di tutti gli aspetti che causano l insorgenza del diabete e alla valutazione della qualità dell assistenza erogata. 3. Utilizzare le evidenze disponibili in campagne di sensibilizzazione al pubblico condivise e promosse in maniera congiunta dalle istituzioni, dalla sanità e dall associazionismo. 4. Garantire un organizzazione sanitaria integrata che contribuisca a modificare gli stili di vita correlati al rischio di diabete e di erogare in modo equo prestazioni di cura innovative. Diabete Italia Onlus c/o Legalitax Studio Legale e Tributario Via Flaminia, Roma C.F P.I segreteria@diabeteitalia.it
Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete
 17 Intergruppo parlamentare Qualità della vita e diabete Associazione Parlamentare per la prevenzione e la cura delle malattie croniche non trasmissibili e la sostenibilità del sistema sanitario Il Manifesto
17 Intergruppo parlamentare Qualità della vita e diabete Associazione Parlamentare per la prevenzione e la cura delle malattie croniche non trasmissibili e la sostenibilità del sistema sanitario Il Manifesto
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
 MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE Roma, 9 Luglio 2009 Indice lingue Italiano Inglese Francese Tedesco Spagnolo Portoghese Danese Cinese Arabo INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2.
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE Roma, 9 Luglio 2009 Indice lingue Italiano Inglese Francese Tedesco Spagnolo Portoghese Danese Cinese Arabo INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2.
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione Associazione Roma
 MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE Roma, 9 Luglio 2009 INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari 3. Educazione
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE Roma, 9 Luglio 2009 INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari 3. Educazione
Manifesto dei diritti della persona con diabete
 Organizzazione e gestione dell assistenza diabetologica A cura di Marco A. Comaschi Dipartimento di Emergenza e Accettazione Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova Nella Sala Stampa "Caduti
Organizzazione e gestione dell assistenza diabetologica A cura di Marco A. Comaschi Dipartimento di Emergenza e Accettazione Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova Nella Sala Stampa "Caduti
IL MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
 IL MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE LA PERSONA CON DIABETE QUALI DIRITTI? Giovedì 21 marzo 2013 AULA MAGNA OSPEDALE SANDRO PERTINI LINA DELLE MONACHE Vice-pesidente Cladiab Coordinamento
IL MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE LA PERSONA CON DIABETE QUALI DIRITTI? Giovedì 21 marzo 2013 AULA MAGNA OSPEDALE SANDRO PERTINI LINA DELLE MONACHE Vice-pesidente Cladiab Coordinamento
La filosofia del Piano Nazionale sul diabete (seconda parte) Scritto da P. Pisanti
 Il Piano Sanitario Nazionale sulla malattia diabetica, nel considerare i bisogni delle persone con diabete in età adulta e in età evolutiva, di quelli che assistono le persone con diabete, sanitari e non,
Il Piano Sanitario Nazionale sulla malattia diabetica, nel considerare i bisogni delle persone con diabete in età adulta e in età evolutiva, di quelli che assistono le persone con diabete, sanitari e non,
Michela Bragliani Servizio Assistenza Distrettuale Regione Emilia Romagna
 Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci in contesti extra familiari, educativi o scolastici, in Emilia Romagna Michela Bragliani Servizio Assistenza
Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci in contesti extra familiari, educativi o scolastici, in Emilia Romagna Michela Bragliani Servizio Assistenza
Nuovi modelli organizzativi in diabetologia. Scritto da Dr. M. Ragonese
 I sistemi sanitari di tutto il mondo si trovano oggi ad impegnare il 70-80% delle loro risorse nella cura delle malattie croniche. È una sfida importante: è infatti forte l impatto della malattia cronica
I sistemi sanitari di tutto il mondo si trovano oggi ad impegnare il 70-80% delle loro risorse nella cura delle malattie croniche. È una sfida importante: è infatti forte l impatto della malattia cronica
Allegato B al Decreto n. 162 del 20 OTT pag. 1/7
 giunta regionale Allegato B al Decreto n. 162 del 20 OTT. 2017 pag. 1/7 Progetto Farmacia dei Servizi: FARMACIEUNITE/ASSOFARM Formazione Residenziale Sessione 1: L evoluzione dell esigenza sanitaria: la
giunta regionale Allegato B al Decreto n. 162 del 20 OTT. 2017 pag. 1/7 Progetto Farmacia dei Servizi: FARMACIEUNITE/ASSOFARM Formazione Residenziale Sessione 1: L evoluzione dell esigenza sanitaria: la
I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA
 Roma, Istituto Superiore di Sanità, 17/11/2006 Il Diabete in Italia Aspetti Epidemiologici e Modelli Assistenziali I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA Roberto Sivieri Logica del Progetto (1/2)
Roma, Istituto Superiore di Sanità, 17/11/2006 Il Diabete in Italia Aspetti Epidemiologici e Modelli Assistenziali I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA Roberto Sivieri Logica del Progetto (1/2)
L assistenza al paziente diabetico nella Regione Lazio
 Graziano Santantonio L assistenza al paziente diabetico nella Regione Lazio U.O.S.D. Diabetologia P.O. San Paolo - Civitavecchia Il sottoscritto DR. GRAZIANO SANTANTONIO ai sensi dell art. 76 comma 4 dell
Graziano Santantonio L assistenza al paziente diabetico nella Regione Lazio U.O.S.D. Diabetologia P.O. San Paolo - Civitavecchia Il sottoscritto DR. GRAZIANO SANTANTONIO ai sensi dell art. 76 comma 4 dell
Ruolo del team diabetologico nella gestione integrata alla persona con diabete
 L assistenza integrata alla persona con diabete in FVG: applicazione del documento di indirizzo regionale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine Udine, 5 Aprile 2017 Ruolo del team diabetologico
L assistenza integrata alla persona con diabete in FVG: applicazione del documento di indirizzo regionale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine Udine, 5 Aprile 2017 Ruolo del team diabetologico
La situazione attuale
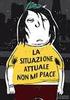 Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
PER MIGLIORARE L ASSISTENZA DIABETOLOGICA Cosa possono fare i professionisti sanitari Concetta Suraci Vice Presidente Diabete Italia
 PER MIGLIORARE L ASSISTENZA DIABETOLOGICA Cosa possono fare i professionisti sanitari Concetta Suraci Vice Presidente Diabete Italia La dott.ssa Concetta Suraci ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di
PER MIGLIORARE L ASSISTENZA DIABETOLOGICA Cosa possono fare i professionisti sanitari Concetta Suraci Vice Presidente Diabete Italia La dott.ssa Concetta Suraci ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di
La continuità assistenziale
 Le reti oncologiche regionali Presente, problematiche e prospettive future La continuità assistenziale Giuseppe Nastasi U.O.C. Oncologia Medica A.O. Bolognini - Seriate (BG) Camera dei Deputati - Palazzo
Le reti oncologiche regionali Presente, problematiche e prospettive future La continuità assistenziale Giuseppe Nastasi U.O.C. Oncologia Medica A.O. Bolognini - Seriate (BG) Camera dei Deputati - Palazzo
Piano Sanitario Nazionale Diabete ( )
 Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2013-2015) Aree di miglioramento
Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2013-2015) Aree di miglioramento
LA CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA CON OBESITÀ
 ANNO IX - SPECIALE 2019 LA CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA CON OBESITÀ Giuseppe Fatati (IO-NET), Roberto Pella (Intergruppo parlamentare Obesità e Diabete, ANCI), Iris Zani (Amici Obesi), Antonio
ANNO IX - SPECIALE 2019 LA CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA CON OBESITÀ Giuseppe Fatati (IO-NET), Roberto Pella (Intergruppo parlamentare Obesità e Diabete, ANCI), Iris Zani (Amici Obesi), Antonio
Valentina Solfrini Imma Cacciapuoti
 Valentina Solfrini Imma Cacciapuoti Il decisore? Più ruolo di sostegno al miglioramento della efficacia delle cure Le priorità di ricerca «sanitaria»? Fare ricerca per ridurre l incertezza su quali interventi,
Valentina Solfrini Imma Cacciapuoti Il decisore? Più ruolo di sostegno al miglioramento della efficacia delle cure Le priorità di ricerca «sanitaria»? Fare ricerca per ridurre l incertezza su quali interventi,
Servizio Sanitario REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA
 Servizio Sanitario REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 340 DEL 31/08/2017 OGGETTO: Autorizzazione implementazione Ambulatorio Infermieristico
Servizio Sanitario REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 340 DEL 31/08/2017 OGGETTO: Autorizzazione implementazione Ambulatorio Infermieristico
PRP Prevenzione e riduzione delle recidive dello Scompenso Cardiaco Cronico (SCC) secondario a patologie cronico-degenerative
 PRP 2010-2012 Prevenzione e riduzione delle recidive dello Scompenso Cardiaco Cronico (SCC) secondario a patologie cronico-degenerative Cagliari maggio 2011 Premessa Obiettivo: Prevenzione e riduzione
PRP 2010-2012 Prevenzione e riduzione delle recidive dello Scompenso Cardiaco Cronico (SCC) secondario a patologie cronico-degenerative Cagliari maggio 2011 Premessa Obiettivo: Prevenzione e riduzione
Dimensioni del problema, criticità, costi. Modelli organizzativi gestionali
 Rosario Iannacchero Dimensioni del problema, criticità, costi Modelli organizzativi gestionali Patologia molto frequente nella popolazione generale Solo emicrania: prevalenza media annua stimata negli
Rosario Iannacchero Dimensioni del problema, criticità, costi Modelli organizzativi gestionali Patologia molto frequente nella popolazione generale Solo emicrania: prevalenza media annua stimata negli
I tavoli di lavoro regionali sulla malattia diabetica in età pediatrica
 I tavoli di lavoro regionali sulla malattia diabetica in età pediatrica Giovanni Chiari Dirigente medico Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica Margherita Borri Cocconcelli Azienda
I tavoli di lavoro regionali sulla malattia diabetica in età pediatrica Giovanni Chiari Dirigente medico Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica Margherita Borri Cocconcelli Azienda
I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO. Dott.G.GIORDANO
 I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO Dott.G.GIORDANO PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE SUPERAMENTO DI UNA ASSISTENZA A COMPARTIMENTI STAGNI VISIONE SISTEMICA DELL ASSISTENZA FONDAMENTALE NELLE PATOLOGIE
I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO Dott.G.GIORDANO PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE SUPERAMENTO DI UNA ASSISTENZA A COMPARTIMENTI STAGNI VISIONE SISTEMICA DELL ASSISTENZA FONDAMENTALE NELLE PATOLOGIE
Dott.Patrizia Ruggeri. 1 Febbraio 2017
 Dott.Patrizia Ruggeri 1 Febbraio 2017 MEDICI DIABETOLOGI DIABETE MALATTIA CRONICA CHRONIC CARE MODEL Centralità della Persona Gestione Integrata Passare dalla cura al prendersi cura significa superare
Dott.Patrizia Ruggeri 1 Febbraio 2017 MEDICI DIABETOLOGI DIABETE MALATTIA CRONICA CHRONIC CARE MODEL Centralità della Persona Gestione Integrata Passare dalla cura al prendersi cura significa superare
ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e in accordo con il Codice Etico della SIMI dichiara
 Il sottoscritto ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e in accordo con il Codice Etico della SIMI dichiara per l evento in oggetto l esistenza negli ultimi due anni
Il sottoscritto ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e in accordo con il Codice Etico della SIMI dichiara per l evento in oggetto l esistenza negli ultimi due anni
Dott. Stefano Zucchini
 L organizzazione dei centri diabetologici pediatrici regionali Giornata Nazionale della Diabesità Promossa dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Dott. Stefano Zucchini Centro
L organizzazione dei centri diabetologici pediatrici regionali Giornata Nazionale della Diabesità Promossa dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Dott. Stefano Zucchini Centro
DOCUMENTO D INTESA SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI E PERSONE IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE SOCIALE IN TRENTINO
 Società Italiana di Medicina delle Migrazioni DOCUMENTO D INTESA SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI E PERSONE IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE SOCIALE IN TRENTINO Gruppo Immigrazione Salute GR.I.S. Trentino 1
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni DOCUMENTO D INTESA SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI E PERSONE IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE SOCIALE IN TRENTINO Gruppo Immigrazione Salute GR.I.S. Trentino 1
IX Giornata mondiale della BPCO
 IX Giornata mondiale della BPCO V Conferenza Nazionale BPCO ROMA 17 Novembre 2010 La Programmazione Sanitaria e la BPCO Dr. Paola Pisanti Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione
IX Giornata mondiale della BPCO V Conferenza Nazionale BPCO ROMA 17 Novembre 2010 La Programmazione Sanitaria e la BPCO Dr. Paola Pisanti Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE E CURA DEL DIABETE MELLITO
 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 2015, N. 190 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 2015, N. 190 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE
Una testimonianza ROMA, 18 NOVEMBRE 2017 SESSIONI NURSING AND TECHNICAL I SESSIONE FOCUS SUL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO: CURARE E PRENDERSI CURA
 Una testimonianza ROMA, 18 NOVEMBRE 2017 SESSIONI NURSING AND TECHNICAL I SESSIONE FOCUS SUL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO: CURARE E PRENDERSI CURA Gli Associati Il Presidente Una testimonianza La Segreteria
Una testimonianza ROMA, 18 NOVEMBRE 2017 SESSIONI NURSING AND TECHNICAL I SESSIONE FOCUS SUL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO: CURARE E PRENDERSI CURA Gli Associati Il Presidente Una testimonianza La Segreteria
GLI ATTORI DEL SISTEMA DAI COMPITI AI RUOLI ALBINO BOTTAZZO
 GLI ATTORI DEL SISTEMA DAI COMPITI AI RUOLI! ALBINO BOTTAZZO Introduzione La salute del paziente Cura della malattia Cura della persona Nel 1946 con l atto di Costituzione dell OMS (Organizzazione Mondiale
GLI ATTORI DEL SISTEMA DAI COMPITI AI RUOLI! ALBINO BOTTAZZO Introduzione La salute del paziente Cura della malattia Cura della persona Nel 1946 con l atto di Costituzione dell OMS (Organizzazione Mondiale
Presentazione del Protocollo di intesa per la valorizzazione dei farmacisti e delle farmacie territoriali nell educazione terapeutica
 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITA SPERIMENTALI E MALATTIE RARE U.O. Comunicazione viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030/3838315 Fax 030/3838280 E-mail: comunicazione@aslbrescia.it CONFERENZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITA SPERIMENTALI E MALATTIE RARE U.O. Comunicazione viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030/3838315 Fax 030/3838280 E-mail: comunicazione@aslbrescia.it CONFERENZA
Indagine conoscitiva sul diabete in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale e alle connessioni con le malattie non trasmissibili
 Indagine conoscitiva sul diabete in rapporto al ervizio anitario Nazionale e alle connessioni con le malattie non trasmissibili XII Commissione Igiene e anità enato della Repubblica Otegno70 insieme ai
Indagine conoscitiva sul diabete in rapporto al ervizio anitario Nazionale e alle connessioni con le malattie non trasmissibili XII Commissione Igiene e anità enato della Repubblica Otegno70 insieme ai
Un nuovo ruolo per il farmacista: la «Pharmaceutical Care»
 Un nuovo ruolo per il farmacista: la «Pharmaceutical Care» A livello mondiale si sta diffondendo la consapevolezza che il ruolo del farmacista di comunità debba evolvere, indirizzandosi verso l erogazione
Un nuovo ruolo per il farmacista: la «Pharmaceutical Care» A livello mondiale si sta diffondendo la consapevolezza che il ruolo del farmacista di comunità debba evolvere, indirizzandosi verso l erogazione
L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo
 L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo Rosangela Ghidelli Coordinatore Infermieristico Caposala U.O. S. Diabetologia e Endocrinologia Azienda Ospedaliera S. Anna Como Presidio
L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo Rosangela Ghidelli Coordinatore Infermieristico Caposala U.O. S. Diabetologia e Endocrinologia Azienda Ospedaliera S. Anna Como Presidio
Specificità del diabete tipo 1 in età evolutiva
 Specificità del diabete tipo 1 in età evolutiva Bassa frequenza della patologia : se in Lombardia ci sono circa 2500 soggetti con diabete al di sotto dei 14-18 anni ciascuno dei circa 1200 Pediatri di
Specificità del diabete tipo 1 in età evolutiva Bassa frequenza della patologia : se in Lombardia ci sono circa 2500 soggetti con diabete al di sotto dei 14-18 anni ciascuno dei circa 1200 Pediatri di
SCHEDA DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO IN AMBITO CLINICO
 Università degli Studi di Torino di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Dipartimento Area Materno Infantile Incidenti Malattie cardiovascolari Malattie cerebrovascolari Malattia diabetica Malattie
Università degli Studi di Torino di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Dipartimento Area Materno Infantile Incidenti Malattie cardiovascolari Malattie cerebrovascolari Malattia diabetica Malattie
PERCORSO INTEGRATO TERRITORIO-OSPEDALE Roviano - 6 giugno La cura per le persone con malattie croniche. Il Progetto IGEA
 PERCORSO INTEGRATO TERRITORIO-OSPEDALE Roviano - 6 giugno 2011 La cura per le persone con malattie croniche Il Progetto IGEA Marina Responsabile Progetto IGEA Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
PERCORSO INTEGRATO TERRITORIO-OSPEDALE Roviano - 6 giugno 2011 La cura per le persone con malattie croniche Il Progetto IGEA Marina Responsabile Progetto IGEA Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
PDTA Diabete RUOLO DELLA STRUTTURA DIABETOLOGICA TERRITORIALE. Cona, 30 Settembre 2017
 PDTA Diabete RUOLO DELLA STRUTTURA DIABETOLOGICA TERRITORIALE Roberto Graziani Cona, 30 Settembre 2017 Il Diabete a Ferrara Ad oggi sono presenti nella Provincia di Ferrara 28.000 pazienti affetti da Diabete
PDTA Diabete RUOLO DELLA STRUTTURA DIABETOLOGICA TERRITORIALE Roberto Graziani Cona, 30 Settembre 2017 Il Diabete a Ferrara Ad oggi sono presenti nella Provincia di Ferrara 28.000 pazienti affetti da Diabete
Il giovane con diabete tra l adolescenza e l età adulta : la transizione. Il punto di vista del pediatra
 Il giovane con diabete tra l adolescenza e l età adulta : la transizione. Il punto di vista del pediatra Renata Lorini Bologna 2-3 maggio 2013 DIABETOLOGIA PEDIATRICA IL TEAM MEDICI STRUTTURATI PSICOLOGHE
Il giovane con diabete tra l adolescenza e l età adulta : la transizione. Il punto di vista del pediatra Renata Lorini Bologna 2-3 maggio 2013 DIABETOLOGIA PEDIATRICA IL TEAM MEDICI STRUTTURATI PSICOLOGHE
Carta dei diritti della persona. Con malattia renale
 Carta dei diritti della persona Con malattia renale Io, per il mio semplice essere persona, ho diritto al raggiungimento del miglior livello di qualità di vita possibile compatibilmente con le mie condizioni
Carta dei diritti della persona Con malattia renale Io, per il mio semplice essere persona, ho diritto al raggiungimento del miglior livello di qualità di vita possibile compatibilmente con le mie condizioni
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1073
 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1073 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice ZANONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2013 Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1073 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice ZANONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2013 Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia. Art. 1. Disposizioni preliminari
 Legge regionale 27 giugno 1990, n. 28 Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia. Art. 1 Disposizioni preliminari 1. Le funzioni e le attività
Legge regionale 27 giugno 1990, n. 28 Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia. Art. 1 Disposizioni preliminari 1. Le funzioni e le attività
(Lista di controllo SPEC. AMB.) cognome nome
 Dichiarazione del possesso dei requisiti ulteriori di qualità generali e specifici previsti per l accreditamento REQUISITI delle STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE
Dichiarazione del possesso dei requisiti ulteriori di qualità generali e specifici previsti per l accreditamento REQUISITI delle STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE
Valutazione psicosociale della malattia diabetica: stato dell arte, criticità e prospettive Dr. Stefano Bartoli Azienda Ospedaliera Universitaria
 Valutazione psicosociale della malattia diabetica: stato dell arte, criticità e prospettive Dr. Stefano Bartoli Azienda Ospedaliera Universitaria "S.Maria" di Terni 2016 GIUGNO SETTEMBRE DICEMBRE Secondo
Valutazione psicosociale della malattia diabetica: stato dell arte, criticità e prospettive Dr. Stefano Bartoli Azienda Ospedaliera Universitaria "S.Maria" di Terni 2016 GIUGNO SETTEMBRE DICEMBRE Secondo
DATO ATTO che la legge regionale di istituzione di A.Li.Sa., 29 luglio 2016, n. 17, prevede tra le
 VISTI La Legge 115/1987 che detta disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito e che stabilisce in particolare all articolo 3 comma 1 che omissis le regioni, tramite le unità sanitarie
VISTI La Legge 115/1987 che detta disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito e che stabilisce in particolare all articolo 3 comma 1 che omissis le regioni, tramite le unità sanitarie
Introduzione. diseases: a vital investment. Questo documento descrive i progetti e gli
 Introduzione L Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), parlando di diabete, lancia un grido di allarme poiché si assiste ad una vera e propria epidemia 1 che colpisce milioni di persone in tutto il
Introduzione L Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), parlando di diabete, lancia un grido di allarme poiché si assiste ad una vera e propria epidemia 1 che colpisce milioni di persone in tutto il
Consiglio Regionale della Puglia
 LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2014, N. 40 Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi 2 LEGGE REGIONALE Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi Il Consiglio regionale
LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2014, N. 40 Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi 2 LEGGE REGIONALE Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi Il Consiglio regionale
L'accoglienza del giovane diabetico nell'ambulatorio dell'adulto: tra adolescenza ed età adulta. Presentazione del percorso formativo
 L'accoglienza del giovane diabetico nell'ambulatorio dell'adulto: tra adolescenza ed età adulta Corso Formazione Formatori Bologna, 2-3 maggio 2013 Presentazione del percorso formativo Luigi Gentile Direttore
L'accoglienza del giovane diabetico nell'ambulatorio dell'adulto: tra adolescenza ed età adulta Corso Formazione Formatori Bologna, 2-3 maggio 2013 Presentazione del percorso formativo Luigi Gentile Direttore
IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE: LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE E IL COORDINAMENTO DEGLI SPECIALISTI
 1 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE: LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE E IL COORDINAMENTO DEGLI SPECIALISTI 2 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LA FAMIGLIA ANALIZZARE
1 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE: LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE E IL COORDINAMENTO DEGLI SPECIALISTI 2 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LA FAMIGLIA ANALIZZARE
METODICHE DIDATTICHE
 Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Pediatria C.L. Triennale Infermieristica Pediatrica A.A.2007/2008 CORSO INTEGRATO SCIENZE UMANE PSICOPEDAGOGICHE METODICHE
Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Pediatria C.L. Triennale Infermieristica Pediatrica A.A.2007/2008 CORSO INTEGRATO SCIENZE UMANE PSICOPEDAGOGICHE METODICHE
STUDENTE. Contratto di Apprendimento Clinico. Stage I II III R
 1 STUDENTE Università degli Studi di Torino Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Corso di Laurea in Infermieristica Sede di Asti Anno
1 STUDENTE Università degli Studi di Torino Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Corso di Laurea in Infermieristica Sede di Asti Anno
LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 85
 LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 85 Norme di attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito. BURA N. 24 DEL 9.10.1998 Art. 1 Obiettivi
LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 85 Norme di attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito. BURA N. 24 DEL 9.10.1998 Art. 1 Obiettivi
LA NUOVA COMMITTENZA: COME INTEGRARE LE STRUTTURE SANITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO RUOLO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
 LA NUOVA COMMITTENZA: COME INTEGRARE LE STRUTTURE SANITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO RUOLO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI MARIA LUISA AGNENI RESP BRANCA PNEUMOLOGIA ASL ROMA1 OSPEDALE TERRITORIO ABBATTERE
LA NUOVA COMMITTENZA: COME INTEGRARE LE STRUTTURE SANITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO RUOLO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI MARIA LUISA AGNENI RESP BRANCA PNEUMOLOGIA ASL ROMA1 OSPEDALE TERRITORIO ABBATTERE
DELIBERA N 1051 DEL 24/7/2006 LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2006
 DELIBERA N 1051 DEL 24/7/2006 LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2006 Assessorato Politiche per la Salute Allegato B LINEE DI PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI
DELIBERA N 1051 DEL 24/7/2006 LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2006 Assessorato Politiche per la Salute Allegato B LINEE DI PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI
L'Assistenza integrata alla persona con diabete in FVG: applicazione del documento di indirizzo regionale.
 L'Assistenza integrata alla persona con diabete in FVG: applicazione del documento di indirizzo regionale. La gestione della cronicità richiede la co-partecipazione di professionalità diverse e complementari,
L'Assistenza integrata alla persona con diabete in FVG: applicazione del documento di indirizzo regionale. La gestione della cronicità richiede la co-partecipazione di professionalità diverse e complementari,
Dall attività motoria. alla prescrizione dell esercizio fisico per la salute. Dall attività motoria. alla prescrizione. salute.
 Dall attività motoria alla prescrizione dell esercizio fisico per la salute Dall attività motoria alla prescrizione Il ruolo dell esercizio della promozione fisico della salute La salute: un bene multidimensionale
Dall attività motoria alla prescrizione dell esercizio fisico per la salute Dall attività motoria alla prescrizione Il ruolo dell esercizio della promozione fisico della salute La salute: un bene multidimensionale
LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON BPCO IN EMILIA-ROMAGNA
 MALATTIE RESPIRATORIE LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON BPCO IN EMILIA-ROMAGNA Anna Baldini Punti di forza e prospettive di miglioramento nella presa in carico del paziente affetto da BPCO 1 / 3 Cittadinanzattiva
MALATTIE RESPIRATORIE LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON BPCO IN EMILIA-ROMAGNA Anna Baldini Punti di forza e prospettive di miglioramento nella presa in carico del paziente affetto da BPCO 1 / 3 Cittadinanzattiva
Il Sistema informativo: Quali soluzioni per l Abruzzo
 REGIONE ABRUZZO ASSESSORATO ALLA SANITA III Convegno PREVENIRE LE COMPLICANZE DEL DIABETE: DALLA RICERCA DI BASE ALL ASSISTENZA ROMA 16 FEBBRAIO 2009 Il Sistema informativo: Quali soluzioni per l Abruzzo
REGIONE ABRUZZO ASSESSORATO ALLA SANITA III Convegno PREVENIRE LE COMPLICANZE DEL DIABETE: DALLA RICERCA DI BASE ALL ASSISTENZA ROMA 16 FEBBRAIO 2009 Il Sistema informativo: Quali soluzioni per l Abruzzo
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per la prevenzione e lotta contro l AIDS
 Allegato alla Delib.G.R. n. 49/15 del 7.12.2011 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per la prevenzione e lotta contro l AIDS 1. Scenario normativo Nell ambito del piano degli interventi
Allegato alla Delib.G.R. n. 49/15 del 7.12.2011 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per la prevenzione e lotta contro l AIDS 1. Scenario normativo Nell ambito del piano degli interventi
Firenze, 12 ottobre 2013
 Firenze, 12 ottobre 2013 Firenze, 12 ottobre 2013 Firenze, 12 ottobre 2013 9 ottobre 2013 L'accoglienza del giovane diabetico nell'ambulatorio dell'adulto: tra adolescenza ed età adulta" Corso formazione
Firenze, 12 ottobre 2013 Firenze, 12 ottobre 2013 Firenze, 12 ottobre 2013 9 ottobre 2013 L'accoglienza del giovane diabetico nell'ambulatorio dell'adulto: tra adolescenza ed età adulta" Corso formazione
PROTOCOLLO D INTESA tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità
 TITOLO: Protocollo d intesa tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione congiunta
TITOLO: Protocollo d intesa tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione congiunta
Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale Accordo Stato Regione del 26/10/2017 CSR/181
 Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale Accordo Stato Regione del 26/10/2017 CSR/181 Regione Proponente Sicilia Linea progettuale Titolo del Progetto Durata del Progetto Linea 5. Gestione della
Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale Accordo Stato Regione del 26/10/2017 CSR/181 Regione Proponente Sicilia Linea progettuale Titolo del Progetto Durata del Progetto Linea 5. Gestione della
Il ginecologo e gli altri operatori del territorio nella salute perinatale. Lavoro di équipe e competenze specifiche
 Il ginecologo e gli altri operatori del territorio nella salute perinatale. Lavoro di équipe e competenze specifiche "La tutela della salute in ambito materno-infantile costituisce un impegno di valenza
Il ginecologo e gli altri operatori del territorio nella salute perinatale. Lavoro di équipe e competenze specifiche "La tutela della salute in ambito materno-infantile costituisce un impegno di valenza
QUALE RUOLO, RESPONSABILITA ED ATTIVITA DEVE AVERE UNA RETE ONCOLOGICA REGIONALE PER GARANTIRE LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
 QUALE RUOLO, RESPONSABILITA ED ATTIVITA DEVE AVERE UNA RETE ONCOLOGICA REGIONALE PER GARANTIRE LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO Dott. Rocco GUERRA Medico in formazione Specialistica Igiene e
QUALE RUOLO, RESPONSABILITA ED ATTIVITA DEVE AVERE UNA RETE ONCOLOGICA REGIONALE PER GARANTIRE LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO Dott. Rocco GUERRA Medico in formazione Specialistica Igiene e
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3119
 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI, ANDRIA e COSTA COMUNICATO ALLA
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI, ANDRIA e COSTA COMUNICATO ALLA
C.P.S.E. L. Sasso C.P.S.I. B. Lomello. S.C. Cardiologia Rivoli
 C.P.S.E. L. Sasso C.P.S.I. B. Lomello S.C. Cardiologia Rivoli L EPIDEMIA DEL MILLENNIO COS E LO SCOMPENSO CARDIACO E un deficit della funzione di pompa del cuore con incapacità di assicurare una adeguata
C.P.S.E. L. Sasso C.P.S.I. B. Lomello S.C. Cardiologia Rivoli L EPIDEMIA DEL MILLENNIO COS E LO SCOMPENSO CARDIACO E un deficit della funzione di pompa del cuore con incapacità di assicurare una adeguata
Dott. T. Spinosa S.O. Analisi e Monitoraggio
 Dott. T. Spinosa S.O. Analisi e Monitoraggio Identificazione della realtà territoriale di attuazione del progetto Il progetto sta monitorando 5 ASL pilota della Regione Campania: A.S.L. NA centro; A.S.L.
Dott. T. Spinosa S.O. Analisi e Monitoraggio Identificazione della realtà territoriale di attuazione del progetto Il progetto sta monitorando 5 ASL pilota della Regione Campania: A.S.L. NA centro; A.S.L.
L assistenza diabetologica nella ASL di Viterbo. Claudia Arnaldi Centro Diabetologico Aziendale ASL Viterbo
 L assistenza diabetologica nella ASL di Viterbo Claudia Arnaldi Centro Diabetologico Aziendale ASL Viterbo LA DIABETOLOGIA NELLA ASL DI VITERBO FINO AL 12 APRILE 2010 AMBULATORI DI ACQUAPENDENTE CIVITA
L assistenza diabetologica nella ASL di Viterbo Claudia Arnaldi Centro Diabetologico Aziendale ASL Viterbo LA DIABETOLOGIA NELLA ASL DI VITERBO FINO AL 12 APRILE 2010 AMBULATORI DI ACQUAPENDENTE CIVITA
obiettivi di miglioramento: AREA PREVENZIONE
 DPCS 2012 Il documento di programmazione sottolinea in particolare le aree e gli obiettivi di miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento riferiti al Cittadino, sono stati costruiti con riferimento alla
DPCS 2012 Il documento di programmazione sottolinea in particolare le aree e gli obiettivi di miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento riferiti al Cittadino, sono stati costruiti con riferimento alla
Caso clinico: Degenza Riabilitativa: «training fisico e non solo»
 Caso clinico: Degenza Riabilitativa: «training fisico e non solo» Uomo 64 anni Diabetico NID Obeso Cardiopatia ischemica Ipertensione arteriosa Ipercolesterolemia Sindrome delle apnee ostruttive notturne
Caso clinico: Degenza Riabilitativa: «training fisico e non solo» Uomo 64 anni Diabetico NID Obeso Cardiopatia ischemica Ipertensione arteriosa Ipercolesterolemia Sindrome delle apnee ostruttive notturne
LA PERCEZIONE DEL PAZIENTE
 LA RETE ONCOLOGICA LAZIALE PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ LA PERCEZIONE DEL PAZIENTE Francesco De Lorenzo F.A.V.O. La rete Oncologica Laziale Roma, 2 dicembre 2010 F.A.V.O. F.A.V.O. F.A.V.O. F.A.V.O. F.A.V.O.
LA RETE ONCOLOGICA LAZIALE PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ LA PERCEZIONE DEL PAZIENTE Francesco De Lorenzo F.A.V.O. La rete Oncologica Laziale Roma, 2 dicembre 2010 F.A.V.O. F.A.V.O. F.A.V.O. F.A.V.O. F.A.V.O.
PROGETTO INTERATENEO DIABETE E FARMACIA
 PROGETTO INTERATENEO DIABETE E FARMACIA Con il patrocinio di: FOFI Università degli Studi di Torino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino Federfarma Piemonte MATERIALE DIDATTICO REALIZZATO DA
PROGETTO INTERATENEO DIABETE E FARMACIA Con il patrocinio di: FOFI Università degli Studi di Torino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino Federfarma Piemonte MATERIALE DIDATTICO REALIZZATO DA
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita
 Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
un gruppo permanente interassociativo ligure per l engagement della persona con diabete tipo 1 Oltre le quattro dita
 PROGETTO FORMATIVO PER OPERATORI SANITARI E PERSONE CON DIABETE TIPO 1 2018-2019: campi scuola per coppie (pazienti con diabete tipo 1 e rispettivi compagni) Per una gestione corretta ed efficace del DM1
PROGETTO FORMATIVO PER OPERATORI SANITARI E PERSONE CON DIABETE TIPO 1 2018-2019: campi scuola per coppie (pazienti con diabete tipo 1 e rispettivi compagni) Per una gestione corretta ed efficace del DM1
XVIII Congresso Nazionale AMD Rossano Calabro 27/05/2011. Le diverse dimensioni del controllo glicemico
 XVIII Congresso Nazionale AMD Rossano Calabro 27/05/2011 Le diverse dimensioni del controllo glicemico Scopo dell Automonitoraggio Ottenere e mantenere il controllo glicemico Prevenire episodi di ipoglicemia
XVIII Congresso Nazionale AMD Rossano Calabro 27/05/2011 Le diverse dimensioni del controllo glicemico Scopo dell Automonitoraggio Ottenere e mantenere il controllo glicemico Prevenire episodi di ipoglicemia
Dott.ssa Cristina Patrizi Medico di Medicina Generale ASL RMC Roma U.O.CAD ASL RMB Roma U.O. Medicina Legale ASL RMB Roma Segretario Generale Siameg
 Dott.ssa Cristina Patrizi Medico di Medicina Generale ASL RMC Roma U.O.CAD ASL RMB Roma U.O. Medicina Legale ASL RMB Roma Segretario Generale Siameg S.I.A.ME.G. Società Italiana per l'aggiornamento del
Dott.ssa Cristina Patrizi Medico di Medicina Generale ASL RMC Roma U.O.CAD ASL RMB Roma U.O. Medicina Legale ASL RMB Roma Segretario Generale Siameg S.I.A.ME.G. Società Italiana per l'aggiornamento del
LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO CON DIABETE MELLITO. Giovedì, 24 maggio 2018
 con il Patrocinio Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO CON DIABETE MELLITO Giovedì, 24 maggio 2018 LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
con il Patrocinio Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO CON DIABETE MELLITO Giovedì, 24 maggio 2018 LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Stili di vita. Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte
 Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte Villa Gualino, Torino, 9 dicembre 2009 Modo di vivere fondato su modelli comportamentali riconoscibili, determinati a loro volta dall interazione
Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte Villa Gualino, Torino, 9 dicembre 2009 Modo di vivere fondato su modelli comportamentali riconoscibili, determinati a loro volta dall interazione
Cittadinanzattiva Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici. X Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità
 Cittadinanzattiva Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici X Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità Minori: diritti rari, costi cronici Audizione Commissione Igiene e Sanità
Cittadinanzattiva Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici X Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità Minori: diritti rari, costi cronici Audizione Commissione Igiene e Sanità
dall adolescenza all età adulta: un modello per i servizi di Salute Mentale
 Conferenza annuale per la salute mentale : un modello per i servizi di Salute Mentale Venerdì 22 Maggio 2009 Teatro della ASL di Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 1 2 IDENTIFICAZIONE E IMPOSTAZIONE DEL
Conferenza annuale per la salute mentale : un modello per i servizi di Salute Mentale Venerdì 22 Maggio 2009 Teatro della ASL di Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 1 2 IDENTIFICAZIONE E IMPOSTAZIONE DEL
WORKSHOP INTERNAZIONALE 17Gennaio 2015 Integrare gli interventi sulla demenza. Esperienze a confronto Centro Congressi Città Studi, Corso Giuseppe
 WORKSHOP INTERNAZIONALE 17Gennaio 2015 Integrare gli interventi sulla demenza. Esperienze a confronto Centro Congressi Città Studi, Corso Giuseppe Pella IL PIANO NAZIONALE DEMENZE Strategie per la promozione
WORKSHOP INTERNAZIONALE 17Gennaio 2015 Integrare gli interventi sulla demenza. Esperienze a confronto Centro Congressi Città Studi, Corso Giuseppe Pella IL PIANO NAZIONALE DEMENZE Strategie per la promozione
Progetto regionale MISURE AFFERENTI ALLA DIAGNOSI, CURA E ASSISTENZA DELLA SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM. Regione Emilia-Romagna
 Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM Progetto regionale MISURE AFFERENTI ALLA DIAGNOSI, CURA E ASSISTENZA DELLA SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM Silvana Borsari
Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM Progetto regionale MISURE AFFERENTI ALLA DIAGNOSI, CURA E ASSISTENZA DELLA SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM Silvana Borsari
Innovazione organizzativa e tecnologica per la gestione del diabete: ti prescrivo un APP
 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento CONVEGNO CARD TRIVENETO LE CURE DOMICILIARI E RESIDENZIALI AD ALTA COMPLESSITÀ Innovazione organizzativa e tecnologica per la gestione
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento CONVEGNO CARD TRIVENETO LE CURE DOMICILIARI E RESIDENZIALI AD ALTA COMPLESSITÀ Innovazione organizzativa e tecnologica per la gestione
Cagliari, 16/10/2015 Dr EMILIO MONTALDO
 Cagliari, 16/10/2015 Dr EMILIO MONTALDO - FAMIGLIA - CAREGIVER D - - - - - MEDICO DISTRETTO MEDICO SPECIALISTA INFERMIERE PRESIDI ASSISTENTE SOCIALE M P ON OS Quali i ruoli del Medico di Medicina Generale?
Cagliari, 16/10/2015 Dr EMILIO MONTALDO - FAMIGLIA - CAREGIVER D - - - - - MEDICO DISTRETTO MEDICO SPECIALISTA INFERMIERE PRESIDI ASSISTENTE SOCIALE M P ON OS Quali i ruoli del Medico di Medicina Generale?
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del
 36646 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1034 Accordo Stato Regioni del 30/10/2014 Accordo, ai sensi dell art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni
36646 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1034 Accordo Stato Regioni del 30/10/2014 Accordo, ai sensi dell art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni
Dalla diagnosi, alla terapia, attraverso tutte le fasi dell assistenza si snoda un vero e proprio percorso che il paziente segue insieme ai
 Franca Savia Coordinatore Infermieristico SOC Oncologia ASL VCO Torino 21 Maggio 2015 1 2 Dalla diagnosi, alla terapia, attraverso tutte le fasi dell assistenza si snoda un vero e proprio percorso che
Franca Savia Coordinatore Infermieristico SOC Oncologia ASL VCO Torino 21 Maggio 2015 1 2 Dalla diagnosi, alla terapia, attraverso tutte le fasi dell assistenza si snoda un vero e proprio percorso che
1.2 - Prevenzione Attiva delle Complicanze del Diabete Tipo 2. Torino, 03/02/2008
 Torino, 03/02/2008 Al Direttore Operativo del CCM Regione: Piemonte Titolo del progetto: Prevenzione attiva delle complicanze del diabete tipo 2 (Gestione integrata del diabete tipo 2) Referente: Dr. Roberto
Torino, 03/02/2008 Al Direttore Operativo del CCM Regione: Piemonte Titolo del progetto: Prevenzione attiva delle complicanze del diabete tipo 2 (Gestione integrata del diabete tipo 2) Referente: Dr. Roberto
Proposta della Fimmg E.R. per la gestione della cronicità nella Regione Emilia Romagna
 Proposta della Fimmg E.R. per la gestione della cronicità nella Regione Emilia Romagna Proposta per la gestione della cronicità in Emilia Romagna Il Piano Nazionale della Cronicità identifica le cure primarie
Proposta della Fimmg E.R. per la gestione della cronicità nella Regione Emilia Romagna Proposta per la gestione della cronicità in Emilia Romagna Il Piano Nazionale della Cronicità identifica le cure primarie
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE
 11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE La legge 38 del 2010 La rete delle cure palliative Il CeAD Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE La legge 38 del 2010 La rete delle cure palliative Il CeAD Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010
IL FARMACISTA E IL PDTA NELLA CONTINUITA ASSISTENZIALE. UOC Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale D.ssa Emma Giordani 16/11/2015
 IL FARMACISTA E IL PDTA NELLA CONTINUITA ASSISTENZIALE UOC Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale D.ssa Emma Giordani 16/11/2015 PDTA come li definisce la normativa 1996 legge finanziaria art.1 comma
IL FARMACISTA E IL PDTA NELLA CONTINUITA ASSISTENZIALE UOC Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale D.ssa Emma Giordani 16/11/2015 PDTA come li definisce la normativa 1996 legge finanziaria art.1 comma
Focus Diabete Proposte per una migliore presa in carico sul territorio del paziente diabetico anziano alla luce del nuovo meccanismo prescrittivo
 LONG-TERM CARE THREE Edizione 2018 degli Stati Generali dell Assistenza a lungo termine Focus Diabete Proposte per una migliore presa in carico sul territorio del paziente diabetico anziano alla luce del
LONG-TERM CARE THREE Edizione 2018 degli Stati Generali dell Assistenza a lungo termine Focus Diabete Proposte per una migliore presa in carico sul territorio del paziente diabetico anziano alla luce del
Rosanna D Antona Presidente Europa Donna Italia
 Rosanna D Antona Presidente Europa Donna Italia EUROPA DONNA Coalizione Europea di lobby per la prevenzione e la cura del tumore al seno presso le Istituzioni pubbliche nazionali e internazionali. 1994
Rosanna D Antona Presidente Europa Donna Italia EUROPA DONNA Coalizione Europea di lobby per la prevenzione e la cura del tumore al seno presso le Istituzioni pubbliche nazionali e internazionali. 1994
Bambini fino in fondo!? Nascere e crescere con disabilità in Lombardia
 Bambini fino in fondo!? Nascere e crescere con disabilità in Lombardia LA PARTECIPAZIONE DI ANFFAS AL GRUPPO DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA
Bambini fino in fondo!? Nascere e crescere con disabilità in Lombardia LA PARTECIPAZIONE DI ANFFAS AL GRUPPO DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA
La relazione terapeutica col paziente sovrappesoobeso: la relazione terapeutica classica vs l approccio integrato
 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico 27100 PAVIA Viale Golgi, 19 La relazione terapeutica col paziente sovrappesoobeso: la
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico 27100 PAVIA Viale Golgi, 19 La relazione terapeutica col paziente sovrappesoobeso: la
Dalla prevenzione alla promozione della salute
 Dalla prevenzione alla promozione della salute La promozione della Salute in Lombardia: il Piano Regionale Prevenzione 2015 2018 ed i Piani Integrati Locali degli interventi di promozione della salute
Dalla prevenzione alla promozione della salute La promozione della Salute in Lombardia: il Piano Regionale Prevenzione 2015 2018 ed i Piani Integrati Locali degli interventi di promozione della salute
La storia dell'oral care in AMD D.Mannino Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino Morelli Reggio Calabria
 La storia dell'oral care in AMD D.Mannino Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino Morelli Reggio Calabria Ai sensi dell art. 3.3 del Regolamento applicativo dell Accordo Stato-Regioni 05.11.2009,
La storia dell'oral care in AMD D.Mannino Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino Morelli Reggio Calabria Ai sensi dell art. 3.3 del Regolamento applicativo dell Accordo Stato-Regioni 05.11.2009,
