IL MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
|
|
|
- Ernesto Valli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE LA PERSONA CON DIABETE QUALI DIRITTI? Giovedì 21 marzo 2013 AULA MAGNA OSPEDALE SANDRO PERTINI LINA DELLE MONACHE Vice-pesidente Cladiab Coordinamento Lazio Associazioni persone con diabete
2 Ponte tra passato e futuro un ideale ponte, un continuum storico, sociale e culturale che ha saputo elaborare e sviluppare il modello di assistenza sociosanitaria alla persona con diabete sancita dal legislatore della legge del 16 marzo 1987 n. 115, per inserirlo in un Sistema Sanitario integrato tra operatori sanitari, persone con diabete e loro familiari, associazioni e società in sinergica collaborazione. un documento condiviso da tutte le Associazioni dei Pazienti diabetici e validato da Cittadinanzattiva O.N.L.U.S. e CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario. un impegno istituzionale ufficiale, sottoscritto il 9 luglio 2009, dall Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione e da Diabete Italia.
3 un approccio condiviso per avviare conseguenti processi di miglioramento della qualità dell assistenza e quindi della vita delle persone con diabete, nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali. una promessa per il futuro mediante il riconoscimento della centralità della persona con diabete, dei suoi diritti, delle sue libertà, ma anche delle sue responsabilità e dei suoi doveri. un documento pluralista, d integrazione socio-culturale: Il Manifesto è stato tradotto in 8 lingue, nel rispetto delle minoranza linguistiche e degli immigrati.
4 Finalità diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle libertà delle persone con diabete. ispirare un modello di governance clinica fondato sulla centralità della persona con diabete, mirante quindi alla sua responsabilizzazione ed alla sua partecipazione anche alla fase decisionale del processo assistenziale. promuovere una maggiore sensibilità con il coinvolgimento della società e delle istituzioni, a livello nazionale, regionale e locale decentrato, nei confronti delle problematiche sottese ai bisogni delle persone con diabete mediante l approvazione di atti legislativi e regolatori che indichino il diabete quale priorità su cui intervenire (Il Manifesto è già stato adottato dalla Regione Toscana e dalla Regione Sardegna e dalle AA.SS.LL. di Prato, Matera e Potenza).
5 Manifesto: quale efficacia? Il Manifesto si esprime in termini generali erga omnes ma non è generico ne indeterminato; Il Manifesto promuove, orienta, indica, invita ma non dispone; Il Manifesto tenta di ridurre l attuale asimmetria informativa sul mondo diabete mediante indicazioni di sistema; Il Manifesto per sua ragion d essere e forma non può assumere un carattere vincolante ne cogente; E allora?
6 E allora nel Manifesto non si deve necessariamente ricercare l efficacia e la cogenza giuridica, quanto piuttosto il sommo valore etico di una promessa protesa ad un futuro migliore
7 IL MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
8 Indice del Manifesto Diritti della persona con diabete sezione I Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari sezione II Educazione continua della persona con diabete sezione III Dialogo medico-persona con diabete sezione IV Controllo del diabete sezione V Prevenzione del diabete sezione VI Impegno nella ricerca sezione VII Associazionismo responsabile sezione VIII Diabete in gravidanza sezione XI Diabete in età evolutiva sezione X Immigrazione e diabete sezione XI
9 Diritti della persona con diabete sezione I I diritti di coloro che hanno il diabete sono gli stessi diritti umani e sociali delle persone senza diabete. I diritti comprendono la parità di accesso all informazione, all educazione terapeutica, al trattamento del diabete e alla diagnosi e cura delle complicanze. Il sistema sanitario deve garantire alla persona con diabete l uso di metodi diagnostici e terapeutici appropriati, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il diritto delle persone con diabete a vivere una vita sociale, educativa, lavorativa alla pari delle persone senza diabete deve essere considerato l obiettivo primario delle azioni di governo.
10 sez. I - Occorre pertanto: Sostenere la persona con diabete e i familiari nel superare gli ostacoli, i pregiudizi e le diffidenze attraverso l'impiego di strumenti informativi, formativi, educativi e sociali con la responsabilizzazione e il concorso attivo delle istituzioni, del sistema socio-sanitario, delle società scientifiche e delle associazioni di volontariato delle persone con diabete. Aumentare la consapevolezza sociale nel mondo della scuola, in quello del lavoro, nei luoghi in cui si pratica attività sportiva, nelle strutture sanitarie e nelle organizzazioni sociali per evitare discriminazioni e preclusioni personali e professionali. Istruire gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e gli istruttori sportivi e sensibilizzare i colleghi di lavoro su come prevenire, riconoscere e trattare le eventuali situazioni di urgenza. Affermare che avere il diabete non preclude la possibilità di perseguire gli obiettivi personali, familiari, lavorativi, sportivi e sociali. Garantire uniformità di accesso al sistema sanitario su tutto il territorio in modo da promuovere la migliore qualità di cura e di vita, la prevenzione e il trattamento delle complicanze. Promuovere in tutte le regioni l identificazione dei soggetti a rischio per garantire una diagnosi precoce di intolleranza glucidica e di diabete mellito.
11 Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari sezione II La persona con diabete e/o i familiari non sono sempre al corrente del percorso assistenziale e degli obiettivi del trattamento farmacologico e nutrizionale a lungo termine, come definiti dalle attuali linee guida terapeutiche. La persona con diabete e i familiari possono credere erroneamente che la situazione sia "sotto controllo" a causa della mancanza di sintomi e sospendere le adeguate terapie o modificarle in modo incongruo. La persona con diabete e i familiari devono ricevere una corretta informazione sulle cause di scompenso e sui fattori di rischio per lo sviluppo di complicanze, affinché siano consapevoli dell importanza di condurre uno stile di vita sano, in linea con le proprie possibilità e i propri bisogni.
12 sez. II - Occorre pertanto: Educare la persona con diabete e i familiari affinché possano vivere in base alle proprie aspirazioni. Aiutare le famiglie a gestire il diabete facendo formazione continua e fornendo informazioni, strumenti e servizi che tengano conto delle necessità delle singole persone. Stimolare gli operatori sanitari (specialisti, medici curanti, infermieri, psicologi, nutrizionisti, podologi, ecc..) ad ascoltare attivamente e per un tempo congruo la persona con diabete e i familiari per conoscerne i bisogni, le aspirazioni e le aspettative. Indurre gli operatori sanitari a spiegare gli obiettivi terapeutici, verificandone sempre la comprensione, e a sviluppare schemi di cura (personalizzati, condivisi, esplicitati in forma scritta e orale) che indichino il trattamento da seguire abitualmente e il comportamento da tenere in eventuali situazioni di urgenza. Invitare tutti gli operatori socio-sanitari a prendersi cura degli aspetti psicologici e sociali della persona con diabete e dei familiari.
13 Educazione continua della persona con diabete sezione III L educazione continua della persona con diabete, dei familiari e del contesto socio-relazionale è uno strumento indispensabile per il successo terapeutico, per prevenire e riconoscere eventuali complicanze e per raggiungere una piena autonomia nelle gestione quotidiana del diabete. È importante riconoscere alla terapia educazionale un ruolo centrale prevedendo corsi strutturati.
14 sez. III - Occorre pertanto: Formare il personale sanitario all educazione terapeutica e le organizzazioni di volontariato all educazione sanitaria della persona con diabete e dei familiari, in funzione delle loro specifiche esigenze cliniche e socio-culturali. Condividere con la persona gli obiettivi e le scelte terapeutiche, avendone dato piena informazione, al fine di facilitare la gestione del diabete nella vita quotidiana. Concordare la cura, l alimentazione salutare e l attività fisica costante e personalizzata. Avvalersi di un gruppo multidisciplinare completo con competenze specifiche (mediche, psicologiche, nutrizionali, infermieristiche, sociali) utili a rimuovere le barriere a una corretta gestione del diabete. Assicurare uniformità di accesso alla terapia educazionale su tutto il territorio nazionale.
15 Dialogo medico-persona con diabete sezione IV Per realizzare un'efficace gestione del diabete è indispensabile che il medico curante e il gruppo multidisciplinare di riferimento conoscano non solo gli aspetti bio-medici ma anche quelli psicologici, relazionali e sociali della persona, le sue percezioni, le sue aspettative, i suoi bisogni, gli ostacoli ed integrino tali elementi nel piano assistenziale. Allo stesso modo, deve essere garantito alla persona con diabete un contesto nel quale esprimere le proprie opinioni e riferire la propria condizione.
16 sez. IV - Occorre pertanto: Indurre gli operatori sanitari ad avere una vera e propria alleanza terapeutica con la persona con diabete e i familiari che comprenda: l ascolto attivo, una comunicazione empatica, un dialogo aperto e la regolare verifica non solo dello stato di salute ma anche della qualità del servizio erogato. Invitare gli operatori sanitari a sostenere la persona con diabete nell acquisizione di una piena consapevolezza della propria condizione e della propria cura. Analizzare le abitudini e le dinamiche individuali e familiari che possono favorire comportamenti a rischio. Aumentare le possibilità di accesso e la disponibilità di contatti con operatori sanitari, attraverso mezzi di comunicazione complementari, quali linee telefoniche e telematiche. Facilitare, quanto più possibile, la continuità di rapporto tra lo stesso gruppo multidisciplinare e la persona con diabete all interno dei centri specialistici e verificare che ciò si realizzi anche attraverso la partecipazione civica.
17 Controllo del diabete sezione V La persona con diabete deve essere consapevole che la sua è una condizione cronica, che può essere asintomatica o presentare sintomi di gravità variabile, e deve essere messa in grado di gestire la propria cura. Una corretta gestione del proprio diabete permette una vita scolastica, lavorativa, affettiva, sportiva e relazionale come quella della persona senza diabete.
18 sez. V - Occorre pertanto: Aumentare la conoscenza della persona con diabete e dei familiari sulle terapie appropriate alle diverse condizioni cliniche, facili da realizzare da parte di ogni singolo individuo e che consentano un agevole adattamento della cura. Favorire, nelle situazioni di ricovero in reparti non specifici, il coinvolgimento del diabetologo nelle scelte terapeutiche o un assistenza diabetologica qualificata. Facilitare l iter burocratico per l accesso a specifiche terapie e a strumenti di somministrazione. Rendere la persona consapevole che il buon controllo del diabete dipende anche da un attività fisica regolare, da una corretta alimentazione, da un peso corporeo nella norma, nonché dal controllo della pressione arteriosa e della dislipidemia. Indurre gli operatori sanitari ad avere una vera e propria alleanza terapeutica con la persona con diabete e i familiari che comprenda: l ascolto attivo, una comunicazione empatica, un dialogo aperto e la regolare verifica non solo dello stato di salute ma anche della qualità del servizio erogato.
19 Prevenzione del diabete sezione VI Vi sono efficaci misure preventive che possono essere attuate nei confronti della popolazione generale per ridurre la comparsa del diabete mellito, contenendone l enorme impatto personale e sociale. Le istituzioni devono validamente collaborare con le associazioni di volontariato, le società scientifiche e le organizzazioni civiche per ridurre la comparsa del diabete nelle persone a rischio. Attività di comunicazione sistematiche e continuative, volte a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce, possono consentire il trattamento tempestivo del diabete e la riduzione di tutte le sue conseguenze.
20 sez. VI - Occorre pertanto: Richiedere alle istituzioni locali e nazionali la diffusione di informazioni e l'attuazione di strategie per la prevenzione del diabete. Informare la popolazione che l'insorgenza del diabete tipo 2 può essere ridotta, anche nelle persone a rischio (adulti e bambini), adottando stili di vita salutari. Coinvolgere le istituzioni a destinare risorse adeguate per la prevenzione e la diagnosi precoce del diabete attraverso una comunicazione continua e coordinata con le associazioni scientifiche, le associazioni di volontariato delle persone con diabete, i loro familiari e le organizzazioni civiche. Considerare la famiglia e la scuola il luogo privilegiato per l educazione ad un corretto stile di vita. Realizzare programmi di informazione ed educazione sanitaria presso la scuola, le associazioni sportive, i centri residenziali per anziani e in generale tutti gli ambienti di vita e di lavoro coinvolgendo le istituzioni sanitarie, i gruppi multidisciplinari e le associazioni di volontariato delle persone con diabete, là dove formate a tale scopo. Invitare gli ambienti extra sanitari (scuola, lavoro, sport e comunità) e i media a diffondere una cultura che promuova scelte di vita salutari. Aumentare la conoscenza della persona con diabete e dei familiari sulle terapie appropriate alle diverse condizioni cliniche, facili da realizzare da parte di ogni singolo individuo e che consentano un agevole adattamento della cura.
21 Impegno nella ricerca sezione VII Investire nella ricerca da parte di università, istituzioni sanitarie, industria, enti pubblici e società scientifiche rappresenta una priorità per la comprensione, prevenzione e gestione del diabete. È importante che la ricerca sia coordinata così da evitare inutili duplicazioni di sforzi economici, risponda alle reali necessità delle persone con diabete e sia indirizzata anche nel campo dell epidemiologia, dell educazione e dell innovazione tecnologica. Grazie ai progressi delle conoscenze sul diabete e sul suo trattamento si potrà migliorare la qualità della vita e prevenire l insorgenza delle complicanze, ridurre i ricoveri ospedalieri e conseguentemente i costi sanitari dovuti a questa condizione ad alto impatto economico e sociale.
22 sez. VII - Occorre pertanto: Aumentare la comunicazione tra enti che fanno ricerca e associazioni di volontariato al fine di comprendere le reali necessità delle persone con diabete e indirizzare correttamente le risorse a disposizione. Investire in innovazione, in ricerca scientifica di base, clinica, epidemiologica e in formazione razionalizzando e incrementando le risorse a disposizione. Impegnare la ricerca in studi che abbiano come obiettivo la modifica della storia naturale della malattia e il miglioramento della qualità della vita della persona con diabete. Investire nell implementazione e nella ricerca di metodologie e mezzi di comunicazione che permettano di trasmettere in modo efficace informazioni rigorose sulle innovazioni scientifiche, sulla prevenzione, sulla gestione intergrata del diabete e che promuovano una corretta rappresentazione sociale della persona con diabete.
23 Associazionismo responsabile sezione VIII L'associazionismo volontario no profit nel campo del diabete in Italia in passato ha contribuito a raggiungere traguardi di assoluto rilievo, come ad esempio la Dichiarazione di Saint Vincent e l approvazione della legge di iniziativa popolare 115/87. Il raggiungimento di risultati legislativi e regolatori, a livello nazionale e locale, appare condizione qualificante dell'azione delle associazioni impegnate a promuovere il diabete quale priorità su cui agire. Appare altrettanto insostituibile il ruolo di collegamento esercitato dalle associazioni tra il sistema sanitario, le persone con diabete, familiari e la società.
24 sez. VIII - Occorre pertanto: Considerare l'associazionismo una risorsa e una componente importante nelle strategie di tutela della persona con diabete. Facilitare la collaborazione tra le associazioni di volontariato delle persone con diabete e i loro familiari, le organizzazioni civiche e i rappresentanti della comunità scientifica. Prevedere la formazione certificata e l accreditamento specifico delle associazioni di volontariato delle persone con diabete e delle associazioni civiche. Facilitare l inserimento di persone con diabete immigrate all interno delle associazioni Considerare l associazionismo e le organizzazioni civiche, attraverso persone formate allo scopo, quale parte attiva nei percorsi di informazione e formazione su diritti e tutela sociale delle persone con diabete. Avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato delle persone con diabete e delle organizzazioni civiche nelle attività di prevenzione del diabete. Sostenere l'azione di volontariato attraverso strumenti legislativi e regolatori. Definire un codice etico di autoregolamentazione e caratteristiche comuni che costituiscano un modello di riferimento per le associazioni. Valorizzare nei colloqui tra operatore sanitario e persona con diabete e suoi familiari l attività delle associazioni di volontariato delle persone con diabete, consigliando di partecipare alla vita associativa
25 Diabete In Gravidanza sezione IX La programmazione e gestione della gravidanza deve essere tutelata attraverso interventi di educazione terapeutica e di assistenza sanitaria specifici al fine di garantire alla donna con diabete e al feto la condizione clinica ottimale nel corso della gestazione e del parto. Occorre pertanto: Educare la donna con diabete sull importanza di programmare la gravidanza affinché il concepimento avvenga in una condizione ottimale per la formazione dell embrione e lo sviluppo fetale. Favorire gli accertamenti per la diagnosi del diabete gestazionale e i controlli successivi al parto. Garantire che l assistenza e il monitoraggio delle donne con diabete in gravidanza e delle donne che hanno sviluppato un diabete gestazionale avvenga da parte di un gruppo multidisciplinare composto dal diabetologo, ginecologo, ostetrica, infermiere e pediatra. Accogliere le gestanti in strutture ospedaliere idonee a gestire le gravidanze a rischio e in cui sia prevista durante tutto il ricovero l assistenza diabetologica.
26 Diabete In Età Evolutiva sezione X Il bambino e l adolescente con diabete hanno diritto nell ambito dell area pediatrica alle migliori prestazioni sanitarie senza alcuna distinzione di sesso, etnia, religione e condizione sociale. È doveroso prendersi cura del bambino e dell adolescente con diabete prestando particolare attenzione a momenti delicati come l inserimento scolastico e il passaggio all età adulta, che andranno favoriti con interventi specifici.
27 sez. X - Occorre pertanto: Garantire al bambino e all adolescente una vita scolastica, sportiva, relazionale e sociale identica ai propri coetanei senza diabete. Sostenere i familiari nella gestione del bambino e dell adolescente con diabete. Favorire la conoscenza dei sintomi per la diagnosi precoce del diabete tipo 1, al fine di evitare la gravità dell esordio e le complicanze che esso comporta. Garantire il migliore iter diagnostico al fine di identificare con precisione la tipologia di diabete e le strategie terapeutiche adatte alle diverse condizioni cliniche. Garantire l accesso alle possibilità di cura più appropriate, innovative e meno invasive. Adottare nel dialogo un linguaggio comprensibile, adeguato all età e alla cultura del bambino e dei familiari. Garantire ambienti ospedalieri e ambulatoriali accoglienti, adatti all infanzia e all adolescenza nei quali siano presenti gruppi multidisciplinari dedicati e specializzati nella cura del diabete in questa fascia d età e nell assistenza ai familiari.
28 sez. X - Occorre pertanto: Assicurare che sia sempre lo stesso gruppo multidisciplinare, all interno dei Centri Specializzati, a prendersi cura del bambino e dei familiari. Assicurare l aggiornamento permanente del personale sanitario al fine di migliorarne costantemente le competenze scientifiche, tecniche e comunicative. Incentivare l attività motoria, compresa quella sportiva, nelle migliori condizioni possibili e senza alcun tipo di limitazione. Promuovere l inserimento nell ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) dei campi scuola per i giovani al fine di facilitare il processo di responsabilizzazione e l autogestione del diabete. Favorire l azione di rete sul territorio tra centri di diabetologia pediatrica di riferimento regionale, centri periferici e pediatri di libera scelta. Facilitare la transizione dell adolescente dal diabetologo pediatra al diabetologo dell adulto affinché si garantisca la continuità della cura e il processo avvenga in modo graduale, attraverso la condivisione degli obiettivi e delle scelte terapeutiche.
29 Immigrazione e Diabete sezione XI La persona con diabete non deve essere discriminata in base alla lingua, all etnia, alla provenienza geografica, alla religione e allo status. Occorre pertanto: Facilitare all immigrato l accesso al sistema sanitario su tutto il territorio nazionale attraverso servizi di mediazione linguistica. Adattare, ove possibile, i programmi di cura della persona con diabete alle usanze dettate dalle tradizioni culturali e religiose se non in contrasto con i diritti dell uomo. Offrire corsi di educazione continua tenuti da gruppi multidisciplinari, supportati da personale anche delle associazioni di volontariato delle persone con diabete in grado di effettuare una comunicazione multilingue presso tutti gli ambienti di vita e di lavoro.
Manifesto dei diritti della persona con diabete
 Organizzazione e gestione dell assistenza diabetologica A cura di Marco A. Comaschi Dipartimento di Emergenza e Accettazione Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova Nella Sala Stampa "Caduti
Organizzazione e gestione dell assistenza diabetologica A cura di Marco A. Comaschi Dipartimento di Emergenza e Accettazione Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova Nella Sala Stampa "Caduti
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
 MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE Parlamentare Roma, 9 Luglio 2009 Parlamentare INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE Parlamentare Roma, 9 Luglio 2009 Parlamentare INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei
Dimensioni del problema, criticità, costi. Modelli organizzativi gestionali
 Rosario Iannacchero Dimensioni del problema, criticità, costi Modelli organizzativi gestionali Patologia molto frequente nella popolazione generale Solo emicrania: prevalenza media annua stimata negli
Rosario Iannacchero Dimensioni del problema, criticità, costi Modelli organizzativi gestionali Patologia molto frequente nella popolazione generale Solo emicrania: prevalenza media annua stimata negli
DOCUMENTO D INTESA SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI E PERSONE IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE SOCIALE IN TRENTINO
 Società Italiana di Medicina delle Migrazioni DOCUMENTO D INTESA SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI E PERSONE IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE SOCIALE IN TRENTINO Gruppo Immigrazione Salute GR.I.S. Trentino 1
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni DOCUMENTO D INTESA SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI E PERSONE IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE SOCIALE IN TRENTINO Gruppo Immigrazione Salute GR.I.S. Trentino 1
PRP Prevenzione e riduzione delle recidive dello Scompenso Cardiaco Cronico (SCC) secondario a patologie cronico-degenerative
 PRP 2010-2012 Prevenzione e riduzione delle recidive dello Scompenso Cardiaco Cronico (SCC) secondario a patologie cronico-degenerative Cagliari maggio 2011 Premessa Obiettivo: Prevenzione e riduzione
PRP 2010-2012 Prevenzione e riduzione delle recidive dello Scompenso Cardiaco Cronico (SCC) secondario a patologie cronico-degenerative Cagliari maggio 2011 Premessa Obiettivo: Prevenzione e riduzione
Educazione Terapeutica. Definizione
 EDUCAZIONE TERAPEUTICA: il fare del Terapista Occupazionale Educazione Terapeutica Definizione Gabriella Casu «Ogni volta che incontro un paziente Io parto da zero. Letteralmente io non so nulla, nulla
EDUCAZIONE TERAPEUTICA: il fare del Terapista Occupazionale Educazione Terapeutica Definizione Gabriella Casu «Ogni volta che incontro un paziente Io parto da zero. Letteralmente io non so nulla, nulla
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI
 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI Art. 1 (Finalità e
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI Art. 1 (Finalità e
I tavoli di lavoro regionali sulla malattia diabetica in età pediatrica
 I tavoli di lavoro regionali sulla malattia diabetica in età pediatrica Giovanni Chiari Dirigente medico Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica Margherita Borri Cocconcelli Azienda
I tavoli di lavoro regionali sulla malattia diabetica in età pediatrica Giovanni Chiari Dirigente medico Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica Margherita Borri Cocconcelli Azienda
La continuità assistenziale
 Le reti oncologiche regionali Presente, problematiche e prospettive future La continuità assistenziale Giuseppe Nastasi U.O.C. Oncologia Medica A.O. Bolognini - Seriate (BG) Camera dei Deputati - Palazzo
Le reti oncologiche regionali Presente, problematiche e prospettive future La continuità assistenziale Giuseppe Nastasi U.O.C. Oncologia Medica A.O. Bolognini - Seriate (BG) Camera dei Deputati - Palazzo
Piano Sanitario Nazionale Diabete ( )
 Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2013-2015) Aree di miglioramento
Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2002-2004) Piano Sanitario Nazionale Diabete (2013-2015) Aree di miglioramento
La situazione attuale
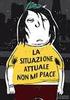 Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
METODICHE DIDATTICHE
 Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Pediatria C.L. Triennale Infermieristica Pediatrica A.A.2007/2008 CORSO INTEGRATO SCIENZE UMANE PSICOPEDAGOGICHE METODICHE
Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Pediatria C.L. Triennale Infermieristica Pediatrica A.A.2007/2008 CORSO INTEGRATO SCIENZE UMANE PSICOPEDAGOGICHE METODICHE
Dott. Stefano Zucchini
 L organizzazione dei centri diabetologici pediatrici regionali Giornata Nazionale della Diabesità Promossa dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Dott. Stefano Zucchini Centro
L organizzazione dei centri diabetologici pediatrici regionali Giornata Nazionale della Diabesità Promossa dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Dott. Stefano Zucchini Centro
PER MIGLIORARE L ASSISTENZA DIABETOLOGICA Cosa possono fare i professionisti sanitari Concetta Suraci Vice Presidente Diabete Italia
 PER MIGLIORARE L ASSISTENZA DIABETOLOGICA Cosa possono fare i professionisti sanitari Concetta Suraci Vice Presidente Diabete Italia La dott.ssa Concetta Suraci ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di
PER MIGLIORARE L ASSISTENZA DIABETOLOGICA Cosa possono fare i professionisti sanitari Concetta Suraci Vice Presidente Diabete Italia La dott.ssa Concetta Suraci ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di
I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA
 Roma, Istituto Superiore di Sanità, 17/11/2006 Il Diabete in Italia Aspetti Epidemiologici e Modelli Assistenziali I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA Roberto Sivieri Logica del Progetto (1/2)
Roma, Istituto Superiore di Sanità, 17/11/2006 Il Diabete in Italia Aspetti Epidemiologici e Modelli Assistenziali I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA Roberto Sivieri Logica del Progetto (1/2)
dall adolescenza all età adulta: un modello per i servizi di Salute Mentale
 Conferenza annuale per la salute mentale : un modello per i servizi di Salute Mentale Venerdì 22 Maggio 2009 Teatro della ASL di Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 1 2 IDENTIFICAZIONE E IMPOSTAZIONE DEL
Conferenza annuale per la salute mentale : un modello per i servizi di Salute Mentale Venerdì 22 Maggio 2009 Teatro della ASL di Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 1 2 IDENTIFICAZIONE E IMPOSTAZIONE DEL
Stili di vita. Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte
 Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte Villa Gualino, Torino, 9 dicembre 2009 Modo di vivere fondato su modelli comportamentali riconoscibili, determinati a loro volta dall interazione
Conferenza dei Servizi di Prevenzione della Regione Piemonte Villa Gualino, Torino, 9 dicembre 2009 Modo di vivere fondato su modelli comportamentali riconoscibili, determinati a loro volta dall interazione
IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE: LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE E IL COORDINAMENTO DEGLI SPECIALISTI
 1 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE: LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE E IL COORDINAMENTO DEGLI SPECIALISTI 2 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LA FAMIGLIA ANALIZZARE
1 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE: LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE E IL COORDINAMENTO DEGLI SPECIALISTI 2 IL RUOLO DELLA CLEFT CRANIOFACIAL NURSE RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LA FAMIGLIA ANALIZZARE
Ferrara 23 settembre 2016
 IBD UNIT L'esperienza forlivese del «CASE MANAGEMENT» Verso un modello gestionale multiprofessionale Ferrara 23 settembre 2016 Deborah Tumedei U.O. Gastroenterologia Ausl della Romagna 1 Direttore Prof.
IBD UNIT L'esperienza forlivese del «CASE MANAGEMENT» Verso un modello gestionale multiprofessionale Ferrara 23 settembre 2016 Deborah Tumedei U.O. Gastroenterologia Ausl della Romagna 1 Direttore Prof.
ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e in accordo con il Codice Etico della SIMI dichiara
 Il sottoscritto ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e in accordo con il Codice Etico della SIMI dichiara per l evento in oggetto l esistenza negli ultimi due anni
Il sottoscritto ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e in accordo con il Codice Etico della SIMI dichiara per l evento in oggetto l esistenza negli ultimi due anni
POLITICA AZIENDALE DESTRI S.R.L.
 Pag. 1 di 5 DESTRI S.R.L. Destri S.r.l., consapevole dell importanza della Qualità del servizio reso ai propri clienti, del miglioramento della Sicurezza dei propri lavoratori e della protezione dell ambiente,
Pag. 1 di 5 DESTRI S.R.L. Destri S.r.l., consapevole dell importanza della Qualità del servizio reso ai propri clienti, del miglioramento della Sicurezza dei propri lavoratori e della protezione dell ambiente,
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE
 MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE 1 INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari 3. Associazionismo responsabile
MANIFESTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE 1 INDICE 1. Diritti della persona con diabete 2. Aspettative e responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari 3. Associazionismo responsabile
PROTOCOLLO D INTESA tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità
 TITOLO: Protocollo d intesa tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione congiunta
TITOLO: Protocollo d intesa tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione congiunta
L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo
 L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo Rosangela Ghidelli Coordinatore Infermieristico Caposala U.O. S. Diabetologia e Endocrinologia Azienda Ospedaliera S. Anna Como Presidio
L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo Rosangela Ghidelli Coordinatore Infermieristico Caposala U.O. S. Diabetologia e Endocrinologia Azienda Ospedaliera S. Anna Como Presidio
L obiettivo. Facilitare. Non è convincere. La comunicazione per una scelta consapevole
 La vaccinazione tra diritto e dovere Quale comunicazione per facilitare la scelta L obiettivo Non è convincere Ma Istituto Superiore di Sanità 10 Gennaio 2011 La comunicazione per una scelta consapevole
La vaccinazione tra diritto e dovere Quale comunicazione per facilitare la scelta L obiettivo Non è convincere Ma Istituto Superiore di Sanità 10 Gennaio 2011 La comunicazione per una scelta consapevole
tra la Regione Toscana e l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Deliberazione GR 996 del 10 novembre 2014
 ADOZIONE SCUOLA Percorso per l attuazione l del Protocollo d Intesa d tra la Regione Toscana e l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Deliberazione GR 996 del 10 novembre 2014 LE FINALITA Promuovere
ADOZIONE SCUOLA Percorso per l attuazione l del Protocollo d Intesa d tra la Regione Toscana e l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Deliberazione GR 996 del 10 novembre 2014 LE FINALITA Promuovere
LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
 LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA Programmazione Programmare significa adattare od orientare un sistema organizzato affinché produca determinati risultati: predisponendo
LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA Programmazione Programmare significa adattare od orientare un sistema organizzato affinché produca determinati risultati: predisponendo
PREVENIRE IL DIABETE: dalla ricerca all'educazione terapeutica. Candidata: Marilena Piardi
 PREVENIRE IL DIABETE: dalla ricerca all'educazione terapeutica Candidata: Marilena Piardi INTRODUZIONE Le malattie croniche costituiscono circa l 80% di tutte le patologie e 70% dei costi diretti della
PREVENIRE IL DIABETE: dalla ricerca all'educazione terapeutica Candidata: Marilena Piardi INTRODUZIONE Le malattie croniche costituiscono circa l 80% di tutte le patologie e 70% dei costi diretti della
IN FORMA. Corso di Formazione per Volontari
 IN FORMA Corso di Formazione per Volontari IN FORMA è un corso di formazione per volontari, per aspiranti tali e per i collaboratori di ALBA, finalizzato a creare, sviluppare o specializzare le competenze
IN FORMA Corso di Formazione per Volontari IN FORMA è un corso di formazione per volontari, per aspiranti tali e per i collaboratori di ALBA, finalizzato a creare, sviluppare o specializzare le competenze
proposta di legge n. 471
 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 471 a iniziativa del Consigliere Ciriaci presentata in data 2 febbraio 2015 NORME PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL ANORESSIA, DELLA BULIMIA
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 471 a iniziativa del Consigliere Ciriaci presentata in data 2 febbraio 2015 NORME PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL ANORESSIA, DELLA BULIMIA
I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO. Dott.G.GIORDANO
 I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO Dott.G.GIORDANO PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE SUPERAMENTO DI UNA ASSISTENZA A COMPARTIMENTI STAGNI VISIONE SISTEMICA DELL ASSISTENZA FONDAMENTALE NELLE PATOLOGIE
I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO Dott.G.GIORDANO PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE SUPERAMENTO DI UNA ASSISTENZA A COMPARTIMENTI STAGNI VISIONE SISTEMICA DELL ASSISTENZA FONDAMENTALE NELLE PATOLOGIE
La collaborazione genitori-professionisti nel processo di Cura della persona con DSA
 Disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi all intervento educativoriabilitativo integrato Carbonia 20.04.2012 e 03.05.2012 La collaborazione genitori-professionisti nel processo di Cura della persona
Disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi all intervento educativoriabilitativo integrato Carbonia 20.04.2012 e 03.05.2012 La collaborazione genitori-professionisti nel processo di Cura della persona
Percorso assistenziale al bambino con eccesso ponderale: un programma di educazione ai corretti stili alimentari e motori
 Percorso assistenziale al bambino con eccesso ponderale: un programma di educazione ai corretti stili alimentari e motori del Fare bambino clic per e modificare dell adolescente lo stile del nell ambulatorio
Percorso assistenziale al bambino con eccesso ponderale: un programma di educazione ai corretti stili alimentari e motori del Fare bambino clic per e modificare dell adolescente lo stile del nell ambulatorio
Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale
 Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale dott. Raffaele FABRIZIO Bologna, 20 gennaio 2010 La società regionale oggi Invecchiamento popolazione (aumento
Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale dott. Raffaele FABRIZIO Bologna, 20 gennaio 2010 La società regionale oggi Invecchiamento popolazione (aumento
Accompagnare al cambiamento
 Accompagnare al cambiamento percorso per Guadagnare salute Rendere facili le scelte salutari Reggio Emilia 24-25-26 settembre 2009 E.Centis*, P.Beltrami*, G.P.Guelfi** (*) Azienda USL Bologna (**) Università
Accompagnare al cambiamento percorso per Guadagnare salute Rendere facili le scelte salutari Reggio Emilia 24-25-26 settembre 2009 E.Centis*, P.Beltrami*, G.P.Guelfi** (*) Azienda USL Bologna (**) Università
17 novembre Giornata mondiale della prematurità
 17 novembre Giornata mondiale della prematurità Incontro O.N.Da La nascita prematura 17 novembre 014 Milano Regione Lombardia Emilia Grazia De Biasi Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato
17 novembre Giornata mondiale della prematurità Incontro O.N.Da La nascita prematura 17 novembre 014 Milano Regione Lombardia Emilia Grazia De Biasi Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato
La gestione del dolore acuto in area critica
 Cento maggio 2002 La gestione del dolore acuto in area critica CSI M.G. Cristofori trattamento non farmacologico Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari * Percentuale di intervistati che ha
Cento maggio 2002 La gestione del dolore acuto in area critica CSI M.G. Cristofori trattamento non farmacologico Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari * Percentuale di intervistati che ha
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LOREFICE, DALL OSSO, SILVIA GIORDANO, BARONI, CECCONI, MANTERO, GRILLO, DI VITA
 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2390 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LOREFICE, DALL OSSO, SILVIA GIORDANO, BARONI, CECCONI, MANTERO, GRILLO, DI VITA Disposizioni
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2390 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LOREFICE, DALL OSSO, SILVIA GIORDANO, BARONI, CECCONI, MANTERO, GRILLO, DI VITA Disposizioni
Cosa sono i consultori? Chi trovi nei consultori? Quali servizi nei consultori? Con sultori familiari
 Cosa sono i consultori? Chi trovi nei consultori? Quali servizi nei consultori? Con sultori familiari Centro Consulenza Giovani Consultori immigrati Funzione di accoglienza Procreazione responsabile Percorso
Cosa sono i consultori? Chi trovi nei consultori? Quali servizi nei consultori? Con sultori familiari Centro Consulenza Giovani Consultori immigrati Funzione di accoglienza Procreazione responsabile Percorso
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
 ! MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IC n. 6 Scuola... LA SPEZIA PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO P.E.I. (Ai sensi dell articolo 12 - L. 104/92) Alunno/a Classe Docente/i di sostegno
! MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IC n. 6 Scuola... LA SPEZIA PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO P.E.I. (Ai sensi dell articolo 12 - L. 104/92) Alunno/a Classe Docente/i di sostegno
PROGETTI DEL CIRCOLO. Ministero dell istruzione, dell Universita e della Ricerca 1 CIRCOLO DIDATTICO VIA NANNI 13 OLBIA
 PROGETTI DEL CIRCOLO Ministero dell istruzione, dell Universita e della Ricerca 1 CIRCOLO DIDATTICO VIA NANNI 13 OLBIA PROGETTO INCLUSIONE: Una Scuola Per Tutti Il progetto è volto a garantire le priorità
PROGETTI DEL CIRCOLO Ministero dell istruzione, dell Universita e della Ricerca 1 CIRCOLO DIDATTICO VIA NANNI 13 OLBIA PROGETTO INCLUSIONE: Una Scuola Per Tutti Il progetto è volto a garantire le priorità
UFFICIO di MEDIAZIONE LINGUISTICO INTERCULTURALE
 UOC MATERNO INFANTILE ETÀ EVOLUTIVA E FAMIGLIA UFFICIO di MEDIAZIONE LINGUISTICO INTERCULTURALE Dott.ssa Mara Fasoli Assistente Sociale 21 gennaio 2014 LA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E uno strumento
UOC MATERNO INFANTILE ETÀ EVOLUTIVA E FAMIGLIA UFFICIO di MEDIAZIONE LINGUISTICO INTERCULTURALE Dott.ssa Mara Fasoli Assistente Sociale 21 gennaio 2014 LA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E uno strumento
Antonella Moretti Cattedra di Reumatologia Scuola di Specializzazione in Reumatologia Università Politecnica delle Marche.
 Antonella Moretti Cattedra di Reumatologia Scuola di Specializzazione in Reumatologia Università Politecnica delle Marche antonellamrt@gmail.com 1 negli USA vengono introdotti i DRG con l obiettivo di
Antonella Moretti Cattedra di Reumatologia Scuola di Specializzazione in Reumatologia Università Politecnica delle Marche antonellamrt@gmail.com 1 negli USA vengono introdotti i DRG con l obiettivo di
Protocollo d intesa: Osservatorio sulle situazioni di disagio nel territorio del comune di Civitella in val di chiana
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA Civitella in val di chiana Protocollo d intesa: Osservatorio sulle situazioni di disagio nel territorio del comune di Civitella in val di chiana CONTRAENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA Civitella in val di chiana Protocollo d intesa: Osservatorio sulle situazioni di disagio nel territorio del comune di Civitella in val di chiana CONTRAENTI
GRUPPO DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA
 Assemblea Nazionale Anffas Onlus Roma, 13 Giugno 2009 Attività CTS 2009 GRUPPO DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA LA PARTECIPAZIONE DI ANFFAS
Assemblea Nazionale Anffas Onlus Roma, 13 Giugno 2009 Attività CTS 2009 GRUPPO DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA LA PARTECIPAZIONE DI ANFFAS
Caso clinico: Degenza Riabilitativa: «training fisico e non solo»
 Caso clinico: Degenza Riabilitativa: «training fisico e non solo» Uomo 64 anni Diabetico NID Obeso Cardiopatia ischemica Ipertensione arteriosa Ipercolesterolemia Sindrome delle apnee ostruttive notturne
Caso clinico: Degenza Riabilitativa: «training fisico e non solo» Uomo 64 anni Diabetico NID Obeso Cardiopatia ischemica Ipertensione arteriosa Ipercolesterolemia Sindrome delle apnee ostruttive notturne
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE (*)
 DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE (*) La legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore * Legge numero
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE (*) La legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore * Legge numero
Gli orientamenti della Regione Sardegna sui sistemi di valutazione e classificazione dell anziano e del disabile
 Dai sistemi di valutazione e classificazione un modello per la governance Gli orientamenti della Regione Sardegna sui sistemi di valutazione e classificazione dell anziano e del disabile Cagliari, 26 ottobre
Dai sistemi di valutazione e classificazione un modello per la governance Gli orientamenti della Regione Sardegna sui sistemi di valutazione e classificazione dell anziano e del disabile Cagliari, 26 ottobre
Normativa DSA e BES il ruolo della Scuola dell Infanzia. Elena Dal Pio Luogo
 Normativa DSA e BES il ruolo della Scuola dell Infanzia Elena Dal Pio Luogo LEGGE 170 8 ottobre 2010 Art. 1 Riconoscimento e definizione di: Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Garantire
Normativa DSA e BES il ruolo della Scuola dell Infanzia Elena Dal Pio Luogo LEGGE 170 8 ottobre 2010 Art. 1 Riconoscimento e definizione di: Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Garantire
L esperienza del centro AISC itinerante Dott. Cristopher Bartoli, Medico Specializzando in Medicina d Emergenza-Urgenza, Università degli studi di
 L esperienza del centro AISC itinerante Dott. Cristopher Bartoli, Medico Specializzando in Medicina d Emergenza-Urgenza, Università degli studi di Roma La Sapienza - Ospedale Sant Andrea - Roma La clinica
L esperienza del centro AISC itinerante Dott. Cristopher Bartoli, Medico Specializzando in Medicina d Emergenza-Urgenza, Università degli studi di Roma La Sapienza - Ospedale Sant Andrea - Roma La clinica
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE
 11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE La legge 38 del 2010 La rete delle cure palliative Il CeAD Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE La legge 38 del 2010 La rete delle cure palliative Il CeAD Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010
Rete del progetto Diade
 La Rete Diade P Progetto realizzato nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia per l'attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione
La Rete Diade P Progetto realizzato nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia per l'attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione
LE MALATTIE RARE. Il ruolo del Pediatra di famiglia. dr Piero Di Saverio Vicesegretario Nazionale F.I.M.P.
 LE MALATTIE RARE Il ruolo del Pediatra di famiglia dr Piero Di Saverio Vicesegretario Nazionale F.I.M.P. dr Piero Di Saverio Vicesegretario Nazionale F.I.M.P. Aspetti che attengono al ruolo del PdF Diagnosi
LE MALATTIE RARE Il ruolo del Pediatra di famiglia dr Piero Di Saverio Vicesegretario Nazionale F.I.M.P. dr Piero Di Saverio Vicesegretario Nazionale F.I.M.P. Aspetti che attengono al ruolo del PdF Diagnosi
Il Piano sotto forma di check-list
 1 Il Piano sotto forma di check-list Il Piano è articolato in 10 obiettivi ciascuno dei quali prevede una serie di sotto-obiettivi e suggerimenti. Il Piano segue con dei riquadri dedicati a situazioni
1 Il Piano sotto forma di check-list Il Piano è articolato in 10 obiettivi ciascuno dei quali prevede una serie di sotto-obiettivi e suggerimenti. Il Piano segue con dei riquadri dedicati a situazioni
WORKSHOP FORMATIVO PER PSICOLOGI LO SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA Metodologia e ambiti di applicazione 5/6 maggio 2012
 1 WORKSHOP FORMATIVO PER PSICOLOGI LO SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA Metodologia e ambiti di applicazione 5/6 maggio 2012 PRESENTAZIONE Da diversi anni la scuola ha aperto le proprie porte al mondo della
1 WORKSHOP FORMATIVO PER PSICOLOGI LO SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA Metodologia e ambiti di applicazione 5/6 maggio 2012 PRESENTAZIONE Da diversi anni la scuola ha aperto le proprie porte al mondo della
Presentazione del Protocollo di intesa per la valorizzazione dei farmacisti e delle farmacie territoriali nell educazione terapeutica
 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITA SPERIMENTALI E MALATTIE RARE U.O. Comunicazione viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030/3838315 Fax 030/3838280 E-mail: comunicazione@aslbrescia.it CONFERENZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITA SPERIMENTALI E MALATTIE RARE U.O. Comunicazione viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030/3838315 Fax 030/3838280 E-mail: comunicazione@aslbrescia.it CONFERENZA
Sandra Vattini 05/04/16
 Sandra Vattini 05/04/16 1 svattini@ausl.pr.it Si prevede la realizzazione di iniziative ed interventi atti a favorire le scelte di salute, l informazione e l educazione nutrizionale, la condivisione ed
Sandra Vattini 05/04/16 1 svattini@ausl.pr.it Si prevede la realizzazione di iniziative ed interventi atti a favorire le scelte di salute, l informazione e l educazione nutrizionale, la condivisione ed
PDTA. Gruppi Multidisciplinari. Continuità assistenziale tra servizi ospedalieri e territoriali (cure palliative,mmg).
 ASSICURARE LA PRESA IN CARICO DELL ASSISTITO NELL INTERO PERCORSO ASSISTENZIALE GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI AL PAZIENTE, STRETTAMENTE CORRELATA ALL EXPERTISE CLINICA E AD UNA ADEGUATA ORGANIZZAZIONE
ASSICURARE LA PRESA IN CARICO DELL ASSISTITO NELL INTERO PERCORSO ASSISTENZIALE GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI AL PAZIENTE, STRETTAMENTE CORRELATA ALL EXPERTISE CLINICA E AD UNA ADEGUATA ORGANIZZAZIONE
Il Ruolo dell Infermiere nel network
 Il Ruolo dell Infermiere nel network Una testimonianza multidisciplinare dello scompenso cardiaco Ercole Vellone, PhD, FESC Ricercatore di Scienze infermieristiche Università di Roma Tor Vergata INCONTRO
Il Ruolo dell Infermiere nel network Una testimonianza multidisciplinare dello scompenso cardiaco Ercole Vellone, PhD, FESC Ricercatore di Scienze infermieristiche Università di Roma Tor Vergata INCONTRO
Il Progetto CCM SOCIAL NET SKILLS Il contributo della Regione Lazio
 Il Progetto CCM SOCIAL NET SKILLS Il contributo della Regione Lazio Dott.ssa Amalia Vitagliano Dirigente Area SanitàPubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening Regione Lazio, 23
Il Progetto CCM SOCIAL NET SKILLS Il contributo della Regione Lazio Dott.ssa Amalia Vitagliano Dirigente Area SanitàPubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening Regione Lazio, 23
Primo intervento pubblico su istituzioni per l infanzia avviene nel periodo fascista, legge n del 1925.
 Primo intervento pubblico su istituzioni per l infanzia avviene nel periodo fascista, legge n. 2277 del 1925. Istituzione dell Opera Nazionale Maternità e Infanzia, obiettivo primario la difesa e il potenziamento
Primo intervento pubblico su istituzioni per l infanzia avviene nel periodo fascista, legge n. 2277 del 1925. Istituzione dell Opera Nazionale Maternità e Infanzia, obiettivo primario la difesa e il potenziamento
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
 SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche 1/6 Premessa Il Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche è la struttura aziendale che ha come finalità la promozione
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche 1/6 Premessa Il Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche è la struttura aziendale che ha come finalità la promozione
IL SENSO DELLA PSICOLOGIA
 INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
L Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AISM è l unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla
 Benvenuti! IL RUOLO DELL AISM L Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AISM è l unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla Promuove e finanzia la ricerca scientifica
Benvenuti! IL RUOLO DELL AISM L Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AISM è l unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla Promuove e finanzia la ricerca scientifica
PREVENZIONE. Linee Guida Regionali 2007
 PREVENZIONE Linee Guida Regionali 2007 Bla bla bla si parla sempre di prevenzione..ma.. Non sempre è chiara la definizione di cosa esattamente si voglia/debba prevenire Di chi lo debba fare E che ruolo
PREVENZIONE Linee Guida Regionali 2007 Bla bla bla si parla sempre di prevenzione..ma.. Non sempre è chiara la definizione di cosa esattamente si voglia/debba prevenire Di chi lo debba fare E che ruolo
Primi passi. una rete di proposte educative per rispondere ai bisogni di bambini e famiglie.
 STILI DI VITA E SALUTE: DAL DIRE AL FARE Verona 12/13 Maggio 2016 INFANZIA PROGETTO PRIMI PASSI E GENITORIALITA UISP PADOVA Primi passi una rete di proposte educative per rispondere ai bisogni di bambini
STILI DI VITA E SALUTE: DAL DIRE AL FARE Verona 12/13 Maggio 2016 INFANZIA PROGETTO PRIMI PASSI E GENITORIALITA UISP PADOVA Primi passi una rete di proposte educative per rispondere ai bisogni di bambini
Casa della Salute di San Secondo
 Casa della Salute di San Secondo PROGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE CON BPCO NELLA CASA DELLA SALUTE DI SAN SECONDO Obiettivo generale è la presa in carico delle persone assistite affette da BPCO
Casa della Salute di San Secondo PROGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE CON BPCO NELLA CASA DELLA SALUTE DI SAN SECONDO Obiettivo generale è la presa in carico delle persone assistite affette da BPCO
Le Cure Palliative erogate in Rete
 Le Cure Palliative erogate in Rete La normativa nazionale e regionale Codigoro - 29 settembre 2012 Mauro Manfredini Focus sulla Rete No Terapia del dolore No Cure Palliative Pediatriche LEGGE n. 39 26
Le Cure Palliative erogate in Rete La normativa nazionale e regionale Codigoro - 29 settembre 2012 Mauro Manfredini Focus sulla Rete No Terapia del dolore No Cure Palliative Pediatriche LEGGE n. 39 26
ENTE I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche dell Educazione e della Formazione.
 PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI ( DM 177/2000, art. 4 ) ENTE I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche dell Educazione
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI ( DM 177/2000, art. 4 ) ENTE I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche dell Educazione
PROGRAMMA DELLE OFFERTE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE A.S. 2008/2009
 PROGRAMMA DELLE OFFERTE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE A.S. 2008/2009 Le proposte hanno come sfondo, obiettivi e modalità di formazione, fissati nella direttiva del Sovrintendente Scolastico in materia
PROGRAMMA DELLE OFFERTE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE A.S. 2008/2009 Le proposte hanno come sfondo, obiettivi e modalità di formazione, fissati nella direttiva del Sovrintendente Scolastico in materia
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMICOLA-PONTELATONE PIANO ANNUALE PER L INCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMICOLA-PONTELATONE PIANO ANNUALE PER L INCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 SIGNIFICATO DEL PAI E CARATTERISTICHE GENERALI Il PAI utilizza la programmazione dell attività didattica
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMICOLA-PONTELATONE PIANO ANNUALE PER L INCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 SIGNIFICATO DEL PAI E CARATTERISTICHE GENERALI Il PAI utilizza la programmazione dell attività didattica
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 212 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Michieletto, Finozzi e Semenzato DISPOSIZIONI
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 212 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Michieletto, Finozzi e Semenzato DISPOSIZIONI
Consultori familiari
 Consultori familiari Le prestazioni del consultorio corsi di accompagnamento alla nascita rivolti ad entrambi i genitori assistenza a domicilio a mamma e neonato dopo il parto (Servizio di Dimissione protetta):
Consultori familiari Le prestazioni del consultorio corsi di accompagnamento alla nascita rivolti ad entrambi i genitori assistenza a domicilio a mamma e neonato dopo il parto (Servizio di Dimissione protetta):
NUOVI Pacchetti Ambulatoriali Complessi: DIABETE, GRAVIDANZA E TRANSIZIONE. Dr.ssa Donatella Bloise Referente del Polo di Diabetologia Ariccia (RM6)
 NUOVI Pacchetti Ambulatoriali Complessi: DIABETE, GRAVIDANZA E TRANSIZIONE Dr.ssa Donatella Bloise Referente del Polo di Diabetologia Ariccia (RM6) Dichiaro di aver ricevuto negli ultimi due anni compensi
NUOVI Pacchetti Ambulatoriali Complessi: DIABETE, GRAVIDANZA E TRANSIZIONE Dr.ssa Donatella Bloise Referente del Polo di Diabetologia Ariccia (RM6) Dichiaro di aver ricevuto negli ultimi due anni compensi
L EDUCAZIONE SINGOLA E DI GRUPPO: A CHI, QUANDO E COME
 L EDUCAZIONE SINGOLA E DI GRUPPO: A CHI, QUANDO E COME Inf. Elide Guerra Servizio di Diabetologia o.c. G.B. Morgagni - Forlì ANIMO BO 2012 Elide Guerra 1 Le evidenze più recenti confermano che migliore
L EDUCAZIONE SINGOLA E DI GRUPPO: A CHI, QUANDO E COME Inf. Elide Guerra Servizio di Diabetologia o.c. G.B. Morgagni - Forlì ANIMO BO 2012 Elide Guerra 1 Le evidenze più recenti confermano che migliore
PDTA Diabete RUOLO DELLA STRUTTURA DIABETOLOGICA TERRITORIALE. Cona, 30 Settembre 2017
 PDTA Diabete RUOLO DELLA STRUTTURA DIABETOLOGICA TERRITORIALE Roberto Graziani Cona, 30 Settembre 2017 Il Diabete a Ferrara Ad oggi sono presenti nella Provincia di Ferrara 28.000 pazienti affetti da Diabete
PDTA Diabete RUOLO DELLA STRUTTURA DIABETOLOGICA TERRITORIALE Roberto Graziani Cona, 30 Settembre 2017 Il Diabete a Ferrara Ad oggi sono presenti nella Provincia di Ferrara 28.000 pazienti affetti da Diabete
La gestione del paziente diabetico dalla dimissione ospedaliera alla presa in carico da parte del Servizio Diabetologico: aspetti infermieristici
 LA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE DELLA PERSONA CON DIABETE IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO: UN UPDATE SULLE PIU' RECENTI ACQUISIZIONI DI GOVERNO CLINICO E GESTIONE DELLA TERAPIA. Cento 28 maggio 2016 La gestione
LA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE DELLA PERSONA CON DIABETE IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO: UN UPDATE SULLE PIU' RECENTI ACQUISIZIONI DI GOVERNO CLINICO E GESTIONE DELLA TERAPIA. Cento 28 maggio 2016 La gestione
Antonio Correra. Società Italiana di Pediatria
 Antonio Correra Società Italiana di Pediatria PEDIATRI IN ITALIA ~12.500 Ricambio minimo 5 % / anno 800 ~ 600-700 n. Specializzandi 600 400 200-400/-500 Pediatri anno ~ 180 In 10 anni -5000 / -4000 0
Antonio Correra Società Italiana di Pediatria PEDIATRI IN ITALIA ~12.500 Ricambio minimo 5 % / anno 800 ~ 600-700 n. Specializzandi 600 400 200-400/-500 Pediatri anno ~ 180 In 10 anni -5000 / -4000 0
Un modello di alleanza sul territorio fra il Centro HUB, Farmacisti e MMG
 Un modello di alleanza sul territorio fra il Centro HUB, Farmacisti e MMG Alfonso Papa Direttore Centro HUB di Terapia del Dolore AORN Dei Colli - Ospedale Monaldi Napoli I Centri HUB per la terapia del
Un modello di alleanza sul territorio fra il Centro HUB, Farmacisti e MMG Alfonso Papa Direttore Centro HUB di Terapia del Dolore AORN Dei Colli - Ospedale Monaldi Napoli I Centri HUB per la terapia del
VIVERE MEGLIO OGNI GIORNO.OVUNQUE.
 REPLY OGNI GIORNO.OVUNQUE. VIVERE MEGLIO Ticuro Reply misura ed interpreta il tuo stile di vita giornaliero. Basato sull Internet of Things (IoT) e sui Big Data, Ticuro Reply migliora la qualità della
REPLY OGNI GIORNO.OVUNQUE. VIVERE MEGLIO Ticuro Reply misura ed interpreta il tuo stile di vita giornaliero. Basato sull Internet of Things (IoT) e sui Big Data, Ticuro Reply migliora la qualità della
Verona Città della Salute e della Qualità della Vita. Facebook:
 Verona Città della Salute e della Qualità della Vita Facebook: www.facebook.com/qualitadellavitabenessereesaluteaverona Progetto Palestre Verona Palestre per la salute Tavolo Tecnico Il Progetto Palestre
Verona Città della Salute e della Qualità della Vita Facebook: www.facebook.com/qualitadellavitabenessereesaluteaverona Progetto Palestre Verona Palestre per la salute Tavolo Tecnico Il Progetto Palestre
La storia dell'oral care in AMD D.Mannino Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino Morelli Reggio Calabria
 La storia dell'oral care in AMD D.Mannino Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino Morelli Reggio Calabria Ai sensi dell art. 3.3 del Regolamento applicativo dell Accordo Stato-Regioni 05.11.2009,
La storia dell'oral care in AMD D.Mannino Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino Morelli Reggio Calabria Ai sensi dell art. 3.3 del Regolamento applicativo dell Accordo Stato-Regioni 05.11.2009,
Dott.ssa Cristina Patrizi Medico di Medicina Generale ASL RMC Roma U.O.CAD ASL RMB Roma U.O. Medicina Legale ASL RMB Roma Segretario Generale Siameg
 Dott.ssa Cristina Patrizi Medico di Medicina Generale ASL RMC Roma U.O.CAD ASL RMB Roma U.O. Medicina Legale ASL RMB Roma Segretario Generale Siameg S.I.A.ME.G. Società Italiana per l'aggiornamento del
Dott.ssa Cristina Patrizi Medico di Medicina Generale ASL RMC Roma U.O.CAD ASL RMB Roma U.O. Medicina Legale ASL RMB Roma Segretario Generale Siameg S.I.A.ME.G. Società Italiana per l'aggiornamento del
Antonella Moretti Cattedra di Reumatologia Scuola di Specializzazione in Reumatologia Università Politecnica delle Marche.
 Antonella Moretti Cattedra di Reumatologia Scuola di Specializzazione in Reumatologia Università Politecnica delle Marche antonellamrt@gmail.com La strategia d intervento, in una malattia così complessa
Antonella Moretti Cattedra di Reumatologia Scuola di Specializzazione in Reumatologia Università Politecnica delle Marche antonellamrt@gmail.com La strategia d intervento, in una malattia così complessa
PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale. AVIS Regionale Toscana
 PROTOCOLLO D INTESA tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale e AVIS Regionale Toscana VISTO il D.L. del 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
PROTOCOLLO D INTESA tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale e AVIS Regionale Toscana VISTO il D.L. del 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto
 Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto Dott.ssa Daniela Galeone Ministero del Lavoro, della Salute e dellepolitiche Sociali Torino,
Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto Dott.ssa Daniela Galeone Ministero del Lavoro, della Salute e dellepolitiche Sociali Torino,
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
 SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE 1/11 Premessa Il Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche è la struttura aziendale che ha come
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE 1/11 Premessa Il Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche è la struttura aziendale che ha come
La continuità assistenziale fra ospedale e territorio. Modena 21 settembre 2006
 La continuità assistenziale fra ospedale e territorio Modena 21 settembre 2006 Continuità assistenziale definizioni continuità della cura coordinazione della cura piano di dimissione case management integrazione
La continuità assistenziale fra ospedale e territorio Modena 21 settembre 2006 Continuità assistenziale definizioni continuità della cura coordinazione della cura piano di dimissione case management integrazione
STATUTO/REGOLAMENTO NETWORK per la costituzione di una Rete Nazionale per la Terapia del dolore e delle cure palliative
 STATUTO/REGOLAMENTO NETWORK per la costituzione di una Rete Nazionale per la Terapia del dolore e delle cure palliative Articolo 1 Istituzione Per iniziativa di Federsanità Anci è istituito il Network
STATUTO/REGOLAMENTO NETWORK per la costituzione di una Rete Nazionale per la Terapia del dolore e delle cure palliative Articolo 1 Istituzione Per iniziativa di Federsanità Anci è istituito il Network
obiettivi di miglioramento: AREA PREVENZIONE
 DPCS 2012 Il documento di programmazione sottolinea in particolare le aree e gli obiettivi di miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento riferiti al Cittadino, sono stati costruiti con riferimento alla
DPCS 2012 Il documento di programmazione sottolinea in particolare le aree e gli obiettivi di miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento riferiti al Cittadino, sono stati costruiti con riferimento alla
L ACCESSO AI SERVIZI SANITARI: SCENARI DI EVOLUZIONE. Lorenzo Sornaga Responsabile Sanità LAZIOcrea S.p.a.
 L ACCESSO AI SERVIZI SANITARI: SCENARI DI EVOLUZIONE Lorenzo Sornaga Responsabile Sanità LAZIOcrea S.p.a. Un CUP regionale, il ReCUP 18 aziende 760 sportelli 250.000 h di back office oltre 12.000.000 prenotazioni
L ACCESSO AI SERVIZI SANITARI: SCENARI DI EVOLUZIONE Lorenzo Sornaga Responsabile Sanità LAZIOcrea S.p.a. Un CUP regionale, il ReCUP 18 aziende 760 sportelli 250.000 h di back office oltre 12.000.000 prenotazioni
l inserimento del paziente in dialisi peritoneale: esperienza del centro di Piacenza Paola Chiappini
 Il predialisi come presupposto fondamentale per l inserimento del paziente in dialisi peritoneale: esperienza del centro di Piacenza Paola Chiappini PROCESSO INIZIALE 1998 Paziente con IRC Medico curante
Il predialisi come presupposto fondamentale per l inserimento del paziente in dialisi peritoneale: esperienza del centro di Piacenza Paola Chiappini PROCESSO INIZIALE 1998 Paziente con IRC Medico curante
La Cardio-Riabilitazione. Riabilitazione: nuova opportunità per i pazienti cardiopatici
 La Cardio-Riabilitazione Riabilitazione: nuova opportunità per i pazienti cardiopatici Dott. Giovanni Pasanisi Unità Operativa di Cardiologia Ospedale del Delta, AUSL di Ferrara Definizione di riabilitazione
La Cardio-Riabilitazione Riabilitazione: nuova opportunità per i pazienti cardiopatici Dott. Giovanni Pasanisi Unità Operativa di Cardiologia Ospedale del Delta, AUSL di Ferrara Definizione di riabilitazione
COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA E TESINO Provincia di Trento
 COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA E TESINO Provincia di Trento REGOLAMENTO ATTIVAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA E LABORATORI FINALIZZATI AL BENESSERE PSICO- FISICO-SENSORIALE DELLE PERSONE ANZIANE Approvato
COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA E TESINO Provincia di Trento REGOLAMENTO ATTIVAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA E LABORATORI FINALIZZATI AL BENESSERE PSICO- FISICO-SENSORIALE DELLE PERSONE ANZIANE Approvato
CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO
 Promuovere il Patient Engagement nei processi di cura grazie a prove di efficacia e misure di impatto - CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dr.ssa Valeria Mastrilli
Promuovere il Patient Engagement nei processi di cura grazie a prove di efficacia e misure di impatto - CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dr.ssa Valeria Mastrilli
Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
 Referente per quanto comunicato Tel. 0982/491235-44 Fax 0982/427968 e-mail: consultorioamantea@libero.it PROGRAMMA DI ATTIVITA PER L ANNO 2016 Il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI), adottato con
Referente per quanto comunicato Tel. 0982/491235-44 Fax 0982/427968 e-mail: consultorioamantea@libero.it PROGRAMMA DI ATTIVITA PER L ANNO 2016 Il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI), adottato con
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita
 Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
PROGETTO - Piano d'azione I.C. - LANZO T.SE
 PROGETTO - Piano d'azione I.C. - LANZO T.SE TOIC82600G VIA VITTORIO VENETO 2 Torino (TO) Piano di Azione - I.C. - LANZO T.SE - pag. 1 In quali aree o in quali aspetti ti senti forte come Scuola/Istituto
PROGETTO - Piano d'azione I.C. - LANZO T.SE TOIC82600G VIA VITTORIO VENETO 2 Torino (TO) Piano di Azione - I.C. - LANZO T.SE - pag. 1 In quali aree o in quali aspetti ti senti forte come Scuola/Istituto
Adozione e sostegno alle famiglie
 Adozione e sostegno alle famiglie Firenze, 19 aprile 2017 «Il lavoro nelle adozioni come pratica di sostegno alla genitorialità: nuovi indirizzi e nuovi strumenti» Regione Toscana Settore Innovazione Sociale
Adozione e sostegno alle famiglie Firenze, 19 aprile 2017 «Il lavoro nelle adozioni come pratica di sostegno alla genitorialità: nuovi indirizzi e nuovi strumenti» Regione Toscana Settore Innovazione Sociale
!!!!!!!! UNIVERSITA +DEGLI+STUDI+DI+PISA+
 UNIVERSITA DEGLISTUDIDIPISA FACOLTA DIMEDICINAECHIRURGIA CORSODILAUREAININFERMIERISTICA (abilitanteallaprofessionesanitariadiinfermiere) Relatore: Prof.ssaAnnaFornari See & Treat una possibile soluzione
UNIVERSITA DEGLISTUDIDIPISA FACOLTA DIMEDICINAECHIRURGIA CORSODILAUREAININFERMIERISTICA (abilitanteallaprofessionesanitariadiinfermiere) Relatore: Prof.ssaAnnaFornari See & Treat una possibile soluzione
