I PROBLEMI DI TENUTA DELLA TAPPATURA DELLE BOTTIGLIE DI VINO IN RELAZIONE ALL IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO
|
|
|
- Carla Colli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 1 I PROBLEMI DI TENUTA DELLA TAPPATURA DELLE BOTTIGLIE DI VINO IN RELAZIONE ALL IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO Milena LAMBRI, Elena GRILLO Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-Alimentare, Facoltà di Agraria, Università Cattolica S. Cuore Piacenza milena.lambri@unicatt.it Introduzione L'impiego del tappo di sughero monopezzo (turacciolo) richiede, da parte dell utilizzatore, massima cura ed attenzione: negligenze, spesso considerate di poca importanza, possono creare inconvenienti di grave entità quali, ad esempio, la perdita di vino. Le bottiglie in cui si verifica questo problema sono indistintamente definite bottiglie colose, ma occorre distinguere la colosità dalla trasudazione (6). Dicesi trasudazione o trafilatura il processo secondo cui il vino si infiltra tra il vetro e il tappo con una perdita di prodotto poco rilevante. La trasudazione può essere momentanea o continuare nel tempo e può anche cessare grazie al colmataggio delle vie di fuga ad opera delle sostanze che compongono l estratto secco del vino. La colosità o colatura costituisce un difetto di maggiore entità con un percolamento attraverso il tappo o lungo una piega di esso. Detto fenomeno si interrompe difficilmente e porta ad una perdita di vino importante che non permette più la commercializzazione della bottiglia. In relazione questi inconvenienti, le alterazioni della presentazione della bottiglia e della qualità del vino sono numerose: - presenza di umidità sotto la capsula con rischio di gusti anomali nel vino; - alterazione della capsula e dell etichetta; - degradazione del vino (ossidazione, acescenza). Sovente, alla base di un difetto di tenuta, ci sono diversi fattori, legati alle variabili di seguito elencate. Scelta della bottiglia con il profilo del collo il più possibile perfetto La superficie interna del collo della bottiglia non deve presentare irregolarità tali da compromettere una corretta chiusura, il profilo interno deve essere leggermente conico e rispettare i diametri previsti per le diverse tipologie. A questo proposito esiste un parametro che permette di valutare la regolarità del profilo interno del collo e serve ad indicare l eventualità del rischio di colature in modo indipendente dal tipo di tappo adottato. Tale parametro è la conicità o svasatura, definita come la differenza tra il diametro del collo bottiglia alla base inferiore del tappo e quello al raso bocca, rapportata al diametro maggiore ed espressa in percentuale (5). La Stazione Sperimentale del Sughero ha proposto in sede di normalizzazione U.N.I. / I.S.O. una conicità minore del 2,5% mentre il Portogallo suggerisce un valore inferiore al 5,0%. In termini pratici è consigliabile evitare l'uso di bottiglie il cui collo abbia una conicità superiore al 10% perché il mancato rispetto di tale condizione può dar luogo a seri inconvenienti, in primis il rischio di colature (5). Chiaramente, se tra le bottiglie impiegate esistono esemplari con conicità inversa, con eccessive protuberanze o rientranze interne del collo, gli inconvenienti potrebbero non riguardare solamente fenomeni di percolamento, ma anche: - espulsione del tappo dalla bottiglia; - difficoltà di tappatura e stappatura; - slittamento del tappo all'interno della bottiglia (1).
2 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 2 Rigorosa scelta dei tappi Le dimensioni dei turaccioli sono regolate da norme sia nazionali che internazionali, rispettivamente dalla norma U.N.I e dalla norma I.S.O (5). I dati relativi alle due norme riguardano le caratteristiche dimensionali ufficiali dei turaccioli che nella pratica, poi, ciascuna azienda fornisce con le dimensioni richieste dalle case enologiche. Quando il diametro della bottiglia al raso bocca è di 17,5 ± 0,4 mm ( collo Italia ) (3) si consiglia normalmente l utilizzo di un tappo monopezzo di diametro pari a 24 mm, mentre lo stesso tipo di tappo con diametro di 26 mm si utilizza solitamente per bottiglie a collo CETIE (6), ovvero con imboccatura a 18, mm (4; 8). In funzione delle dimensioni e della forma del collo della bottiglia si devono scegliere le dimensioni più opportune del tappo. La differenza tra il diametro del tappo e quello interno del collo della bottiglia ritenuta ottimale per avere una buona garanzia di tenuta, è indicata da diversi autori non inferiore a 5 mm lungo tutta l altezza del tappo (1; 6). Controllo del livello del liquido Un altro aspetto da non dimenticare riguarda il livello di riempimento della bottiglia che deve essere calcolato a seconda del tipo di bottiglia, della temperatura del vino (durante le fasi di imbottigliamento, di stoccaggio, di trasporto), della lunghezza del tappo e del volume nominale della bottiglia secondo il D.L. CEE n. 451, 3 luglio Diversi autori indicano che, per un incremento di temperatura durante la conservazione da 20 a 40 C, il volume di un vino con grado alcolico del 12% aumenta di 4,2 ml (tabella 1). Logicamente se l imbottigliamento è fatto ad una temperatura diversa da 20 C bisogna calcolare opportunamente il livello di riempimento (1; 2; 4; 9). Tabella 1 - Esempio di dilatazione apparente prevedibile (ml) subita da un vino secco con gradazione alcolica di 12% vol in bottiglia da 750 ml, a seguito di incrementi di temperatura durante la conservazione (4). Il vino si espande in media di circa 0,2 ml/ C e la dilatazione è condizionata dal tenore alcolico: di questo bisogna tener conto al momento dell'imbottigliamento in quanto un aumento della temperatura riduce lo spazio di testa e pregiudica la tenuta del tappo e, in certi casi, la resistenza meccanica della bottiglia (1). Il volume del vino aumenta ed il livello risale nel collo della bottiglia; simultaneamente la pressione cresce fino a superare la soglia di tenuta stagna della tappatura: ciò provocherà uno spandimento del vino fra il vetro e il tappo poiché il volume del liquido non è più contenibile nella bottiglia stessa. L'innalzamento eccessivo del livello durante la conservazione del vino, provocando una riduzione del volume vuoto all'interno della bottiglia, può causare aumenti della pressione interna della camera d'aria tali da influire negativamente sulla qualità della tappatura. Questo aspetto viene spesso trascurato perché nelle cantine, durante l'operazione di imbottigliamento, non sempre è possibile adeguare il livello di riempimento al variare della temperatura del vino. Nelle moderne riempitrici si sta diffondendo il sistema di controllo
3 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 3 computerizzato che, in base alla temperatura del vino in lavorazione, al suo coefficiente di dilatazione termica, al volume totale della bottiglia da riempire, regola il volume di liquido in modo da lasciare libero lo spazio di testa sufficiente a contenere le variazioni volumetriche del vino, ovviamente nel rispetto delle disposizioni contemplate dalla legge dei preimballaggi citata in precedenza. Il livello di riempimento della bottiglia e la lunghezza del tappo condizionano il volume della camera d aria. Infatti, durante la tappatura, l'aria presente nel collo della bottiglia viene intrappolata al di sotto del tappo; si genera così nello spazio di testa una pressione del valore di 1,5-2 bar (1). Per limitare i problemi legati alla creazione di una sovrappressione ed alla presenza di ossigeno nella camera d'aria della bottiglia, è stato concepito il sistema di imbottigliamento sotto vuoto. Anche l'imbottigliamento sotto CO 2 può essere utile perché questo gas si discioglie nel vino e lascia delle pressioni residue molto basse; l'azoto invece è poco solubile nel vino e il suo impiego può causare qualche problema (1; 6). Alcune aziende, per limitare la possibile ossidazione del vino, applicano la tecnica della tappatura a raso bocca o a schizzi (6; 7). Questa tecnica consiste nel riempimento completo della bottiglia. Questo sistema di tappatura, pur presentando uno scarso interesse per quanto riguarda l'ossidazione, è invece estremamente sfavorevole alla tenuta stagna della bottiglia. L'eccesso di vino spinto dal tappo macchia il sughero e fuoriesce dalla bottiglia. Inoltre, la pressione raggiunta è molto elevata (fino a 5 kg/cm 2 ) e spesso superiore alla pressione di tenuta stagna che assicura l'otturazione: ciò causa una colatura immediata al momento del coricamento della bottiglia. Infine le bottiglie così riempite, supponendo che l'imbottigliamento sia fatto a 20 C, non potranno sopportare senza conseguenze dannose un minimo aumento di temperatura. Questo genere di tappatura è più che sconsigliata. E bene ricordare che la sovrappressione, generata nello spazio di testa in seguito all inserimento del tappo, tende lentamente a diminuire per effetto della parziale espulsione di aria attraverso il tappo. Il calo di pressione si verifica nelle bottiglie conservate in posizione verticale subito dopo la tappatura; è, quindi, importante, ai fini dell'ermeticità, tenere le bottiglie in posizione verticale per un tempo sufficientemente lungo a permettere un primo ritorno elastico del sughero. Per avere una buona tenuta del tappo sarebbe indispensabile mantenere in piedi la bottiglia appena tappata per alcune ore, in modo da allocarla in posizione orizzontale solo quando il tappo può assicurare una tenuta perfetta. Le cadenze elevate di imbottigliamento spesso non permettono di rispettare quest'ultimo termine (4; 10). Ruolo della linea d imbottigliamento La buona tenuta del tappo è fortemente compromessa se il collo della bottiglia è bagnato. Infatti, il film liquido presente tra sughero e vetro fa sì che il sughero inumidito perda di elasticità, facilitando il passaggio di liquido (4; 6). In questo modo anche tappi normalmente elastici finiscono per avere problemi di tenuta. Le cause possono derivare da: cattiva asciugatura dopo il lavaggio della bottiglia, formazione di condensa a causa della differenza di temperatura tra il vetro e il vino, flusso di riempimento orientato in modo da provocare turbolenza del vino con conseguente formazione di schiuma, livello di riempimento troppo alto, processo di livellamento del vino mediante livellatore ad iniezione di gas. II corretto funzionamento della tappatrice consente, altresì, di mantenere il tappo nelle migliori condizioni di integrità. Se si considera la tramoggia di ricezione e le canalizzazioni di discesa dei tappi, i fattori che favoriscono la buona qualità della tappatura sono (1; 4): il movimento dolce dei sistemi meccanici e pneumatici, la mancanza di asperità o di parti taglienti, la compatibilità tra il diametro dei dispositivi di discesa ed il calibro dei tappi,
4 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 4 il buono stato di tutte le parti mobili. L'alimentazione delle tramogge deve essere effettuata automaticamente, tramite elevatori a coclea, mantenendo il livello dei tappi sempre al minimo: ciò permette di danneggiare i tappi il meno possibile. Il punzone di inserimento deve consentire il buon posizionamento del tappo e, al momento dell'appoggio, deve avere una centratura e una verticalità buone; inoltre non deve presentare brecce o crepe. Il livello di affondamento ideale per un vino tranquillo si situa a raso bocca sia per favorire l'applicazione della capsula, sia per controllare precisamente il volume della camera d'aria tra sughero e vino, sia per evitare che il fondo del tappo venga spinto fino ad un punto del collo della bottiglia eccessivamente svasato dove il sughero non fa più tenuta. Inoltre, il raso bocca esatto permette al tappo di occupare precisamente la leggera svasatura presente sul bordo interno della bocca della bottiglia, creando un giunto di tenuta supplementare. Tuttavia, alcuni tecnici preferiscono affondare leggermente il tappo per compensare una piccola risalita dovuta all'elasticità naturale del sughero: in questo caso non si dovrebbe superare la tolleranza di 0,5 mm (4). Il sistema di compressione più adatto è quello a 4 ganasce. Occorre controllare periodicamente l'usura progressiva delle ganasce in modo da assicurare sempre: il mantenimento della forma cilindrica del tappo durante la fase di compressione, la regolarità del diametro di compressione delle ganasce, un buon accoppiamento delle superfici di scorrimento delle ganasce, con gioco ridotto al minimo, la mancanza di crepe sugli spigoli di contatto delle ganasce e di irregolarità sulla loro superficie laterale per evitare di pizzicare il sughero (1). Per quanto concerne la cadenza della tappatrice, il principio generale da rispettare è il seguente: compressione lenta, affondamento rapido. Indicativamente le cadenze orarie consigliabili sono: per un tappatore monotesta, da 800 a 3000 tappi (raccomandato 2500); per un tappatore pluritesta, da 800 a 1500 tappi (raccomandato 1250) (4; 6). PROVE SPERIMENTALI DI DILATAZIONE TERMICA DEL VINO Presso l Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-Alimentare dell Università Cattolica del S.Cuore di Piacenza sono state effettuate alcune prove sperimentali di dilatazione termica di vino rosso contenuto in bottiglie bordolesi di vetro trasparente con livello di riempimento a 20 C, indicato sul fondo della bottiglia, a 70 mm dal raso bocca. Su n.2 bottiglie (bottiglia 1 e bottiglia 2) sono state condotte due prove distinte a due diversi livelli di riempimento alla temperatura di 20 C, per un totale di 4 campioni secondo le linee seguenti: - PROVA A: riempimento a 70 mm dal raso bocca, tappatura con turaccioli monopezzo 24x44 mm e stoccaggio delle bottiglie a 40 C, 50 C e 60 C. - PROVA B: riempimento ad un valore diverso da quello indicato per la temperatura di 20 C e arbitrariamente fissato a 60 mm dal raso bocca, tappatura con turaccioli monopezzo 24x44 mm e stoccaggio delle bottiglie a 40 C, 50 C e 60 C, mantenendo la bottiglia 1 in posizione verticale e la bottiglia 2 in posizione orizzontale. L obiettivo delle prove era di verificare il comportamento della tappatura in sughero monopezzo, applicando condizioni estreme in termini di temperatura-tempo di conservazione. Per ambedue le prove la procedura sperimentale si è svolta secondo i seguenti punti: a. misurazione del profilo del collo della bottiglia e calcolo della conicità; b. riempimento della bottiglia con vino rosso e misurazione del livello raggiunto dal pelo libero del vino a 20 C; c. misurazione del diametro del collo della bottiglia nella zona compresa tra il pelo libero del vino e 45 mm di profondità; d. tappatura delle bottiglie con un turacciolo monopezzo di dimensioni 24x44 mm; e. misura della profondità raggiunta da detto turacciolo rispetto al raso bocca;
5 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 5 f. misura dell altezza dello spazio di testa; g. calcolo del volume vuoto compreso tra il vino e il turacciolo. Tutte le misure sono state eseguite con apposito calibro digitale di precisione centesimale. Risultati Profilo del collo bottiglia I risultati relativi alla misurazione dei diametri interni del collo bottiglia valutati lungo la saldatura del vetro e perpendicolarmente ad essa sono riportati nelle figure 1 e 2. I grafici illustrano l andamento dei diametri interni a partire dal raso bocca (punto 0.0 mm sino a 50 mm di profondità da esso, punto 50 mm). Figura 1 Profilo interno del collo della bottiglia n.1 saldatura perpendicolare alla saldatura 19,50 diametro collo (mm) 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 profondità dal raso bocca (mm) Figura 2 Profilo interno del collo della bottiglia n.2 saldatura perpendicolare alla saldatura 20,00 diametro collo (mm) 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 profondità dal raso bocca (mm)
6 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 6 Come si può desumere dalle curve-profilo ottenute, le bottiglie impiegate nelle prove possiedono una buona regolarità dei diametri interni: i valori al raso bocca non sono mai superiori agli estremi della tolleranza indicati per il collo Italia in mm; la svasatura è progressiva e si arresta a circa 30 mm di profondità, ad essa fa seguito una costanza dei diametri misurati che, a 45 mm dal raso bocca, non superano mai il valore massimo per detto collo ritenuto pari a mm. Dai i dati campionati a 45 mm di profondità e da quelli misurati al raso bocca è stata calcolata la conicità del collo; è stata inoltre valutata l eventuale presenza di deformazioni dei diametri confrontando detto valore con la conicità calcolata a 40 mm di profondità. Dai dati ottenuti (tabella 2) si evince che le bottiglie non presentano alcuna deformazione del profilo interno. Tabella 2 Conicità del collo delle bottiglie calcolata dalle misure a 40 e a 45 mm di profondità Bottiglia 1 Bottiglia 2 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm Conicità lungo la saldatura 6,4 6, ,1 Conicità lungo la perpendicolare alla saldatura 8,2 8,4 10,2 10,4 Le altre misurazioni effettuate sulle bottiglie sono riportate in tabella 3 per la prova A (livello di riempimento a 70 mm dal raso bocca) e in tabella 4 per la prova B (livello di riempimento a 60 mm dal raso bocca). Tabella 3 Misurazioni effettuate sulle bottiglie per l esecuzione della prova A Bottiglia 1 Bottiglia 2 Livello raggiunto dal pelo libero del vino a 20 C (L 20 C ) mm mm Diametro medio del collo tra pelo libero e 45 mm di profondità mm mm Profondità del turacciolo dal raso bocca mm mm Altezza dello spazio di testa ( H) mm mm Volume vuoto tra vino e tappo 7.57 ml 7.91 ml Tabella 4 Misurazioni effettuate sulle bottiglie per l esecuzione della prova B Bottiglia 1 Bottiglia 2 Livello raggiunto dal pelo libero del vino a 20 C (L 20 C ) mm mm Diametro medio del collo tra pelo libero e 45 mm di profondità mm mm Profondità del turacciolo dal raso bocca mm mm Altezza dello spazio di testa ( H) mm mm Volume vuoto tra vino e tappo 4.06 ml 4.33 ml
7 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 7 Dilatazione termica - Prova A La prova sperimentale di dilatazione termica del vino ha previsto lo stazionamento dei campioni in termostato a differenti temperature: 40 C, 50 C e 60 C per un tempo variabile dalle 3 alle 8 ore. Come detto in precedenza, in questa prova ambedue le bottiglie sono state mantenute in posizione verticale. Al termine di ogni fase è stata effettuata la misurazione del livello del vino. La situazione alla temperatura di 20 C, ovvero a Ti, è riportata in figura 3. Figura 3 Situazione dei campioni a 20 C Bottiglia 1: L 20 C = mm H = mm Bottiglia 2: L 20 C = mm H = mm Al termine del periodo di stazionamento dei campioni a 40 C è stato misurato il livello raggiunto dal vino (figura 4).
8 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 8 Figura 4 Situazione dei campioni dopo stazionamento di 8 ore a 40 C Bottiglia 1: L 40 C = mm H = mm Bottiglia 2: L 40 C = mm H = mm Alla temperatura di 40 C si osserva un innalzamento rilevante del livello del vino nel collo della bottiglia con una conseguente riduzione dello spazio di testa che passa da circa 24 mm di altezza, misurati a 20 C, a circa 13 mm rilevati dopo stoccaggio a 40 C. A questa temperatura i campioni, se mantenuti in posizione verticale, non presentano alcun problema di perdita di prodotto. Per osservare il fenomeno della risalita capillare del vino e della sua fuoriuscita al raso bocca occorre spingere l innalzamento termico sino a 60 C (figura 5).
9 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 9 Figura 5 Situazione dei campioni dopo stazionamento di 8 ore a 40 C e di 3 ore a 60 C Bottiglia 1 Bottiglia 2
10 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 10 Quando i campioni sostano per poche ore alla temperatura di 60 C si riscontra una piccola perdita di prodotto, ma se lo stoccaggio è prolungato, sino ad 8 ore, si produce una trafilazione di vino di maggiore entità con auto-espulsione del tappo come evidente in figura 6. Figura 6 Situazione dei campioni dopo 8 ore di stazionamento a 60 C Bottiglia 1 Bottiglia 2 - Prova B La prova sperimentale B ha previsto il riempimento delle bottiglie ad un livello di circa 60 mm dal raso bocca, ovvero ad un valore non conforme a quello indicato sul fondo del recipiente. In seguito è stato effettuato lo stazionamento dei campioni in termostato a temperature di 40 C e 50 C per un tempo variabile dalle 3 alle 8 ore. Come detto in precedenza, durante tale stoccaggio la bottiglia n.1 è rimasta in posizione verticale, mentre la bottiglia n.2 è stata mantenuta in posizione orizzontale. Al termine di ogni fase è stata effettuata la misurazione del livello del vino. La situazione alla temperatura di 20 C, ovvero a Ti, è riportata in figura 7.
11 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 11 Figura 7 Situazione dei campioni a Ti = 20 C. Bottiglia 1 - verticale L 20 C = mm; H = mm Bottiglia 2 - orizzontale L 20 C = mm; H = mm Alla temperatura di 40 C il vino lambisce il tappo nella bottiglia verticale, mentre in quella orizzontale si osserva già una perdita di prodotto (figura 8). Figura 8 Situazione dei campioni dopo 3 ore di stazionamento a 40 C Bottiglia 1 - verticale L 40 C = mm; H = 2.15 mm Bottiglia 2 - orizzontale Risulta evidente dalle figure che a 40 C si manifesta un fenomeno di trafilazione se la bottiglia è coricata. Detto fenomeno produce una perdita di vino che comincia a fuoriuscire dal raso bocca. Nella bottiglia orizzontale il livello del vino misurato a 40 C è pari ad un valore di mm con una differenza di mm rispetto alla bottiglia verticale. Tale differenza rappresenta la perdita di vino che, tenendo conto del diametro della bottiglia 2 (tabella 4), può essere stimata in circa 1,5 ml. I campioni sono stati posti nuovamente in termostato a 50 C e lasciati per successive 3 ore. Quanto osservato è riportato in figura 9.
12 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 12 Figura 9 Situazione dopo stazionamento di 3 ore a 40 C e di 3 ore a 50 C Bottiglia 1 - verticale Bottiglia 2 - orizzontale In ambedue le situazioni (bottiglia verticale e bottiglia orizzontale) è stata osservata una trafilazione con perdita di prodotto più cospicua nel caso della bottiglia mantenuta in posizione orizzontale. I valori del livello del vino raggiunto dopo il riscaldamento a 50 C e il successivo raffreddamento a 20 C sono riportati nella tabella 5. Nella medesima tabella è indicato anche il volume di vino evacuato dalle bottiglie in seguito a stoccaggio di 3 ore a 50 C. Tabella 9 Misurazioni effettuate sulle bottiglie al termine della prova B Livello raggiunto dal pelo libero del vino dopo 3 ore a 50 C (misurato a 20 C) (L 50 C ) Bottiglia n.1 verticale Bottiglia n.2 orizzontale mm mm Livello raggiunto dal pelo libero del vino a 20 C (L 20 C ) mm mm Variazione del livello alla temperatura di 20 C (L 50 C - L 20 C ) 4.27 mm 6.62 mm Volume di vino evacuato dalla bottiglia 1.4 ml 2.2 ml CONCLUSIONI Da quanto esposto emerge che lo stazionamento del vino a 40 C e a 50 C, ovvero con uno scostamento termico rispetto alla temperatura di riempimento, pari rispettivamente a +20 C e a + 30 C, ha provocato: - risalita capillare del liquido tra il vetro e il tappo già a 40 C con perdita di prodotto nelle bottiglie coricate, se non viene rispettato l idoneo livello di riempimento indicato sul fondo delle bottiglie stesse; - trafilazione con fuoriuscita di vino a 60 C in tutte le situazioni considerate, accompagnata, sovente, dall auto- espulsione del turacciolo; - perdita di prodotto generalmente più elevata nelle bottiglie mantenute in posizione orizzontale. Dalle osservazioni effettuate in base alle prove sperimentali si può affermare che, per bottiglie bordolesi collo Italia, un livello di riempimento a 20 C pari a circa 60 mm dal raso bocca comporta
13 LAMBRI ET AL., PROBLEMI DI COLATURA E IMPIEGO DEL TAPPO IN SUGHERO, PAG. 13 la formazione di un volume vuoto tra vino e tappo del tutto insufficiente a contenere l espansione del liquido in caso di stoccaggio delle bottiglie a temperature vicine o superiori ai 40 C. Il rispetto dell idoneo livello di riempimento alla temperatura di 20 C, peraltro indicato sul fondo delle bottiglie e pari a 70 mm, comporta, in caso di aumento della temperatura, la trafilazione di una parte del vino che, nelle nostre prove, si è osservata a partire da una temperatura di 50 C. A tale temperatura la perdita di prodotto si rende evidente solamente nella bottiglia mantenuta in posizione orizzontale, mentre nella bottiglia conservata in verticale il livello del vino non raggiunge ancora la base del tappo. Nel caso della bottiglia mantenuta in verticale il liquido inizia la risalita capillare e fuoriesce al raso bocca solamente in seguito a stazionamento per alcune ore alla temperatura di 60 C. E dimostrato, quindi, come, posta una buona regolarità del profilo del collo ed un valore corretto di conicità dello stesso, il fenomeno della trafilazione del vino con fuoriuscita al raso bocca sia legato in maniera diretta all incremento termico subito dal prodotto durante lo stoccaggio. Il rispetto del livello di riempimento previsto a 20 C, per ciascuna tipologia di bottiglia, consente di dilazionare il manifestarsi di detto fenomeno a temperature molto elevate per lo stoccaggio di un vino e, quindi, con tutta probabilità, più difficilmente raggiungibili. BIBLIOGRAFIA 1. Colagrande O., 1996, «Il tappo di sughero», Chiriotti Ed., Pinerolo. 2. Fédération Française des Syndicats du Liège, 1998, «Charte des bouchonniers liégeurs», Centre Technique de Documentation du Liège. 3. Istituto di Enologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Stazione Sperimentale del Sughero, Tempio Pausania, Regione Autonoma della Sardegna, 1996, «Disciplinare sulla produzione ed utilizzo del tappo di sughero in enologia», La Nuovissima Ed., Tempio Pausania. 4. Mazzoleni V., Zironi R., Campisi B., 2001, «Manuale d uso sulle tecniche di tappatura delle bottiglie di vino», Tipografia Filacorda, Udine. 5. Pes A., 1995, «Il sughero in cantina: il turacciolo, il tappo a fungo, il tappo di sughero agglomerato», La Nuovissima Ed., Tempio Pausania. 6. Riboulet J.M., Alegoet C., 1986, «Aspects pratiques du bouchage des vins», Bourgogne publications Ed., La Chapelle de Guinchay. 7. Tablino L., 2002, «Speciale: Sughero», Vignevini, 4, aprile. 8. Tablino L., 2004, «Speciale: i processi d imbottigliamento», Vignevini, 10, ottobre. 9. «La tappatura : scelta e controllo», 2005, Beverage Machines, Vodret A., 2004, «Il Sughero in Enologia: i disciplinari di produzione», Dossier OICCE Times n.3, Supplemento al n.21.
L utilizzo corretto dei tappi di sughero Fattori di Influenza Aggiornato al:
 Aggiornato al: 1.1.214 Pagina 1/9 Condizioni ottimali Temperatura del Sughero: 1-2 Umidità del Sughero: - 7% Imboccatura della bottiglia secondo EN 12726:2, imboccatura leggermente conica. 1 2, 1, 1, Evacuazione
Aggiornato al: 1.1.214 Pagina 1/9 Condizioni ottimali Temperatura del Sughero: 1-2 Umidità del Sughero: - 7% Imboccatura della bottiglia secondo EN 12726:2, imboccatura leggermente conica. 1 2, 1, 1, Evacuazione
LA TERMINOLOGIA E LE CARATTERISTICHE. a. Tappo da spumante. b. Gabbietta. c. Bottiglia
 A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE
 MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE la tenuta alla pressione del tappo spumante 03 incidenti di tappatura e possibili cause 05 difetti visibili sulla chiusura dopo la stappatura della bottiglia
MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE la tenuta alla pressione del tappo spumante 03 incidenti di tappatura e possibili cause 05 difetti visibili sulla chiusura dopo la stappatura della bottiglia
LINEE GUIDA PER L'IMBOTTIGLIAMENTO
 BRENTAPACK srl Via Armentera, 8/10 38051 Borgo Valsugana (TN)- Italy Tel +39.0461.1788028 P.IVA 02242580229 info@brentapack.com www.brentapack.com LINEE GUIDA PER L'IMBOTTIGLIAMENTO PREMESSA L imbottigliamento
BRENTAPACK srl Via Armentera, 8/10 38051 Borgo Valsugana (TN)- Italy Tel +39.0461.1788028 P.IVA 02242580229 info@brentapack.com www.brentapack.com LINEE GUIDA PER L'IMBOTTIGLIAMENTO PREMESSA L imbottigliamento
GLI INCIDENTI DI TAPPATURA E LE POSSIBILI CAUSE. a. Bottiglia. tappo scanalato. d. Gabbiettatura
 A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
PROCEDURA DI COLLAUDO PER TUBAZIONI IN PE PER TRASPORTO DI ACQUA
 PROCEDURA DI COLLAUDO PER TUBAZIONI IN PE PER TRASPORTO DI ACQUA GENERALITA Secondo il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 le condotte realizzate devono essere sottoposte ad una
PROCEDURA DI COLLAUDO PER TUBAZIONI IN PE PER TRASPORTO DI ACQUA GENERALITA Secondo il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 le condotte realizzate devono essere sottoposte ad una
Cessioni fenoliche dal tappo di sughero e potenziale effetto sulla stabilità proteica del vino
 Cessioni fenoliche dal tappo di sughero e potenziale effetto sulla stabilità proteica del vino Gabrielli M., Fracassetti D, Tirelli A. Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione, l'ambiente.
Cessioni fenoliche dal tappo di sughero e potenziale effetto sulla stabilità proteica del vino Gabrielli M., Fracassetti D, Tirelli A. Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione, l'ambiente.
EFFETTI DELLA STAGIONATURA DEL SUGHERO SULLA TENUTA DI TAPPI MONOPEZZO
 GIUA ET AL., EFFETTI DELLA STAGIONATURA DEL SUGHERO SULLA TENUTA DI TAPPI MONOPEZZO, PAG. 1 EFFETTI DELLA STAGIONATURA DEL SUGHERO SULLA TENUTA DI TAPPI MONOPEZZO M. Giua (1), F. Pampiro (1), G. Marzeddu
GIUA ET AL., EFFETTI DELLA STAGIONATURA DEL SUGHERO SULLA TENUTA DI TAPPI MONOPEZZO, PAG. 1 EFFETTI DELLA STAGIONATURA DEL SUGHERO SULLA TENUTA DI TAPPI MONOPEZZO M. Giua (1), F. Pampiro (1), G. Marzeddu
DALL IDEA AL PROGETTO
 DALL IDEA AL PROGETTO Obiettivo di questo progetto è quello di realizzare l assemblaggio di almeno dieci componenti appartenenti ad un assieme reale per noi facilmente reperibile. Il modello rappresentato
DALL IDEA AL PROGETTO Obiettivo di questo progetto è quello di realizzare l assemblaggio di almeno dieci componenti appartenenti ad un assieme reale per noi facilmente reperibile. Il modello rappresentato
VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. LA RISPOSTA DI UNA AZIENDA ITALIANA Maria Manara Dal Cin S.p.A. (Sesto San Giovanni, MI)
 MANARA, VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. PAG. 1 VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. LA RISPOSTA DI UNA AZIENDA ITALIANA Maria Manara Dal Cin S.p.A. (Sesto San Giovanni,
MANARA, VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. PAG. 1 VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. LA RISPOSTA DI UNA AZIENDA ITALIANA Maria Manara Dal Cin S.p.A. (Sesto San Giovanni,
SPU MA NTE MANUALE DI TAPPATURA PER VINI SPUMANTI. Amorim. Il sughero del futuro, un po prima.
 SPU MA NTE MANUALE DI TAPPATURA PER VINI SPUMANTI Amorim. Il sughero del futuro, un po prima. La sola analisi di laboratorio, non può assicurare il massimo risultato raggiungibile nella tappatura, in quanto,
SPU MA NTE MANUALE DI TAPPATURA PER VINI SPUMANTI Amorim. Il sughero del futuro, un po prima. La sola analisi di laboratorio, non può assicurare il massimo risultato raggiungibile nella tappatura, in quanto,
IL SERVIZIO DELLA BIRRA
 IL SERVIZIO DELLA BIRRA 1. LA SCHIUMA Rappresenta una specie di filtro naturale del prodotto. Infatti protegge le molecole aromatiche dalle ossidazioni e amplifica le caratteristiche della birra stessa.
IL SERVIZIO DELLA BIRRA 1. LA SCHIUMA Rappresenta una specie di filtro naturale del prodotto. Infatti protegge le molecole aromatiche dalle ossidazioni e amplifica le caratteristiche della birra stessa.
DICHTOMATIK. Istruzioni per la progettazione delle sedi. Tenuta statica
 DICHTOMATIK Istruzioni per la progettazione delle sedi Se possibile, le sedi per installazione (cave) degli O-Ring dovrebbero essere con angoli retti. Le dimensioni di pro fon dità e larghezza richieste
DICHTOMATIK Istruzioni per la progettazione delle sedi Se possibile, le sedi per installazione (cave) degli O-Ring dovrebbero essere con angoli retti. Le dimensioni di pro fon dità e larghezza richieste
L apertura se a cavatappi
 L apertura se a cavatappi Il gesto di stappare una bottiglia se a rinunciare al sughero Si chiama HELIX ed è la soluzione innovativa pensata per i vini di rapido consumo voluta da due leader internazionali
L apertura se a cavatappi Il gesto di stappare una bottiglia se a rinunciare al sughero Si chiama HELIX ed è la soluzione innovativa pensata per i vini di rapido consumo voluta da due leader internazionali
POMPE CENTRIFUGHE IN MATERIALI PLASTICI RESISTENTI ALLA CORROSIONE
 via Torino 12 Tel + 39 (0) 11 913 90 63 10032 Brandizzo To Italy Fax + 39 (0) 11 913 73 13 www.savinobarbera.com info@savinobarbera.com POMPE CENTRIFUGHE IN MATERIALI PLASTICI RESISTENTI ALLA CORROSIONE
via Torino 12 Tel + 39 (0) 11 913 90 63 10032 Brandizzo To Italy Fax + 39 (0) 11 913 73 13 www.savinobarbera.com info@savinobarbera.com POMPE CENTRIFUGHE IN MATERIALI PLASTICI RESISTENTI ALLA CORROSIONE
NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE
 NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE D R. F L A V I A N A C A L I G N A NO D R. M A S S I M O L O R U S S O D R. I G N A Z I O R O P P O L O N Y LO N - C A R BON PROVE DI DUREZZA E DI TRAZIONE INTRODUZIONE
NYLON-CARBON DUREZZA & TRAZIONE D R. F L A V I A N A C A L I G N A NO D R. M A S S I M O L O R U S S O D R. I G N A Z I O R O P P O L O N Y LO N - C A R BON PROVE DI DUREZZA E DI TRAZIONE INTRODUZIONE
Settore Ricerca & Sviluppo
 La Cismondi S.r.l. è stata iscritta nell albo dei laboratori altamente qualificati dal Ministero dell Università e della Ricerca scientifica con Decreto n. 2326. Settore Ricerca & Sviluppo DATI del COMMITTENTE
La Cismondi S.r.l. è stata iscritta nell albo dei laboratori altamente qualificati dal Ministero dell Università e della Ricerca scientifica con Decreto n. 2326. Settore Ricerca & Sviluppo DATI del COMMITTENTE
IIL COLLAUDO NELLE CONDOTTE NON IN PRESSIONE
 IIL COLLAUDO NELLE CONDOTTE NON IN PRESSIONE Scopo del collaudo (ad aria o ad acqua) e quello di verificare l efficienza e la funzionalità idraulica di un collettore posato in opera. In particolare si
IIL COLLAUDO NELLE CONDOTTE NON IN PRESSIONE Scopo del collaudo (ad aria o ad acqua) e quello di verificare l efficienza e la funzionalità idraulica di un collettore posato in opera. In particolare si
RAPPORTO DI PROVA R
 RAPPORTO DI PROVA DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE, DELLA RESISTENZA AL GELO E DELLA RESISTENZA A FLESSIONE AL TERMINE DEI 100 CICLI DI GELO/DISGELO DEL PRODOTTO COTTO DI FORNACE DELLA DITTA
RAPPORTO DI PROVA DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE, DELLA RESISTENZA AL GELO E DELLA RESISTENZA A FLESSIONE AL TERMINE DEI 100 CICLI DI GELO/DISGELO DEL PRODOTTO COTTO DI FORNACE DELLA DITTA
Istruzioni per il montaggio
 Istruzioni per il montaggio Indicazioni importanti sulle Istruzioni per il montaggio VOSS Per ottenere dai prodotti VOSS un rendimento ottimale e la massima sicurezza di funzionamento, è importante rispettare
Istruzioni per il montaggio Indicazioni importanti sulle Istruzioni per il montaggio VOSS Per ottenere dai prodotti VOSS un rendimento ottimale e la massima sicurezza di funzionamento, è importante rispettare
GLI IMPIANTI DI SCARICO INDICAZIONI, VINCOLI E REQUISITI DI PROGETTAZIONE
 GLI IMPIANTI DI SCARICO INDICAZIONI, VINCOLI E REQUISITI DI PROGETTAZIONE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per la progettazione degli impianti di scarico si fa riferimento alla normativa europea composta da
GLI IMPIANTI DI SCARICO INDICAZIONI, VINCOLI E REQUISITI DI PROGETTAZIONE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per la progettazione degli impianti di scarico si fa riferimento alla normativa europea composta da
LA SALDATURA A SCINTILLIO SECONDO EN Bologna, 03/11/2016 Amedeo Iafrati
 LA SALDATURA A SCINTILLIO SECONDO EN 14587-2 Bologna, 03/11/2016 Amedeo Iafrati LA SALDATURA A SCINTILLIO SECONDO EN 14587-2 RFI CON L ISTRUZIONE TECNICA RFI TCAR ST AR 07 001B REVISIONATA IL 02/09/2015
LA SALDATURA A SCINTILLIO SECONDO EN 14587-2 Bologna, 03/11/2016 Amedeo Iafrati LA SALDATURA A SCINTILLIO SECONDO EN 14587-2 RFI CON L ISTRUZIONE TECNICA RFI TCAR ST AR 07 001B REVISIONATA IL 02/09/2015
Storia e Competenze 3
 2 Il Sugherificio Reggiano srl è un azienda certificata ISO 90001:2000 ed è in possesso del certificato di conformità C.E.LIEGE, certificazioni rilasciate da Bureau Veritas Italia. L oggetto sociale è
2 Il Sugherificio Reggiano srl è un azienda certificata ISO 90001:2000 ed è in possesso del certificato di conformità C.E.LIEGE, certificazioni rilasciate da Bureau Veritas Italia. L oggetto sociale è
Profili laminati di alta qualità
 L'acciaio antiusura Profili laminati di alta qualità STEEL FOR LIFE WARRANTY ESTRONG è un acciaio legato a basso contenuto di Carbonio e con elevati tenori di Boro, Molibdeno e Nichel, tali da ottimizzare
L'acciaio antiusura Profili laminati di alta qualità STEEL FOR LIFE WARRANTY ESTRONG è un acciaio legato a basso contenuto di Carbonio e con elevati tenori di Boro, Molibdeno e Nichel, tali da ottimizzare
MANUALE DI ASSISTENZA PER UNA CORRETTA REGOLAZIONE DELLA TESTA CAPSULATRICE PER L IMBOTTIGLIAMENTO CON TAPPI A VITE
 MANUALE DI ASSISTENZA PER UNA CORRETTA REGOLAZIONE DELLA TESTA CAPSULATRICE PER L IMBOTTIGLIAMENTO CON TAPPI A VITE Impronta testa Durante la tappatura la prima operazione che la testa capsulatrice effettua
MANUALE DI ASSISTENZA PER UNA CORRETTA REGOLAZIONE DELLA TESTA CAPSULATRICE PER L IMBOTTIGLIAMENTO CON TAPPI A VITE Impronta testa Durante la tappatura la prima operazione che la testa capsulatrice effettua
ATTREZZATURA DI LABORATORIO
 ATTREZZATURA DI LABORATORIO Le attrezzature e gli utensili che si trovano in un laboratorio chimico possono essere di materiale diverso: porcellana, plastica, sughero, gomma, vetro. Il vetro Parlando di
ATTREZZATURA DI LABORATORIO Le attrezzature e gli utensili che si trovano in un laboratorio chimico possono essere di materiale diverso: porcellana, plastica, sughero, gomma, vetro. Il vetro Parlando di
Esercitazione 2 Ciclo a vapore a recupero
 Esercitazione 2 Ciclo a vapore a recupero Lo scopo di questa esercitazione è la progettazione di un ciclo a recupero: l impianto è composto da un ciclo a vapore ad un livello di pressione che utilizza
Esercitazione 2 Ciclo a vapore a recupero Lo scopo di questa esercitazione è la progettazione di un ciclo a recupero: l impianto è composto da un ciclo a vapore ad un livello di pressione che utilizza
Scheda tecnica. Raccordi filettati in Ghisa Malleabile
 Scheda tecnica Raccordi filettati in Ghisa Malleabile Raccordi filettati in ghisa malleabile Normativa del prodotto e campo di applicazione I raccordi sono conformi alla norma EN 10242:1994 simbolo del
Scheda tecnica Raccordi filettati in Ghisa Malleabile Raccordi filettati in ghisa malleabile Normativa del prodotto e campo di applicazione I raccordi sono conformi alla norma EN 10242:1994 simbolo del
Nitrati e irrigazione
 Lisciviazione (kg ha -1 N-NO3) Irrigazioni (m 3 ha -1 ) Nitrati e irrigazione L irrigazione può diventare una pratica colturale in grado di influenzare negativamente l ambiente mediante il movimento dell'acqua
Lisciviazione (kg ha -1 N-NO3) Irrigazioni (m 3 ha -1 ) Nitrati e irrigazione L irrigazione può diventare una pratica colturale in grado di influenzare negativamente l ambiente mediante il movimento dell'acqua
Guida per un corretto utilizzo di SUPERCAP
 Guida per un corretto utilizzo di SUPERCAP 1-2 - 3 - TAPPI VINO PREMESSA Data la variabilità delle tipologie dei vini, dei processi di produzione e di imbottigliamento, il tappo SUPERCAP deve essere utilizzato
Guida per un corretto utilizzo di SUPERCAP 1-2 - 3 - TAPPI VINO PREMESSA Data la variabilità delle tipologie dei vini, dei processi di produzione e di imbottigliamento, il tappo SUPERCAP deve essere utilizzato
La smussatura di ingranaggi con grande modulo
 La smussatura di ingranaggi con grande modulo I metodi di smussatura normalmente usati per ingranaggi di modulo fino a 6-8 mm prodotti in lotti non troppo piccoli, usano utensili che lavorano per compressione
La smussatura di ingranaggi con grande modulo I metodi di smussatura normalmente usati per ingranaggi di modulo fino a 6-8 mm prodotti in lotti non troppo piccoli, usano utensili che lavorano per compressione
INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE
 INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE 1. Principio di funzionamento 2. Metodi di misura con le termocoppie 3. Costruzione delle Termocoppie 4. Termocoppie ad isolamento tradizionale 5. Termocoppie ad isolamento
INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE 1. Principio di funzionamento 2. Metodi di misura con le termocoppie 3. Costruzione delle Termocoppie 4. Termocoppie ad isolamento tradizionale 5. Termocoppie ad isolamento
PROCEDURE GENERALI PER LA STERILIZZAZIONE DI CARTUCCE FILTRANTI NEL SETTORE FARMACEUTICO E COSMETICO
 - PROCEDURE GENERALI PER LA STERILIZZAZIONE DI CARTUCCE FILTRANTI NEL SETTORE FARMACEUTICO E COSMETICO R&D Maggio 2008 Pagina 1 di 4 INDICE Procedure generali per la sterilizzazione in linea di cartucce
- PROCEDURE GENERALI PER LA STERILIZZAZIONE DI CARTUCCE FILTRANTI NEL SETTORE FARMACEUTICO E COSMETICO R&D Maggio 2008 Pagina 1 di 4 INDICE Procedure generali per la sterilizzazione in linea di cartucce
LA 1 a LEGGE DI VOLTA E GAY LUSSAC O DELLE ISOBARICHE
 1 LA 1 a LEGGE DI VOLTA E GAY LUSSAC O DELLE ISOBARICHE L energia si presenta in diverse forme e una delle più importanti è il calore. I fenomeni naturali sono quasi sempre accompagnati da sviluppo o assorbimento
1 LA 1 a LEGGE DI VOLTA E GAY LUSSAC O DELLE ISOBARICHE L energia si presenta in diverse forme e una delle più importanti è il calore. I fenomeni naturali sono quasi sempre accompagnati da sviluppo o assorbimento
Prove sperimentali a rottura di travi rettangolari in cemento armato con staffatura tipo Spirex e staffatura tradizionale
 Università degli Studi di Firenze DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE LABORATORIO PROVE STRUTTURE E MATERIALI Via di Santa Marta, 3-50139 Firenze Prove sperimentali a rottura di travi rettangolari
Università degli Studi di Firenze DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE LABORATORIO PROVE STRUTTURE E MATERIALI Via di Santa Marta, 3-50139 Firenze Prove sperimentali a rottura di travi rettangolari
Documento n. 3 Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale di macchine irroratrici in uso per colture erbacee
 Documento n. 3 Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale di macchine irroratrici in uso per colture erbacee A cura del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento Nazionale
Documento n. 3 Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale di macchine irroratrici in uso per colture erbacee A cura del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento Nazionale
I CALCESTRUZZI CELLULARI NELLE APPLICAZIONI DI INGEGNERIA GEOTECNICA: CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale Corso di Laurea Triennale in: INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale Corso di Laurea Triennale in: INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED
TRATTAMENTI TERMICI DEI MATERIALI FERROSI
 TRATTAMENTI TERMICI DEI MATERIALI FERROSI Tempra Processi di tempra A seconda di come viene eseguito il trattamento, consentono di ottenere: un cambiamento di struttura totale a temperatura ambiente con
TRATTAMENTI TERMICI DEI MATERIALI FERROSI Tempra Processi di tempra A seconda di come viene eseguito il trattamento, consentono di ottenere: un cambiamento di struttura totale a temperatura ambiente con
Valutazione del rischio per i lavori su coperture
 CONVEGNO NAZIONALE I lavori su coperture Valutazione del rischio per i lavori su coperture Luca Rossi 8 ottobre 2011 Sala Large Gallery Hall 22-25 Bolognafiere, Quartiere Fieristico Programma Introduzione
CONVEGNO NAZIONALE I lavori su coperture Valutazione del rischio per i lavori su coperture Luca Rossi 8 ottobre 2011 Sala Large Gallery Hall 22-25 Bolognafiere, Quartiere Fieristico Programma Introduzione
Lezioni del Corso di Fondamenti di Metrologia
 Facoltà di Ingegneria Lezioni del Corso di Fondamenti di Metrologia 11. Taratura nel settore dimensionale Indice Taratura di Calibri (UNI 9313) Taratura di comparatori (UNI 9191) Taratura di micrometri
Facoltà di Ingegneria Lezioni del Corso di Fondamenti di Metrologia 11. Taratura nel settore dimensionale Indice Taratura di Calibri (UNI 9313) Taratura di comparatori (UNI 9191) Taratura di micrometri
IL CAMPIONAMENTO DI GAS DALLE FUMAROLE (CON FIORETTO E AMPOLLA A SODA)
 IL CAMPIONAMENTO DI GAS DALLE FUMAROLE (CON FIORETTO E AMPOLLA A SODA) PREMESSA La sorveglianza dei vulcani nel corso degli anni ha sviluppato le proprie tecniche con l ausilio delle nuove tecnologie.
IL CAMPIONAMENTO DI GAS DALLE FUMAROLE (CON FIORETTO E AMPOLLA A SODA) PREMESSA La sorveglianza dei vulcani nel corso degli anni ha sviluppato le proprie tecniche con l ausilio delle nuove tecnologie.
LA TENUTA ALLA PRESSIONE DEL TAPPO DA. elastica. b. Effetto tappo corona. c. Tenuta alla trasmissione del gas
 A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
sul prodotto TECNOPAINT SPECIAL del Colorificio A. & B. CASATI S.p.a. via Valpantena, 59/b Poiano (VR)
 U NIVERSITA CATTOLICA DEL S ACRO C UORE F ACOLTA DI A GRARIA - PIACENZA ISTITUTO DI ENOLOGIA E INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE Piacenza, 5 maggio 2008 RAPPORTO DI PROVA N 63/2008 sul prodotto TECNOPAINT SPECIAL
U NIVERSITA CATTOLICA DEL S ACRO C UORE F ACOLTA DI A GRARIA - PIACENZA ISTITUTO DI ENOLOGIA E INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE Piacenza, 5 maggio 2008 RAPPORTO DI PROVA N 63/2008 sul prodotto TECNOPAINT SPECIAL
LUOGO E DATA DI EMISSIONE: Faenza, 29/08/2014 TIPO DI PRODOTTO: NORMATIVE APPLICATE: UNI EN 1339 DATA RICEVIMENTO CAMPIONI: 11/07/2014
 CertiMaC soc.cons. a r.l. Via Granarolo, 62 48018 Faenza RA Italy tel. +39 0546 670363 fax +39 0546 670399 www.certimac.it info@certimac.it R.I. RA, partita iva e codice fiscale 02200460398 R.E.A. RA 180280
CertiMaC soc.cons. a r.l. Via Granarolo, 62 48018 Faenza RA Italy tel. +39 0546 670363 fax +39 0546 670399 www.certimac.it info@certimac.it R.I. RA, partita iva e codice fiscale 02200460398 R.E.A. RA 180280
Precisione di misura
 Precisione di misura Valori energetici e Grado di rendimento per Inverter FV Sunny Boy e Sunny Mini Central Contenuto Qualsiasi utente desidera essere informato al meglio sulla potenza e il rendimento
Precisione di misura Valori energetici e Grado di rendimento per Inverter FV Sunny Boy e Sunny Mini Central Contenuto Qualsiasi utente desidera essere informato al meglio sulla potenza e il rendimento
MANUALE DI TAPPATURA PER VINI SPUMANTI
 A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
Impianti di propulsione navale
 Motori diesel 4T Interfacce con il sistema nave Ogni motore installato a bordo ha sostanzialmente quattro tipologie di interfacce con la nave, precisamente: Trasmissione potenza: collegamento meccanico
Motori diesel 4T Interfacce con il sistema nave Ogni motore installato a bordo ha sostanzialmente quattro tipologie di interfacce con la nave, precisamente: Trasmissione potenza: collegamento meccanico
sul prodotto INTONACO RASANTE del Colorificio A. & B. CASATI S.p.a. via Valpantena, 59/b Poiano (VR)
 U NIVERSITA CATTOLICA DEL S ACRO C UORE F ACOLTA DI A GRARIA - PIACENZA ISTITUTO DI ENOLOGIA E INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE Piacenza, 5 maggio 2008 RAPPORTO DI PROVA N 70/2008 sul prodotto INTONACO RASANTE
U NIVERSITA CATTOLICA DEL S ACRO C UORE F ACOLTA DI A GRARIA - PIACENZA ISTITUTO DI ENOLOGIA E INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE Piacenza, 5 maggio 2008 RAPPORTO DI PROVA N 70/2008 sul prodotto INTONACO RASANTE
GAMMA ISOLANTE ISOSTIF
 CARATTERISTICHE FISICHE DELLA GAMMA ISOLANTE ISOSTIF Conduttività termica (λ). Resistenza e Trasmittanza termica. La prestazione termica di una parete, pavimentazione o copertura, intesa come calcolo del
CARATTERISTICHE FISICHE DELLA GAMMA ISOLANTE ISOSTIF Conduttività termica (λ). Resistenza e Trasmittanza termica. La prestazione termica di una parete, pavimentazione o copertura, intesa come calcolo del
SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI :2007
 SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI 11240-1:2007 Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Prodotti
SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI 11240-1:2007 Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Prodotti
IL TAGLIO ORBITALE DELLE VITI SENZA FINE UNA TECNOLOGIA ECOSOSTENIBILE
 IL TAGLIO ORBITALE DELLE VITI SENZA FINE UNA TECNOLOGIA ECOSOSTENIBILE Marco Benincasa (Benincasa Meccanica) Giampaolo Giacomozzi (Varvel SpA) Massimiliano Turci (Studio Tecnico Turci) Riduttori a vite
IL TAGLIO ORBITALE DELLE VITI SENZA FINE UNA TECNOLOGIA ECOSOSTENIBILE Marco Benincasa (Benincasa Meccanica) Giampaolo Giacomozzi (Varvel SpA) Massimiliano Turci (Studio Tecnico Turci) Riduttori a vite
Lista di controllo Allegato 03 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC
 CO.RE.CO VENETO Indicazioni per stesura DVR STD Versione 2012 Lista di controllo Allegato 03 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC SE RISPONDE Sì: CONTINUARE CON LA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DELL ATTIVITÀ
CO.RE.CO VENETO Indicazioni per stesura DVR STD Versione 2012 Lista di controllo Allegato 03 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC SE RISPONDE Sì: CONTINUARE CON LA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DELL ATTIVITÀ
Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie
 Dicembre 2016 Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie Le falegnamerie sono impianti di lavorazione del legno, solitamente rappresentati da capannoni industriali, nei quali una serie di
Dicembre 2016 Zone a rischio di esplosione e incendio: le falegnamerie Le falegnamerie sono impianti di lavorazione del legno, solitamente rappresentati da capannoni industriali, nei quali una serie di
Profili laminati di alta qualità
 L'acciaio antiusura Profili laminati di alta qualità ESTRONG è un acciaio legato a basso contenuto di Carbonio e con elevati tenori di Boro, Molibdeno e Nichel, tali da ottimizzare le caratteristiche meccaniche
L'acciaio antiusura Profili laminati di alta qualità ESTRONG è un acciaio legato a basso contenuto di Carbonio e con elevati tenori di Boro, Molibdeno e Nichel, tali da ottimizzare le caratteristiche meccaniche
Lista di controllo Allegato 03 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC
 CO.RE.CO VENETO Indicazioni per stesura DVR STD Versione 2012 Lista di controllo Allegato 03 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC SE RISPONDE Sì: CONTINUARE CON LA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DELL ATTIVITÀ
CO.RE.CO VENETO Indicazioni per stesura DVR STD Versione 2012 Lista di controllo Allegato 03 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC SE RISPONDE Sì: CONTINUARE CON LA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DELL ATTIVITÀ
Accumulatori inerziali per acqua refrigerata Manuale d uso e manutenzione
 Trade-Mark TM I S SAR 200 I S SAR 300 I S SAR 500 I S SAR 800 I S SAR 1000 Accumulatori inerziali per acqua refrigerata Manuale d uso e manutenzione Cod. 122958 Agg. 14.10.2014 Indice 1. Informazioni di
Trade-Mark TM I S SAR 200 I S SAR 300 I S SAR 500 I S SAR 800 I S SAR 1000 Accumulatori inerziali per acqua refrigerata Manuale d uso e manutenzione Cod. 122958 Agg. 14.10.2014 Indice 1. Informazioni di
f yd = f yk ; s 0, 7 f yk calcestruzzo armato. Le caratteristiche degli acciai, conformi con le Norme Tecniche, vengono presentate più avanti.
 Acciaio per cemento armato ordinario. Le barre di armatura sono caratterizzate dal diametro della barra tonda equipesante, calcolato nell ipotesi che il peso specifico dell acciaio sia 7850 kg/m 3. Secondo
Acciaio per cemento armato ordinario. Le barre di armatura sono caratterizzate dal diametro della barra tonda equipesante, calcolato nell ipotesi che il peso specifico dell acciaio sia 7850 kg/m 3. Secondo
Università degli Studi di Cassino Facoltà di Ingegneria. Lezioni del Corso di Misure Meccaniche e Termiche. G.04 La Conferma Metrologica
 Facoltà di Ingegneria Lezioni del Corso di Misure Meccaniche e Termiche G.04 La Conferma Metrologica Il termine Conferma metrologica non è presente nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per conoscere il
Facoltà di Ingegneria Lezioni del Corso di Misure Meccaniche e Termiche G.04 La Conferma Metrologica Il termine Conferma metrologica non è presente nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per conoscere il
4.11 CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE
 Unione Industriale 61 di 94 4.11 CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PER PROVA, MISURAZIONE E COLLAUDO 4.11.1 Generalità Il capitolo indica le modalità con cui devono essere gestite le apparecchiature di controllo,
Unione Industriale 61 di 94 4.11 CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PER PROVA, MISURAZIONE E COLLAUDO 4.11.1 Generalità Il capitolo indica le modalità con cui devono essere gestite le apparecchiature di controllo,
1. Introduzione 1.1 Scopo della tesi
 1. Introduzione 1.1 Scopo della tesi Fluidizzare un letto di particelle solide con un gas è un ottima tecnica per assicurare il mescolamento delle particelle ed il contatto intimo tra le due fasi. Di conseguenza,
1. Introduzione 1.1 Scopo della tesi Fluidizzare un letto di particelle solide con un gas è un ottima tecnica per assicurare il mescolamento delle particelle ed il contatto intimo tra le due fasi. Di conseguenza,
SCHEDA 8A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A RUOTE A CARREGGIATA STANDARD MODELLO SAME CENTAURO
 SCHEDA 8A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A RUOTE A CARREGGIATA STANDARD MODELLO SAME CENTAURO Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione stipulata
SCHEDA 8A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A RUOTE A CARREGGIATA STANDARD MODELLO SAME CENTAURO Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione stipulata
Nozioni di base sui cuscinetti volventi
 Nozioni di base sui cuscinetti volventi Montaggio e smontaggio Operazioni preliminari Premesse Immagazzinamento Piano di lavoro Il cuscinetto esatto Pulizia del luogo di montaggio Pag. 2 Immagazzinamento
Nozioni di base sui cuscinetti volventi Montaggio e smontaggio Operazioni preliminari Premesse Immagazzinamento Piano di lavoro Il cuscinetto esatto Pulizia del luogo di montaggio Pag. 2 Immagazzinamento
TORRI EVAPORATIVE. Separatori di gocce a pannello in PVC DEC 130, DES 130, DES 130 Max, Blade. Riempimenti in PVC FMC 12, FMC 19, FMC 27 e FMV 21
 TORRI EVAPORATIVE Refill-tech solutions S.r.l. produce riempimenti sintetici e separatori di gocce per diversi settori industriali tra cui le Torri Evaporative. La gamma di prodotti per queste applicazioni
TORRI EVAPORATIVE Refill-tech solutions S.r.l. produce riempimenti sintetici e separatori di gocce per diversi settori industriali tra cui le Torri Evaporative. La gamma di prodotti per queste applicazioni
Utensili rullatori. Tecnologia della rullatura. Vantaggi della rullatura DREX -TOOLS UTENSILI RULLATORI
 Utensili rullatori La DREX -TOOLS vanta sin dal 1980 una solida esperienza nel settore della rullatura. L azienda, con il supporto di personale tecnico di vasta esperienza, ha creato una nuova linea di
Utensili rullatori La DREX -TOOLS vanta sin dal 1980 una solida esperienza nel settore della rullatura. L azienda, con il supporto di personale tecnico di vasta esperienza, ha creato una nuova linea di
sul prodotto HOBBY CASA del Colorificio A. & B. CASATI S.p.a. via Valpantena, 59/b Poiano (VR)
 U NIVERSITA CATTOLICA DEL S ACRO C UORE F ACOLTA DI A GRARIA - PIACENZA ISTITUTO DI ENOLOGIA E INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE Piacenza, 5 maggio 2008 RAPPORTO DI PROVA N 72/2008 sul prodotto HOBBY CASA del
U NIVERSITA CATTOLICA DEL S ACRO C UORE F ACOLTA DI A GRARIA - PIACENZA ISTITUTO DI ENOLOGIA E INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE Piacenza, 5 maggio 2008 RAPPORTO DI PROVA N 72/2008 sul prodotto HOBBY CASA del
FORNI DA PRERISCALDO MATRICI
 FORNI DA PRERISCALDO MATRICI FORNI INDUSTRIALI & TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO TERMICO 1402 ALBAPLANT Società specializzata nella produzione di forni industriali; progetta e realizza forni e linee per
FORNI DA PRERISCALDO MATRICI FORNI INDUSTRIALI & TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO TERMICO 1402 ALBAPLANT Società specializzata nella produzione di forni industriali; progetta e realizza forni e linee per
addirittura, prima ancora di poter caricare il veicolo, bisogna verificare le effettive proprietà e caratteristiche di quest ultimo.
 2. Struttura del veicolo e dispositivi per il bloccaggio del carico Occorre tenere nella debita considerazione le caratteristiche tecniche dei veicoli e dei dispositivi di bloccaggio. Anche se esistono
2. Struttura del veicolo e dispositivi per il bloccaggio del carico Occorre tenere nella debita considerazione le caratteristiche tecniche dei veicoli e dei dispositivi di bloccaggio. Anche se esistono
Applicazioni Industriali
 Applicazioni Industriali Stampaggio a freddo - Tranciatura Marco Raimondi e-mail: mraimondi@liuc.it Lavorazione a freddo delle lamiere È il processo più diffuso per la produzione di grande serie di componentistica
Applicazioni Industriali Stampaggio a freddo - Tranciatura Marco Raimondi e-mail: mraimondi@liuc.it Lavorazione a freddo delle lamiere È il processo più diffuso per la produzione di grande serie di componentistica
SCHEDA 12A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A RUOTE A CARREGGIATA STANDARD MODELLO FIAT 411R E SIMILI (FIAT 312R, etc.)
 SCHEDA 12A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A RUOTE A CARREGGIATA STANDARD MODELLO FIAT 411R E SIMILI (FIAT 312R, etc.) Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista:
SCHEDA 12A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A RUOTE A CARREGGIATA STANDARD MODELLO FIAT 411R E SIMILI (FIAT 312R, etc.) Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista:
La qualità dei tappi di sughero
 La qualità dei tappi di sughero Franco Pampiro, Maria Giua, Giovanni Antonio Farris Alla Ricerca della qualità nella filiera sughero-vino Oristano 12 maggio 2006 - Auditorium di San Domenico Le prestazioni
La qualità dei tappi di sughero Franco Pampiro, Maria Giua, Giovanni Antonio Farris Alla Ricerca della qualità nella filiera sughero-vino Oristano 12 maggio 2006 - Auditorium di San Domenico Le prestazioni
Istruzioni per il montaggio
 Istruzioni per il montaggio Indicazioni importanti sulle Istruzioni per il montaggio VOSS Per ottenere dai prodotti VOSS un rendimento ottimale e la massima sicurezza di funzionamento, è importante rispettare
Istruzioni per il montaggio Indicazioni importanti sulle Istruzioni per il montaggio VOSS Per ottenere dai prodotti VOSS un rendimento ottimale e la massima sicurezza di funzionamento, è importante rispettare
Lezione Il calcestruzzo armato I
 Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato
 Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato Effetti generali dell incendio a) Distribuzione della temperatura nelle strutture. Una distribuzione di temperatura non uniforme con differenze di dilatazione
Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato Effetti generali dell incendio a) Distribuzione della temperatura nelle strutture. Una distribuzione di temperatura non uniforme con differenze di dilatazione
CO 2 supercritica: La nuova microgranina di sughero a zero contaminazioni
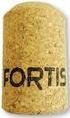 CO 2 supercritica: La nuova microgranina di sughero a zero contaminazioni Verona PIANTA DE PRODUZIONE FORTIS FORTISMIX FORTISWINE NUOVE TECNOLOGIE CO2 SUPERCRITICA Fondamenti della tecnologia dei fluidi
CO 2 supercritica: La nuova microgranina di sughero a zero contaminazioni Verona PIANTA DE PRODUZIONE FORTIS FORTISMIX FORTISWINE NUOVE TECNOLOGIE CO2 SUPERCRITICA Fondamenti della tecnologia dei fluidi
Il nuovo orizzonte del legno ISTRUZIONI DI POSA REV SISTEMA RIVESTIMENTO PARETE NOVOWOOD (DOGHE 127x15)
 Il nuovo orizzonte del legno ISTRUZIONI DI POSA REV. 1.1-10.16 SISTEMA RIVESTIMENTO PARETE NOVOWOOD (DOGHE 127x15) ELENCO DEI MATERIALI DA IMPIEGARE DOGHE 127x15x2000mm cod. 127H15 UTILIZZO MEDIO A m2
Il nuovo orizzonte del legno ISTRUZIONI DI POSA REV. 1.1-10.16 SISTEMA RIVESTIMENTO PARETE NOVOWOOD (DOGHE 127x15) ELENCO DEI MATERIALI DA IMPIEGARE DOGHE 127x15x2000mm cod. 127H15 UTILIZZO MEDIO A m2
Il cono d affilatura nelle punte elicoidali. Riprendendo la figura N 1 della descrizione generale, si possono dare le seguenti definizioni:
 Il cono d affilatura nelle punte elicoidali Riprendendo la figura N 1 della descrizione generale, si possono dare le seguenti definizioni: Fig.N 1- Alcuni angoli caratteristici della punta elicoidale ε
Il cono d affilatura nelle punte elicoidali Riprendendo la figura N 1 della descrizione generale, si possono dare le seguenti definizioni: Fig.N 1- Alcuni angoli caratteristici della punta elicoidale ε
Manuale d Uso e Manutenzione
 Pompa proporzionale Manuale d Uso e Manutenzione 33 Manuale d uso MixRite è azionato dal flusso dell acqua, con una minima perdita di carico. Non sono richieste sorgenti esterne di energia. L unità inietta
Pompa proporzionale Manuale d Uso e Manutenzione 33 Manuale d uso MixRite è azionato dal flusso dell acqua, con una minima perdita di carico. Non sono richieste sorgenti esterne di energia. L unità inietta
COMPARATORE 1/100 COMPARATORE GRADUATO
 COMPARATORE 1/100 CLASSIFICAZIONE DELLO STRUMENTO: COMPARATORE GRADUATO Avente una approssimazione di 0,01 mm ESIGENZE DI VERIFICA: E utilizzato per il controllo di errori di forma dei pezzi e per misurazioni
COMPARATORE 1/100 CLASSIFICAZIONE DELLO STRUMENTO: COMPARATORE GRADUATO Avente una approssimazione di 0,01 mm ESIGENZE DI VERIFICA: E utilizzato per il controllo di errori di forma dei pezzi e per misurazioni
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV Prof. Dott. Bernhard Elsener
 Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
LABORATORIO DI MECCANICA AGRARIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIE
 LABORATORIO DI MECCANICA AGRARIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIE Certificato di prova eseguita secondo le prescrizioni del Codice OCSE per la prove ufficiali delle strutture di protezione
LABORATORIO DI MECCANICA AGRARIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIE Certificato di prova eseguita secondo le prescrizioni del Codice OCSE per la prove ufficiali delle strutture di protezione
SCHEDA 13A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO FIAT 411C E SIMILI (FIAT 451C, FIAT 455C, etc.)
 SCHEDA 13A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO FIAT 411C E SIMILI (FIAT 451C, FIAT 455C, etc.) Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione
SCHEDA 13A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO FIAT 411C E SIMILI (FIAT 451C, FIAT 455C, etc.) Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione
Tabella riepilogativa delle composizioni acustiche DESCRIZIONE
 DESCRIZIONE Le vetrate isolanti a protezione acustica e basso emissive sono state studiate per migliorare le prestazioni sotto il profilo dell isolamento acustico combinandole con il comfort dell isolamento
DESCRIZIONE Le vetrate isolanti a protezione acustica e basso emissive sono state studiate per migliorare le prestazioni sotto il profilo dell isolamento acustico combinandole con il comfort dell isolamento
SCHEDA 30A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO LAMBORGHINI C674 E SIMILI
 SCHEDA 30A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO LAMBORGHINI C674 E SIMILI Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione stipulata dalla
SCHEDA 30A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A CINGOLI MODELLO LAMBORGHINI C674 E SIMILI Il presente documento è stato realizzato nell ambito dell attività di ricerca prevista: dalla convenzione stipulata dalla
IV Convegno Nazionale SICUREZZA ED ESERCIZIO FERROVIARIO
 IV Convegno Nazionale SICUREZZA ED ESERCIZIO FERROVIARIO Soluzioni e Strategie per lo Sviluppo del Trasporto Ferroviario Roma, 2 Ottobre 2015 Tecniche di misura sperimentali per la determinazione delle
IV Convegno Nazionale SICUREZZA ED ESERCIZIO FERROVIARIO Soluzioni e Strategie per lo Sviluppo del Trasporto Ferroviario Roma, 2 Ottobre 2015 Tecniche di misura sperimentali per la determinazione delle
BILANCIAMENTO STATICO DELLA PORTATA Valvole manuali
 FOCUS TECNICO Bilanciamento parte 2 BILANCIAMENTO STATICO DELLA PORTATA Valvole manuali Le valvole manuali vengono utilizzate per effettuare il bilanciamento statico dell impianto. Per svolgere questa
FOCUS TECNICO Bilanciamento parte 2 BILANCIAMENTO STATICO DELLA PORTATA Valvole manuali Le valvole manuali vengono utilizzate per effettuare il bilanciamento statico dell impianto. Per svolgere questa
THIXOESTRUSIONE DI LEGHE DI ALLUMINIO
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI THIXOESTRUSIONE DI LEGHE DI ALLUMINIO Relatore: Ing. ANNALISA POLA Correlatore: Ing. ALBERTO ARRIGHINI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI THIXOESTRUSIONE DI LEGHE DI ALLUMINIO Relatore: Ing. ANNALISA POLA Correlatore: Ing. ALBERTO ARRIGHINI
CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI DI FORMATURA PLASTICA
 CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI DI FORMATURA PLASTICA 1 CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI DI FORMATURA PLASTICA Condotta facendo riferimento ad alcuni elementi caratteristici dei processi: temperatura alla quale
CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI DI FORMATURA PLASTICA 1 CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI DI FORMATURA PLASTICA Condotta facendo riferimento ad alcuni elementi caratteristici dei processi: temperatura alla quale
Caratterizzazione dei depositi PVD
 P&P Thin Film Advanced Technologies Caratterizzazione dei depositi PVD Principali parametri e strumenti per la definizione delle caratteristiche morfologiche e tribologiche dei depositi nel settore decorativo
P&P Thin Film Advanced Technologies Caratterizzazione dei depositi PVD Principali parametri e strumenti per la definizione delle caratteristiche morfologiche e tribologiche dei depositi nel settore decorativo
Contenuti Approfondimento sulle VARIABILI del PROCESSO Pressione Portata Temperatura Tempo di Raffreddamento
 ITIS Giulio Natta Istituto Tecnico Industriale per la meccanica e le materie plastiche - Liceo Scientifico Tecnologico Via XX settembre 14/A - Rivoli TO Tecnologie Materie Plastiche Modulo3 INIEZIONE Lezione
ITIS Giulio Natta Istituto Tecnico Industriale per la meccanica e le materie plastiche - Liceo Scientifico Tecnologico Via XX settembre 14/A - Rivoli TO Tecnologie Materie Plastiche Modulo3 INIEZIONE Lezione
La deformazione plastica. La deformazione plastica. Lavorazioni per deformazione. Il processo di laminazione Estrusione e trafilatura.
 La deformazione plastica La deformazione plastica Lavorazioni per deformazione Il processo di laminazione Estrusione e trafilatura La formatura della lamiera 2 2006 Politecnico di Torino 1 Obiettivi della
La deformazione plastica La deformazione plastica Lavorazioni per deformazione Il processo di laminazione Estrusione e trafilatura La formatura della lamiera 2 2006 Politecnico di Torino 1 Obiettivi della
a) 36/100 b) 1/3 c)
 Da un urna contenente 10 palline, di cui 6 bianche e 4 nere, si estraggono due palline. Determinare la probabilità del seguente evento E=«le due palline sono bianche» nel caso di estrazioni a) con rimbussolamento
Da un urna contenente 10 palline, di cui 6 bianche e 4 nere, si estraggono due palline. Determinare la probabilità del seguente evento E=«le due palline sono bianche» nel caso di estrazioni a) con rimbussolamento
Valvole di zona 2 vie, 3 vie Serie VU02 - VU3 - VU4
 Valvole di zona vie, vie Serie VU0 - VU - VU4 Caratteristiche principali - Disponibili nelle versioni a vie, vie - Con possibilità di raccordo by-pass VU4 - Attacchi femmina DN /4 - - Pesi e ingombri ridotti
Valvole di zona vie, vie Serie VU0 - VU - VU4 Caratteristiche principali - Disponibili nelle versioni a vie, vie - Con possibilità di raccordo by-pass VU4 - Attacchi femmina DN /4 - - Pesi e ingombri ridotti
iglidur J200: Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato
 iglidur : Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Bassa usura anche in ambienti sporchi Per carichi medio-bassi
iglidur : Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Bassa usura anche in ambienti sporchi Per carichi medio-bassi
CADF S.p.A. Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione SCHEMI TECNICI Pagina 20
 SCHEMI TECNICI Pagina 20 SCHEMI TECNICI Pagina 21 SCHEMI TECNICI Pagina 22 DIMENSIONAMENTO DELLE COLONNE E COLLETTORI DI SCARICO (in conformità a norme UNI 12056/01) DETERMINAZIONE DEL CARICO DI ACQUE
SCHEMI TECNICI Pagina 20 SCHEMI TECNICI Pagina 21 SCHEMI TECNICI Pagina 22 DIMENSIONAMENTO DELLE COLONNE E COLLETTORI DI SCARICO (in conformità a norme UNI 12056/01) DETERMINAZIONE DEL CARICO DI ACQUE
Supplemento alle istruzioni di servizio e di montaggio
 Tecnica degli azionamenti \ Automazione \ Integrazione di sistema \ Servizi di assistenza Supplemento alle istruzioni di servizio e di montaggio Riduttori industriali Riduttori a coppia conica e ad ingranaggi
Tecnica degli azionamenti \ Automazione \ Integrazione di sistema \ Servizi di assistenza Supplemento alle istruzioni di servizio e di montaggio Riduttori industriali Riduttori a coppia conica e ad ingranaggi
Istruzioni per volumetriche serie
 Istruzioni per volumetriche serie 8404-8406 PINTOSSI+C S.p.A. Via Ponte Gandovere 43 25064 Gussago BS Italia Tel. +39,030,3733138 fax +39.030.3733140 www.pintossi.it info@pintossi.it Istruzioni di montaggio
Istruzioni per volumetriche serie 8404-8406 PINTOSSI+C S.p.A. Via Ponte Gandovere 43 25064 Gussago BS Italia Tel. +39,030,3733138 fax +39.030.3733140 www.pintossi.it info@pintossi.it Istruzioni di montaggio
SPECIAL. 6x200 LUNGHEZZA (L) DIAMETRO DEL NOCCIOLO
 VITI SPECIAL TPS TORX - CERTIFICATE SPECIFICHE TETTO& VITE SERIE SPECIAL È LA VITE PORTANTE PER LEGNO AD USO PROFESSIONALE DA UTILIZZARSI SENZA PRE-FORO. I sistemi speciali autosvasanti a ridosso della
VITI SPECIAL TPS TORX - CERTIFICATE SPECIFICHE TETTO& VITE SERIE SPECIAL È LA VITE PORTANTE PER LEGNO AD USO PROFESSIONALE DA UTILIZZARSI SENZA PRE-FORO. I sistemi speciali autosvasanti a ridosso della
RIPRENDIAMO DAL MODULO BASE I
 CORSO DI FORMAZIONE (ai sensi art. 37, D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) LA SICUREZZA NELLA SCUOLA CORSO BASE MODULO A 1 PRINCIPALI RISCHI PER IL PERSONALE ATA RIPRENDIAMO DAL MODULO BASE I CONCETTI DI: PERICOLO,
CORSO DI FORMAZIONE (ai sensi art. 37, D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) LA SICUREZZA NELLA SCUOLA CORSO BASE MODULO A 1 PRINCIPALI RISCHI PER IL PERSONALE ATA RIPRENDIAMO DAL MODULO BASE I CONCETTI DI: PERICOLO,
TEORIA DEGLI ERRORI DI MISURA, IL CALCOLO DELLE INCERTEZZE
 TEORIA DEGLI ERRORI DI MISURA, IL CALCOLO DELLE INCERTEZZE Errore di misura è la differenza fra l indicazione fornita dallo strumento e la dimensione vera della grandezza. Supponendo che la grandezza vera
TEORIA DEGLI ERRORI DI MISURA, IL CALCOLO DELLE INCERTEZZE Errore di misura è la differenza fra l indicazione fornita dallo strumento e la dimensione vera della grandezza. Supponendo che la grandezza vera
scaricatori di condensa
 scaricatori di condensa Nel mondo degli scaricatori di condensa, la distribuzione da parte di Oil Service s.r.l. ha raggiunto livelli di tutto rispetto. Gli scaricatori distribuiti da Oil Service s.r.l.
scaricatori di condensa Nel mondo degli scaricatori di condensa, la distribuzione da parte di Oil Service s.r.l. ha raggiunto livelli di tutto rispetto. Gli scaricatori distribuiti da Oil Service s.r.l.
