LA TENUTA ALLA PRESSIONE DEL TAPPO DA. elastica. b. Effetto tappo corona. c. Tenuta alla trasmissione del gas
|
|
|
- Lidia Pagani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero CAPITOLO LA TENUTA ALLA PRESSIONE DEL TAPPO DA SPUMANTE Paragrafi a. Modifica strutturale e deformazione elastica b. Effetto tappo corona c. Tenuta alla trasmissione del gas
2 a. Modifica strutturale e deformazione elastica LA TENUTA ALLA PRESSIONE DEL TAPPO DA SPUMANTE Per l imbottigliamento di vini spumanti (più recentemente anche per alcuni tipi di birra) si utilizza un tipo di tappatura che viene abitualmente definita come tappatura a fungo, denominazione che trae origine dalla caratteristica forma che assume il tappo con il suo utilizzo (Figura 1). La tappatura a fungo consente la conservazione della pressione all interno della bottiglia addirittura per anni e questa prestazione si ottiene grazie alle infinite esperienze consolidate nel lungo periodo e derivanti da errori, correzioni e successi che si sono via via succeduti. Scopo di questo paragrafo è di ricavare, sulla base dei parametri pervenuti dalla migliore e più consolidata tradizione, le giustificazioni meccaniche e scientifiche del loro equilibrio e della loro sinergia funzionale. Va innanzitutto chiarito che, contrariamente a quanto si potrebbe credere, per la tappatura a fungo la funzione di contrasto alla fuoriuscita del gas dalla bottiglia è demandata alla parte di tappo esterna alla bottiglia stessa, e precisamente alla tenuta che tale parte è in grado di effettuare sul raso bocca della bottiglia. Occorre quindi studiare il comportamento ed il funzionamento della parte di tappo esterna al raso bocca della bottiglia, quindi in pratica alla parte in agglomerato di sughero, materiale che ha una densità molto alta ed anche molto più costante rispetto a quella del sughero naturale. Più in generale, occorre analizzare come funzioni dal punto di vista meccanico il tappo e, soprattutto, come varino le sue caratteristiche fisiche iniziali in funzione della dinamica del processo di tappatura gabbiettatura.» Figura 1» Figura 2 Come prima cosa, si osserva che la densità iniziale già molto elevata, subisce un ulteriore notevole aumento che varia, in funzione della dinamica del processo di tappatura gabbiettatura, a seconda delle sezioni del tappo. Per esemplificare e rendere visivamente comprensibili le trasformazioni strutturali nel tappo durane il suo utilizzo, si è adottato un artificio grafico nella rappresentazione delle sezioni del In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 34 di 42
3 tappo (intese nel seguito in senso geometrico). La superficie del tappo viene infatti rappresentata come se fosse composta da un insieme di riquadri che, in partenza, hanno una dimensione di 2x2 mm e racchiudono quindi un area di 4 mm² (Figura 2). Nel caso delle sezioni radiali (Figura 3), si è rappresentato l insieme come composto da settori di corona circolare, che anche in questo caso rappresentano ciascuno una superficie di 4 mm². Le sezioni raffigurate nelle Figure 2 e 3 rappresentano la sezione verticale e la sezione radiale mediana di un tappo da spumante di misura normale, cioè di 30,5 mm di diametro e di 48 mm di lunghezza.» Figura 3» Figura 4 Nel seguito, il posizionamento, l eventuale rotazione angolare e/o il rimpicciolimento delle sezioni unitarie varranno a testimoniare (ed a suggerire visivamente) quanto avviene nella struttura dei tappi durante la tappatura gabbiettatura e le variazioni di densità che essi subiscono al loro interno, particolarmente in alcune zone funzionalmente determinanti. Vista l importanza prevalente della parte in agglomerato, non si evidenzierà la difformità di composizione del tappo (sughero naturale / agglomerato), in quanto non significativa per la funzione in esame. Il tappo, quindi, sarà considerato e rappresentato come se fosse costituito da materiale omogeneo. Fatte queste premesse, si considerino in modo sequenziale le modificazioni strutturali che subisce il tappo a fungo nel corso del suo utilizzo. Il primo passaggio è quello che deriva dal processo di introduzione nel collo della bottiglia da parte del tappatore (cfr. paragrafo Tappatura). Essendo la densità iniziale dell agglomerato di circa 280 kg/m³, nel momento in cui il tappo viene compresso radialmente nel tappatore fino a raggiungere un diametro di 15,5-16 mm, esso aumenta la propria la densità fino a circa 1000 kg/m³ con un rapporto di 3,63 volte il valore iniziale. A puro titolo di curiosità, il valore di densità raggiunto dall agglomerato di sughero nel momento di massima costrizione radiale da parte delle ganasce del tappatore supera decisamente quello di molti legni di essenza dura quali il faggio, il mogano, il castagno, il noce, ecc. Questo aumento di densità si può In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 35 di 42
4 constatare visivamente dall esame comparativo in Figura 4 sia delle sezioni verticali (A e B) che di quelle radiali (C e D). La Figura 4 rappresenta le sezioni: A = sezione verticale mediana del tappo da spumante prima del suo utilizzo; B = sezione verticale mediana del tappo da spumante compresso dalle ganasce del compressore del tappatore; C = sezione radiale del tappo da spumante prima del suo utilizzo; D = sezione radiale del tappo in qualsiasi punto di quota (se riferito a ganasce del tipo cilindrico).» Figura 5» Figura 6 Negli istanti immediatamente successivi all introduzione, la struttura interna del tappo può essere rappresentata come in Figura 5, dove è riportata la sua sezione verticale. In questa Figura la freccia indica una zona in cui l espansione del sughero non è ancora avvenuta totalmente, per il tempo limitato che non l ha permessa e per la vicinanza con il raso-bocca della bottiglia che la limita meccanicamente. Nel breve periodo che intercorre tra la tappatura e la gabbiettatura, la parte di tappo esterna alla bottiglia e particolarmente la parte indicata in Figura 5 dalla freccia, continuerà la sua espansione come evidenziato dal confronto tra la sezione di Figura 5 e quella di Figura 6. A seguito della gabbiettatura, il tappo viene compresso, deformato ed assestato sul raso bocca della bottiglia, per determinare il cosiddetto effetto tappo corona. Viene così formata la testa del tappo che, in base alla forma del cappellotto della gabbietta e del rasobocca della bottiglia ed in base alla velocità con cui è condotta la gabbiettatura, subisce compattazioni diverse. In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 36 di 42
5 » Figura 7» Figura 8 In Figura 7, è rappresentato in A l aspetto che deve avere la bottiglia tappata e gabbiettata correttamente, mentre, in B è visibile una ipotetica sezione verticale mediana del medesimo soggetto. Si vedono, in B appunto, delle aree diversamente colorate che differenziano, in modo sommario, zone in cui la compattazione del materiale è avvenuta in modo diverso. Allo scopo di rendere più chiaro e dettagliato il discorso, nella Figura 8 è rappresentata la sezione dl tappo in B della Figura 7 ingrandita e liberata dalle sezioni di bottiglia e gabbietta. La suddivisione in 4 zone (A, B, C, D) della sezione rappresentata in Figura 8 ci consente di analizzare separatamente ognuna di esse e di motivare la loro diversificazione. Le zone A, B, e C sono assoggettate solo a compressione assiale (verticale). Vista l estrema rapidità con cui si realizza la gabbiettatura, si determina una deformazione di schiacciamento molto maggiore sia in A che è la zona di applicazione della forza che in C che è la zona di contrasto e reazione a tale forza, piuttosto che in B (zona intermediata tra le due precedenti e quindi da loro preservata). L appoggio della zona C è costituito dal raso bocca della bottiglia e dalla parte di tappo penetrata in essa al momento della tappatura. La zona D è costituta dalla parte di tappo penetrata nella bottiglia ed è interessata unicamente da compressione radiale che raggiunge gli 830 kg/m³ se si fissano i seguenti parametri standard: Ø imboccatura bottiglia = 17,3 ± 0,3 mm; Ø tappo = 30,5 mm; densità iniziale agglomerato = 280 Kg per m³ In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 37 di 42
6 » Figura 9» Figura 10 La complessa dinamica dell assestamento della testa del tappo sul raso bocca della bottiglia è riassunta nella Figura 9, che rappresenta come agiscano le forze interne alla testa del tappo dovute all elasticità del sughero, durante ed immediatamente dopo la gabbiettatura. Le forze che agiscono tra il cappellotto della gabbietta ed il raso bocca della bottiglia, sono schematizzate da due frecce rosse laterali ed una gialla centrale che a sua volta si ramifica in varie direzioni. Partendo da quest ultima, notiamo innanzitutto che essa si scarica nella parte di tappo penetrata nella bottiglia. Essa determina l ulteriore piccolo affondamento del tappo post gabbiettatura, ed è contrastata sia dall attrito che il tappo genera nel penetrare ulteriormente nella bottiglia (dovuto alla forza di espansione radiale del sughero penetrato nella bottiglia), sia dai legami strutturali dell agglomerato stesso. Le due frecce rosse, invece, rappresentano le componenti che, interagendo con le superfici di appoggio, formano il tappo nella zona C di Figura 8 consentendo l effetto tappo corona. Quando la situazione si è stabilizzata, (Figura 10), l analisi delle forze di reazione che si scaricano sul cappellotto della gabbietta, e quindi ne mettono in trazione le gambe, mostra che le componenti principali derivano dall appoggio della testa del tappo sul raso bocca e, solo in minima parte, dal cuore del tappo in quanto la forza che ha agito in questa direzione si è scaricata provocando l affondamento ulteriore del tappo. Sempre dall analisi di Figura 10 è possibile notare che il gambo del tappo si espande con sempre maggior forza in direzione radiale ottenendo una buona chiusura laterale. Il tappo, nella parte penetrata, funziona come un normale tappo raso, ma contribuisce anche esso all effetto tappo corona in quanto conferisce perfetta stabilità alla zona di contatto sul raso bocca non consentendo movimenti reciproci tappo-collo. Riconsiderando la zona C di Figura 8, si osserva che essa ha una zona di appoggio la cui area è molto più piccola di quella dell intera superficie del cappellotto della gabbietta, essendo costituita solamente dalla corona circolare rappresentata dal raso In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 38 di 42
7 bocca della bottiglia. Per precisione, questa superficie non è piana bensì toroidale e tuttavia, per semplicità di trattazione, verrà considerata come fosse una superficie piana. Per una legge fisica ben nota, una forza (espressa in kg forza) esercita su di una data superficie (espressa in cm²) una pressione specifica (Kg/cm²) inversamente proporzionale all area di detta superficie. Ne consegue che, considerando pari a 2 cm² l area della zona di appoggio del tappo sul raso bocca della bottiglia champagnotta e pari a Kg un valore medio di sforzo prodotto dalla gabbiettatrice, la pressione specifica nel momento dell applicazione della gabbietta è di kg/cm² (sul raso bocca della bottiglia). Se invece si considera pari a Kg il valore di mantenimento determinato dalla reazione elastica dell agglomerato della testa del tappo durante il periodo di conservazione della bottiglia, la pressione specifica si attesta su un valore pari a kg /cm². In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 39 di 42
8 b. Effetto tappo corona LA TENUTA ALLA PRESSIONE DEL TAPPO DA SPUMANTE Quando la gabbietta viene utilizzata unitamente al tappo di sughero, la funzione di impedire la fuoriuscita del tappo stesso, per quanto importante, non è certamente la sola svolta. Infatti, quando la gabbietta viene vincolata (per opera della macchina gabbiettatrice) alla baga della bottiglia, si determina una deformazione elastica della parte del tappo di sughero che è stata intenzionalmente lasciata fuori dal collo della bottiglia nella fase di tappatura. Questa deformazione elastica ha caratteristiche ben precise e risponde alla necessità di ottenere il cosiddetto effetto tappo corona da parte del tappo. L effetto tappo corona è quell effetto constatabile appunto nell utilizzo del tappo corona. Quest ultimo è costituito da un cappellotto metallico capace di aggraffarsi alla bocca della bottiglia mediante la compressione di una sottile guarnizione tra la sua parte metallica ed il raso bocca della bottiglia. Nel tappo corona dunque la tenuta ai liquidi ed ai gas è demandata unicamente ad una sottile guarnizione, al contempo elastica ed impermeabile, opportunamente compressa al fine di adattarsi perfettamente alle microcanalizzazioni presenti sul raso bocca della bottiglia, sigillandole ermeticamente. La gabbietta riesce ad ottenere lo stesso effetto dal tappo di sughero, sfruttandone l elasticità e la deformabilità, comprimendolo assialmente sul raso bocca della bottiglia sino ad ottenere una zona di massima compattazione del materiale in cui si determina, per deformazione elastica, la chiusura delle microporosità dell agglomerato di sughero e quindi il cosiddetto effetto tappo corona (pressione specifica sul raso bocca della bottiglia, fino a 150 kg/cm² e più).» Figura 1 Quanto finora esposto è illustrato schematicamente in Figura 1 dove sono rappresentate le sezioni verticali di due colli di bottiglia, il primo, chiuso da un tappo corona ed il secondo da un tappo di sughero a fungo con la corretta compressione della testa indotta dalla gabbiettatura. In questa immagine sono evidenziate con delle In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 40 di 42
9 frecce gialle le zone di contatto (il raso bocca) delle bottiglie dove si determina, appunto, l effetto tappo corona. L effetto tappo corona è certamente essenziale e determinante nella funzione demandata al tappo di trattenere il gas all interno della bottiglia. In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 41 di 42
10 c. Tenuta alla trasmissione del gas LA TENUTA ALLA PRESSIONE DEL TAPPO DA SPUMANTE Per tenuta alla trasmissione o penetrazione del gas attraverso un corpo in agglomerato si intende la propensione di un gas posto sotto pressione ad attraversare l agglomerato stesso. E' logico pensare che un agglomerato con una maggiore resistenza alla trasmissione del gas abbia, a parità di altri parametri, migliori prestazioni nel mantenere la pressione interna alla bottiglia. Il controllo della penetrazione di gas attraverso un corpo in agglomerato può dare un indicazione circa la presenza all interno del corpo di canalizzazioni o interstizi eventualmente formatisi durante la sua produzione. Occorre tenere presente che la forte compressione subita dal tappo all interno del collo della bottiglia è comunque in grado di contrastare tali irregolarità, ma è pur sempre vero che se l agglomerato ha una perfetta tenuta alla trasmissione del gas, a maggior ragione ciò avviene a seguito dell imbottigliamento. E possibile effettuare il test di tenuta alla trasmissione del gas mediante un semplice apparato che consiste in due testine, una delle quali collegata ad una bombola di aria compressa (testina insufflatrice) e l altra ad un sistema di misura della pressione per semplice gorgogliamento in acqua o mediante un manometro (testina captatrice). Le testine vengono serrate alle due estremità del corpo in agglomerato e all interno della testina insufflatrice viene aumentata la pressione fino ad un valore opportuno (es. 5 atm per simulare la sovrappressione interna di una bottiglia di spumante). Si valuta l eventuale aumento di pressione all interno della testina captatrice entro qualche secondo dall inizio del test. In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero pag. 42 di 42
LA TERMINOLOGIA E LE CARATTERISTICHE. a. Tappo da spumante. b. Gabbietta. c. Bottiglia
 A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
GLI INCIDENTI DI TAPPATURA E LE POSSIBILI CAUSE. a. Bottiglia. tappo scanalato. d. Gabbiettatura
 A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
A cura di: Valeria Mazzoleni Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare Facoltà di Agraria Via E. Parmense 84 29100 Piacenza In collaborazione con: Michele Addis, Antonio Bianco, Alberto Ferrero
SPU MA NTE MANUALE DI TAPPATURA PER VINI SPUMANTI. Amorim. Il sughero del futuro, un po prima.
 SPU MA NTE MANUALE DI TAPPATURA PER VINI SPUMANTI Amorim. Il sughero del futuro, un po prima. La sola analisi di laboratorio, non può assicurare il massimo risultato raggiungibile nella tappatura, in quanto,
SPU MA NTE MANUALE DI TAPPATURA PER VINI SPUMANTI Amorim. Il sughero del futuro, un po prima. La sola analisi di laboratorio, non può assicurare il massimo risultato raggiungibile nella tappatura, in quanto,
MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE
 MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE la tenuta alla pressione del tappo spumante 03 incidenti di tappatura e possibili cause 05 difetti visibili sulla chiusura dopo la stappatura della bottiglia
MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE la tenuta alla pressione del tappo spumante 03 incidenti di tappatura e possibili cause 05 difetti visibili sulla chiusura dopo la stappatura della bottiglia
MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE
 MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE la tenuta alla pressione del tappo spumante 03 incidenti di tappatura e possibili cause 05 difetti visibili sulla chiusura dopo la stappatura della bottiglia
MANUALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TAPPO SPUMANTE la tenuta alla pressione del tappo spumante 03 incidenti di tappatura e possibili cause 05 difetti visibili sulla chiusura dopo la stappatura della bottiglia
Aspetti tecnici riguardanti il tappo di sughero Tecniche e limiti di utilizzo
 Aspetti tecnici riguardanti il tappo di sughero Tecniche e limiti di utilizzo Enot. Zaniotto Stefano 1 Febbraio 2010 .PRIMA DI PARTIRE Spesso crediamo di conoscere una cosa o un processo perché lo abbiamo
Aspetti tecnici riguardanti il tappo di sughero Tecniche e limiti di utilizzo Enot. Zaniotto Stefano 1 Febbraio 2010 .PRIMA DI PARTIRE Spesso crediamo di conoscere una cosa o un processo perché lo abbiamo
Maurizio Giugni Titolo della lezione Verifica statica delle condotte DN SN
 Maurizio Giugni Titolo della lezione Verifica statica delle condotte # Lezione n. Parole chiave: Tubazioni. Verifica statica. Corso di Laurea: Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Insegnamento: Infrastrutture
Maurizio Giugni Titolo della lezione Verifica statica delle condotte # Lezione n. Parole chiave: Tubazioni. Verifica statica. Corso di Laurea: Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Insegnamento: Infrastrutture
DICHTOMATIK. Istruzioni per la progettazione delle sedi. Tenuta statica
 DICHTOMATIK Istruzioni per la progettazione delle sedi Se possibile, le sedi per installazione (cave) degli O-Ring dovrebbero essere con angoli retti. Le dimensioni di pro fon dità e larghezza richieste
DICHTOMATIK Istruzioni per la progettazione delle sedi Se possibile, le sedi per installazione (cave) degli O-Ring dovrebbero essere con angoli retti. Le dimensioni di pro fon dità e larghezza richieste
ESERCITAZIONE 7. Dr.ssa Valeria Monti Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Fisica a.a
 ESERCITAZIONE 7 Dr.ssa Valeria Monti Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Fisica a.a. 2016 2017 Esercizio 1 Calcolare la densità dell ossigeno a 0 C e alla pressione di 1 atm. Esercitazione
ESERCITAZIONE 7 Dr.ssa Valeria Monti Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Fisica a.a. 2016 2017 Esercizio 1 Calcolare la densità dell ossigeno a 0 C e alla pressione di 1 atm. Esercitazione
se F a /F r e P = 0.4 F r + Y F a se F a /F r > e
 Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Progettazione di Sistemi Meccanici (Prof.ssa C. Colombo, Prof. C. Gorla) Appello esame 05.09.2016 ATTENZIONE:
Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Progettazione di Sistemi Meccanici (Prof.ssa C. Colombo, Prof. C. Gorla) Appello esame 05.09.2016 ATTENZIONE:
L utilizzo corretto dei tappi di sughero Fattori di Influenza Aggiornato al:
 Aggiornato al: 1.1.214 Pagina 1/9 Condizioni ottimali Temperatura del Sughero: 1-2 Umidità del Sughero: - 7% Imboccatura della bottiglia secondo EN 12726:2, imboccatura leggermente conica. 1 2, 1, 1, Evacuazione
Aggiornato al: 1.1.214 Pagina 1/9 Condizioni ottimali Temperatura del Sughero: 1-2 Umidità del Sughero: - 7% Imboccatura della bottiglia secondo EN 12726:2, imboccatura leggermente conica. 1 2, 1, 1, Evacuazione
4. Esercitazione 4: Dimensionamento del primo stadio di un compressore assiale
 4. Esercitazione 4: Dimensionamento del primo stadio di un compressore assiale Lo scopo della presente esercitazione è il dimensionamento del primo stadio di un compressore assiale. Con riferimento alla
4. Esercitazione 4: Dimensionamento del primo stadio di un compressore assiale Lo scopo della presente esercitazione è il dimensionamento del primo stadio di un compressore assiale. Con riferimento alla
SCHEMA DI MONTAGGIO CONDOTTA E STRUTTURE PORTANTI
 SCHEMA DI MONTAGGIO CONDOTTA E STRUTTURE PORTANTI PREMESSE Le condotte sono delle strutture portanti metalliche, di forma tubolare e costituite da più piastre in lamiera ondulata, opportunamente curvate,
SCHEMA DI MONTAGGIO CONDOTTA E STRUTTURE PORTANTI PREMESSE Le condotte sono delle strutture portanti metalliche, di forma tubolare e costituite da più piastre in lamiera ondulata, opportunamente curvate,
Cenni sulle proprietà elastiche dei solidi
 Cenni sulle proprietà elastiche dei solidi La nozione di corpo rigido deriva dal fatto che i corpi solidi sono caratterizzati dall avere una forma ed un volume non facilmente modificabili. Nella realtà
Cenni sulle proprietà elastiche dei solidi La nozione di corpo rigido deriva dal fatto che i corpi solidi sono caratterizzati dall avere una forma ed un volume non facilmente modificabili. Nella realtà
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 25/01/2011
 Compito di Fisica Generale (Meccanica) 25/01/2011 1) Un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi su di una guida orizzontale. Il punto è attaccato ad una molla di costante elastica k. La guida
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 25/01/2011 1) Un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi su di una guida orizzontale. Il punto è attaccato ad una molla di costante elastica k. La guida
Esame di Fisica I secondo parziale
 Esame di Fisica I secondo parziale Corso di Laurea in Chimica, 16/06/2014 1. Un vagone di massa M A =3 10 4 Kg urta contro un altro fermo di massa M B. Nell urto il 25% dell energia cinetica iniziale viene
Esame di Fisica I secondo parziale Corso di Laurea in Chimica, 16/06/2014 1. Un vagone di massa M A =3 10 4 Kg urta contro un altro fermo di massa M B. Nell urto il 25% dell energia cinetica iniziale viene
Fisica Generale I (primo e secondo modulo) A.A , 15 luglio 2009
 Fisica Generale I (primo e secondo modulo) A.A. 2008-09, 15 luglio 2009 Esercizi di meccanica relativi al primo modulo del corso di Fisica Generale I, anche equivalente ai corsi di Fisica Generale 1 e
Fisica Generale I (primo e secondo modulo) A.A. 2008-09, 15 luglio 2009 Esercizi di meccanica relativi al primo modulo del corso di Fisica Generale I, anche equivalente ai corsi di Fisica Generale 1 e
POCHI ACCORGIMENTI UN GRANDE RISULTATO
 POCHI ACCORGIMENTI UN GRANDE RISULTATO Ottenere una ottima qualità dell imbottigliamento Conegliano 20 Febbraio 2015 Premesse Cambio irreversibile del vino da prodotto alimentare a bene voluttuario e status
POCHI ACCORGIMENTI UN GRANDE RISULTATO Ottenere una ottima qualità dell imbottigliamento Conegliano 20 Febbraio 2015 Premesse Cambio irreversibile del vino da prodotto alimentare a bene voluttuario e status
-&3%/ Per quanto riguarda il valore delle portate massime che si intende applicare ai cassetti, la situazione è riassunta dalla seguente tabella;
 !"# #$$#"%&'( (##"# )**&)+,)-!./0)*1110,)-!./0)*!"# #$$#"%&'( (##"# *&)23+-0-4--56 %--0.),0-,-%323 -&3%/ La presente relazione ha lo scopo di definire e di verificare la situazione dei carichi e delle
!"# #$$#"%&'( (##"# )**&)+,)-!./0)*1110,)-!./0)*!"# #$$#"%&'( (##"# *&)23+-0-4--56 %--0.),0-,-%323 -&3%/ La presente relazione ha lo scopo di definire e di verificare la situazione dei carichi e delle
FISICA E LABORATORIO INDIRIZZO C.A.T. CLASSE PRIMA. OBIETTIVI U. D. n 1.2: La rappresentazione di dati e fenomeni
 FISICA E LABORATORIO INDIRIZZO C.A.T. CLASSE PRIMA Le competenze di base a conclusione dell obbligo di istruzione sono le seguenti: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
FISICA E LABORATORIO INDIRIZZO C.A.T. CLASSE PRIMA Le competenze di base a conclusione dell obbligo di istruzione sono le seguenti: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
RELAZIONE DI CALCOLO
 RELAZIONE DI CALCOLO CONDOTTA IN ACCIAIO Premessa La costruzione della Strada Provinciale in oggetto prevede la realizzazione di una rotatoria sul tracciato esistente attraversato dal canale di bonifica
RELAZIONE DI CALCOLO CONDOTTA IN ACCIAIO Premessa La costruzione della Strada Provinciale in oggetto prevede la realizzazione di una rotatoria sul tracciato esistente attraversato dal canale di bonifica
Collegamenti nelle strutture
 1 Collegamenti nelle strutture Le tipologie delle unioni bullonate o saldate sono molteplici e dipendono essenzialmente da: caratteristiche dell unione: nell ambito di quelle bullonate si possono avere
1 Collegamenti nelle strutture Le tipologie delle unioni bullonate o saldate sono molteplici e dipendono essenzialmente da: caratteristiche dell unione: nell ambito di quelle bullonate si possono avere
Laboratorio di Tecnologie Biomediche
 Laboratorio di Tecnologie Biomediche Collegamenti meccanici Carmelo De Maria carmelo.demaria@unipi.it Imbiettamenti collegamenti di tipo smontabile che hanno per scopo quello di impedire la rotazione relativa
Laboratorio di Tecnologie Biomediche Collegamenti meccanici Carmelo De Maria carmelo.demaria@unipi.it Imbiettamenti collegamenti di tipo smontabile che hanno per scopo quello di impedire la rotazione relativa
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 17/01/2013
 Compito di Fisica Generale (Meccanica) 17/01/2013 1) Un proiettile massa m è connesso ad una molla di costante elastica k e di lunghezza a riposo nulla. Supponendo che il proiettile venga lanciato a t=0
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 17/01/2013 1) Un proiettile massa m è connesso ad una molla di costante elastica k e di lunghezza a riposo nulla. Supponendo che il proiettile venga lanciato a t=0
4 SOLLECITAZIONI INDOTTE. 4.1 Generalità
 4 SOLLECITAZIONI INDOTTE 4.1 Generalità Le azioni viste inducono uno stato pensionale interno alla struttura e all edificio che dipende dalla modalità con cui le azioni si esplicano. Le sollecitazioni
4 SOLLECITAZIONI INDOTTE 4.1 Generalità Le azioni viste inducono uno stato pensionale interno alla struttura e all edificio che dipende dalla modalità con cui le azioni si esplicano. Le sollecitazioni
La resistenza dei materiali può essere misurata facendo ricorso a prove normalizzate.
 La resistenza dei materiali può essere misurata facendo ricorso a prove normalizzate. Segui attentamente il video relativo ad una prova normalizzata di trazione LA PROVA DI TRAZIONE Molte sono le prove
La resistenza dei materiali può essere misurata facendo ricorso a prove normalizzate. Segui attentamente il video relativo ad una prova normalizzata di trazione LA PROVA DI TRAZIONE Molte sono le prove
Collegamenti tra albero e mozzo
 Collegamenti tra albero e mozzo L albero è un corpo cilindrico a più gradini su cui sono calettati gli organi rotanti, da cui riceve o a cui trasmette il moto Supporti Gli elementi caratteristici degli
Collegamenti tra albero e mozzo L albero è un corpo cilindrico a più gradini su cui sono calettati gli organi rotanti, da cui riceve o a cui trasmette il moto Supporti Gli elementi caratteristici degli
ESERCIZIO 1 SOLUZIONI
 - ESERCIZIO - Un corpo di massa m = 00 g si trova su un tavolo liscio. Il corpo m è mantenuto inizialmente fermo, appoggiato ad una molla di costante elastica k = 00 N/m, inizialmente compressa. Ad un
- ESERCIZIO - Un corpo di massa m = 00 g si trova su un tavolo liscio. Il corpo m è mantenuto inizialmente fermo, appoggiato ad una molla di costante elastica k = 00 N/m, inizialmente compressa. Ad un
Statica ed equilibrio dei corpi
 Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 16 luglio 2013
 Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 16 luglio 013 Problema 1 Un cubo di legno di densità ρ = 800 kg/m 3 e lato a = 50 cm è inizialmente in quiete, appoggiato su un piano orizzontale.
Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 16 luglio 013 Problema 1 Un cubo di legno di densità ρ = 800 kg/m 3 e lato a = 50 cm è inizialmente in quiete, appoggiato su un piano orizzontale.
Soluzioni Esonero di Fisica I - Meccanica Anno Accademico
 Soluzioni Esonero di Fisica I - Meccanica Anno Accademico 006-007 Esercizio n.: Un punto materiale di massa m e vincolato a muoversi lungo un binario orizzontale scabro. Siano µ s e µ d i coefficienti
Soluzioni Esonero di Fisica I - Meccanica Anno Accademico 006-007 Esercizio n.: Un punto materiale di massa m e vincolato a muoversi lungo un binario orizzontale scabro. Siano µ s e µ d i coefficienti
proporzionalità.notebook October 20, 2013
 Esempi Esempi tratti da test di ammissione alle varie facoltà universitarie Medicina Veterinaria 2007 2008 Un cilindro contiene gas perfetto mantenuto a temperatura costante T. Se il suo volume viene ridotto
Esempi Esempi tratti da test di ammissione alle varie facoltà universitarie Medicina Veterinaria 2007 2008 Un cilindro contiene gas perfetto mantenuto a temperatura costante T. Se il suo volume viene ridotto
Prof. Guido Di Pronio Materia: Meccania Agraria Modulo: Meccania Agraria dei cereali, degli ulivi e degli orticoli da campo e loro derivati
 Prof. Guido Di Pronio Materia: Meccania Agraria Modulo: Meccania Agraria dei cereali, degli ulivi e degli orticoli da campo e loro derivati Meccanica agraria Dott. Agr. Guido Di Pronio TRATTORE ORGANI
Prof. Guido Di Pronio Materia: Meccania Agraria Modulo: Meccania Agraria dei cereali, degli ulivi e degli orticoli da campo e loro derivati Meccanica agraria Dott. Agr. Guido Di Pronio TRATTORE ORGANI
Lezione 9 Statica dei fluidi. Densità e pressione. Legge di Stevin. Conseguenze della legge di Stevin.
 Lezione 9 Statica dei fluidi. Densità e pressione. Legge di Stevin. Conseguenze della legge di Stevin. Caratteristiche comuni a liquidi e gas Un fluido è genericamente un liquido o un gas. Caratteristiche
Lezione 9 Statica dei fluidi. Densità e pressione. Legge di Stevin. Conseguenze della legge di Stevin. Caratteristiche comuni a liquidi e gas Un fluido è genericamente un liquido o un gas. Caratteristiche
Esercizi e problemi supplementari sulla dinamica dei sistemi di punti materiali
 Esercizi e problemi supplementari sulla dinamica dei sistemi di punti materiali A) Applicazione del teorema dell impulso + conservazione quantità di moto Problema n. 1: Un blocco A di massa m = 4 kg è
Esercizi e problemi supplementari sulla dinamica dei sistemi di punti materiali A) Applicazione del teorema dell impulso + conservazione quantità di moto Problema n. 1: Un blocco A di massa m = 4 kg è
Itappiper spumanti TipieTerminologia
 Itappiper spumanti TipieTerminologia Pag.1di5 Tappo da spumante classicocon due rondelle di sughero naturale Testa superiore Smusso superiore Fianco Corpo in agglomerato I termini indicati nella grafica
Itappiper spumanti TipieTerminologia Pag.1di5 Tappo da spumante classicocon due rondelle di sughero naturale Testa superiore Smusso superiore Fianco Corpo in agglomerato I termini indicati nella grafica
Laboratorio di Tecnologie Biomediche
 Laboratorio di Tecnologie Biomediche Collegamenti meccanici Carmelo De Maria carmelo.demaria@unipi.it Imbiettamenti collegamenti di tipo smontabile che hanno per scopo quello di impedire la rotazione relativa
Laboratorio di Tecnologie Biomediche Collegamenti meccanici Carmelo De Maria carmelo.demaria@unipi.it Imbiettamenti collegamenti di tipo smontabile che hanno per scopo quello di impedire la rotazione relativa
Esame di Fisica Data: 18 Febbraio Fisica. 18 Febbraio Problema 1
 Fisica 18 Febbraio 2013 ˆ Esame meccanica: problemi 1, 2 e 3. ˆ Esame elettromagnetismo: problemi 4, 5 e 6. Problema 1 Un corpo di massa M = 12 kg, inizialmente in quiete, viene spinto da una forza di
Fisica 18 Febbraio 2013 ˆ Esame meccanica: problemi 1, 2 e 3. ˆ Esame elettromagnetismo: problemi 4, 5 e 6. Problema 1 Un corpo di massa M = 12 kg, inizialmente in quiete, viene spinto da una forza di
STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.36 - A.T.1.1.
 COMUNE DI CHIAVENNA PROVINCIA DI SONDRIO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA (Ambito di trasformazione 1.1. Via per Uggia) LOCALITA BETTE, CHIAVENNA (SO) STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.36 - A.T.1.1.
COMUNE DI CHIAVENNA PROVINCIA DI SONDRIO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA (Ambito di trasformazione 1.1. Via per Uggia) LOCALITA BETTE, CHIAVENNA (SO) STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.36 - A.T.1.1.
Problemi di dinamica del punto materiale
 Problemi di dinamica del punto materiale 1. Un corpo di massa M = 200 kg viene lanciato con velocità v 0 = 36 km/ora su un piano inclinato di un angolo θ = 30 o rispetto all orizzontale. Nel salire, il
Problemi di dinamica del punto materiale 1. Un corpo di massa M = 200 kg viene lanciato con velocità v 0 = 36 km/ora su un piano inclinato di un angolo θ = 30 o rispetto all orizzontale. Nel salire, il
2. Vibrazioni longitudinali nelle barre
 . Vibrazioni longitudinali nelle barre Si richiama, all interno di questo paragrafo, l analisi delle vibrazioni longitudinali di barre nell intorno della configurazione di equilibrio statico. Si ipotizzi,
. Vibrazioni longitudinali nelle barre Si richiama, all interno di questo paragrafo, l analisi delle vibrazioni longitudinali di barre nell intorno della configurazione di equilibrio statico. Si ipotizzi,
Cinematica e Dinamica
 LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA - TUTORATO FISICA I Cinematica e Dinamica Margherita Lembo 28 Marzo 2018 1. PROBLEMA Un disco da hockey su una pista gelata è dotato di una velocità iniziale di 20.0 m/s,
LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA - TUTORATO FISICA I Cinematica e Dinamica Margherita Lembo 28 Marzo 2018 1. PROBLEMA Un disco da hockey su una pista gelata è dotato di una velocità iniziale di 20.0 m/s,
CO 2 supercritica: La nuova microgranina di sughero a zero contaminazioni
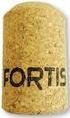 CO 2 supercritica: La nuova microgranina di sughero a zero contaminazioni Verona PIANTA DE PRODUZIONE FORTIS FORTISMIX FORTISWINE NUOVE TECNOLOGIE CO2 SUPERCRITICA Fondamenti della tecnologia dei fluidi
CO 2 supercritica: La nuova microgranina di sughero a zero contaminazioni Verona PIANTA DE PRODUZIONE FORTIS FORTISMIX FORTISWINE NUOVE TECNOLOGIE CO2 SUPERCRITICA Fondamenti della tecnologia dei fluidi
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria e Architettura. Fondamenti di Costruzioni Meccaniche Tensione e deformazione Carico assiale
 Esercizio N.1 Un asta di acciaio è lunga 2.2 m e non può allungarsi più di 1.2 mm quando le si applica un carico di 8.5 kn. Sapendo che E = 200 GPa, determinare: (a) il più piccolo diametro dell asta che
Esercizio N.1 Un asta di acciaio è lunga 2.2 m e non può allungarsi più di 1.2 mm quando le si applica un carico di 8.5 kn. Sapendo che E = 200 GPa, determinare: (a) il più piccolo diametro dell asta che
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 10/01/2012
 Compito di Fisica Generale (Meccanica) 10/01/2012 1) In un piano orizzontale sono assegnati due assi cartesiani x e y. Uno strato di liquido occupa lo spazio fra y = 0 ed y = d e si muove a velocità costante
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 10/01/2012 1) In un piano orizzontale sono assegnati due assi cartesiani x e y. Uno strato di liquido occupa lo spazio fra y = 0 ed y = d e si muove a velocità costante
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA. Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta
 INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
IPSSAR P. ARTUSI - Forlimpopoli (Fc) 1 ANNO MODULO: ACCOGLIENZA
 MODULO: ACCOGLIENZA - Il programma di Fisica da svolgere assieme - Conoscere gli alunni - Il metodo di lavoro e di valutazione - Far conoscere agli alunni il metodo di lavoro - Esporre il metodo di valutazione
MODULO: ACCOGLIENZA - Il programma di Fisica da svolgere assieme - Conoscere gli alunni - Il metodo di lavoro e di valutazione - Far conoscere agli alunni il metodo di lavoro - Esporre il metodo di valutazione
sfera omogenea di massa M e raggio R il momento d inerzia rispetto ad un asse passante per il suo centro di massa vale I = 2 5 MR2 ).
 ESERCIZI 1) Un razzo viene lanciato verticalmente dalla Terra e sale con accelerazione a = 20 m/s 2. Dopo 100 s il combustibile si esaurisce e il razzo continua a salire fino ad un altezza massima h. a)
ESERCIZI 1) Un razzo viene lanciato verticalmente dalla Terra e sale con accelerazione a = 20 m/s 2. Dopo 100 s il combustibile si esaurisce e il razzo continua a salire fino ad un altezza massima h. a)
CAPITOLO 7: ESEMPI PRATICI: 7.1 Esempi di dinamica.
 CAPITOLO 7: ESEMPI PRATICI: 7.1 Esempi di dinamica. Questo capitolo vuole fornire una serie di esempi pratici dei concetti illustrati nei capitoli precedenti con qualche approfondimento. Vediamo subito
CAPITOLO 7: ESEMPI PRATICI: 7.1 Esempi di dinamica. Questo capitolo vuole fornire una serie di esempi pratici dei concetti illustrati nei capitoli precedenti con qualche approfondimento. Vediamo subito
Esame 29 Settembre 2017
 Esame 29 Settembre 2017 Roberto Bonciani e Paolo Dore Corso di Fisica Generale 1 Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Roma La Sapienza Anno Accademico 2016-2017 Esercizio 1 Esame - Fisica
Esame 29 Settembre 2017 Roberto Bonciani e Paolo Dore Corso di Fisica Generale 1 Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Roma La Sapienza Anno Accademico 2016-2017 Esercizio 1 Esame - Fisica
Tenuta laterale. Rotaia LM. Figura 1: Struttura della guida LM tipo HRW
 Guida LM Tipo HRW con rotaia larga a capacità di carico uguale in tutte le direzioni Frontale di ricircolo Tenuta frontale Nipplo ingrassatore Carrello LM Sfere Lamierino Tenuta laterale Rotaia LM Figura
Guida LM Tipo HRW con rotaia larga a capacità di carico uguale in tutte le direzioni Frontale di ricircolo Tenuta frontale Nipplo ingrassatore Carrello LM Sfere Lamierino Tenuta laterale Rotaia LM Figura
Consigli pratici per l'officina. Viti della testata e montaggio della testata. Consigli e informazioni per l'uso n. 2
 Consigli pratici per l'officina Viti della testata e montaggio della testata Consigli e informazioni per l'uso n. 2 Viti della testa unione robusta per una perfetta tenuta stagna Attraverso la forza di
Consigli pratici per l'officina Viti della testata e montaggio della testata Consigli e informazioni per l'uso n. 2 Viti della testa unione robusta per una perfetta tenuta stagna Attraverso la forza di
Esercizi di dinamica
 Esercizi di dinamica Esercitazioni di Fisica LA per ingegneri - A.A. 2003-2004 M F1, m v0 α F2, M α F3 Esercizio 1 Un blocco di massa M = 1.20 kg (figura F1) si trova in equilibrio appoggiato su una molla
Esercizi di dinamica Esercitazioni di Fisica LA per ingegneri - A.A. 2003-2004 M F1, m v0 α F2, M α F3 Esercizio 1 Un blocco di massa M = 1.20 kg (figura F1) si trova in equilibrio appoggiato su una molla
Facoltà di Farmacia - Anno Accademico A 18 febbraio 2010 primo esonero
 Facoltà di Farmacia - Anno Accademico 2009-2010 A 18 febbraio 2010 primo esonero Corso di Laurea: Laurea Specialistica in FARMACIA Nome: Cognome: Matricola Aula: Canale: Docente: Riportare sul presente
Facoltà di Farmacia - Anno Accademico 2009-2010 A 18 febbraio 2010 primo esonero Corso di Laurea: Laurea Specialistica in FARMACIA Nome: Cognome: Matricola Aula: Canale: Docente: Riportare sul presente
struttura e forma Il problema che gli architetti dovettero affrontare era quale fosse la forma ideale per la torre. Le ipotesi di base erano due:
 Il problema che gli architetti dovettero affrontare era quale fosse la forma ideale per la torre. Le ipotesi di base erano due: RETTANGOLARE scartata a priori perché gli angoli possono variare TRIANGOLARE
Il problema che gli architetti dovettero affrontare era quale fosse la forma ideale per la torre. Le ipotesi di base erano due: RETTANGOLARE scartata a priori perché gli angoli possono variare TRIANGOLARE
CAPITOLO 2 CICLO BRAYTON TURBINE A GAS FLUIDO: MONOFASE
 CAPITOLO 2 CICLO BRAYTON TURBINE A GAS FLUIDO: MONOFASE 1 CICLO BRAYTON IL CICLO TERMODINAMICO BRAYTON E COMPOSTO DA QUATTRO TRASFORMAZIONI PRINCIPALI (COMPRESSIONE, RISCALDAMENTO, ESPANSIONE E RAFFREDDAMENTO),
CAPITOLO 2 CICLO BRAYTON TURBINE A GAS FLUIDO: MONOFASE 1 CICLO BRAYTON IL CICLO TERMODINAMICO BRAYTON E COMPOSTO DA QUATTRO TRASFORMAZIONI PRINCIPALI (COMPRESSIONE, RISCALDAMENTO, ESPANSIONE E RAFFREDDAMENTO),
Esercitazione 2. Soluzione
 Esercitazione 2 Esercizio 1 - Resistenza dell aria Un blocchetto di massa m = 0.01 Kg (10 grammi) viene appoggiato delicatamente con velocità iniziale zero su un piano inclinato rispetto all orizziontale
Esercitazione 2 Esercizio 1 - Resistenza dell aria Un blocchetto di massa m = 0.01 Kg (10 grammi) viene appoggiato delicatamente con velocità iniziale zero su un piano inclinato rispetto all orizziontale
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV Prof. Dott. Bernhard Elsener
 Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
ESERCIZI DI RIEPILOGO
 ESERCIZI DI RIEPILOGO Elisabetta Bissaldi (Politecnico di Bari) - A.A. 2017-2018 2 Esercizio R.1 Una spira rettangolare di lati a = 10 cm e b = 6 cm e di resistenza R = 10 Ω si muove con velocità costante
ESERCIZI DI RIEPILOGO Elisabetta Bissaldi (Politecnico di Bari) - A.A. 2017-2018 2 Esercizio R.1 Una spira rettangolare di lati a = 10 cm e b = 6 cm e di resistenza R = 10 Ω si muove con velocità costante
marchisio MACCHINE ENOLOGICHE PROFESSIONALI oenological machines machine enologique maquina enologicas Maschine önologische
 marchisio MACCHINE ENOLOGICHE PROFESSIONALI oenological machines machine enologique maquina enologicas Maschine önologische Riempimento 4. Monoblocchi Riempimento Modello M974 punti salienti - highlights
marchisio MACCHINE ENOLOGICHE PROFESSIONALI oenological machines machine enologique maquina enologicas Maschine önologische Riempimento 4. Monoblocchi Riempimento Modello M974 punti salienti - highlights
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV Prof. Dott. Bernhard Elsener
 Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata Soluzione Esercitazione IV ESERCIZIO 4.1 E dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 1. Determinare le fasi
ITS MAKER Modulo industrializzazione di prodotto. Modena, febbraio 2017
 ITS MAKER Modulo industrializzazione di prodotto Modena, febbraio 2017 Lavorazioni delle lamiere Le lamiere sono molto diffuse come elementi strutturali in vari settori dell industria metalmeccanica; esempio
ITS MAKER Modulo industrializzazione di prodotto Modena, febbraio 2017 Lavorazioni delle lamiere Le lamiere sono molto diffuse come elementi strutturali in vari settori dell industria metalmeccanica; esempio
PROVA SCRITTA DI FISICA I - LT INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA DEL 12/02/2018
 PROVA SCRITTA DI FISICA I - LT INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA DEL 12/02/2018 Esercizio n. 1 Un hard disk di vecchia generazione ha un diametro D=5.25 pollici e una massa m=500gr. Una volta acceso
PROVA SCRITTA DI FISICA I - LT INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA DEL 12/02/2018 Esercizio n. 1 Un hard disk di vecchia generazione ha un diametro D=5.25 pollici e una massa m=500gr. Una volta acceso
Esercitazione di Meccanica dei fluidi con Fondamenti di Ingegneria Chimica. Scambio di materia (II)
 Esercitazione di Meccanica dei fluidi con Fondamenti di Ingegneria himica Esercitazione 6 (FI) - 1 Gennaio 016 Scambio di materia (II) Esercizio 1 Evaporazione di acqua da una piscina Stimare la perdita
Esercitazione di Meccanica dei fluidi con Fondamenti di Ingegneria himica Esercitazione 6 (FI) - 1 Gennaio 016 Scambio di materia (II) Esercizio 1 Evaporazione di acqua da una piscina Stimare la perdita
STUDIO DI MASSIMA DI UNA STRUTTURA TRASPORTABILE PER UN AEROGENERATORE DI CONCEZIONE INNOVATIVA
 Università degli Studi di Bologna FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Laboratorio di CAD STUDIO DI MASSIMA DI UNA STRUTTURA TRASPORTABILE PER UN AEROGENERATORE DI CONCEZIONE INNOVATIVA
Università degli Studi di Bologna FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Laboratorio di CAD STUDIO DI MASSIMA DI UNA STRUTTURA TRASPORTABILE PER UN AEROGENERATORE DI CONCEZIONE INNOVATIVA
Tipologie di murature portanti
 Tipologie di murature portanti Le murature costituite dall assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta possono essere a singolo paramento, se la parete è senza cavità o giunti verticali continui
Tipologie di murature portanti Le murature costituite dall assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta possono essere a singolo paramento, se la parete è senza cavità o giunti verticali continui
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE Prova scritta di FISICA 30 gennaio 2012
 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE Prova scritta di FISICA 30 gennaio 2012 1) Un corpo di massa m = 1 kg e velocità iniziale v = 5 m/s si muove su un piano orizzontale scabro, con coefficiente di attrito
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE Prova scritta di FISICA 30 gennaio 2012 1) Un corpo di massa m = 1 kg e velocità iniziale v = 5 m/s si muove su un piano orizzontale scabro, con coefficiente di attrito
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 16/01/2015
 Compito di Fisica Generale (Meccanica) 16/01/2015 1) Un cannone spara un proiettile di massa m con un alzo pari a. Si calcoli in funzione dell angolo ed in presenza dell attrito dell aria ( schematizzato
Compito di Fisica Generale (Meccanica) 16/01/2015 1) Un cannone spara un proiettile di massa m con un alzo pari a. Si calcoli in funzione dell angolo ed in presenza dell attrito dell aria ( schematizzato
La risposta ad ogni quesito è scritta in carattere normale, ulteriori spiegazioni saranno scritte in corsivo.
 La risposta ad ogni quesito è scritta in carattere normale, ulteriori spiegazioni saranno scritte in corsivo. ESERCIZIO 1 a) Dall osservazione del diagramma si evince che ad un elevata temperatura di fusione
La risposta ad ogni quesito è scritta in carattere normale, ulteriori spiegazioni saranno scritte in corsivo. ESERCIZIO 1 a) Dall osservazione del diagramma si evince che ad un elevata temperatura di fusione
Nome: Cognome: Data: 01/04/2017
 Esercizio N. 1 Valutazione 5 Un ala, lunga L = 25m, è modellata come una trave in alluminio (E = 72GPa, Iy=2e-4m 4 ) incastrata alla fusoliera in x=0m, come in figura. La sollecitazione che si vuole studiare
Esercizio N. 1 Valutazione 5 Un ala, lunga L = 25m, è modellata come una trave in alluminio (E = 72GPa, Iy=2e-4m 4 ) incastrata alla fusoliera in x=0m, come in figura. La sollecitazione che si vuole studiare
Fondamenti di Meccanica Esame del
 Politecnico di Milano Fondamenti di Meccanica Esame del 0.02.2009. In un piano verticale un asta omogenea AB, di lunghezza l e massa m, ha l estremo A vincolato a scorrere senza attrito su una guida verticale.
Politecnico di Milano Fondamenti di Meccanica Esame del 0.02.2009. In un piano verticale un asta omogenea AB, di lunghezza l e massa m, ha l estremo A vincolato a scorrere senza attrito su una guida verticale.
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L AUTONOMIA
 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L AUTONOMIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LORGNA-PINDEMONTE VERONA INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L AUTONOMIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LORGNA-PINDEMONTE VERONA INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA
Problemi di Fisica per l ammissione alla Scuola Galileiana Problema 1
 Problemi di Fisica per l ammissione alla Scuola Galileiana 2015-2016 Problema 1 Un secchio cilindrico di raggio R contiene un fluido di densità uniforme ρ, entrambi ruotanti intorno al loro comune asse
Problemi di Fisica per l ammissione alla Scuola Galileiana 2015-2016 Problema 1 Un secchio cilindrico di raggio R contiene un fluido di densità uniforme ρ, entrambi ruotanti intorno al loro comune asse
Prima classificazione fondazioni
 Prima classificazione fondazioni Una struttura trasferisce al terreno attraverso le fondazioni il proprio peso, il peso di ciò che contiene oltre a tutte le forze verticali e laterali che agiscono su di
Prima classificazione fondazioni Una struttura trasferisce al terreno attraverso le fondazioni il proprio peso, il peso di ciò che contiene oltre a tutte le forze verticali e laterali che agiscono su di
Meccanica. 1. Lavoro, forze conservative e teorema dell energia cinetica 2. Energia potenziale e conservazione dell energia meccanica
 Meccanica 1. Lavoro, forze conservative e teorema dell energia cinetica 2. Energia potenziale e conservazione dell energia meccanica Lavoro di una forza Forza costante Forza non costante Unità di misura
Meccanica 1. Lavoro, forze conservative e teorema dell energia cinetica 2. Energia potenziale e conservazione dell energia meccanica Lavoro di una forza Forza costante Forza non costante Unità di misura
Dottorato in Fisica XIV ciclo n.s. 21 gennaio 2013 Prova scritta n.1
 Dottorato in Fisica XIV ciclo n.s. 1 gennaio 013 Prova scritta n.1 Compito 1. I processi oscillatori in fisica. Conseguenze della corrente di spostamento nelle equazioni di Maxwell. Un cilindro di raggio
Dottorato in Fisica XIV ciclo n.s. 1 gennaio 013 Prova scritta n.1 Compito 1. I processi oscillatori in fisica. Conseguenze della corrente di spostamento nelle equazioni di Maxwell. Un cilindro di raggio
N.B.: I dati geometrici includono gli spessori dei liquidi 1 e 2.
 ' ' ) 1) Assegnate tutte le dimensioni geometriche, i pesi specifici r e Ym, la forza verticale F agente sul pistone (comprendente anche il peso proprio del pistone), l'indicazione ~ del manometro differenziale,
' ' ) 1) Assegnate tutte le dimensioni geometriche, i pesi specifici r e Ym, la forza verticale F agente sul pistone (comprendente anche il peso proprio del pistone), l'indicazione ~ del manometro differenziale,
DUOPAC. Struttura POLYPAC SEALING SYSTEMS. Guarnizioni per pistone DPS-DPC
 Struttura Disponibili in due differenti versioni: DPS per montaggio su pistone monoblocco DPC per montaggio su pistone in due pezzi le guarnizioni DUOPAC sono particolarmente indicate per la tenuta su
Struttura Disponibili in due differenti versioni: DPS per montaggio su pistone monoblocco DPC per montaggio su pistone in due pezzi le guarnizioni DUOPAC sono particolarmente indicate per la tenuta su
Capitolo 3 Cinematica e Dinamica
 Capitolo 3 Cinematica e Dinamica 3.1 Cinematica del Manovellismo Centrato Una volta aver calcolato dimensioni e masse caratteristiche del motore nel suo complessivo e di ogni singolo componente dello stesso,
Capitolo 3 Cinematica e Dinamica 3.1 Cinematica del Manovellismo Centrato Una volta aver calcolato dimensioni e masse caratteristiche del motore nel suo complessivo e di ogni singolo componente dello stesso,
Esercizi Termodinamica
 Esercizio 1 Esercizi Termodinamica Esercitazioni di Fisica LA per ingegneri - A.A. 2007-2008 Determinare il volume occupato da 10 g di ossigeno (massa molare 32 g/mole) alla pressione di 1 atm e alla temperatura
Esercizio 1 Esercizi Termodinamica Esercitazioni di Fisica LA per ingegneri - A.A. 2007-2008 Determinare il volume occupato da 10 g di ossigeno (massa molare 32 g/mole) alla pressione di 1 atm e alla temperatura
METODI DI RAPPRESENTAZIONE DI UN SISTEMA
 METODI DI RAPPRESENTAZIONE DI UN SISTEMA PROPRIETA ELEMENTARI Proprietà elementari dei componenti idraulici Proprietà elementari dei componenti termici Proprietà elementari dei componenti meccanici Proprietà
METODI DI RAPPRESENTAZIONE DI UN SISTEMA PROPRIETA ELEMENTARI Proprietà elementari dei componenti idraulici Proprietà elementari dei componenti termici Proprietà elementari dei componenti meccanici Proprietà
VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. LA RISPOSTA DI UNA AZIENDA ITALIANA Maria Manara Dal Cin S.p.A. (Sesto San Giovanni, MI)
 MANARA, VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. PAG. 1 VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. LA RISPOSTA DI UNA AZIENDA ITALIANA Maria Manara Dal Cin S.p.A. (Sesto San Giovanni,
MANARA, VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. PAG. 1 VINO-CONTENITORE-CHIUSURA: UNA RELAZIONE COMPLESSA. LA RISPOSTA DI UNA AZIENDA ITALIANA Maria Manara Dal Cin S.p.A. (Sesto San Giovanni,
STATICA E DINAMICA DEI FLUIDI
 STATICA E DINAMICA DEI FLUIDI Pressione Principio di Pascal Legge di Stevino Spinta di Archimede Conservazione della portata Teorema di Bernoulli Legge di Hagen-Poiseuille Moto laminare e turbolento Stati
STATICA E DINAMICA DEI FLUIDI Pressione Principio di Pascal Legge di Stevino Spinta di Archimede Conservazione della portata Teorema di Bernoulli Legge di Hagen-Poiseuille Moto laminare e turbolento Stati
Fisica Generale I (primo e secondo modulo) A.A , 14 Gennaio 2010
 Fisica Generale I (primo e secondo modulo) A.A. 2009-10, 14 Gennaio 2010 Esercizi di meccanica relativi al primo modulo del corso di Fisica Generale I, anche equivalente ai corsi di Fisica Generale 1 e
Fisica Generale I (primo e secondo modulo) A.A. 2009-10, 14 Gennaio 2010 Esercizi di meccanica relativi al primo modulo del corso di Fisica Generale I, anche equivalente ai corsi di Fisica Generale 1 e
LEZIONE 1. IL PROGETTO STRUTTURALE Parte 2. La modellazione. Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A
 Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A. 2007-2008 Facoltà di Architettura Università degli Studi di Genova LEZIONE 1 IL PROGETTO STRUTTURALE Parte 2. La modellazione LA MODELLAZIONE INPUT
Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A. 2007-2008 Facoltà di Architettura Università degli Studi di Genova LEZIONE 1 IL PROGETTO STRUTTURALE Parte 2. La modellazione LA MODELLAZIONE INPUT
MOTO CIRCOLARE UNIFORME
 MOTO CIRCOLARE UNIFORME La velocita di un corpo puo variare in modulo (valore), ma anche in direzione e/o verso (e un vettore!) P 2 P 1 Un corpo si muove di moto circolare uniforme se percorre una circonferenza
MOTO CIRCOLARE UNIFORME La velocita di un corpo puo variare in modulo (valore), ma anche in direzione e/o verso (e un vettore!) P 2 P 1 Un corpo si muove di moto circolare uniforme se percorre una circonferenza
IL MOTO ARMONICO QUALCHE RIMANDO ALLA FORZA CENTRIPETA E AL MOTO CIRCOLARE
 www.aliceappunti.altervista.org IL MOTO ARMONICO QUALCHE RIMANDO ALLA FORZA CENTRIPETA E AL MOTO CIRCOLARE Nel moto circolare uniforme, il moto è generato da una accelerazione centripeta, diretta verso
www.aliceappunti.altervista.org IL MOTO ARMONICO QUALCHE RIMANDO ALLA FORZA CENTRIPETA E AL MOTO CIRCOLARE Nel moto circolare uniforme, il moto è generato da una accelerazione centripeta, diretta verso
Inoltre si consiglia di svolgere i seguenti esercizi:
 I.I.S.S. MARIE CURIE Savignano sul Rubicone Esercizi di FISICA per la classe 1 DT A.S. 2017-2018 Prof. Alberto Pasini Si consiglia di riguardare tutti gli esercizi svolti in classe e assegnati come compito
I.I.S.S. MARIE CURIE Savignano sul Rubicone Esercizi di FISICA per la classe 1 DT A.S. 2017-2018 Prof. Alberto Pasini Si consiglia di riguardare tutti gli esercizi svolti in classe e assegnati come compito
ESERCITAZIONE: PROPRIETÁ DEI MATERIALI. Ing. Luigi Coppola
 ESERCITAZIONE: PROPRIETÁ DEI MATERIALI Ing. Luigi Coppola MODULO SECANTE Si traccia una linea che congiunge l origine degli assi e il punto della curva corrispondente al 40% di σ R E cm =22000 (f cm /10)
ESERCITAZIONE: PROPRIETÁ DEI MATERIALI Ing. Luigi Coppola MODULO SECANTE Si traccia una linea che congiunge l origine degli assi e il punto della curva corrispondente al 40% di σ R E cm =22000 (f cm /10)
I CUSCINETTI VOLVENTI
 I CUSCINETTI VOLVENTI COSA SONO? Organi meccanici interposti tra albero e struttura rigida con lo scopo di: favorire la rotazione regolare dell albero ridurre al minimo l attrito sopportare le forze trasmesse
I CUSCINETTI VOLVENTI COSA SONO? Organi meccanici interposti tra albero e struttura rigida con lo scopo di: favorire la rotazione regolare dell albero ridurre al minimo l attrito sopportare le forze trasmesse
Terza prova parziale di Fisica Data: 15 Dicembre Fisica. 15 Dicembre Test a risposta singola
 Fisica 15 Dicembre 2011 Test a risposta singola ˆ Una forza si dice conservativa quando: Il lavoro compiuto dalla forza su un qualsiasi cammino chiuso è nullo Il lavoro compiuto dalla forza su un qualsiasi
Fisica 15 Dicembre 2011 Test a risposta singola ˆ Una forza si dice conservativa quando: Il lavoro compiuto dalla forza su un qualsiasi cammino chiuso è nullo Il lavoro compiuto dalla forza su un qualsiasi
La corrente di un fluido
 La corrente di un fluido 0 La corrente di un fluido è il movimento ordinato di un liquido o di un gas. 0 La portata q è il rapporto tra il volume di fluido V che attraversa una sezione in un tempo t ed
La corrente di un fluido 0 La corrente di un fluido è il movimento ordinato di un liquido o di un gas. 0 La portata q è il rapporto tra il volume di fluido V che attraversa una sezione in un tempo t ed
69.8/3 = 23.2 = 23 automobili
 Meccanica 19 Aprile 2017 Problema 1 (1 punto) Una moto salta una fila di automobili di altezza h= 1.5 m e lunghezza l=3m ciascuna. La moto percorre una rampa che forma con l orizzontale un angolo = 30
Meccanica 19 Aprile 2017 Problema 1 (1 punto) Una moto salta una fila di automobili di altezza h= 1.5 m e lunghezza l=3m ciascuna. La moto percorre una rampa che forma con l orizzontale un angolo = 30
Resistenza dei materiali
 Scheda riassuntiva capitoli 8-1 Resistenza dei materiali a resistenza dei materiali mette in relazione tra loro i seguenti elementi: Trazione/ Carichi compressione Taglio Flessione Torsione Deformazioni
Scheda riassuntiva capitoli 8-1 Resistenza dei materiali a resistenza dei materiali mette in relazione tra loro i seguenti elementi: Trazione/ Carichi compressione Taglio Flessione Torsione Deformazioni
Programmazione modulare
 Programmazione modulare 2016-2017 Indirizzo: BIENNIO Disciplina: FISICA Classe: I a D - I a E - I a F Ore settimanali previste: 3 (2 ore di teoria 1 ora di Laboratorio) Titolo Modulo Contenuti Conoscenze
Programmazione modulare 2016-2017 Indirizzo: BIENNIO Disciplina: FISICA Classe: I a D - I a E - I a F Ore settimanali previste: 3 (2 ore di teoria 1 ora di Laboratorio) Titolo Modulo Contenuti Conoscenze
Fisica Medica Esercizi
 Fisica Medica Esercizi Roberto Guerra roberto.guerra@unimi.it Dipartimento di Fisica Università degli studi di Milano (1) Data la seguente equazione: L = 2P V /x t a) ricavare x in funzione delle altre
Fisica Medica Esercizi Roberto Guerra roberto.guerra@unimi.it Dipartimento di Fisica Università degli studi di Milano (1) Data la seguente equazione: L = 2P V /x t a) ricavare x in funzione delle altre
Meccanica del punto materiale
 Meccanica del punto materiale Princìpi della dinamica. Forze. Momento angolare. Antonio Pierro @antonio_pierro_ (https://twitter.com/antonio_pierro_) Per consigli, suggerimenti, eventuali errori o altro
Meccanica del punto materiale Princìpi della dinamica. Forze. Momento angolare. Antonio Pierro @antonio_pierro_ (https://twitter.com/antonio_pierro_) Per consigli, suggerimenti, eventuali errori o altro
ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE
 UPPORI RULLO INRODUZION La MILX.p.. ha deciso di mettere a disposizione dei clienti la sua professionalità creando una linea completa di supporti a rullo, garantendone la qualità e fornendo l assistenza
UPPORI RULLO INRODUZION La MILX.p.. ha deciso di mettere a disposizione dei clienti la sua professionalità creando una linea completa di supporti a rullo, garantendone la qualità e fornendo l assistenza
