RECUPERO DI UNA CAVITA NATURALE: INDAGINE PRELIMINARE SU ASPETTI MICROCLIMATICI E ILLUMINOTECNICI PROPOSTA DI SOLUZIONI ECOCOMPATIBILI
|
|
|
- Fabrizio Catalano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 7 Congresso Nazionale CIRIAF Atti (Perugia 3/31 marzo 27) RECUPERO DI UNA CAVITA NATURALE: INDAGINE PRELIMINARE SU ASPETTI MICROCLIMATICI E ILLUMINOTECNICI PROPOSTA DI SOLUZIONI ECOCOMPATIBILI C. Buratti 1, P. Ricciardi 2, M.Vergoni 1 1 CIRIAF, Sez. Fisica Tecnica e Inquinamento Ambientale, Università di Perugia, Via Duranti 67, 6125 Perugia 2 CIRIAF, Sez. Inquinamento Acustico e da Emissioni Gassose, Università di Pavia, Via Ferrata 1, 271 Pavia SOMMARIO Lo studio del comfort termoigrometrico e illuminotecnico in ambienti moderati di tipo convenzionale è da tempo oggetto di studio e numerosi sono i lavori presenti in Letteratura. Oggetto del presente lavoro è la fase preliminare di studio per rendere abitabile una cavità naturale situata nel comune di Sacrofano, in provincia di Roma. Il progetto nasce da un idea del proprietario della grotta che ha coinvolto diverse figure tra cui l Università di Perugia, l amministrazione locale ed alcune aziende che operano nel settore di impianti eco-compatibili ed energie rinnovabili. E stata condotta una campagna di rilievi con lo scopo di valutare le attuali condizioni dell ambiente, indagando i principali parametri microclimatici, di qualità dell aria ed illuminotecnici. In fase di post-processing, si sono calcolati gli indici PMV e PPD e confrontati i valori con gli standard previsti sia dalla UNI EN ISO 773 che dalla ISO-DIS 773. Per il comfort visivo, i valori di Illuminamento e Luminanza misurati sono stati messi in relazione con quelli prescritti dalla norma UNI EN E stata condotta parallelamente una ricerca finalizzata ad individuare i prodotti offerti dal mercato per climatizzare ed illuminare la grotta in maniera eco-compatibile: particolare interesse è stato rivolto all impiego dell energia solare e delle biomasse. Sono stati ipotizzati, inoltre, alcuni interventi strutturali ed architettonici per adeguare la cavità agli standard abitativi minimi e creare i presupposti per l alloggiamento di impianti tecnologici ad impatto ambientale ridotto. INTRODUZIONE Il comfort in ambienti confinati ha coinvolto molteplici settori tecnico-scientifici che, con crescente enfasi, si sono sviluppati con il fine di rendere il più possibile gradevole la permanenza in ambienti confinati da parte degli occupanti. Gli aspetti microclimatici hanno avuto negli studi del fisico danese Fanger un impulso deciso e determinante nell ispirare nuove normative e offrire spunti ai progettisti per migliorare le prestazioni degli impianti, ottimizzando anche le tecnologie disponibili. La presenza di luce poi, è uno dei fattori principali che influenzano l abitabilità di un luogo chiuso: una buona illuminazione garantisce ai soggetti che si trovano ad occupare un ambiente, momentaneamente o in maniera stabile, un elevata qualità della visione, cautelando la salute dell organo della vista, offrendo una valorizzazione estetica dell ambiente stesso, con conseguente benessere anche psicologico. Molteplici sono gli studi presenti in Letteratura che trattano separatamente o congiuntamente il benessere termoigrometrico e illuminotecnico in luoghi quali residenze, uffici, scuole, attività commerciali: sono tutti spazi appositamente progettati e realizzati con destinazioni d uso prestabilite e perciò subordinate a standard ormai consolidati. Nel presente lavoro si espongono i risultati di uno studio preliminare indirizzato a recuperare e rendere vivibile una cavità naturale tufacea, per trasformarla in un ambiente salubre con l impiego esclusivo di soluzioni architettoniche e tecnologiche eco-compatibili. La cavità è situata nel comune di Sacrofano, in provincia di Roma: l idea ha preso forma dalla volontà del proprietario di realizzare un ambiente pilota che funga da elemento trainante per sfruttare al meglio tali cavità, tipiche della zona, quasi sempre inutilizzate. Il progetto ha coinvolto anche l amministrazione comunale di Sacrofano e numerosi sono stati i contatti anche con operatori di mercato specializzati nella produzione di soluzioni impiantistiche eco-compatibili. La cavità è stata dapprima studiata da altre figure professionali legate alla committenza, dal punto di vista architettonico, della stabilità strutturale e dei materiali. Lo studio è articolato in una ricerca bibliografica mirata alle problematiche in esame, successivamente si è passati alla programmazione di una campagna di misure per valutare le attuali condizioni all interno della grotta; l elaborazione dei risultati ed il confronto con gli intervalli imposti dalle normative tecniche ha suggerito le prime indicazioni per intervenire sul sito, mediante alcune soluzioni impiantistiche ad impatto ambientale limitato, la cui progettazione preliminare costituisce il punto ultimo in questa fase del lavoro. INQUADRAMENTO DEL SITO E LAYOUT DELLA CAMPAGNA SPERIMENTALE La grotta di Sacrofano La grotta tufacea si trova all interno del Parco Naturale Regionale di Veio, tra la Via Flaminia e la Via Cassia a nord di Roma; il territorio ha un andamento prevalentemente collinare (fig. 1), non vi sono rilievi accentuati e la gran parte delle alture derivano da crateri e depositi vulcanici. La grande valle di Sacrofano, infatti, è nata dalla depressione di piccole e grandi bocche crateriche e presenta pianure intervallate ad altopiani, gole e balze. Il tutto è stato creato dalla lenta erosione dei corsi d acqua e dalla giovane stratificazione di rocce di tipo tufaceo.
2 E possibile, inoltre, osservare sulle pareti la presenza di piccole cavità, di varie dimensioni, tipiche della roccia tufacea, che vanno a costituire delle nicchie tondeggianti rialzate rispetto al pavimento e che probabilmente erano adibite a scaffali quando la grotta era utilizzata come cantina. All esterno, nella parte superiore all ingresso della grotta, in posizione leggermente arretrata, si rileva la presenza di un altra cavità di forma irregolare, con una superficie pari circa a 5 m2 e altezza irregolare, mediamente pari a 1,8 m, che incide sulla volta della grotta principale. Strumentazione di misura e pianificazione del rilievo Figura 1: il territorio di Sacrofano visibile dalla cavità naturale oggetto di studio. Non è da sottovalutare l aspetto storico - archeologico del sito, che ha rappresentato un centro di modesta importanza in diverse epoche. Gli edifici che dominano queste zone sono prevalentemente realizzati in tufo, un materiale povero che rappresenta ancora oggi la pietra locale più diffusa, grazie alla sua lavorabilità, creando dei blocchi di pietrame che, esposti all aria, prendono maggior consistenza. La cavità naturale si trova a circa 26 m su livello del mare, ha uno sviluppo prevalentemente longitudinale lungo l asse sud-nord, con ingresso orientato a sud, che si affaccia su uno spazio aperto di circa 4 m2: tale superficie è delimitata dal muro di un abitazione sul lato ovest, mentre ad est si apre lasciando spazio all ingresso di un altra grotta, di proprietà diversa. E possibile accedere alla cavità attraverso un cancello metallico sormontato da un arco e montato su una parete di blocchi di tufo che chiude l apertura naturale della grotta, avanzando l ingresso originario di circa un metro e mezzo. All interno della grotta si distinguono 5 zone: un piccolo ingresso (A), con pareti in blocchi di tufo; l ambiente principale (B), il più ampio e maggiormente vivibile della grotta; un corridoio (C) sviluppato in lunghezza, per circa 8 metri, ma di larghezza variabile tra un minimo di circa 1,6 m e un massimo di 1,81 m, e due nicchie, una sulla parete est (D) di dimensioni maggiori, e una ad ovest (E) di dimensioni più contenute. N Gli strumenti impiegati nei rilievi microclimatici sono stati: due multiacquisitori della linea BABUC e le relative sonde conformi a quanto prescritto dalla UNI EN ISO 7726, montate in differenti configurazioni. In particolare, le sonde connesse alle centraline hanno permesso il rilievo delle principali grandezze riportate nella UNI EN ISO 773 e nella ISO/DIS 773 quali: - temperatura dell aria secca e umida; - umidità relativa; - velocità dell aria; - temperatura del globotermometro; - pressione atmosferica; - temperatura asimmetrica radiante; - temperatura del pavimento; - concentrazione di CO2. Da tali valori, in automatico, o tramite software in post processing, lo strumento è in grado di determinare alcuni indici globali e locali di comfort: - PMV; - PPD; - rischio da corrente d aria; - gradiente verticale di temperatura; - percentuale di insoddisfatti da temperatura del pavimento. Ai fini del rilievo illuminotecnica, si sono impiegati due strumenti della Konica Minolta, il luxmetro-colorimetro Chromameter CL-2 e il misuratore di Luminanza LS-1, in grado di misurare: - illuminamento (lux); - temperatura di colore (Kelvin); - luminanza (cd/m2). Mediante tali parametri è possibile valutare il comfort visivo secondo quanto previsto dalla UNI EN Figura 2: planimetria e sezione della cavità naturale.
3 Le misure sono state effettuate in una giornata dell ottobre 26 e consistono in un ciclo di misure mattutino e uno pomeridiano. In aggiunta, due termoigrometri a capelli sono stati posizionati rispettivamente nella grotta superiore (per rappresentare le condizioni esterne), e nell ambiente principale all interno della cavità: il rilievo ha avuto la durata di due settimane. Per le due centraline BABUC sono state individuate 4 postazioni (fig. 3), una esterna e tre interne, così da relazionare i dati con la situazione meteorologica e climatica stagionale. Ciascun rilievo ha avuto la durata di 1 minuti in ogni posizione, con un intervallo di acquisizione pari a 2 secondi, per un totale di 3 valori istantanei. RISULTATI DEI RILIEVI DELLO STATO ATTUALE Comfort microclimatico L analisi dei risultati si è basata sul confronto dei valori ottenuti per ogni postazione; successivamente gli stessi sono stati mediati per ottenere una sintesi delle condizioni termoigrometriche della cavità durante la sessione del mattino e quelle del pomeriggio. Ai fini del calcolo degli indici microclimatici, è stato necessario effettuare delle ipotesi circa l attività metabolica svolta dai soggetti e la resistenza termica dell abbigliamento (Tab.1), con un ipotesi di rendimento meccanico pari allo %. Tabella 1: ipotesi sull attività metabolica e resistenza termica del vestiario. Attività metabolica Riferimento M = 1,33 met (77,5 W/m2), occupazione impiegato (UNI EN 28996) M = 1,2 met (7 W/m2), attività sedentaria Resistenza termica del vestiario Composizione tipica autunno (uomo) 1,3 clo (UNI EN ISO 992) Composizione tipica autunno (donna),92 clo In tabella 2 e 3 sono riportati i valori delle principali grandezze ambientali rispettivamente per le sessioni mattutina e pomeridiana. I dati delle postazioni 2 e 3, rappresentativi dell ambiente principale, sono stati raggruppati dal momento che sono stati rilevati valori pressoché coincidenti. Figura 3: centraline microclimatiche posizionate al termine del corridoio, sul lato nord, della cavità in corrispondenza delle nicchie D e E. Allo stato attuale, la grotta non è dotata di impianto di illuminazione artificiale: per le misure di illuminamento sono stati individuati 16 punti, uniformemente distribuiti su tutta la superficie della grotta. Non essendo ancora stati definiti i compiti visivi, ci si è limitati a verificare le zone di passaggio ipotetiche, posizionando lo strumento ad un altezza di 2 cm da terra. Le misure di luminanza (fig. 4) hanno riguardato il solo contributo imputabile alla riflessione di alcune superfici: si sono scelti 5 punti in corrispondenza della porta d ingresso, valutati da tre diverse posizioni, e altri 5 punti sulla parete interna, valutati in una sola posizione. Figura 4: Luminanzometro in prossimità di una parete all interna alla cavità. Tabella 2: sintesi dei parametri microclimatici (mattino). ta Postazione 1 Esterno Postazione 2/3 Postazione 4 tu CO2 (ppm) tg Pa (hpa) 21,82 17,18 61, ,4 76, , ,92 16,85 89, , ,7 UR (%) Tabella 3: sintesi dei parametri microclimatici (pomeriggio). ta tu UR (%) CO2 (ppm) Postazione 1 Esterno 22,59 17,91 62,6 Postazione 2/3 2,5 17,72 75,77 Postazione 4 17,64 16,82 92,4 tg Pa (hpa) , , Si osserva che l umidità relativa è estremamente elevata, soprattutto in fondo alla cavità, con valori (punte oltre il 9%) che ricadono al di fuori degli intervalli imposti dalle norme. La temperatura secca diminuisce notevolmente passando dalla postazione 1 alla 4, sia di mattino che di pomeriggio: c è una differenza di 3,9 C tra l esterno e il fondo della grotta durante la mattina, mentre di pomeriggio l escursione raggiunge i 5 C. La temperatura a bulbo umido, invece, si mantiene costante nelle tre diverse postazioni: l escursione tra la posizione 2 e la 4 è sempre inferiore a 1 C. La differenza di umidità relativa tra l esterno e il lato nord della grotta è di circa il 28% nel ciclo di misura mattutino, 3% in quello pomeridiano. La massima escursione termica tra la temperatura interna e quella esterna è di 2 C di mattino e diventa di oltre 4 C nel pomeriggio. I valori di temperatura esterna misurati non sono in linea
4 con i dati storico-statistici che si riscontrano usualmente in questo periodo, in quanto risultano ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Passando all analisi degli indici globali, in postazione 2 e 3 (Tab. 4), i valori PMV poco si discostano dalla neutralità termica, con una PPD attorno al 5% sia nel ciclo di misura mattutino che in quello pomeridiano. Nella postazione 4, la PPD tende ad aumentare fino ad oltre il 15% nelle ore pomeridiane, a causa dell umidità relativa particolarmente elevata e di temperature al di sotto di 18 C. Tabella 4: valori medi degli indici PMV e PPD all interno della cavità. Postazione 2 e 3 4 Indice PMV PPD (%) PMV PPD (%) -,16 5,54 -,58 12,4 -,24 6,29 -,7 15,42 Relativamente al discomfort locale, si è ottenuta una PPD superiore al 5% per il gradiente di temperatura verticale nel ciclo di misure mattutino per le posizioni 2 e 3 (Fig. 5); in posizione 4, invece, tale indice si mantiene sempre al di sotto del 2%. Sempre nelle posizioni 2 e 3 è rilevante la percentuale di insoddisfatti da temperatura del pavimento, pari al 1,2% e 11,3% rispettivamente di mattino e di pomeriggio, in corrispondenza di una temperatura superficiale di circa 18 C (Fig. 6). In postazione 4, la differenza di temperatura verticale è sempre al di sotto dei 3 C raccomandati dalla normativa, e la percentuale di insoddisfatti è sempre inferiore al 2% (Fig. 7) La temperatura del pavimento (Fig. 8) è pari a 16,95 C e 17,4 C rispettivamente di mattino e di pomeriggio, e per questo la percentuale di insoddisfatti è vicina al 15% (13,9% e 12,5% rispettivamente). Tcollo Tcaviglie MATTINO Tcollo Tcaviglie Ins 1.6 Ins 1.8 POMERIGGIO Figura 7: valori medi postazione 4 - Gradiente termico verticale e percentuale di insoddisfatti. Tsuperf Tsuperf 17.4 Tcollo Tcaviglie Ins Ins 13.9 Ins 12.5 Tcollo 21.2 Tcaviglie Tcollo Tcaviglie Tsuperf Ins Tcollo Tcaviglie Ins. 5.4 Ins. MATTINA POMERIGGIO MATTINO POMERIGGIO Ins. 2.3 Figura 8: valori medi postazione 4 Temperatura del pavimento e percentuale di insoddisfatti. Figura 5: valori medi postazione 2 e 3 - Gradiente termico verticale e Percentuale Prevista di insoddisfatti. Tsuperf Ins. 1.2 Tsuperf Ins Tsuperf Ins. E da sottolineare come, in ogni momento della giornata, siano nulli i valori del rischio da corrente d aria: questo fatto è rappresentativo di velocità dell aria e di intensità di turbolenza prossime allo zero in ogni ambiente della grotta, soprattutto nella parte più lontana dall ingresso. Per quel che riguarda la qualità dell aria, misurata valutando la concentrazione di anidride carbonica, in postazione 2 e 3 la percentuale di insoddisfatti assume valori molto bassi, attorno al 2-3%; valori più elevati (6%), ma comunque contenuti negli standard qualitativi richiesti si hanno in fondo alla cavità. Comfort illuminotecnico MATTINA POMERIGGIO Figura 6: valori medi postazione 2 e 3 Temperatura del pavimento e Percentuale Prevista di Insoddisfatti. Nella parte della cavità più lontana dalla porta d ingresso (punti 1-6), il contributo della luce naturale è molto scarso, con valori inferiori a 5 lux (Tab. 5). Per quanto riguarda la parte restante, nelle ore mattutine si registra un andamento dei valori di illuminamento generalmente crescente man mano che ci si avvicina alla porta d ingresso, passando dai 9 lux del punto 7 ai 6669 lux del punto 16, con alcune eccezioni causate
5 dalla presenza di oggetti d ingombro all interno della grotta e di rami di alberi, all esterno, che muovendosi schermano la luce diretta del sole, come succede ad esempio nei punti 1 e 14, nei quali si ha un abbassamento rispetto ai punti precedenti rispettivamente da 14 a 1 lux e da 112 a 93 lux. Analoghi risultati si hanno nelle ore pomeridiane, nelle quali, però, l illuminamento assume valori generalmente più bassi, ad eccezione di alcuni punti (come ad esempio il 12, 14 e 15) che nel pomeriggio sono interessati da raggi solari diretti, grazie all abbassamento del sole e che, quindi, presentano un innalzamento dell illuminamento rispetto al valore mattutino da 5 a 56 lux per il punto 12, da 93 a 116 lux per il punto 14 e da 267 a 418 lux per il punto 15. In figura 9 sono riportate le curve isolux durante la giornata di rilievo. Tabella 5: valori di illuminamento all interno della cavità Punto ILLUMINAMENTO Dai dati in tabella 6, si osserva come i valori di luminanza risultino strettamente correlati alla posizione relativa tra le postazioni di misura e il percorso compiuto dal sole rispetto all orientamento dell ingresso della cavità. Il punto A, all apice dell arco, è l unico ad essere irradiato direttamente dalla luce solare: nella postazione di misura si osservano valori costanti, nelle altre due posizioni si hanno valori più elevati nelle ore mattutine rispetto a quelle pomeridiane, con un picco di 4115 cd/m2 misurato alla distanza di 5,5 m; la luminanza minore 152 cd/m2, si registra a 1,2 m. La luminanza del punto B nelle ore pomeridiane alla distanza di 2,5 m dalla porta d ingresso è risultata la più elevata con un valore di 7372 cd/m2, nettamente superiore a tutti gli altri misurati e determinato dalla posizione particolarmente favorevole della postazione di misura rispetto alla luce naturale filtrante dall esterno. I valori mediamente più bassi sono stati misurati nei punti C e D che, trovandosi ai lati della porta, ricevono minore luce diretta a causa delle pareti degli edifici vicini e delle ante del cancello. Nel punto E infine, si sono misurati valori costanti nella sessione mattutina mentre nel pomeriggio, nel punto più prossimo all ingresso, il valore è risultato più basso rispetto a quello ottenuto per gli altri due, differenza spiegabile con l ombra portata da una struttura limitrofa posta a destra del varco d ingresso. Si riportano le curve di livello per visualizzare la luminanza sulla porta d ingresso (Fig. 1) per la distanza intermedia di 5,5 m. Tabella 6: valori della Luminanza sulla porta d ingresso. Punto A Punto B Punto C Punto D Punto E a) b) Figura 9: planimetria della cavità - Curve Isolux (mattina (a) pomeriggio(b)) Le misure di luminanza sono state effettuate su vari punti della porta di ingresso (unica sorgente di luce naturale), da tre diverse distanze dalla stessa, e sulla parete interna parallela all ingresso. Sono stati scelti i punti più significativi, tenendo conto della presenza dell arco sovrastante che, nonostante le ridotte dimensioni, aumenta notevolmente l apporto di luce all interno della grotta. Distanza Ingresso (verso l interno) 2,5 m 5,5 m 1,2 m a) b) Figura 1: curve di livello della luminanza sulla porta d ingresso(mattina (a) pomeriggio(b)) 25 3
6 IPOTESI DI PROGETTO PRELIMINARE Interventi strutturali ed architettonici L intervento mira a mantenere gli ambienti presenti senza separarli o crearne di nuovi, realizzando, però, alcune operazioni di modellamento e ampliamento, dopo aver effettuato opportune verifiche di consolidamento statico e strutturale. In particolare: 1. ampliamento dell attuale ingresso e consolidamento della volta dove oggi sono presenti travi in acciaio; 2. pulizia del piano di calpestio da terra e materiale inerte e livellamento della pavimentazione; 3. realizzazione di una pavimentazione in pietra naturale sopraelevata, con opportuna impermeabilizzazione; 4. rimozione dei muretti in blocchi di tufo presenti sul lato ovest della grotta e pulizia della vasca che può fungere da serbatoio di acqua; 5. livellamento del piano di calpestio del corridoio che, attualmente, ha una pendenza di circa il 1 %; 6. ampliamento delle dimensioni del vano sinistro; 7. ampliamento della nicchia destra creando, così, due ambienti simmetrici e speculari; 8. ampliamento dell ingresso e sostituzione parziale della muratura con materiali trasparenti. Soluzioni per il comfort microclimatico Per dotare la grotta di impianti ecocompatibili, le soluzioni individuate sono da ricercare nell impiego di energia solare, termica e fotovoltaica integrata, per la parte termica, con energia da biomasse. Si ipotizza la realizzazione di un impianto a pavimento al di sotto della pavimentazione rialzata. Il riscaldamento del fluido termovettore è ottenibile installando una serie di pannelli solari piani ai fianchi della cavità superiore, a ridosso del pendio. Una possibile disposizione delle tubazioni, può assumere la configurazione di figura 11, con interasse 2 cm, temperatura del fluido 3 C circa. spesso, però, insufficiente o inefficace e, specialmente nei mesi invernali, dispendiosa in termini di riscaldamento dei locali. La pavimentazione rialzata, inoltre, garantisce l annullamento delle radiazioni di radon dal pavimento nell ambiente. Infine, si pensa di dotare la cavità di sistemi specifici per eliminare l umidità che risale per capillarità nei muri,al fine di migliorare le condizioni di vita e ridurre i costi di riscaldamento. Ipotesi per il comfort illuminotecnico Le ipotesi correttive consistono in primo luogo nell integrazione di sistemi di captazione e trasporto della luce naturale all interno della grotta con un impianto di illuminazione artificiale. Il mercato offre molteplici sistemi per la captazione della luce naturale: - lucernari: servono per condurre la luce all interno dell edificio attraverso il tetto; - tubi di luce: sono condotti verticali o orizzontali, con pareti interne ad alta riflessione, che trasmettono la luce dall esterno all interno; - light pipes: simili ai tubi luce, sono costituiti da una serie di specchi collegati ad un eliostato; - sistemi fotovoltaici; - fibre ottiche: sistemi di lenti di Fresnel che filtrano la luce solare captata da un eliostato. In particolare, si sono rivelati interessanti i Captatori Solari dell azienda BRIXIA SOLAR (Fig. 12). Sono piccoli congegni semisferici, caratterizzati da un sistema di captazione ottica: sono costituiti da un captatore posto all interno della calotta semisferica all estremità, che direziona la luce solare e la incanala in un condotto ad alta riflessione, che può seguire percorsi obliqui, orizzontali, trasportando la luce nell ambiente desiderato, dove un diffusore, applicato all altezza del soffitto, la diffonde all interno dell ambiente. E presente anche un sistema di ricambio d aria. Figura 11: disposizione delle tubazioni per il riscaldamento a pavimento Come integrazione al sistema solare termico, si prevede l inserimento di una caldaia funzionante a biomasse, che per facilità di stoccaggio e rendimento di combustione può essere alimentata a pellet. Un problema, da non sottovalutare è costituito dalle emissioni di radon: questo gas, estremamente pesante, tende ad accumularsi e, poiché la pressione all interno di un ambiente è leggermente più bassa di quella esterna, l aria tende a stagnare piuttosto che a rinnovarsi. Un metodo immediato per evitare l accumulo di questo gas è l aerazione degli ambienti, soprattutto nei casi in cui questi siano interrati o a contatto diretto con il terreno, come nel caso in esame. Una corretta e continua ventilazione può contrastare l'aumento della concentrazione di radon; questa tecnica risulta Figura 12: captatori solari Brixia Solar Schema costruttivo Per la grotta in esame il diametro individuato è di 52 mm, che può illuminare superfici tra 25 e 36 m 2, con un flusso luminoso pari a 15 lumen. Nel posizionamento, occorre tener conto che la luce in uscita dal condotto dipende
7 fortemente dall intensità luminosa del sole e diminuisce in relazione alla lunghezza del condotto, per cui è consigliabile posizionare il captatore sulla copertura della grotta, alternandolo con i pannelli solari necessari al riscaldamento, ma arretrato il più possibile rispetto all ingresso, in modo tale da raggiungere facilmente il fondo della grotta con un condotto più breve possibile. E inoltre possibile captare una maggiore radiazione luminosa, senza variare la posizione, elevando i captatori mediante Torrette Solari in rame. Considerata la superficie della grotta, di circa 65 m 2, e per garantire un valore puntuale dell'illuminamento di almeno 1 lux è necessario un flusso luminoso totale di circa 655 lm. La scelta percorribile è quella di lampade ad alogeni per tensione di rete ad attacco doppio, che soddisfano i requisiti flusso, temperatura di colore, durata e risparmio energetico: si prevede l impiego di 9 lampade con 5 W di potenza ciascuna, adeguatamente distribuite (Fig. 13). Figura 13: ipotesi di posizionamento delle lampade. CONCLUSIONI In Letteratura esistono molteplici studi volti all indagine delle condizioni di benessere per gli occupanti di ambienti moderati convenzionali, progettati e realizzati per garantire qualità ottimali in spazi confinati. Il presente studio ha come oggetto la valutazione delle condizioni termoigrometriche ed illuminotecniche all interno di una cavità naturale per rendere la stessa abitabile e rispondente alle esigenze di comfort. Il progetto nasce da un idea del proprietario della grotta che ha coinvolto diverse figure tra cui l Università di Perugia, l amministrazione locale ed alcune aziende che operano nel settore di impianti ecocompatibili ed energie rinnovabili. Il lavoro ha portato alla definizione del comfort termoigrometrico e illuminotecnico all interno di una cavità naturale situata nel territorio di Sacrofano in provincia di Roma. Attraverso una campagna di misure è stata valutata la possibilità di recuperare la grotta tufacea, oggi in disuso, per trasformarla in un ambiente vivibile impiegando esclusivamente soluzioni a ridotto impatto ambientale. Dal punto di vista microclimatico, in linea generale si può affermare che la cavità, nonostante sia distante dall idea classica di luogo confortevole e sia attualmente allo stato di abbandono, non offre uno standard qualitativo eccessivamente inferiore a quelli previsti dalla normativa tecnica. I risultati sono stati comunque ottenuti in una giornata con condizioni esterne favorevoli e dunque, per avere un quadro più rappresentativo, occorrerebbe monitorare i parametri con maggiore continuità. I punti di misura individuati all interno della cavità sono l ambiente principale (postazione 2 e postazione 3) e il lato nord della cavità: in fondo alla grotta (postazione 4). All interno dell ambiente principale non si sono riscontrati particolari valori fuori norma; tuttavia, si sono evidenziati tre aspetti su cui è opportuno soffermarsi: - l umidità relativa riscontrata risulta costantemente superiore al 7% (in media è pari al 76%); - il gradiente verticale di temperatura riscontrato raggiunge il limite di 3 C, con una PPD che supera il 5%; - facendo una media tra le temperature del pavimento, rilevate nel ciclo di misura mattutino e in quello pomeridiano, si riscontra una temperatura media superficiale di 18 C, a cui corrisponde una percentuale prevista di insoddisfatti media di 11%. E importante notare che, mentre il problema legato all eccessiva umidità dell aria è riscontrato in ognuna delle due postazioni individuate all interno della grotta, l elevato gradiente di temperatura verticale costituisce un evento singolare, che non si è ripetuto in corrispondenza del lato nord della cavità, dove si ha una differenza di temperatura media di 1,5-1,6 C. Particolare attenzione va posta alla temperatura del pavimento, che è in media pari a 18 C, a causa dell elevata umidità del suolo, e ricade al di fuori dell intervallo imposto dalla normativa (19 26 C): gli insoddisfatti da temperatura superficiale, quindi, superano sempre il 1%. Per quel che riguarda la qualità dell aria, non si sono riscontrate percentuali di insoddisfatti da concentrazione di anidride carbonica superiori al 2%, inoltre non si hanno insoddisfatti da asimmetria radiante e anche il draft risk (DR) è costantemente nullo. In fondo alla grotta, sia di mattino che di pomeriggio, le percentuali di insoddisfatti aumentano notevolmente per l elevato grado di umidità, lo scarso irraggiamento solare e il non adeguato ricambio d aria. Infatti, sono state rilevate le seguenti problematiche: - l umidità relativa media è pari al 91%; - gli insoddisfatti da temperatura del pavimento sono in media pari al 13,2%, la temperatura superficiale è pari a 17 C; - la temperatura dell aria è pari, in media, a 17,5 C. Si sono ipotizzate soluzioni tecnologiche ed architettoniche; i criteri fondamentali su cui si è basato il progetto sono la razionalizzazione dell assetto distributivo, l ottimizzazione della struttura e del sistema tecnologico e l applicazione di soluzioni eco-sostenibili alternative. Le risorse energetiche impiegabili sono l energia solare e la bioenergia derivante dalle biomasse. Una progettazione più accurata degli interventi necessita di un estensione del rilievo a periodi in cui si hanno le condizioni esterne più gravose (pieno inverno e pieno estate). In merito ai rilievi illuminotecnici, le misure di illuminamento hanno interessato 16 punti dislocati su tutta la superficie della cavità, mentre la luminanza è stata misurata in 5 punti sulla porta d ingresso (unica fonte luminosa naturale per l ambiente), da tre diverse distanze, in modo da variare l angolazione con cui la luce solare entra nella cavità, e sulla parete interna. Dall analisi dei dati è emerso che, per quanto riguarda l illuminamento, si riscontrano valori sostanzialmente crescenti a partire dai punti sul fondo della grotta fino a quelli più vicini all ingresso, con alcune eccezioni causate dalla presenza di ingombri non rimovibili. Si è osservato che, dal fondo alla fine del corridoio che porta alla sala principale, l illuminamento assume valori inferiori a 5 lux, quindi quasi trascurabili e molto inferiori rispetto agli oltre 65 lux misurati di fronte all ingresso. Si sono misurati valori di illuminamento più elevati la mattina rispetto al pomeriggio in quasi tutti i punti, per il fatto che l ingresso della cavità è esposto a sud.
8 Per quanto riguarda, invece, la luminanza sulla porta d ingresso, si sono riscontrati valori diversi sui medesimi punti, dalle tre diverse distanze (2,5; 5,5; 1,2 m) in stretta correlazione con il percorso del sole sulla linea di orizzonte e dall orientamento dell ingresso della cavità. Nei punti laterali si sono misurati valori più bassi dal momento che non sono colpiti da luce diretta e parzialmente schermati dagli edifici confinanti e dalle ante del cancello. I valori della luminanza sulla parete interna, invece, si sono rivelati bassi, assumendo anche valori prossimi allo zero, poiché non è presente alcuna superficie riflettente o sorgente luminosa in quella direzione. Dai dati emersi dalla campagna di misura in sito, si è riscontrata la necessità di proporre delle soluzioni per ovviare all evidente scarsità di luce naturale, soprattutto nelle zone più interne della cavità, non solo mediante un impianto di illuminazione artificiale, ma anche con sistemi di captazione della luce naturale da sfruttare nelle ore diurne, consentendo un notevole risparmio energetico. Oltre al contributo dei sistemi solari fotovoltaici, che potrebbero alimentare un sistema di 9 lampade ad alogeni, si è studiato l inserimento nel contesto di captatori solari capaci di convogliare all interno la luce naturale incidente su dispositivi a torretta. NOMENCLATURA CO 2 = concentrazione di anidride carbonica (ppm); Ins. = insoddisfatti a causa di discomfort locale (%); Pa = pressione atmosferica (hpa); PMV = voto medio previsto; PPD = percentuale prevista di insoddisfatti (%); T = temperatura ; UR = umidità relativa (%). Pedici: a = aria secca; g = globotermometro u = aria umida. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 1. FELLI M., Lezioni di Fisica Tecnica1, Termodinamica, Macchine, Impianti, Nuova edizione a cura di Francesco Ascdrubali, Morlacchi Editore, Perugia, Maggio FELLI M., Lezioni di Fisica Tecnica 2, Trasmissione del calore, Acustica, Tecnica dell illuminazione, Nuova edizione a cura di Cinzia Buratti, Morlacchi Editore, Perugia, Ottobre FANGER P.O., Thermal comfort, McGraw Hill, New York, MONCADA LO GIUDICE G., COPPI M., Benessere termico e qualità dell'aria interna. Roma: Masson ALFANO G., D AMBROSIO F.R., RICCIO G., La valutazione delle condizioni termoigrometriche negli ambienti di lavoro: comfort e sicurezza. Napoli: CUEN ASHRAE. Physiological principles, comfort and health. In: ASHRAE Fundamentals, capitolo 8. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers, Inc MONCADA LO GIUDICE G., Principi di illuminotecnica, PEG, Milano, AGHEMO C., LO VERSO V., Guida alla progettazione dell illuminazione naturale, AIDI BONOMO M. e BUCCIANTI R., Guida Tecnica per l Illuminazione degli Interni 1. BARDUCCI I., Fotometria e Colorimetria, ESA, Roma FELLIN L. e FORCOLINI G. e PALLADINO P., Manuale di Illuminotecnica, Tecniche Nuove, Settimo Milanese (MI), ISO, 23. Ergonomics of thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort. ISO/DIS 773. Geneva: International Standardization Organization, UNI-EN-ISO 1551 Ergonomia degli ambienti termici Valutazione dell influenza dell ambiente termico mediante scale di giudizio soggettive. Gennaio ASHRAE, 24. Thermal Environment Conditions for Human Occupancy ASHRAE Standard 55/24. Geneva, UNI, Ergonomia Determinazione della produzione di energia termica metabolica, Norma UNI-EN 28996, Unificazione Italiana, Milano, UNI, Ambienti termici Strumenti e metodi per la misura delle grandezze fisiche, Norma UNI-EN 27726, Unificazione Italiana, Milano, UNI-EN-ISO 992 Ergonomia degli ambienti termici Valutazione dell isolamento termico e della resistenza evaporativi dell abbigliamento. Marzo ASHRAE Standard 62.1/24 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 19. Standard ASTM , Guide for Using Indoor Carbon Dioxide Concentrations of Evaluate Indoor Air Quality and Ventilation, May UNI 138, Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale, UNI 138/A1, Illuminotecnica. Illuminazione di interni, UNI EN , Luce e illuminazione Illuminazione dei posti di lavoro Parte 1: Posti di lavoro interni, 24
MISURE MICROCLIMATICHE METODOLOGIE E STRUMENTI
 MISURE MICROCLIMATICHE METODOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 7730:2006 Ergonomia degli ambienti termici. Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante
MISURE MICROCLIMATICHE METODOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 7730:2006 Ergonomia degli ambienti termici. Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante
RELAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA
 RELAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA 1. Obiettivi di progettazione sostenibile. Il progetto del nuovo fabbricato residenziale, in località Cervia, Centro Storico, verrà sviluppato in alcune sue parti secondo
RELAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA 1. Obiettivi di progettazione sostenibile. Il progetto del nuovo fabbricato residenziale, in località Cervia, Centro Storico, verrà sviluppato in alcune sue parti secondo
Corso di: Tecnica del controllo ambientale. a.a
 Corso di: Tecnica del controllo ambientale a.a. 2012-2013 Benessere ambientale dell individuo Benessere ambientale dell individuo Benessere termoigrometrico t i Condizione di neutralità termica, in cui
Corso di: Tecnica del controllo ambientale a.a. 2012-2013 Benessere ambientale dell individuo Benessere ambientale dell individuo Benessere termoigrometrico t i Condizione di neutralità termica, in cui
I PARAMETRI SOGGETTIVI
 Conoscere il rischio / Ergonomia / Comfort termico I PARAMETRI SOGGETTIVI Premessa Per ricavare un quadro verosimile della situazione microclimatica all interno degli ambienti lavorativi è necessario determinare,
Conoscere il rischio / Ergonomia / Comfort termico I PARAMETRI SOGGETTIVI Premessa Per ricavare un quadro verosimile della situazione microclimatica all interno degli ambienti lavorativi è necessario determinare,
Master Universitario di II livello in Edilizia sostenibile ed efficienza energetica Politecnico di Torino Ed. I a.a. 2011/2012 TESI DI MASTER
 Master Universitario di II livello in Edilizia sostenibile ed efficienza energetica Politecnico di Torino Ed. I a.a. 2011/2012 TESI DI MASTER Sviluppo del progetto di ricerca WSAN M&C Wireless Sensor &
Master Universitario di II livello in Edilizia sostenibile ed efficienza energetica Politecnico di Torino Ed. I a.a. 2011/2012 TESI DI MASTER Sviluppo del progetto di ricerca WSAN M&C Wireless Sensor &
Tecnica del controllo ambientale: Il benessere Termoigrometrico Parte II Gli ambienti moderati. Marco Dell isola
 Tecnica del controllo ambientale: Il benessere Termoigrometrico Parte II Gli ambienti moderati Marco Dell isola Indice PARTE 2 Gli ambienti moderati Generalità Gli indici di benessere Indici di sensazione
Tecnica del controllo ambientale: Il benessere Termoigrometrico Parte II Gli ambienti moderati Marco Dell isola Indice PARTE 2 Gli ambienti moderati Generalità Gli indici di benessere Indici di sensazione
Valutazioni di comfort in edifici esistenti. ing. Roberto Armani ing. Massimiliano Busnelli
 Valutazioni di comfort in edifici esistenti ing. Roberto Armani ing. Massimiliano Busnelli Rimini, 08 novembre 2016 LE NOSTRE CASE SONO SALUBRI? Il benessere indoor questo SCONOSCIUTO! SCONOSCIUTO: Cos
Valutazioni di comfort in edifici esistenti ing. Roberto Armani ing. Massimiliano Busnelli Rimini, 08 novembre 2016 LE NOSTRE CASE SONO SALUBRI? Il benessere indoor questo SCONOSCIUTO! SCONOSCIUTO: Cos
A6.7 MICROCLIMA. CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03. MODULO A Unità didattica
 Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole MICROCLIMA MODULO A Unità didattica A6.7 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 Definizioni CLIMA Fattori atmosferici
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole MICROCLIMA MODULO A Unità didattica A6.7 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 Definizioni CLIMA Fattori atmosferici
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto S.S.A. Sistema Complesso Qualità dell Aria, Rumore, CEM Pag.
 2 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di Michele Stortini e Marco Deserti ARPA - S M R) 2.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio
2 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di Michele Stortini e Marco Deserti ARPA - S M R) 2.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio
Edifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologiche
 Parma, 6 giugno 2012 Auditorium Polifunzionale Università degli Studi di Parma INTERVENTO DI GIORGIO PAGLIARINI Edifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologiche Edificio a energia
Parma, 6 giugno 2012 Auditorium Polifunzionale Università degli Studi di Parma INTERVENTO DI GIORGIO PAGLIARINI Edifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologiche Edificio a energia
(Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA - SIMC)
 Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 21 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 21 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA
MISURE MICROCLIMATICHE METODOLOGIE E STRUMENTI
 MISURE MICROCLIMATICHE METODOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 7730:2006 Ergonomia degli ambienti termici. Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante
MISURE MICROCLIMATICHE METODOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 7730:2006 Ergonomia degli ambienti termici. Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante
Questi indicatori sono stati elaborati in relazione al territorio della Provincia di Ravenna.
 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA - SIMC) 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della qualità dell
3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA - SIMC) 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della qualità dell
Integrazione luce naturale/luce artificiale in ambito industriale Parte 1: Analisi dell ambiente luminoso per il capannone AleniaAermacchi
 Integrazione luce naturale/luce artificiale in ambito industriale Parte 1: Analisi dell ambiente luminoso per il capannone Franco Gugliermetti, Fabio Bisegna Report RSE/2009/37 Ente per le Nuove tecnologie,
Integrazione luce naturale/luce artificiale in ambito industriale Parte 1: Analisi dell ambiente luminoso per il capannone Franco Gugliermetti, Fabio Bisegna Report RSE/2009/37 Ente per le Nuove tecnologie,
EDIFICI A CONSUMO ENERGETICO QUASI ZERO
 ECO-CASE EDILCLIMA EDIFICI A CONSUMO ENERGETICO QUASI ZERO PLANIMETRIA PRELIMINARE Tenendo conto dei vincoli legati al lotto si è definita una soluzione planimetrica di massima. SCELTA DELLA TIPOLOGIA
ECO-CASE EDILCLIMA EDIFICI A CONSUMO ENERGETICO QUASI ZERO PLANIMETRIA PRELIMINARE Tenendo conto dei vincoli legati al lotto si è definita una soluzione planimetrica di massima. SCELTA DELLA TIPOLOGIA
SAPP EASY-KLIMA IL SOFFITTO RADIANTE METALLICO
 SAPP EASY-KLIMA IL SOFFITTO RADIANTE METALLICO SAPP EASY-KLIMA IL SOFFITTO RADIANTE METALLICO Oltre 30 anni di know-how sui sistemi radianti, la consolidata esperienza sul radiante a soffitto Leonardo,
SAPP EASY-KLIMA IL SOFFITTO RADIANTE METALLICO SAPP EASY-KLIMA IL SOFFITTO RADIANTE METALLICO Oltre 30 anni di know-how sui sistemi radianti, la consolidata esperienza sul radiante a soffitto Leonardo,
Elaborazione dati ambientali microclimatici
 Elaborazione dati ambientali microclimatici IPER CARREFOUR SAN GIULIANO MILANESE S.S. Emilia Km 315 20098 San Giuliano Milanese(MI) INDICE Indice... 2 PREMESSA... 3 IL RISCHIO FISICO: CONDIZIONI GENERALI...
Elaborazione dati ambientali microclimatici IPER CARREFOUR SAN GIULIANO MILANESE S.S. Emilia Km 315 20098 San Giuliano Milanese(MI) INDICE Indice... 2 PREMESSA... 3 IL RISCHIO FISICO: CONDIZIONI GENERALI...
Il microclima. Cosa vuol dire?
 1 Cosa vuol dire? DEFINIZIONE Insieme degli aspetti fisici che caratterizzano l aria degli ambienti confinati, intendendosi per tali tutte quelle infrastrutture più o meno separate dall ambiente esterno
1 Cosa vuol dire? DEFINIZIONE Insieme degli aspetti fisici che caratterizzano l aria degli ambienti confinati, intendendosi per tali tutte quelle infrastrutture più o meno separate dall ambiente esterno
MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE
 01/09/2003 dr. Gabriele M. Campurra 1 ENEA ENEA --Sede Sede di di Brindisi Corso Corso di di Formazione e Informazione 22 22 e 23 23 maggio maggio 2002 2002 MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE Dr. Dr. Gabriele
01/09/2003 dr. Gabriele M. Campurra 1 ENEA ENEA --Sede Sede di di Brindisi Corso Corso di di Formazione e Informazione 22 22 e 23 23 maggio maggio 2002 2002 MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE Dr. Dr. Gabriele
Rapporto N. H.0611.S.393.EMCP-Produzione
 Rapporto N. H.0611.S.393.EMCP-Produzione Riscaldamento di fabbricati industriali Comparazione delle emissioni termiche di pannelli radianti a soffitto e riscaldamento a pavimento Capannoni adibiti a produzione
Rapporto N. H.0611.S.393.EMCP-Produzione Riscaldamento di fabbricati industriali Comparazione delle emissioni termiche di pannelli radianti a soffitto e riscaldamento a pavimento Capannoni adibiti a produzione
Energy-Efficient Building Design. Metodologie per infrastrutture complesse e di pregio architettonico
 Energy-Efficient Building Design Metodologie per infrastrutture complesse e di pregio architettonico In questo lavoro vengono presentate metodologie di analisi relative all efficientamento energetico su
Energy-Efficient Building Design Metodologie per infrastrutture complesse e di pregio architettonico In questo lavoro vengono presentate metodologie di analisi relative all efficientamento energetico su
prof. ing. Anna Magrini Il progetto del recupero: problematiche
 prof. ing. Anna Magrini Università degli Studi di Pavia Il progetto del recupero: problematiche Efficienza energetica dell involucro edilizio Edificio degli anni 1950-80 200-250 kwh/m 2 a Legge 373 / 1976
prof. ing. Anna Magrini Università degli Studi di Pavia Il progetto del recupero: problematiche Efficienza energetica dell involucro edilizio Edificio degli anni 1950-80 200-250 kwh/m 2 a Legge 373 / 1976
SOFTWARE Norma UNI EN manuale d utilizzo 1 SOFTWARE. Benessere Termico Norma UNI EN 7730
 SOFTWARE Norma UNI EN 7730 - manuale d utilizzo 1 SOFTWARE Benessere Termico Norma UNI EN 7730 SOFTWARE Norma UNI EN 7730 - manuale d utilizzo 2 SCOPO DEL SOFTWARE Calcolare gli indici di comfort termico
SOFTWARE Norma UNI EN 7730 - manuale d utilizzo 1 SOFTWARE Benessere Termico Norma UNI EN 7730 SOFTWARE Norma UNI EN 7730 - manuale d utilizzo 2 SCOPO DEL SOFTWARE Calcolare gli indici di comfort termico
Recupero energetico di edifici tradizionali
 CONVEGNO FORMATIVO Recupero energetico di edifici tradizionali Strumenti e tecniche Salone Polifunzionale "Grand Place", Pollein, 5 novembre 2013 CONVEGNO FORMATIVO La metodologia del Quaderno per il recupero
CONVEGNO FORMATIVO Recupero energetico di edifici tradizionali Strumenti e tecniche Salone Polifunzionale "Grand Place", Pollein, 5 novembre 2013 CONVEGNO FORMATIVO La metodologia del Quaderno per il recupero
Gli impianti e la direttiva 2010/31/UE
 EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO Gli impianti e la direttiva 2010/31/UE Marco Masoero Dipartimento di Energetica Politecnico di Torino 1/41 Italia Domanda di energia primaria Italia: domanda di energia primaria
EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO Gli impianti e la direttiva 2010/31/UE Marco Masoero Dipartimento di Energetica Politecnico di Torino 1/41 Italia Domanda di energia primaria Italia: domanda di energia primaria
I ponti termici possono rappresentare fino al 20% del calore totale disperso da un ambiente.
 Isolamento termico dei componenti L isolamento termico di un componente di tamponamento esterno è individuato dalla resistenza termica complessiva: trasmittanza (U espressa in W/m 2 K) L isolamento termico
Isolamento termico dei componenti L isolamento termico di un componente di tamponamento esterno è individuato dalla resistenza termica complessiva: trasmittanza (U espressa in W/m 2 K) L isolamento termico
La produzione di freddo per mezzo dell irraggiamento solare (Solar cooling)
 La produzione di freddo per mezzo dell irraggiamento solare (Solar cooling) Il ricorso a tecnologie capaci di impiegare in maniera proficua la radiazione solare è diventata una prassi ormai molto comune
La produzione di freddo per mezzo dell irraggiamento solare (Solar cooling) Il ricorso a tecnologie capaci di impiegare in maniera proficua la radiazione solare è diventata una prassi ormai molto comune
LA LUCE: energia radiante capace di eccitare la retina e dar luogo alla sensazione visiva
 LA LUCE: energia radiante capace di eccitare la retina e dar luogo alla sensazione visiva cc LA LUCE: cc diurna notturna LA LUCE: lunghezza d onda del visibile cc 400/800 nm LA LUCE: lunghezza d onda del
LA LUCE: energia radiante capace di eccitare la retina e dar luogo alla sensazione visiva cc LA LUCE: cc diurna notturna LA LUCE: lunghezza d onda del visibile cc 400/800 nm LA LUCE: lunghezza d onda del
DISCOMFORT TERMICO PER GLI ADDETTI AI LAVORI IN STRUTTURE DI ALLEVAMENTO CON RAFFRESCAMENTO PER NEBULIZZAZIONE
 Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. DISCOMFORT TERMICO PER GLI ADDETTI AI LAVORI IN STRUTTURE DI ALLEVAMENTO CON RAFFRESCAMENTO
Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. DISCOMFORT TERMICO PER GLI ADDETTI AI LAVORI IN STRUTTURE DI ALLEVAMENTO CON RAFFRESCAMENTO
Materiale didattico validato da: L ambiente luminoso. Il Benessere Visivo. Rev. 1 lug Illuminamento slide 1 di 25
 L ambiente luminoso Il Benessere Visivo Rev. 1 lug. 2009 Illuminamento slide 1 di 25 Cos è la luce La luce è un energia radiante in grado di eccitare la retina dell occhio producendo una sensazione visiva.
L ambiente luminoso Il Benessere Visivo Rev. 1 lug. 2009 Illuminamento slide 1 di 25 Cos è la luce La luce è un energia radiante in grado di eccitare la retina dell occhio producendo una sensazione visiva.
I sistemi di illuminazione in ambienti con pericolo di esplosione: l illuminazione dei serbatoi
 Gennaio 2016 I sistemi di illuminazione in ambienti con pericolo di esplosione: l illuminazione dei serbatoi 1. Introduzione Negli insediamenti industriali coesistono di norma diversi sistemi di illuminazione
Gennaio 2016 I sistemi di illuminazione in ambienti con pericolo di esplosione: l illuminazione dei serbatoi 1. Introduzione Negli insediamenti industriali coesistono di norma diversi sistemi di illuminazione
Grandezze fotometriche
 Capitolo 3 Grandezze fotometriche 3.1 Intensità luminosa E una grandezza vettoriale di simbolo I. Ha come unità di misura la candela(cd). La candela è l unità di misura fondamentale del sistema fotometrico.
Capitolo 3 Grandezze fotometriche 3.1 Intensità luminosa E una grandezza vettoriale di simbolo I. Ha come unità di misura la candela(cd). La candela è l unità di misura fondamentale del sistema fotometrico.
COSTRUZIONE DI 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA CON CRITERI DI EDILIZIA ECO COMPATIBILE IN VIA CESARE DELL ACQUA A TRIESTE
 COSTRUZIONE DI 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA CON CRITERI DI EDILIZIA ECO COMPATIBILE IN VIA CESARE DELL ACQUA A TRIESTE DPR 31/08/2010, N 0201/Pres Accordo di programma tra:
COSTRUZIONE DI 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA CON CRITERI DI EDILIZIA ECO COMPATIBILE IN VIA CESARE DELL ACQUA A TRIESTE DPR 31/08/2010, N 0201/Pres Accordo di programma tra:
Ambiente termico moderato. Indagine strumentale e valutazione dell ambiente microclimatico in alcune cabine di guida di locomotori.
 Ambiente termico moderato. Indagine strumentale e valutazione dell ambiente microclimatico in alcune cabine di guida di locomotori. P.Tura, M. Fontana ARPA Piemonte Rischio Industriale ed Igiene Industriale
Ambiente termico moderato. Indagine strumentale e valutazione dell ambiente microclimatico in alcune cabine di guida di locomotori. P.Tura, M. Fontana ARPA Piemonte Rischio Industriale ed Igiene Industriale
Riqualificazione di edifici scolastici: le esperienze dell Università Iuav di Venezia
 Riqualificazione di edifici scolastici: le esperienze dell Università Iuav di Venezia Francesca cappelletti Dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi UniversitÀ Iuav di venezia
Riqualificazione di edifici scolastici: le esperienze dell Università Iuav di Venezia Francesca cappelletti Dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi UniversitÀ Iuav di venezia
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
SCUOLA PRIMARIA GIROLAMO LORENZI
 SCUOLA PRIMARIA GIROLAMO LORENZI Cappotto di lana Riduzione dei consumi Tetto Illuminazione Pellicola vetri Adeguamento antisismico Impianti Insonorizzazione Umidità Circolazione dell aria QUALITÀ DELLA
SCUOLA PRIMARIA GIROLAMO LORENZI Cappotto di lana Riduzione dei consumi Tetto Illuminazione Pellicola vetri Adeguamento antisismico Impianti Insonorizzazione Umidità Circolazione dell aria QUALITÀ DELLA
VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA
 Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Il verde pensile ed il costruito. Matteo Fiori
 Il verde pensile ed il costruito matteo.fiori@polimi.it Perché intervenire? 2 Creazione di nuovi spazi di relax Riqualificazione architettonica Miglioramento della qualità ambientale dell ambiente confinato
Il verde pensile ed il costruito matteo.fiori@polimi.it Perché intervenire? 2 Creazione di nuovi spazi di relax Riqualificazione architettonica Miglioramento della qualità ambientale dell ambiente confinato
DK 500V SCHEDA TECNICA ROOF INDICE. 1. Anagrafica. 2. Caratteristiche Tecniche. 3. Certificazioni. 4. Utilizzo. 5. Posa in Opera. 6.
 INDICE 1. Anagrafica 2. Caratteristiche Tecniche 3. Certificazioni 4. Utilizzo 5. Posa in Opera 6. Dati tecnici 7. Voce di capitolato 1/11 1. ANAGRAFICA CODICE PRODOTTO: GRUPPO: FAMIGLIA: NOME: 1-4010V
INDICE 1. Anagrafica 2. Caratteristiche Tecniche 3. Certificazioni 4. Utilizzo 5. Posa in Opera 6. Dati tecnici 7. Voce di capitolato 1/11 1. ANAGRAFICA CODICE PRODOTTO: GRUPPO: FAMIGLIA: NOME: 1-4010V
Sistemi radianti a pavimento a basso spessore e bassa inerzia: tipologie e caratteristiche
 Sistemi radianti a pavimento a basso spessore e bassa inerzia: Ing. Clara Peretti Segretario Generale Consorzio Q-RAD Febbraio 2017 Figura 1. Sistemi radianti a basso spessore I sistemi radianti a pavimento
Sistemi radianti a pavimento a basso spessore e bassa inerzia: Ing. Clara Peretti Segretario Generale Consorzio Q-RAD Febbraio 2017 Figura 1. Sistemi radianti a basso spessore I sistemi radianti a pavimento
La luce naturale per il risparmio energetico ed il comfort visivo: un esempio di analisi
 La luce naturale per il risparmio energetico ed il comfort visivo: un esempio di analisi Francesca Fragliasso E possibile progettare la luce naturale? - Le difficoltà legate al suo sfruttamento La disponibilità
La luce naturale per il risparmio energetico ed il comfort visivo: un esempio di analisi Francesca Fragliasso E possibile progettare la luce naturale? - Le difficoltà legate al suo sfruttamento La disponibilità
VENTILAZIONE
 VENTILAZIONE 1 Sensibilizzare i Professionisti RISPARMIO ENERGETICO Le problematiche attuali: il clima ed il consumo energetico degli edifici COME FARE? Strategie per i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento:
VENTILAZIONE 1 Sensibilizzare i Professionisti RISPARMIO ENERGETICO Le problematiche attuali: il clima ed il consumo energetico degli edifici COME FARE? Strategie per i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento:
Arch. Silvio RUFOLO. Geom. Antonio MANCINI. Arch. Silvio RUFOLO. Arch. Antonio DATTIS
 PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE Arch. Silvio RUFOLO RESPONSABILE del PROCEDIMENTO Geom. Antonio MANCINI PROGETTISTI Arch. Silvio RUFOLO Arch. Antonio DATTIS P.O. Puglia FESR 2007-2013 ASSE VII
PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE Arch. Silvio RUFOLO RESPONSABILE del PROCEDIMENTO Geom. Antonio MANCINI PROGETTISTI Arch. Silvio RUFOLO Arch. Antonio DATTIS P.O. Puglia FESR 2007-2013 ASSE VII
DIMENSIONAMENTO ILLUMINOTECNICO
 DIMENSIONAMENTO ILLUMINOTECNICO Giovanni Parrotta Classe concorso A040 Prerequisiti: Grandezze fotometriche Le relazioni che individuano le grandezze fotometriche sono relative a sorgenti puntiformi, ovvero
DIMENSIONAMENTO ILLUMINOTECNICO Giovanni Parrotta Classe concorso A040 Prerequisiti: Grandezze fotometriche Le relazioni che individuano le grandezze fotometriche sono relative a sorgenti puntiformi, ovvero
Arch. ERIKA FAVRE. La riqualificazione energetica degli edifici pubblici
 Arch. ERIKA FAVRE La riqualificazione energetica degli edifici pubblici L esperienza della Valle d Aosta nell ambito del POR L esperienza della Valle d Aosta nell ambito del POR-FESR 2007/2013 Approvazione,
Arch. ERIKA FAVRE La riqualificazione energetica degli edifici pubblici L esperienza della Valle d Aosta nell ambito del POR L esperienza della Valle d Aosta nell ambito del POR-FESR 2007/2013 Approvazione,
Situazione meteorologica
 Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
FRANGISOLE SISTEMI OSCURANTI
 INFISSI METALLICI FRANGISOLE SISTEMI OSCURANTI SISTEMI OSCURANTI Caratteristiche Straordinario lo stile contemporaneo ed evoluto che il sistema è in grado di offrire. La nuova serie è più di un semplice
INFISSI METALLICI FRANGISOLE SISTEMI OSCURANTI SISTEMI OSCURANTI Caratteristiche Straordinario lo stile contemporaneo ed evoluto che il sistema è in grado di offrire. La nuova serie è più di un semplice
PERUGIA, 13 marzo Casa passiva: un metodo di progettazione e non uno standard. Umberto Desideri, Emanuele Aloisi
 PERUGIA, 13 marzo 2013 Casa passiva: un metodo di progettazione e non uno standard Umberto Desideri, Emanuele Aloisi Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Ingegneria (Industriale) Bilancio
PERUGIA, 13 marzo 2013 Casa passiva: un metodo di progettazione e non uno standard Umberto Desideri, Emanuele Aloisi Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Ingegneria (Industriale) Bilancio
Pannelli solari a HEAT PIPE
 Pannelli solari a HEAT PIPE Gli heat pipe applicati ai sistemi di condizionamento estivo Negli ultimi anni, la domanda di elettricità nel periodo estivo ha raggiunto picchi estremi per l uso eccessivo
Pannelli solari a HEAT PIPE Gli heat pipe applicati ai sistemi di condizionamento estivo Negli ultimi anni, la domanda di elettricità nel periodo estivo ha raggiunto picchi estremi per l uso eccessivo
INDAGINE SUI FLUSSI DI TRAFFICO
 INDAGINE SUI FLUSSI DI TRAFFICO Campagna di monitoraggio presso il Comune di Cazzago San Martino Dal 19/6/212 al 21/6/212 Redatta Giovanni Santoro Verificata e Approvata Prof. Ing. Maurizio Tira Sommario
INDAGINE SUI FLUSSI DI TRAFFICO Campagna di monitoraggio presso il Comune di Cazzago San Martino Dal 19/6/212 al 21/6/212 Redatta Giovanni Santoro Verificata e Approvata Prof. Ing. Maurizio Tira Sommario
L edificio adibito ad asilo nido, oggetto del presente intervento, verrà climatizzato
 1. PREMESSA L edificio adibito ad asilo nido, oggetto del presente intervento, verrà climatizzato mediante un sistema ad acqua impiegando come unità terminali dei ventilconvettori sistemati a pavimento.
1. PREMESSA L edificio adibito ad asilo nido, oggetto del presente intervento, verrà climatizzato mediante un sistema ad acqua impiegando come unità terminali dei ventilconvettori sistemati a pavimento.
MISURE DI RUMORE ALL INTERNO DI ABITAZIONI PRODOTTO DAL FUNZIONAMENTO DI TURBINE EOLICHE
 Associazione Italiana di Acustica 41 Convegno Nazionale Pisa, 17-19 giugno 2014 MISURE DI RUMORE ALL INTERNO DI ABITAZIONI PRODOTTO DAL FUNZIONAMENTO DI TURBINE EOLICHE Gino Iannace, Amelia Trematerra
Associazione Italiana di Acustica 41 Convegno Nazionale Pisa, 17-19 giugno 2014 MISURE DI RUMORE ALL INTERNO DI ABITAZIONI PRODOTTO DAL FUNZIONAMENTO DI TURBINE EOLICHE Gino Iannace, Amelia Trematerra
Report Monitoraggio Traffico
 2012 Campagna di Monitoraggio presso il Comune di Calcio nel periodo da 03/07/2012 al 05/07/2012 Redatta Giovanni Santoro Verificata e Approvata Prof. Ing. Maurizio Tira Sommario Premessa... 3 Obiettivo
2012 Campagna di Monitoraggio presso il Comune di Calcio nel periodo da 03/07/2012 al 05/07/2012 Redatta Giovanni Santoro Verificata e Approvata Prof. Ing. Maurizio Tira Sommario Premessa... 3 Obiettivo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. Laurea Magistrale in Archite>ura
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Laurea Magistrale in Archite>ura L. I. di PROGETTAZIONE TECNICA E STRUTTURALE Modulo Impianti a.a. 2012-2013 Teoria del comfort Docente:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Laurea Magistrale in Archite>ura L. I. di PROGETTAZIONE TECNICA E STRUTTURALE Modulo Impianti a.a. 2012-2013 Teoria del comfort Docente:
I sistemi geotermici a bassa temperatura: il terreno come sorgente termica
 I sistemi geotermici a bassa temperatura: il terreno come sorgente termica Con i sistemi geotermici a bassa temperatura, l utilizzo del terreno come sorgente termica, tramite una moderna pompa di calore,
I sistemi geotermici a bassa temperatura: il terreno come sorgente termica Con i sistemi geotermici a bassa temperatura, l utilizzo del terreno come sorgente termica, tramite una moderna pompa di calore,
Tabelle di valutazione del contributo percentuale: grafici operativi Esempio di software ad input numerico Esempio di software ad input grafico
 Adriano Magliocco Elementi di progettazione bioclimatica Metodi di calcolo preliminare per il dimensionamento dei sistemi solari passivi Tabelle di valutazione del contributo percentuale: grafici operativi
Adriano Magliocco Elementi di progettazione bioclimatica Metodi di calcolo preliminare per il dimensionamento dei sistemi solari passivi Tabelle di valutazione del contributo percentuale: grafici operativi
Impianti di illuminazione
 Impianti Meccanici 1 L di un locale industriale influenza la percentuale di infortuni e sulla qualità della produzione Illuminamento scarso significa : - Un progressivo senso di stanchezza degli operatori
Impianti Meccanici 1 L di un locale industriale influenza la percentuale di infortuni e sulla qualità della produzione Illuminamento scarso significa : - Un progressivo senso di stanchezza degli operatori
Come funziona una pompa di calore geotermica
 Come funziona una pompa di calore geotermica La pompa di calore reversibile abbinata a sonde geotermiche assorbe calore dalla terra e lo trasferisce dell'abitazione o all'acqua da scaldare in inverno;
Come funziona una pompa di calore geotermica La pompa di calore reversibile abbinata a sonde geotermiche assorbe calore dalla terra e lo trasferisce dell'abitazione o all'acqua da scaldare in inverno;
Il Solare a Concentrazione
 Tecnologie delle Energie Rinnovabili Il Solare a Concentrazione Prof. Daniele Cocco Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, Università di Cagliari daniele.cocco@unica.it http://people.unica.it/danielecocco/
Tecnologie delle Energie Rinnovabili Il Solare a Concentrazione Prof. Daniele Cocco Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, Università di Cagliari daniele.cocco@unica.it http://people.unica.it/danielecocco/
CasaClima classe A oro a Milano: il Type-A
 Un edificio residenziale CasaClima classe A oro a Milano: il Type-A Type-A è l edificio residenziale progettato dallo Studio associato d architettura i3d di Milano con la collaborazione dello studio AB
Un edificio residenziale CasaClima classe A oro a Milano: il Type-A Type-A è l edificio residenziale progettato dallo Studio associato d architettura i3d di Milano con la collaborazione dello studio AB
Comfort abitativo dei sistemi radianti di nuova generazione e pavimentazioni di legno
 Comfort abitativo dei sistemi radianti di nuova generazione e pavimentazioni di legno Clara Peretti Ingegnere, Consorzio Q-RAD Sistemi radianti + rivestimenti in legno = elevato comfort Sistemi radianti
Comfort abitativo dei sistemi radianti di nuova generazione e pavimentazioni di legno Clara Peretti Ingegnere, Consorzio Q-RAD Sistemi radianti + rivestimenti in legno = elevato comfort Sistemi radianti
Rete di monitoraggio della qualità dell aria della Provincia di Rimini Report 2012
 Rete di monitoraggio della qualità dell aria della Provincia di Rimini Report 2012 NOx - Via Flaminia Valori orari NOx - Parco Marecchia Valori orari 500 500 Valore limite media annuale Media annuale Valore
Rete di monitoraggio della qualità dell aria della Provincia di Rimini Report 2012 NOx - Via Flaminia Valori orari NOx - Parco Marecchia Valori orari 500 500 Valore limite media annuale Media annuale Valore
BENESSERE AMBIENTALE ED IMPLICAZIONI PROGETTUALI. Relatore: Dr.Ing. Francesco Carrer
 BENESSERE AMBIENTALE ED IMPLICAZIONI PROGETTUALI Relatore: Dr.Ing. Francesco Carrer Comfort Psicologico Comfort Termoigrometrico Condizioni di Benessere Ambientale Comfort Respiratorio Olfattivo Comfort
BENESSERE AMBIENTALE ED IMPLICAZIONI PROGETTUALI Relatore: Dr.Ing. Francesco Carrer Comfort Psicologico Comfort Termoigrometrico Condizioni di Benessere Ambientale Comfort Respiratorio Olfattivo Comfort
Capitolo 6 Risultati pag. 382
 Capitolo 6 Risultati pag. 382 generazione del calore per riscaldamento urbano, ed è comunque uniformemente distribuita sui quadranti interessati dal teleriscaldamento, con maggiore effetto su quelli più
Capitolo 6 Risultati pag. 382 generazione del calore per riscaldamento urbano, ed è comunque uniformemente distribuita sui quadranti interessati dal teleriscaldamento, con maggiore effetto su quelli più
RICERCA & PROGETTO Galassi, Mingozzi e associati
 MISURA IN OPERA DEI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO DI DUE SISTEMI TUBOLARI DI TRASPORTO DELLA LUCE NATURALE POSTI A CONFRONTO PRESSO LA NUOVA SEDE DI NUNCAS SPA A SETTIMO MILANESE Ing. Angelo Mingozzi Documento
MISURA IN OPERA DEI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO DI DUE SISTEMI TUBOLARI DI TRASPORTO DELLA LUCE NATURALE POSTI A CONFRONTO PRESSO LA NUOVA SEDE DI NUNCAS SPA A SETTIMO MILANESE Ing. Angelo Mingozzi Documento
Illuminazione efficiente nell industria, nel terziario e nel pubblico. Workshop edifici ed illuminazione pubblica Assolombarda 19 febbraio 2008
 Illuminazione efficiente nell industria, nel terziario e nel pubblico Workshop edifici ed illuminazione pubblica Assolombarda 19 febbraio 2008 INTRODUZIONE L'illuminazione è stato il primo servizio offerto
Illuminazione efficiente nell industria, nel terziario e nel pubblico Workshop edifici ed illuminazione pubblica Assolombarda 19 febbraio 2008 INTRODUZIONE L'illuminazione è stato il primo servizio offerto
Il problema delle costruzioni: rapporto sui consumi e sulle prestazioni. Non solo energia: ovvero non c è solo l energia che passa per il contatore
 Il problema delle costruzioni: rapporto sui consumi e sulle prestazioni Non solo energia: ovvero non c è solo l energia che passa per il contatore La valutazione della qualità ambientale in fase di progetto:
Il problema delle costruzioni: rapporto sui consumi e sulle prestazioni Non solo energia: ovvero non c è solo l energia che passa per il contatore La valutazione della qualità ambientale in fase di progetto:
thermobox Il termosifone del futuro da incasso a parete
 thermobox Il termosifone del futuro da incasso a parete thermobox è l innovativo radiatore convettivo da incasso a parete per il riscaldamento civile. Nasce per rispondere alle esigenze di razionalizzazione
thermobox Il termosifone del futuro da incasso a parete thermobox è l innovativo radiatore convettivo da incasso a parete per il riscaldamento civile. Nasce per rispondere alle esigenze di razionalizzazione
CASA LOW CASA LOW. Il massimo comfort è realizzabile
 CASA LOW Il massimo comfort è realizzabile Vantaggi del Sistema 4 MESI Basso Costo di Costruzione Tempi di Consegna Basso Impatto Ambientale Bassi Costi di Gestione Low - = Parete Tradizionale con Cappotto:
CASA LOW Il massimo comfort è realizzabile Vantaggi del Sistema 4 MESI Basso Costo di Costruzione Tempi di Consegna Basso Impatto Ambientale Bassi Costi di Gestione Low - = Parete Tradizionale con Cappotto:
S/V. Superficie esterna tot. m 2. m 3. 8 unità separate ,2
 Requisiti progettuali ed operativi per la sostenibilità degli edifici Prof.Luigi Bruzzi Requisiti progettuali (Progetto) Fattore di forma Esposizione (punti cardinali) Isolamento termico (pareti opache
Requisiti progettuali ed operativi per la sostenibilità degli edifici Prof.Luigi Bruzzi Requisiti progettuali (Progetto) Fattore di forma Esposizione (punti cardinali) Isolamento termico (pareti opache
Il Solare a Concentrazione
 Tecnologie delle Energie Rinnovabili Il Solare a Concentrazione Prof. Daniele Cocco Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, Università di Cagliari daniele.cocco@unica.it http://people.unica.it/danielecocco/
Tecnologie delle Energie Rinnovabili Il Solare a Concentrazione Prof. Daniele Cocco Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, Università di Cagliari daniele.cocco@unica.it http://people.unica.it/danielecocco/
Corso di Fisica Te T cnica Ambientale Benessere nesser termico Benessere nesser integr ato integr Il b enessere termico
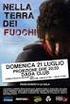 Benessere integrato Il benessere termico Il benessere integrato Quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell ambiente termico acustico luminoso Stato di neutralità termica, in cui il soggetto
Benessere integrato Il benessere termico Il benessere integrato Quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell ambiente termico acustico luminoso Stato di neutralità termica, in cui il soggetto
Tunnel Solare nel centro storico
 Tunnel Solare nel centro storico Una forma di luce integrativa per i locali non illuminati in maniera adeguata Indice 2 Il contesto storico 3 L utilità del Tunnel Solare 4 Un illuminamento adeguato 5 La
Tunnel Solare nel centro storico Una forma di luce integrativa per i locali non illuminati in maniera adeguata Indice 2 Il contesto storico 3 L utilità del Tunnel Solare 4 Un illuminamento adeguato 5 La
POLITECNICO DI TORINO
 POLITECNICO DI TORINO Vittorio Verda Dipartimento Energia POMPE DI CALORE GEOTERMICHE Il calore della terra a casa nostra. La Geotermia: cos è, come funziona, quanto si risparmia Pompe di calore a compressione
POLITECNICO DI TORINO Vittorio Verda Dipartimento Energia POMPE DI CALORE GEOTERMICHE Il calore della terra a casa nostra. La Geotermia: cos è, come funziona, quanto si risparmia Pompe di calore a compressione
L ingresso principale di Piazza Giacomini è confermato con un nuovo disegno del cortile interno, mentre viene definito un accesso indipendente alla zo
 Rapporto con il contesto urbano e organizzazione degli spazi esterni Il progetto prevede di mantenere l impostazione esistente, riorganizzando accessi ed aree e rifunzionalizzando i volumi per ridurre
Rapporto con il contesto urbano e organizzazione degli spazi esterni Il progetto prevede di mantenere l impostazione esistente, riorganizzando accessi ed aree e rifunzionalizzando i volumi per ridurre
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL ALLEGATO XIV del D.LGS.
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi In collaborazione con CEFAS IL MICROCLIMA A cura di:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi In collaborazione con CEFAS IL MICROCLIMA A cura di:
Laterizi Impredil s.r.l.
 Laterizi Impredil s.r.l. Catalogo SOLUZIONI COSTRUTTIVE Soluzioni su misura per qualsiasi intervento edilizio La progettazione dell involucro edilizio riveste importanza fondamentale nella determinazione
Laterizi Impredil s.r.l. Catalogo SOLUZIONI COSTRUTTIVE Soluzioni su misura per qualsiasi intervento edilizio La progettazione dell involucro edilizio riveste importanza fondamentale nella determinazione
IL COMFORT ABITATIVO
 IL COMFORT ABITATIVO ( sui concetti e sulle definizioni di base ) I RIFERIMENTI NORMATIVI legge 373 del 30/04/76 legge 10 del 09/01/91 direttiva 93/76 CEE del 13/09/93 direttiva 2002/91/CE D.L. 19/08/2005
IL COMFORT ABITATIVO ( sui concetti e sulle definizioni di base ) I RIFERIMENTI NORMATIVI legge 373 del 30/04/76 legge 10 del 09/01/91 direttiva 93/76 CEE del 13/09/93 direttiva 2002/91/CE D.L. 19/08/2005
GEOTERMIA PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI
 GEOTERMIA PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 Rilasciata da RINA con emissione corrente in data 13/07/2012 ATTESTAZIONE SOA Rilasciata da BENTLEY SOA in data 24/01/2013 per
GEOTERMIA PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 Rilasciata da RINA con emissione corrente in data 13/07/2012 ATTESTAZIONE SOA Rilasciata da BENTLEY SOA in data 24/01/2013 per
SCUOLA MEDIA STATALE E. FERMI Memoria descrittiva di progetto - Prima Fase
 SCUOLA MEDIA STATALE E. FERMI Memoria descrittiva di progetto - Prima Fase Il progetto ha come obiettivo la risoluzione dei problemi di frammentazione e segregazione degli spazi scolastici tramite la creazione
SCUOLA MEDIA STATALE E. FERMI Memoria descrittiva di progetto - Prima Fase Il progetto ha come obiettivo la risoluzione dei problemi di frammentazione e segregazione degli spazi scolastici tramite la creazione
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI FINALI
 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI FINALI 4 Aprile 2014 Centro Congressi Camera di Commercio Perugia Relazione ing. Gabriele De Micheli - U.O. Servizi Tecnologici Energetici Informatici Comune di Perugia Bando
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI FINALI 4 Aprile 2014 Centro Congressi Camera di Commercio Perugia Relazione ing. Gabriele De Micheli - U.O. Servizi Tecnologici Energetici Informatici Comune di Perugia Bando
Metodologia di calcolo della prestazione energetica dell illuminazione nel terziario
 Metodologia di calcolo della prestazione energetica dell illuminazione nel terziario Ridurre emissioni di CO₂ Ridurre dipendenza energetica PROTOCOLLO DI KYOTO (1997) EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Metodologia di calcolo della prestazione energetica dell illuminazione nel terziario Ridurre emissioni di CO₂ Ridurre dipendenza energetica PROTOCOLLO DI KYOTO (1997) EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PROF. ING. FLAVIO FUCCI UNIVERSITÀ DEL MOLISE. Autore - Affiliazione
 PROF. ING. FLAVIO FUCCI UNIVERSITÀ DEL MOLISE EFFICIENZA ENERGETICA per edifici adibiti ad uso civile Minima energia da utilizzare per mantenere le condizioni di benessere EE = ---------------------------------------------
PROF. ING. FLAVIO FUCCI UNIVERSITÀ DEL MOLISE EFFICIENZA ENERGETICA per edifici adibiti ad uso civile Minima energia da utilizzare per mantenere le condizioni di benessere EE = ---------------------------------------------
ESEMPI COSTRUTTIVI CON SISTEMA A SECCO IN T O S C A N A
 ESEMPI COSTRUTTIVI CON SISTEMA A SECCO IN T O S C A N A arch. Alessandro Panichi Docente di TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE Dipartimento TAeD Universita di Firenze D. LEG.VI 192 2005 / 311 2006 Allegato
ESEMPI COSTRUTTIVI CON SISTEMA A SECCO IN T O S C A N A arch. Alessandro Panichi Docente di TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE Dipartimento TAeD Universita di Firenze D. LEG.VI 192 2005 / 311 2006 Allegato
Misura del campo magnetico generato da cabine di trasformazione MT/bt: criticità e definizione di un metodo Sara Adda, Enrica Caputo
 Misura del campo magnetico generato da cabine di trasformazione MT/bt: criticità e definizione di un metodo Sara Adda, Enrica Caputo Obiettivi e metodi Finalità del lavoro: definire una metodologia di
Misura del campo magnetico generato da cabine di trasformazione MT/bt: criticità e definizione di un metodo Sara Adda, Enrica Caputo Obiettivi e metodi Finalità del lavoro: definire una metodologia di
Distributori Italia prodotti. SKY-TILE Bioclimatic Modular Skylights. Ecosolux s.r.l. Via Catone, Milano Tel
 PARAMETRI PRINCIPALI PER MODELLI DI SIMULAZIONE - Dimensioni della stanza - Altezza totale - Condizioni del cielo soleggiato - Fattore di mantenimento - Trasmissione della luce attraverso il vetro - Riflessione
PARAMETRI PRINCIPALI PER MODELLI DI SIMULAZIONE - Dimensioni della stanza - Altezza totale - Condizioni del cielo soleggiato - Fattore di mantenimento - Trasmissione della luce attraverso il vetro - Riflessione
Sede operativa: Via Ferraiolo SALERNO Codice Fiscale - Partita IVA: Tel Fax
 RELAZIONE TECNICA sulle misure di campo elettromagnetico in banda larga effettuate nella città di SALERNO nel seguente sito: SRB TIM via dei Greci, 96 1 SOMMARIO INTRODUZIONE 3 NORMATIVA VIGENTE 4 MISURE
RELAZIONE TECNICA sulle misure di campo elettromagnetico in banda larga effettuate nella città di SALERNO nel seguente sito: SRB TIM via dei Greci, 96 1 SOMMARIO INTRODUZIONE 3 NORMATIVA VIGENTE 4 MISURE
2.5. Progettazione del modulo
 2.5 Progettazione del modulo Ricerca delle condizioni di applicabilità delle Fonti Energetiche Nuove e Rinnovabili sul territorio. Il modulo urbano sostenibile per piccoli insediamenti I diagrammi solari
2.5 Progettazione del modulo Ricerca delle condizioni di applicabilità delle Fonti Energetiche Nuove e Rinnovabili sul territorio. Il modulo urbano sostenibile per piccoli insediamenti I diagrammi solari
europlus-silentium EFFETTO SULLA TRASMISSIONE DEL RUMORE AL CALPESTIO PROGETTO DI RICERCA ALLESTIMENTO IN LABORATORIO
 EFFETTO SULLA TRASMISSIONE DEL RUMORE AL CALPESTIO Misure di rumore di calpestio su solaio laterocementizio in laboratorio secondo UNI EN ISO 140-6 Nel mese di maggio 2009 è iniziata la sperimentazione
EFFETTO SULLA TRASMISSIONE DEL RUMORE AL CALPESTIO Misure di rumore di calpestio su solaio laterocementizio in laboratorio secondo UNI EN ISO 140-6 Nel mese di maggio 2009 è iniziata la sperimentazione
Corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 e smi
 della Corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 e smi PROGRAMMA, DOCENTI e CALENDARIO Mod. A: Normativa ed introduzione alla certificazione
della Corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 e smi PROGRAMMA, DOCENTI e CALENDARIO Mod. A: Normativa ed introduzione alla certificazione
CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLA GALLERIA DEL VENTO DALLARA. G.V. Iungo, G. Lombardi
 CARATTERIAIONE DEL FLSSO DELLA GALLERIA DEL VENTO DALLARA G.V. Iungo, G. Lombardi DDIA 2008-3 Marzo 2008 Indice Pagina 1 Misure d anemometro a filo caldo e di Pitot statico 2 1.1 Set-up 2 1.2 Analisi dei
CARATTERIAIONE DEL FLSSO DELLA GALLERIA DEL VENTO DALLARA G.V. Iungo, G. Lombardi DDIA 2008-3 Marzo 2008 Indice Pagina 1 Misure d anemometro a filo caldo e di Pitot statico 2 1.1 Set-up 2 1.2 Analisi dei
Qual buon vento? di Carolina Sarpi
 STORIe 1 Qual buon vento? Ventilazione naturale e meccanica degli ambienti industriali sono tecniche normalmente utilizzate in alternativa. Possono invece essere combinate per raggiungere obiettivi difficilmente
STORIe 1 Qual buon vento? Ventilazione naturale e meccanica degli ambienti industriali sono tecniche normalmente utilizzate in alternativa. Possono invece essere combinate per raggiungere obiettivi difficilmente
Solare termico, panoramica delle tecnologie e analisi dei meccanismi di incentivazione vigenti
 Solare termico, panoramica delle tecnologie e analisi dei meccanismi di incentivazione vigenti Marco Calderoni Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano WILO Forum Italy Milano, 4 dicembre, 2013 Il
Solare termico, panoramica delle tecnologie e analisi dei meccanismi di incentivazione vigenti Marco Calderoni Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano WILO Forum Italy Milano, 4 dicembre, 2013 Il
Tetto verde su un edifico della Regione Marche : dati di comportamento energetico in un anno di monitoraggio
 II Convegno Nazionale Il verde pensile nel clima Mediterraneo Genova, 6 Marzo 2009 Salone Energethica Fiera di Genova Tetto verde su un edifico della Regione Marche : dati di comportamento energetico in
II Convegno Nazionale Il verde pensile nel clima Mediterraneo Genova, 6 Marzo 2009 Salone Energethica Fiera di Genova Tetto verde su un edifico della Regione Marche : dati di comportamento energetico in
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto Figura Dislocazione delle stazioni meteorologiche
 Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 1 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 1 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della
IL MICROCLIMA. Il lavoro del consulente a seguito di ispezione e prescrizione in ambiente di lavoro SEVERO CALDO / SEVERO FREDDO
 IL MICROCLIMA Il lavoro del consulente a seguito di ispezione e prescrizione in ambiente di lavoro SEVERO CALDO / SEVERO FREDDO Dott. Massimo ALTAMURA Geom. Marco DE SANTIS IL MICROCLIMA Complesso di parametri
IL MICROCLIMA Il lavoro del consulente a seguito di ispezione e prescrizione in ambiente di lavoro SEVERO CALDO / SEVERO FREDDO Dott. Massimo ALTAMURA Geom. Marco DE SANTIS IL MICROCLIMA Complesso di parametri
Laboratorio di Costruzione dell architettura
 Laboratorio di Costruzione dell architettura Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio sito nel centro storico di Enna. 1. Inquadramento 2. Stato di fatto 1. Analisi climatica 2. Rilievo
Laboratorio di Costruzione dell architettura Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio sito nel centro storico di Enna. 1. Inquadramento 2. Stato di fatto 1. Analisi climatica 2. Rilievo
Prestazioni energetiche di un edificio
 Prestazioni energetiche di un edificio Fabbisogni energetici Determinazione delle prestazioni energetiche Sistema edificio-impianto termico Flussi termici Zona termica e temperatura di progetto I fabbisogni
Prestazioni energetiche di un edificio Fabbisogni energetici Determinazione delle prestazioni energetiche Sistema edificio-impianto termico Flussi termici Zona termica e temperatura di progetto I fabbisogni
