DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO - MECCANISMI DI TRASPORTO -
|
|
|
- Aureliana Morelli
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTÀ DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO - MECCANISMI DI TRASPORTO - Prof. Ing. Luigi Coppola
2 CAUSE DI DISSESTO E DEGRADO DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E PRECOMPRESSO AMBIENTE SISMA ERRORI PROGETTUALI ERRATA SCELTA DEGLI INGREDIENTI DIFETTI DI COSTRUZIONE CAUSE INTERNE
3 TIPI E CAUSE DI DEGRADO DEGRADO ENDOGENO CAUSA SCATENANTE NEL MATERIALE DI CUI È COMPOSTA LA STRUTTURA DEGRADO ESOGENO ALTERAZIONI A SEGUITO DI AGENTI ESTERNI ALLA STRUTTURA
4 CAUSE DI DEGRADO DEL CALCESTRUZZO E DELLE ARMATURE INTERNE ESTERNE (ambientali) SCELTA NON CORRETTA DEGLI INGREDIENTI: Acqua, Aggregati, Additivi e Aggiunte FLUIDI AGGRESSIVI Gli ingredienti del calcestruzzo contengono sostanze indesiderabili cioè incompatibili con le armature o con la stessa matrice cementizia Esplicano la loro azione nei confronti del calcestruzzo e delle armature essendo presenti nell ambiente in cui la struttura è situata.
5 CAUSE Il degrado del calcestruzzo e delle armature può essere ricondotto sostanzialmente a due cause principali: CHIMICHE ED ELETTRO-CHIMICHE che implicano, cioè, reazioni chimiche e processi elettrochimici tra i fluidi aggressivi provenienti dall ambiente esterno e, rispettivamente, gli ingredienti o i prodotti di idratazione del cemento e le barre di armatura; FISICHE, determinate dalle variazioni di temperatura del calcestruzzo e/o dell ambiente esterno, dai gradienti di umidità relativa oppure derivanti dai carichi statici e dinamici agenti sulla struttura, dai carichi impulsivi, da quelli ciclici e dalle azioni abrasive.
6 DEGRADO DEL CALCESTRUZZO E DELLE ARMATURE CAUSE CHIMICHE - ELETTROCHIMICHE CAUSE FISICHE ENDOGENE ESOGENE ENDOGENE ESOGENE SOLFATI CARBONATAZIONE ΔT INTERNE (GETTI MASSIVI) ΔT ESTERNE (GELO - DISGELO) SILICE-ALCALI ACIDO CARBONICO INCENDIO CARBONATO- ALCALI CLORURI RITIRO CLORURI SOLFATI URTI SOLFURI SOSTANZE DI PROVENIENZA INDUSTRIALE SALI DISGELANTI EROSIONE CAVITAZIONE ABRASIONE FATICA
7 AZIONE AGGRESSIVA SUPERFICIALE INTERNA MARGINALE DISTRUTTIVA TRASCURABILE
8 AZIONE AGGRESSIVA / PENETRAZIONE AZIONE AGGRESSIVA FACILITÀ DI PENETRARE E MUOVERSI ALL INTERNO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
9 POROSITÀ E PENETRABILITÀ POROSITÀ TOTALE DEL CLS MECCANISMI DI PENETRAZIONE NEL CLS DISTRIBUZIONE DIMENSIONALE PORI INTERCONNESSIONE TRA I PORI
10 MECCANISMI DI PENETRAZIONE Sono TRE i meccanismi che determinano la penetrazione dei fluidi aggressivi nel calcestruzzo ed ognuno è associato ad una diversa forza motrice : 1. la PERMEAZIONE è il meccanismo per il quale la penetrazione del fluido aggressivo è determinato da un gradiente di pressione; 2. la DIFFUSIONE in cui l ingresso nel mezzo poroso è governato da un gradiente di concentrazione; 3. l ASSORBIMENTO O SUZIONE CAPILLARE generato dalle forze di adesione superficiale per affinità di un liquido, e dell acqua in particolare, con le superfici di un solido (del calcestruzzo per i nostri scopi).
11 PENETRABILITÁ PERMEABILITÁ MOVIMENTO GENERATO DA UN GRADIENTE DI PRESSIONE DIFFUSIONE MOVIMENTO (gas, ione, etc.) GENERATO DA UN GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE ASSORBIMENTO O SUZIONE CAPILLARE GENERATO DA FORZE DI ADESIONE SUPERFICIALE PER AFFINITÀ DI UN LIQUIDO CON LE SUPERFICI DI UN SOLIDO
12 ZONA (1) : il meccanismo di trasporto è legato sia alla pressione esercitata dall acqua che alla presenza di sostanze in forma ionica in essa disciolta: permeazione + diffusione di sostanze in forma ionica ZONA (2) : assorbimento di acqua per suzione capillare e diffusione in forma ionica. ZONA (3) : diffusione dei gas (CO 2, O 2 ) presenti nell atmosfera. N.B. La diffusione dei gas in ZONA(1) è ingegneristicamente non significativa. Allo stesso modo la diffusione non è significativa nelle porzioni di struttura a contatto con il terreno in assenza di acque di falda (ZONA (4)). In presenza di acqua nel terreno i meccanismi di trasporto sono identici a quelli della ZONA (1)
13 PERMEABILITÁ La PERMEAZIONE è il meccanismo di trasporto di un fluido in un mezzo poroso generato da gradienti di pressione. Il movimento all interno della matrice cementizia, alla luce della ridotta dimensione dei pori, avviene con velocità così bassa da poterlo ritenere laminare.
14 LEGGE DI DARCY dq dt 1 A = K dh l dq/dt = flusso di acqua [m 3 /s]; A = area della sezione del provino di calcestruzzo perpendicolare al flusso di acqua [m 2 ]; l = lunghezza del provino di calcestruzzo DISTANZA TRA LE DUE FACCE A DIFFERENZA DI PRESSIONE dh [m]; dh = gradiente di pressione in metri di colonna d acqua [m]; K = permeabilità all acqua del materiale [m /s ].
15 ACQUA IN PRESSIONE PERMEABILITÁ A: AREA SEZIONE PERPENDICOLARE AL FLUSSO DI ACQUA SEZ A - A dq dt 1 A = K dh l K = permeabilità dq/dt = flusso di acqua in m 3 /s A = area sezione in m 2 l = lunghezza del provino in m dh = differenza di pressione in metri di colonna d acqua tra le due facce a distanza l
16 STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA STRUTTURE INTERRATE (MURI VERTICALI E PLATEE DI FONDAZIONE); PISCINE NATATORIE; VASCHE PER ACQUA POTABILE; CANALI DI IRRIGAZIONE; K < m/s p H2O < 20 mm a /c < 0.55 VASCHE DI SEDIMENTAZIONE IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE; VASCHE CONTENENTI LIQUIDI E SOSTANZE INQUINANTI; MURI PERIMETRALI DI BACINI DI CARENAGGIO; VASCHE DI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO TIPO SPIG; K < m/s p H2O < 10 mm a /c < 0.50
17 COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ Il coefficiente di permeabilità rappresenta la velocità con cui l acqua può muoversi in un calcestruzzo poroso allorquando, superata la fase transitoria, il materiale, a regime, si presenta con le porosità capillari completamente sature di acqua.
18 PERMEABILITÁ E POROSITÁ CAPILLARE La permeabilità della pasta di cemento, in particolare, è influenzata sia dal volume di pori che dalla loro dimensione. Relativamente a questo aspetto le porosità rappresentate dagli spazi interstratici tra i prodotti di idratazione, per la ridotta dimensione (diametro medio pari a 40 nm), sono caratterizzate da un coefficiente di permeabilità di circa m/s. Per contro, nei pori capillari, per la maggiore dimensione che li contraddistingue, la velocità con cui l acqua può muoversi è circa 3-6 ordini di grandezza più elevata. Ne consegue che la permeabilità di una pasta di cemento è sostanzialmente governata dalla porosità capillare e, quindi, dipende dagli stessi parametri che influenzano sia il volume totale dei pori capillari che la loro distribuzione dimensionale.
19 VOLUME PORI TOTALE Ad un AUMENTO DEL VOLUME TOTALE DEI PORI CAPILLARI corrisponde: un incremento della probabilità che i pori siano connessi reciprocamente contribuendo in maniera determinante al flusso di acqua attraverso la matrice cementizia; un aumento del diametro dei pori più abbondanti (ad esempio, passando da un rapporto a/c di 0.40 ad uno di 0.65 il volume dei pori di diametro maggiore di 0.2 micrometri aumenta da 5 a 35 litri) maggiore coefficiente di permeabilità della pasta di cemento.
20 Variazione della distribuzione dimensionale dei pori in funzione della durata della stagionatura umida alla temperatura di 21 C. 50 STAGIONATURA: 1g Volume dei pori (%) gg 28g 6 mesi 1 anno ,1 0,01 0,001 Diametro dei pori (mm)
21 Coefficiente di permeabilità di una pasta di cemento con rapporto a/c = 0.65 in funzione della durata della maturazione umida. Età Coefficiente di permeabilità, K (m/s) 6 ore giorni giorni giorni giorni giorni
22 IMPORTANTE PERMEABILITÁ FISSATO a/c PASTA DI CEMENTO CALCESTRUZZO per la presenza di difetti e di microfessurazioni all interfaccia pasta-aggregato.
23
24 Distribuzione dimensionale dei pori di paste di cemento Portland e di paste confezionate con cenere volante e/o fumo di silice maturate per 28 giorni. 100 Volume dei pori (cm 3 /g) 10 1 CLS (D max =32 mm) CLS (D max =25 mm) BETONCINO (D max =12.7 mm) MALTA (D max =4 mm) PASTA DI CEMENTO 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Diametro dei pori (mm)
25 STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA STRUTTURE INTERRATE (MURI VERTICALI E PLATEE DI FONDAZIONE); PISCINE NATATORIE; VASCHE PER ACQUA POTABILE; CANALI DI IRRIGAZIONE; K < m/s p H2O < 20 mm a /c < 0.55 VASCHE DI SEDIMENTAZIONE IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE; VASCHE CONTENENTI LIQUIDI E SOSTANZE INQUINANTI; MURI PERIMETRALI DI BACINI DI CARENAGGIO; VASCHE DI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO TIPO SPIG; K < m/s p H2O < 10 mm a /c < 0.50
26 IMPOSSIBILITÁ La prova di permeabilità per la determinazione del coefficiente K non è sempre conducibile. Infatti, nei calcestruzzi di bassa porosità, con rapporto inferiore a 0.50, pur instaurando tra le facce del provino delle differenze di pressione (ΔH) molto alte (ad esempio, 20 atm pari a 20 m di colonna d acqua), non si riesce a permeare l intera lunghezza del provino e, quindi, non essendo possibile misurare il flusso di acqua sulla faccia opposta a quella dove l acqua è in pressione non si può determinare K.
27 ACQUA IN PRESSIONE PERMEABILITÁ A: AREA SEZIONE PERPENDICOLARE AL FLUSSO DI ACQUA SEZ A - A dq dt 1 A = K dh l K = permeabilità dq/dt = flusso di acqua in m 3 /s A = area sezione in m 2 l = lunghezza del provino in m dh = differenza di pressione in metri di colonna d acqua tra le due facce a distanza l
28 NORMA EN La norma EN , suggeriscono di valutare l impermeabilità del calcestruzzo assoggettando una faccia di un provino ad un flusso di acqua in pressione (500 kpa) per 72 ore, al termine delle quali misurare lo spessore di calcestruzzo penetrato dall acqua sulle facce ottenute per rottura del provino parallelamente al flusso di acqua.
29 STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA STRUTTURE INTERRATE (MURI VERTICALI E PLATEE DI FONDAZIONE); PISCINE NATATORIE; VASCHE PER ACQUA POTABILE; CANALI DI IRRIGAZIONE; K < m/s p H2O < 20 mm a /c < 0.55 VASCHE DI SEDIMENTAZIONE IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE; VASCHE CONTENENTI LIQUIDI E SOSTANZE INQUINANTI; MURI PERIMETRALI DI BACINI DI CARENAGGIO; VASCHE DI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO TIPO SPIG; K < m/s p H2O < 10 mm a /c < 0.50
30 IMPERMEABILITÀ Requisito di impermeabilità STRUTTURE CHE DEBBONO GARANTIRE UNA TENUTA IDRAULICA, DOVE UNA PERDITA DI ACQUA DETERMINA SERI INCONVENIENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA STESSA O DEGLI AMBIENTI AD ESSA ADIACENTI. FONDAZIONI E DEI MURI PERIMETRALI IN UNA STRUTTURA INTERRATA (vani cantinati, parcheggi interrati, etc.) dove una eccessiva permeabilità del calcestruzzo potrebbe favorire l ingresso dell acqua presente nel terreno (difetti nelle opere di raccolta e istradamento dell acqua piovana oppure presenza di falde sotterranee) nei vani cantinati con grave pregiudizio per l utilizzo degli ambienti interni.
31 PISCINE - ACQUEDOTTI Il problema riguarda anche: 1. le piscine natatorie; 2. le vasche che contengono acqua potabile (acquedotti) o acque reflue (come accade nelle torri di raffreddamento tipo Spig o nelle vasche di sedimentazione degli impianti di depurazione); 3. bacini di carenaggio per la costruzione e la manutenzione delle navi laddove la permeazione dell acqua attraverso le murature perimetrali può causare seri inconvenienti nei locali macchine posti a tergo di queste strutture.
32 PRESCRIZIONI Per queste tipologie di opere si può conseguire il requisito di impermeabilità senza necessariamente dover ricorrere all impiego di rivestimenti protettivi impermeabili a base di membrane bituminose o di malte cementizie modificate con lattici purché si osservino le seguenti PRESCRIZIONI: impiego di calcestruzzi con rapporto a/c inferiori, a seconda del tipo di struttura, a 0.55 o 0.50 che evidenzino una penetrazione di acqua determinata con la procedura stabilita dalla norma EN non superiore rispettivamente a 20 mm e 10 mm
33 Valori massimi della penetrazione d acqua (UNI EN ) da inserire nella prescrizione di capitolato in base al rapporto (a/c) DEF. (a/c) DEF p H2O [mm] (UNI EN )
34 POSA IN OPERA Posa in opera del conglomerato e compattazione dei getti eseguita con perfetta cura per evitare che si manifestino fenomeni di segregazione esterna (con formazione di vespai e nidi di ghiaia) e che rimangano percentuali eccessive di aria intrappolata nell impasto. Relativamente a questo aspetto si fa notare come la presenza dei nidi di ghiaia rappresenti un fenomeno deleterio per la permeabilità di calcestruzzo che in queste zone, per la carenza di pasta di cemento e l eccesso di aggregato grosso, assume valori di permeabilità tipici delle terre non coesive (K = 10-3 m/s) che possono risultare fino a 6-10 ordini di grandezza maggiori di quelle di un calcestruzzo ben compattato
35 MATURAZIONE UMIDA Maturazione umida dei getti per almeno 7 giorni. Questa prescrizione equivale a mantenere le strutture casserate o a proteggerle subito dopo la rimozione dei casseri con teli di iuta bagnati giornalmente;
36 WATER-STOP Accurata esecuzione delle riprese di getto in corrispondenza dell attacco fondazione/muri perimetrali. In questi punti singolari, infatti, è elevato il rischio che si formi una soluzione di continuità ( giunto freddo ) che costituisce una via preferenziale di fuga per l acqua. Nella pratica il problema si risolve fissando, mediante chiodi, viti oppure con un adesivo, sull estradosso della superficie della fondazione, un profilo di materiale espansivo(in forma di nastri di dimensioni all incirca di mm x mm x alcuni metri) predisposto a seguire lo sviluppo della muratura perimetrale e in modo che risulti equidistante dalle facce esterne del manufatto. Il profilo (individuato anche con il termine commerciale waterstop ) ha capacità di espandere in presenza di acqua di circa il %.
37 WATER-STOP PIANTA Disposizione del profilo espansivo A Ripresa di getto (giunto "freddo"): possibile infiltrazione o perdita di acqua SEZIONE A-A Fondazione A Muro Fondazione DETTAGLIO COSTRUTTIVO Profilo Espansivo Armature Fondazione Ripresa di getto
38 A. B. C. PROTEZIONE IN GOMMA. Durante l'iniezione della resina organica si solleva permettendo la fuoriuscita del sistema impermeabilizzante MICROFORI SCHELETRO RIGIDO
39 DIFFUSIONE Il trasporto delle sostanze aggressive nel calcestruzzo può essere determinato da una DIFFERENZA DI CONCENTRAZIONE DEL FLUIDO DIFFONDENTE esistente tra due facce opposte di una determinata struttura. In questo caso, il meccanismo di trasporto prende il nome di processo di diffusione ed è governato dalla PRIMA LEGGE DI DIFFUSIONE DI FICK: dm = D A c 2 c 1 dt x dm = incremento di massa della sostanza diffondente (in Kg); A = area della sezione ortogonale al flusso della sostanza diffondente (in m 2 ); c 1 = concentrazione della sostanza diffondente sulla superficie esterna della struttura in calcestruzzo (in Kg/m 3 ); c 2 = concentrazione della sostanza diffondente nel calcestruzzo (in Kg/m 3 ) ad una distanza x (in m) dall esterno che rappresenta il fronte di avanzamento della sostanza stessa; dt = intervallo di tempo (in s) in cui si è registrato l incremento di massa dm; D = coefficiente di diffusione della sostanza diffondente (in m 2 /s).
40 COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE dm dt 1 dc = D A x D = kg m 2 s = D kg m 4 = m2 s
41 DIFFUSIONE E CONCENTRAZIONE dc (supposto che inizialmente nel calcestruzzo ad una distanza x dalla superficie la concentrazione della sostanza diffondente sia nulla, dc rappresenta la concentrazione della sostanza diffondente nell ambiente a contatto con la superficie della struttura) dm/dt
42 DIFFUSIONE D - coefficiente di diffusione dm/dt
43 Il valore di D è influenzato da: FATTORI POROSITÀ DELLA MATRICE CEMENTIZIA qualità della ZONA DI TRANSIZIONE NATURA DELLA SPECIE DIFFONDENTE prodotti di idratazione del cemento (e, quindi, dipende dal TIPO DI CEMENTO utilizzato) in quanto capaci di legare alcune delle sostanze diffondenti TEMPERATURA a cui avviene il processo; GRADO DI SATURAZIONE DEI PORI CAPILLARI della matrice cementizia
44 GAS Diffusione in acqua è circa 4 ordini di grandezza inferiore a quella che avviene in aria. DIFFUSIONE ACQUA DIFFUSIONE ARIA IONI La diffusione può avvenire solo in acqua e, pertanto, essa risulta più efficace all aumentare del grado di saturazione dei pori capillari del cls
45 DIFFUSIONE DEI GAS NELLE STRUTTURE IDRAULICHE I processi di diffusione dell anidride carbonica gassosa e dell ossigeno in: 1. strutture idrauliche o marine permanentemente immerse; 2. strutture interrate caratterizzate da un grado elevato di saturazione non sono significativi da un punto di vista ingegneristico
46 DIFFUSIONE IN FORMA IONICA La DIFFUSIONE DI SOSTANZE IN FORMA IONICA sebbene avvenga anche in calcestruzzi con un basso grado di saturazione, procede con MAGGIORE VELOCITÀ IN CALCESTRUZZI SATURI DI ACQUA e, quindi, risulta particolarmente significativa in strutture idrauliche, in quelle marine permanentemente immerse, in quelle orizzontali sottoposte al trattamento con sali disgelanti, nelle strutture interrate (sia completamente come avviene, ad esempio, per un palo di fondazione, che parzialmente, come nel caso dei rivestimenti in calcestruzzo di gallerie) a contatto con falde acquifere.
47 STRUTTURE AEREE PROCESSI DI DIFFUSIONE OSSIGENO ANIDRIDE CARBONICA IN FORMA GASSOSA CORROSIONE DELLE BARRE DI ARMATURA
48 STRUTTURE IDRAULICHE PROCESSI DI DIFFUSIONE ACIDO CARBONICO DISCIOLTO IN ACQUA /SOLFATI CLORURO strutture marine e in quelle sottoposte al trattamento con sali disgelanti (strade, piste aeroportuali, piazzali, etc.) CORROSIONE DELLE BARRE DI ARMATURA DEGRADO DEL CALCESTRUZZO
49 STRUTTURE INTERRATE PROCESSI DI DIFFUSIONE SOLFATI PRESENTI IN TERRENI E/O NELLE ACQUE DI FALDA DEGRADO DEL CALCESTRUZZO
50 TIPOLOGIA DI STRUTTURA STRUTTURE AEREE IN CLIMI TEMPERATI STRUTTURE AEREE IN CLIMI CONTINENTALI RIGIDI STRUTTURE INTERRATE STRUTTURE PARZIALMENTE INTERRATE ESEMPI Edifici, ponti e viadotti Edifici, ponti e viadotti Fondazioni Gallerie, muri di sostegno, vasche, muri perimetrali scantinati FLUIDI AGGRESSIVI E DEGRADO DEI MATERIALI CO 2, O 2, H 2 O Corrosione armature CO 2, O 2, H 2 O Corrosione armature Degrado del cls per DELTA T H 2 O, SO 4 = Degrado cls per SO 4 = CO 2, O 2, H 2 O, SO 4 = Corrosione (CO 2 ) Degrado cls per SO 4 = STRUTTURE SOTTOPOSTE AL TRAFFICO VEICOLARE IN CLIMI CONTINENTALI RIGIDI STRUTTURE IN ZONE MARINE STRUTTURE IDRAULICHE Piazzali esterni, strade in cls, ponti e viadotti, piste aereoportuali Banchine, moli, edifici residenziali e infrastrutture Canali, briglie, vasche, acquedotti CO 2, O 2, H 2 O, Cl - Corrosione (CO 2 + Cl - ) Degrado cls per sali Degrado cls per DT CO 2, O 2, H 2 O, Cl -, SO 4 = Corrosione (CO 2 + Cl - ) Degrado cls per SO 4 = H 2 CO 3-, H 2 O Degrado cls per H 2 CO - 3
51 ASSORBIMENTO Una struttura in calcestruzzo asciutta o parzialmente satura è in grado di assorbire di acqua. Il volume di acqua assorbito è funzione del volume di pori capillari non occupato dall acqua. Pertanto, l assorbimento è funzione de: 1.la qualità del calcestruzzo; 2.Il grado di saturazione dei pori capillari. Ad esempio, un calcestruzzo con rapporto a/c di 0.70 e con grado di saturazione prossimo ad 1 evidenzierebbe un assorbimento d acqua inferiore ad un calcestruzzo con rapporto a/c di 0.40 (con un volume di pori capillari molto più basso) che presentasse un grado di saturazione prossimo a 0 (asciutto)
DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO MECCANISMI DI TRASPORTO
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO MECCANISMI DI TRASPORTO Prof. Ing. Luigi Coppola CAUSE DI DISSESTO E DEGRADO DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO MECCANISMI DI TRASPORTO Prof. Ing. Luigi Coppola CAUSE DI DISSESTO E DEGRADO DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA
 4 STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA Questa sezione è dedicata alle opere per le quali si richiedono requisiti di tenuta idraulica e, pertanto, essa riguarda le prescrizioni di capitolato per le strutture interrate
4 STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA Questa sezione è dedicata alle opere per le quali si richiedono requisiti di tenuta idraulica e, pertanto, essa riguarda le prescrizioni di capitolato per le strutture interrate
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA. Esempi di domande a risposta multipla. Prof. Ing. Luigi Coppola
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola La calce, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola La calce, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
ESEMPI DI PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO. gennaio
 ESEMPI DI PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO gennaio 2015 1 EDIFICI ABITATIVI (UNI 11104) gennaio 2015 2 COSTRUZIONI INDUSTRIALI (UNI 11104) gennaio 2015 3 OPERE INGEGNERISTICHE (UNI 11104) gennaio 2015
ESEMPI DI PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO gennaio 2015 1 EDIFICI ABITATIVI (UNI 11104) gennaio 2015 2 COSTRUZIONI INDUSTRIALI (UNI 11104) gennaio 2015 3 OPERE INGEGNERISTICHE (UNI 11104) gennaio 2015
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA. Esempi di domande a risposta multipla. Prof. Ing. Luigi Coppola
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola Il gesso, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola Il gesso, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO INTRODUZIONE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO INTRODUZIONE Prof. Ing. Luigi Coppola L. Coppola Concretum Introduzione alla durabilità D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO INTRODUZIONE Prof. Ing. Luigi Coppola L. Coppola Concretum Introduzione alla durabilità D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE
Durabilità e classe di esposizione del calcestruzzo
 Durabilità e classe di esposizione del Durabilità Per garantire la durabilità delle strutture in armato ordinario o precompresso, esposte all azione dell ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti
Durabilità e classe di esposizione del Durabilità Per garantire la durabilità delle strutture in armato ordinario o precompresso, esposte all azione dell ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti
STRUTTURE IN AMBIENTE MARINO
 5 STRUTTURE IN AMBIENTE MARINO Questa sezione è dedicata alle opere situate in ambiente marino e riguarda sia quelle tipologie di strutture direttamente in contatto con l acqua di mare quali i moli, i
5 STRUTTURE IN AMBIENTE MARINO Questa sezione è dedicata alle opere situate in ambiente marino e riguarda sia quelle tipologie di strutture direttamente in contatto con l acqua di mare quali i moli, i
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica. Docente: Dr. Giorgio Pia
 Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia L Idratazione 2C 3 S + 6H = C 3 S 2 H 3 + 3Ca(OH) 2 2C 2 S + 4H = C 3 S 2 H 3 + Ca(OH) 2 L Idratazione 2C 3 S + 6H = C
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia L Idratazione 2C 3 S + 6H = C 3 S 2 H 3 + 3Ca(OH) 2 2C 2 S + 4H = C 3 S 2 H 3 + Ca(OH) 2 L Idratazione 2C 3 S + 6H = C
CEMENTO PORTLAND AL CALCARE UNI EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R
 CEMENTO PORTLAND AL CALCARE UNI EN 97- CEM II/A-LL 42,5 R stagionatura Questo cemento contiene dal 80% al 94% di clinker e dal 6% al 20% di calcare. Da questi valori sono esclusi, secondo la UNI EN 97-,
CEMENTO PORTLAND AL CALCARE UNI EN 97- CEM II/A-LL 42,5 R stagionatura Questo cemento contiene dal 80% al 94% di clinker e dal 6% al 20% di calcare. Da questi valori sono esclusi, secondo la UNI EN 97-,
Cause del degrado. Degrado del calcestruzzo armato e Durabilità. Corrosione. Passivazione dell armatura. Carbonatazione.
 Cause del degrado Degrado del calcestruzzo armato e Durabilità 1 - Corrosione delle armature promossa da: - carbonatazione; - dal cloruro. - Attacco solfatico della matrice cementizia i -esterno; - interno.
Cause del degrado Degrado del calcestruzzo armato e Durabilità 1 - Corrosione delle armature promossa da: - carbonatazione; - dal cloruro. - Attacco solfatico della matrice cementizia i -esterno; - interno.
POROSITA DELLA MATRICE CEMENTIZIA E RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA POROSITA DELLA MATRICE CEMENTIZIA E RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola RESISTENZA A COMPRESSIONE paste
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA POROSITA DELLA MATRICE CEMENTIZIA E RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola RESISTENZA A COMPRESSIONE paste
Settore Ricerca & Sviluppo
 La Cismondi S.r.l. è stata iscritta nell albo dei laboratori altamente qualificati dal Ministero dell Università e della Ricerca scientifica con Decreto n. 2326. Settore Ricerca & Sviluppo DATI del COMMITTENTE
La Cismondi S.r.l. è stata iscritta nell albo dei laboratori altamente qualificati dal Ministero dell Università e della Ricerca scientifica con Decreto n. 2326. Settore Ricerca & Sviluppo DATI del COMMITTENTE
Prescrizione, Durabilità, Controlli di accettazione
 Prescrizione, Durabilità, Controlli di accettazione PRESCRIZIONE DURABILITA classi di esposizione CONTROLLI DI ACCETTAZIONE page 71 Prescrizione APPROFONDIMENTI PRESTAZIONE GARANTITA Classe di resistenza
Prescrizione, Durabilità, Controlli di accettazione PRESCRIZIONE DURABILITA classi di esposizione CONTROLLI DI ACCETTAZIONE page 71 Prescrizione APPROFONDIMENTI PRESTAZIONE GARANTITA Classe di resistenza
PROVA DI ESAME SCRITTO DI MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA Prof. Luigi Coppola
 PROVA DI ESAME SCRITTO DI MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA Prof. Luigi Coppola Appello del 4 Settembre 2006 ESERCIZIO Lungo la nuova tratta autostradale di collegamento tra Belluno e Cortina d Ampezzo
PROVA DI ESAME SCRITTO DI MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA Prof. Luigi Coppola Appello del 4 Settembre 2006 ESERCIZIO Lungo la nuova tratta autostradale di collegamento tra Belluno e Cortina d Ampezzo
I CEMENTI COMUNI E LA NORMA EN 197-1
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I CEMENTI COMUNI E LA NORMA EN 197-1 Prof. Ing. Luigi Coppola NORMATIVA NORMA EUROPEA EN 197-1 regola la produzione dei cementi: requisiti composizionali,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I CEMENTI COMUNI E LA NORMA EN 197-1 Prof. Ing. Luigi Coppola NORMATIVA NORMA EUROPEA EN 197-1 regola la produzione dei cementi: requisiti composizionali,
I LEGANTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: LEGANTI AEREI ED IDRAULICI
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I LEGANTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: LEGANTI AEREI ED IDRAULICI Prof. Ing. Luigi Coppola CLASSIFICAZIONE LEGANTI CONDIZIONI IN CUI AVVIENE L
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I LEGANTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: LEGANTI AEREI ED IDRAULICI Prof. Ing. Luigi Coppola CLASSIFICAZIONE LEGANTI CONDIZIONI IN CUI AVVIENE L
DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO LA CARBONATAZIONE E LA CORROSIONE DEI FERRI DI ARMATURA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO LA CARBONATAZIONE E LA CORROSIONE DEI FERRI DI ARMATURA Prof. Ing. Luigi Coppola CLASSI D ESPOSIZIONE AMBIENTALE classe
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO LA CARBONATAZIONE E LA CORROSIONE DEI FERRI DI ARMATURA Prof. Ing. Luigi Coppola CLASSI D ESPOSIZIONE AMBIENTALE classe
PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DELLE PARTI IN C.A. (TRAVI, PARETI, SETTI, SOLETTE ECC.)
 PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DELLE PARTI IN C.A. (TRAVI, PARETI, SETTI, SOLETTE ECC.) Il calcestruzzo dovrà possedere i seguenti requisiti: - CLASSE DI RESISTENZA:
PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DELLE PARTI IN C.A. (TRAVI, PARETI, SETTI, SOLETTE ECC.) Il calcestruzzo dovrà possedere i seguenti requisiti: - CLASSE DI RESISTENZA:
RELAZIONE SUI MATERIALI
 RELAZIONE SUI MATERIALI 1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO DM 2008 Norme tecniche per le costruzioni UNI EN 1992-1-1 Progettazione delle strutture in c.a. UNI EN 206-1 Calcestruzzo, specificazione, prestazione,
RELAZIONE SUI MATERIALI 1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO DM 2008 Norme tecniche per le costruzioni UNI EN 1992-1-1 Progettazione delle strutture in c.a. UNI EN 206-1 Calcestruzzo, specificazione, prestazione,
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE STRADALI
 6. STRUTTURE E INFRASTRUTTURE STRADALI Questa sezione è dedicata al calcestruzzo destinato alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture stradali e riguarda pertanto, i ponti, i viadotti, i tombini
6. STRUTTURE E INFRASTRUTTURE STRADALI Questa sezione è dedicata al calcestruzzo destinato alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture stradali e riguarda pertanto, i ponti, i viadotti, i tombini
LE FUNZIONI BASE. Prof. Ing. Luigi Coppola UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA LE FUNZIONI BASE Prof. Ing. Luigi Coppola EQ. di POWERS e FUNZIONI BASE La funzione base per la resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA LE FUNZIONI BASE Prof. Ing. Luigi Coppola EQ. di POWERS e FUNZIONI BASE La funzione base per la resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo
RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI PS_ST.R4
 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA PROVINCIA DI VITERBO RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI PS_ST.R4 OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA PROVINCIA DI VITERBO RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI PS_ST.R4 OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Prof. Ing. Luigi Coppola. L. Coppola Cum Solidare Introduzione al restauro delle strutture in calcestruzzo
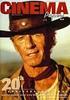 INTRODUZIONE AL RESTAURO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola SISTEMI E PRODOTTI PER L ANCORAGGIO Per ancorare le armature al calcestruzzo Per sigillare o riempire cavità al fine di
INTRODUZIONE AL RESTAURO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola SISTEMI E PRODOTTI PER L ANCORAGGIO Per ancorare le armature al calcestruzzo Per sigillare o riempire cavità al fine di
Cause di degrado e prescrizioni minime del calcestruzzo
 Cause di degrado e prescrizioni minime del calcestruzzo Bologna, 20 Giugno 2007 Roberto Marino 1 Quadro legislativo Legge n 1086 del 5/11/ 71 D.M.del 9/1/96 Circolare Ministero LL.PP. (15 ottobre 1996)
Cause di degrado e prescrizioni minime del calcestruzzo Bologna, 20 Giugno 2007 Roberto Marino 1 Quadro legislativo Legge n 1086 del 5/11/ 71 D.M.del 9/1/96 Circolare Ministero LL.PP. (15 ottobre 1996)
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica. Docente: Dr. Giorgio Pia
 Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia Proprietà allo stato fresco Proprietà allo stato fresco Il Calcestruzzo fresco deve poter essere Questo è possibile se
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia Proprietà allo stato fresco Proprietà allo stato fresco Il Calcestruzzo fresco deve poter essere Questo è possibile se
Concreto CEM II/A-LL 42,5 R
 Concreto CEM II/A-LL 42,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Concreto è un prodotto che viene utilizzato per la confezione di calcestruzzi con resistenza caratteristica
Concreto CEM II/A-LL 42,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Concreto è un prodotto che viene utilizzato per la confezione di calcestruzzi con resistenza caratteristica
I LEGANTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: INTRODUZIONE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I LEGANTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: INTRODUZIONE Prof. Ing. Luigi Coppola LEGANTI I leganti impiegati nel settore delle costruzioni (gesso,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I LEGANTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: INTRODUZIONE Prof. Ing. Luigi Coppola LEGANTI I leganti impiegati nel settore delle costruzioni (gesso,
Impiego del nitrato di calcio come additivo accelerante dei cementi di miscela
 Impiego del nitrato di calcio come additivo accelerante dei cementi di miscela Silvia Collepardi 1, Mario Collepardi 1, Roberto Troli 1 e Wolfram Franke 2 1 ENCO, Ponzano Veneto, Italia 2 YARA, Porsgrunn,
Impiego del nitrato di calcio come additivo accelerante dei cementi di miscela Silvia Collepardi 1, Mario Collepardi 1, Roberto Troli 1 e Wolfram Franke 2 1 ENCO, Ponzano Veneto, Italia 2 YARA, Porsgrunn,
VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DEL PENETRON STANDARD IN CALCESTRUZZI POROSI O FESSURATI
 Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 52655 del 24/11/2004) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 52655 del 24/11/2004) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
Corso di Laurea in Ingegneria Edile
 Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
Corso di Laurea in Ingegneria Edile
 Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
Performo CEM I 52,5 R
 Performo CEM I 52,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Performo è un prodotto che viene utilizzato quasi esclusivamente per la confezione di calcestruzzi per i quali
Performo CEM I 52,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Performo è un prodotto che viene utilizzato quasi esclusivamente per la confezione di calcestruzzi per i quali
Bergamo, 14 maggio 2015 Bellezza: il cemento innovativo di Italcementi per Palazzo Italia a Expo Roberta Alfani - Italcementi
 Bergamo, 14 maggio 2015 Bellezza: il cemento innovativo di Italcementi per Palazzo Italia a Expo 2015 Roberta Alfani - Italcementi Che cos è i.active BIODYNAMIC i.active BIODYNAMIC è una malta ad elevata
Bergamo, 14 maggio 2015 Bellezza: il cemento innovativo di Italcementi per Palazzo Italia a Expo 2015 Roberta Alfani - Italcementi Che cos è i.active BIODYNAMIC i.active BIODYNAMIC è una malta ad elevata
COS È LA SCIENZA DEI MATERIALI? È la scienza che studia le relazioni esistenti tra la struttura dei materiali e le loro proprietà
 COS È LA SCIENZA DEI MATERIALI? È la scienza che studia le relazioni esistenti tra la struttura dei materiali e le loro proprietà COS È L INGEGNERIA DEI MATERIALI? È la progettazione della struttura di
COS È LA SCIENZA DEI MATERIALI? È la scienza che studia le relazioni esistenti tra la struttura dei materiali e le loro proprietà COS È L INGEGNERIA DEI MATERIALI? È la progettazione della struttura di
Progetto esecutivo. Calcoli strutturali 3.1 Relazione sui materiali c.a. e acciaio
 Lavori di protezione del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza del 1 e 2 lotto della strada di collegamento tra la S.S. Melfi-Potenza e l'abitato di Venosa - Lavori di completamento
Lavori di protezione del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza del 1 e 2 lotto della strada di collegamento tra la S.S. Melfi-Potenza e l'abitato di Venosa - Lavori di completamento
Calcestruzzo indurito
 Calcestruzzo indurito Proprietà principali durabilità proprietà meccaniche scorrimento viscoso (creep) proprietà termiche (a) proprietà meccaniche la elevata resistenza meccanica del calcestruzzo deriva
Calcestruzzo indurito Proprietà principali durabilità proprietà meccaniche scorrimento viscoso (creep) proprietà termiche (a) proprietà meccaniche la elevata resistenza meccanica del calcestruzzo deriva
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI IL CALCESTRUZZO
 TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI IL CALCESTRUZZO Firenze, lunedì 8 gennaio 2007 miscelazione di uno o più leganti con acqua, inerti fini (sabbia), inerti grossi ed eventuali additivi
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI IL CALCESTRUZZO Firenze, lunedì 8 gennaio 2007 miscelazione di uno o più leganti con acqua, inerti fini (sabbia), inerti grossi ed eventuali additivi
GEOMETRIA DEI PROVINI E RESISTENZA A COMPRESSIONE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA GEOMETRIA DEI PROVINI E RESISTENZA A COMPRESSIONE Prof. Ing. Luigi Coppola DIMENSIONI DEI PROVINI determinazione della RESISTENZA A COMPRESSIONE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA GEOMETRIA DEI PROVINI E RESISTENZA A COMPRESSIONE Prof. Ing. Luigi Coppola DIMENSIONI DEI PROVINI determinazione della RESISTENZA A COMPRESSIONE
1. Premesse, Normative di riferimento criteri di qualificazione e accettazione
 1. Premesse, Normative di riferimento criteri di qualificazione e accettazione La presente relazione illustra i materiali il cui uso è prescritto per la realizzazione delle opere previste in progetto e
1. Premesse, Normative di riferimento criteri di qualificazione e accettazione La presente relazione illustra i materiali il cui uso è prescritto per la realizzazione delle opere previste in progetto e
Impermeabilizzazione Cristallina
 Impermeabilizzazione Cristallina per for concrete strutture di structures calcestruzzo 156 BENFER Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001/2008 Brochure Impermeabilizzazione cristallina...impermeabilizza
Impermeabilizzazione Cristallina per for concrete strutture di structures calcestruzzo 156 BENFER Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001/2008 Brochure Impermeabilizzazione cristallina...impermeabilizza
page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008
 page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008 Riferimenti sulle caratteristiche del calcestruzzo nelle NTC 2008 CAPITOLO
page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008 Riferimenti sulle caratteristiche del calcestruzzo nelle NTC 2008 CAPITOLO
PROGETTARE LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN CA E CAP
 Giornata di Aggiornamento su Degrado e Consolidamento delle Strutture in Cemento Armato Firenze, 30 novembre 2007. PROGETTARE LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN CA E CAP prof. ing. Sergio Tattoni Università
Giornata di Aggiornamento su Degrado e Consolidamento delle Strutture in Cemento Armato Firenze, 30 novembre 2007. PROGETTARE LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN CA E CAP prof. ing. Sergio Tattoni Università
CORROSIONE DELL ACCIAIO NEGLI AMBIENTI NATURALI
 CORROSIONE DELL ACCIAIO NEGLI AMBIENTI NATURALI Negli ambienti naturali, cui sono esposte la maggior parte delle infrastrutture e costruzioni civili le reazioni di corrosione seguono un meccanismo elettrochimico.
CORROSIONE DELL ACCIAIO NEGLI AMBIENTI NATURALI Negli ambienti naturali, cui sono esposte la maggior parte delle infrastrutture e costruzioni civili le reazioni di corrosione seguono un meccanismo elettrochimico.
GESTIONE delle RISORSE IDRICHE
 Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
Planitop Rasa & Ripara
 Planitop Rasa & Ripara MALTA CEMENTIZIA DI CLASSE R2 A PRESA RAPIDA PER LA RIPARAZIONE E LA RASATURA DEL CALCESTRUZZO C.P. MK690910 (I) 10/14 solo prodotto per rasare e ripristinare le superfi ci in 1calcestruzzo
Planitop Rasa & Ripara MALTA CEMENTIZIA DI CLASSE R2 A PRESA RAPIDA PER LA RIPARAZIONE E LA RASATURA DEL CALCESTRUZZO C.P. MK690910 (I) 10/14 solo prodotto per rasare e ripristinare le superfi ci in 1calcestruzzo
Capitolo 12 Le acque sotterranee
 Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
Quello previsto dal progettista? Quello progettato dal produttore? o Quello che, alla fine, ci si ritrova in opera?
 Università degli Studi di Padova Dipartimento di Costruzioni e Trasporti CORSO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI anno accademico 2009-10 Docente: Ing. Roberto Scotta LA DURABILITA DEL CALCESTRUZZO Padova 15/12/09
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Costruzioni e Trasporti CORSO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI anno accademico 2009-10 Docente: Ing. Roberto Scotta LA DURABILITA DEL CALCESTRUZZO Padova 15/12/09
Unical. S e c o n d o l a n o r m a t i v a i t a l i a n a e d e u r o p e a
 Unical Schema semplificato per la prescrizione della durabilità delle strutture in c.a. S e c o n d o l a n o r m a t i v a i t a l i a n a e d e u r o p e a ( e s t r a t t o d a l l a G u i d a a l l
Unical Schema semplificato per la prescrizione della durabilità delle strutture in c.a. S e c o n d o l a n o r m a t i v a i t a l i a n a e d e u r o p e a ( e s t r a t t o d a l l a G u i d a a l l
BBC Betonrossi Basic Concrete a cura di Luigi Coppola e del Servizio Tecnologico di Betonrossi S.p.A.
 8 I CEMENTI COMUNI E LA NORMA UNIEN 1971 I cementi disponibili in commercio sono principalmente costituiti da miscele di cemento Portland con materiali pozzolanici, materiali pozzolanici a comportamento
8 I CEMENTI COMUNI E LA NORMA UNIEN 1971 I cementi disponibili in commercio sono principalmente costituiti da miscele di cemento Portland con materiali pozzolanici, materiali pozzolanici a comportamento
LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA. cls normale
 1.6 TIPI DI CLS cls normale 2000 2600 Cls normale: conglomerato cementizio caratterizzato in generale da rapporto a/c > 0,45 e con resistenza caratteristica cubica 55 (N/mm 2 ) ovvero 550 (dan/cm 2 ) cls
1.6 TIPI DI CLS cls normale 2000 2600 Cls normale: conglomerato cementizio caratterizzato in generale da rapporto a/c > 0,45 e con resistenza caratteristica cubica 55 (N/mm 2 ) ovvero 550 (dan/cm 2 ) cls
ESERCITAZIONI: Prescrizioni di capitolato e calcolo del copriferro
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA ESERCITAZIONI: Prescrizioni di capitolato e calcolo del copriferro Prof. Ing. Luigi Coppola APPELLO GENNAIO 2009 Le Isole Tremiti (Foggia) non dispongono
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA ESERCITAZIONI: Prescrizioni di capitolato e calcolo del copriferro Prof. Ing. Luigi Coppola APPELLO GENNAIO 2009 Le Isole Tremiti (Foggia) non dispongono
MATERIALI POZZOLANICI A COMPORTAMENTO IDRAULICO
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MATERIALI POZZOLANICI A COMPORTAMENTO IDRAULICO Prof. Ing. Luigi Coppola REAZIONE POZZOLANICA Pozzolana + CH + H => C-S-H + C-A-H Potrà avvenire
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MATERIALI POZZOLANICI A COMPORTAMENTO IDRAULICO Prof. Ing. Luigi Coppola REAZIONE POZZOLANICA Pozzolana + CH + H => C-S-H + C-A-H Potrà avvenire
CERTIFICAZIONE FPC PER PRODOTTI COPERTI DA MARCATURA CE
 M/100 _ PREFABBRICATI EN 1168 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari M/100 _ PREFABBRICATI EN 1520 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con
M/100 _ PREFABBRICATI EN 1168 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari M/100 _ PREFABBRICATI EN 1520 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con
Suddivisione delle norme relative all impermeabilizzazione secondo la norma SIA 270
 Suddivisione delle norme relative all impermeabilizzazione secondo la norma SIA 270 Suddivisione delle norme relative all impermeabilizzazione secondo i materiali e i sistemi impiegati Edilizia (architettura)
Suddivisione delle norme relative all impermeabilizzazione secondo la norma SIA 270 Suddivisione delle norme relative all impermeabilizzazione secondo i materiali e i sistemi impiegati Edilizia (architettura)
11.1 11.2 11.3 11.4 INDICE. Degradi del calcestruzzo e prevenzioni DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI CAUSE CHIMICHE CORROSIONE DELLE ARMATURE
 INDICE 11 11.2 11.4 DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI CORROSIONE DELLE ARMATURE CAUSE MECCANICHE- STRUTTURALI 11.1 CAUSE CHIMICHE 11.3 CAUSE FISICHE DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI 11 DEGRADI
INDICE 11 11.2 11.4 DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI CORROSIONE DELLE ARMATURE CAUSE MECCANICHE- STRUTTURALI 11.1 CAUSE CHIMICHE 11.3 CAUSE FISICHE DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI 11 DEGRADI
con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Reggio Emilia
 con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Qualificazione e Controlli per le opere in Calcestruzzo Armato con il D.M. 14.01.2008 Ruoli e Responsabilità Reggio Emilia 15.10.2010 SCENARIO
con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Qualificazione e Controlli per le opere in Calcestruzzo Armato con il D.M. 14.01.2008 Ruoli e Responsabilità Reggio Emilia 15.10.2010 SCENARIO
Indice. Presentazione
 ROMANE 28-02-2007 16:20 Pagina VII Prefazione Presentazione XIII XVIII Capitolo 1 I leganti e il loro impiego nel settore delle costruzioni 1.1 Introduzione 1 1.2 Leganti aerei e idraulici 2 1.3 Il gesso
ROMANE 28-02-2007 16:20 Pagina VII Prefazione Presentazione XIII XVIII Capitolo 1 I leganti e il loro impiego nel settore delle costruzioni 1.1 Introduzione 1 1.2 Leganti aerei e idraulici 2 1.3 Il gesso
NORME UNI EN e MARCATURA CE delle barriere stradali NEW JERSEY
 NORME UNI EN e MARCATURA CE delle barriere stradali NEW JERSEY Abbiamo provveduto a uniformare in nostri prodotti secondo le direttive UNI EN obbligatorie che li riguardano, con conseguente marcatura CE.
NORME UNI EN e MARCATURA CE delle barriere stradali NEW JERSEY Abbiamo provveduto a uniformare in nostri prodotti secondo le direttive UNI EN obbligatorie che li riguardano, con conseguente marcatura CE.
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO FACCIAVISTA
 8 STRUTTURE IN CALCESTRUZZO FACCIAVISTA Questa sezione è dedicata alle prescrizioni di capitolato per le strutture in calcestruzzo le cui superfici debbono rimanere a vista e dove, quindi, l estetica del
8 STRUTTURE IN CALCESTRUZZO FACCIAVISTA Questa sezione è dedicata alle prescrizioni di capitolato per le strutture in calcestruzzo le cui superfici debbono rimanere a vista e dove, quindi, l estetica del
Struttura e Proprietà del Calcestruzzo
 Struttura e Proprietà del Prof. Bernhard Elsener, Dipartimento di Chimica Inorganica ed Analitica Università degli Studi di Cagliari Email: belsener@unica.it http://dipcia.unica.it/superf/ Parte di questa
Struttura e Proprietà del Prof. Bernhard Elsener, Dipartimento di Chimica Inorganica ed Analitica Università degli Studi di Cagliari Email: belsener@unica.it http://dipcia.unica.it/superf/ Parte di questa
Un importante materiale da costruzione nell ingegneria civile è il calcestruzzo armato.
 ESERCIZIO 1 Un importante materiale da costruzione nell ingegneria civile è il calcestruzzo armato. a) Indicare quali prodotti si formano durante la presa del cemento portland e spiegare perché le armature
ESERCIZIO 1 Un importante materiale da costruzione nell ingegneria civile è il calcestruzzo armato. a) Indicare quali prodotti si formano durante la presa del cemento portland e spiegare perché le armature
Architettura Tecnica I. prof. ing. Vincenzo Sapienza
 Ingegneria Edile-Architettura Architettura Tecnica I IL CALCESTRUZZO (CLS) prof. ing. Vincenzo Sapienza TIPI DI CONGLOMERATI BOIACCA = legante + acqua MALTA = legante + acqua + sabbia CALCESTRUZZI = cemento
Ingegneria Edile-Architettura Architettura Tecnica I IL CALCESTRUZZO (CLS) prof. ing. Vincenzo Sapienza TIPI DI CONGLOMERATI BOIACCA = legante + acqua MALTA = legante + acqua + sabbia CALCESTRUZZI = cemento
TCA3/T. BETONCINO monocomponente tixotropico fibrorinforzato
 01/12 1 di 1 BETONCINO monocomponente tixotropico fibrorinforzato è un betoncino monocomponente tixotropico fibrorinforzato polimero modificato a base di speciali leganti idraulici solfato resistenti e
01/12 1 di 1 BETONCINO monocomponente tixotropico fibrorinforzato è un betoncino monocomponente tixotropico fibrorinforzato polimero modificato a base di speciali leganti idraulici solfato resistenti e
GUIDA AL CALCESTRUZZO
 COME SI SCEGLIE IL CALCESTRUZZO CLASSE DI RESISTENZA CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE CLASSE DI ESPOSIZIONE RAPPORTO ACQUA/CEMENTO DIMENSIONE MASSIMA NOMINALE DELLʼAGGREGATO Dmax CMC di Cipolla Giuseppe S.r.l.
COME SI SCEGLIE IL CALCESTRUZZO CLASSE DI RESISTENZA CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE CLASSE DI ESPOSIZIONE RAPPORTO ACQUA/CEMENTO DIMENSIONE MASSIMA NOMINALE DELLʼAGGREGATO Dmax CMC di Cipolla Giuseppe S.r.l.
Servizio Facility e Energy Management U.O. PATRIMONIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELAZIONE SUI MATERIALI
 Servizio Facility e Energy Management U.O. PATRIMONIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELAZIONE SUI MATERIALI Oggetto: lavori di ampliamento deposito automezzi COTRAL di Blera (VT) Responsabile S.F.E. Dott. Renato
Servizio Facility e Energy Management U.O. PATRIMONIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELAZIONE SUI MATERIALI Oggetto: lavori di ampliamento deposito automezzi COTRAL di Blera (VT) Responsabile S.F.E. Dott. Renato
TEKNA CHEM Srl WATERSTOP - GIUNTI DI DILATAZIONE
 TEKNA CHEM Srl WATERSTOP - GIUNTI DI DILATAZIONE Waterstop WATERTEK La TEKNA CHEM fornisce una completa gamma di prodotti per la sigillatura delle riprese di getto. Da molti anni siamo presenti sul mercato
TEKNA CHEM Srl WATERSTOP - GIUNTI DI DILATAZIONE Waterstop WATERTEK La TEKNA CHEM fornisce una completa gamma di prodotti per la sigillatura delle riprese di getto. Da molti anni siamo presenti sul mercato
MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA Prof. Ing. Luigi Coppola IL MECCANISMO DI IDRATAZIONE DEL CEMENTO: PRESA E INDURIMENTO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA Prof. Ing. Luigi Coppola IL MECCANISMO DI IDRATAZIONE DEL CEMENTO: PRESA E INDURIMENTO
RX 101 VOLTECO. Il prodotto. Dove si impiega GIUNTI SCHEDA TECNICA 2 BA S /06
 RX 101 Il prodotto RX 101 è un waterstop bentonitico idroespansivo composto da Bentonite di Sodio naturale Volclay e gomma butilica. SCHEDA TECNICA 2 Dove si impiega Sigillatura delle riprese verticali
RX 101 Il prodotto RX 101 è un waterstop bentonitico idroespansivo composto da Bentonite di Sodio naturale Volclay e gomma butilica. SCHEDA TECNICA 2 Dove si impiega Sigillatura delle riprese verticali
DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO GELO/DISGELO E SALI DISGELANTI
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO GELO/DISGELO E SALI DISGELANTI Prof. Ing. Luigi Coppola CLASSI D ESPOSIZIONE AMBIENTALE ITALIA classe ambiente/agenti
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO GELO/DISGELO E SALI DISGELANTI Prof. Ing. Luigi Coppola CLASSI D ESPOSIZIONE AMBIENTALE ITALIA classe ambiente/agenti
CALCESTRUZZI DUREVOLI
 CALCESTRUZZI DUREVOLI In base alle Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, la durabilità di una struttura in c.a. è il risultato dell azione di quattro attori che intervengono alla sua realizzazione: Il
CALCESTRUZZI DUREVOLI In base alle Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, la durabilità di una struttura in c.a. è il risultato dell azione di quattro attori che intervengono alla sua realizzazione: Il
LA DURABILITA DEL CALCESTRUZZO ARMATO
 - - -. TECNOLOGIE PIETRO PEDEFERRI LUCA BERTOLINI "" LA DURABILITA DEL CALCESTRUZZO ARMATO con CD-ROM.. McGraw-Hill l. f, IUAV - VENEZIA AREA SERV. BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTALI H 9311 BIBLIOTECA CENTRALE
- - -. TECNOLOGIE PIETRO PEDEFERRI LUCA BERTOLINI "" LA DURABILITA DEL CALCESTRUZZO ARMATO con CD-ROM.. McGraw-Hill l. f, IUAV - VENEZIA AREA SERV. BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTALI H 9311 BIBLIOTECA CENTRALE
INFLUENZA DELLA COMPATTAZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO SULLA RESISTENZA MECCANICA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
 INFLUENZA DELLA COMPATTAZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO SULLA RESISTENZA MECCANICA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA Anno XIII - Numero 41-2008 Antoni Borsoi, Jean Jacob Ogoumah Olagot e Roberto Troli info@encosrl.it
INFLUENZA DELLA COMPATTAZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO SULLA RESISTENZA MECCANICA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA Anno XIII - Numero 41-2008 Antoni Borsoi, Jean Jacob Ogoumah Olagot e Roberto Troli info@encosrl.it
SEDE OPERATIVA Via G.B. Sammartini, Milano w w w. p r o i t e r. c o m
 SEDE OPERATIVA Via G.B. Sammartini, 5 20125 Milano w w w. p r o i t e r. c o m Gallerie in pressione Gallerie a pelo libero Effetti Prevenzione Fenomeni fisico/meccanici Fenomeni chimici Problemi statici
SEDE OPERATIVA Via G.B. Sammartini, 5 20125 Milano w w w. p r o i t e r. c o m Gallerie in pressione Gallerie a pelo libero Effetti Prevenzione Fenomeni fisico/meccanici Fenomeni chimici Problemi statici
GLI EFFETTI DELLA TEMPERATURA SULLE PROPRIETA DEL CALCESTRUZZO: lavorazione in clima caldo e freddo
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA GLI EFFETTI DELLA TEMPERATURA SULLE PROPRIETA DEL CALCESTRUZZO: lavorazione in clima caldo e freddo Prof. Ing. Luigi Coppola PROVE DI LABORATORIO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA GLI EFFETTI DELLA TEMPERATURA SULLE PROPRIETA DEL CALCESTRUZZO: lavorazione in clima caldo e freddo Prof. Ing. Luigi Coppola PROVE DI LABORATORIO
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
Lezione 4 GEOTECNICA. Docente: Ing. Giusy Mitaritonna
 Lezione 4 GEOTECNICA Docente: Ing. Giusy Mitaritonna e-mail: g.mitaritonna@poliba.it - Lezione 4 A. Cenni sul moto di filtrazione nelle terre B. Tensioni efficaci in presenza di forze di filtrazione C.
Lezione 4 GEOTECNICA Docente: Ing. Giusy Mitaritonna e-mail: g.mitaritonna@poliba.it - Lezione 4 A. Cenni sul moto di filtrazione nelle terre B. Tensioni efficaci in presenza di forze di filtrazione C.
CORROSIONE DA CARBONATAZIONE: FENOMENO DI DEGRADO E PREVENZIONE
 CORROSIONE DA CARBONATAZIONE: FENOMENO DI DEGRADO E PREVENZIONE Federica Lollini Politecnico di Milano Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta federica.lollini@polimi.it Riassunto
CORROSIONE DA CARBONATAZIONE: FENOMENO DI DEGRADO E PREVENZIONE Federica Lollini Politecnico di Milano Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta federica.lollini@polimi.it Riassunto
LINEA DISBOCRET : Ripara, Proteggi e Decora il C.A. con Caparol
 LINEA DISBOCRET : LINEA DISBOCRET I prodotti della Linea Disbocret sono garantiti da più di 50 anni di esperienza con molteplici referenze. Oggi come ieri, il Sistema Disbocret è il riferimento per tutto
LINEA DISBOCRET : LINEA DISBOCRET I prodotti della Linea Disbocret sono garantiti da più di 50 anni di esperienza con molteplici referenze. Oggi come ieri, il Sistema Disbocret è il riferimento per tutto
GEOTECNICA LEZIONE 3 FILTRAZIONE MONODIMENSIONALE. Ing. Alessandra Nocilla
 GEOTECNICA LEZIONE 3 FILTRAZIONE MONODIMENSIONALE Ing. Alessandra Nocilla 1 ACQUA NEL TERRENO Nell affrontare la maggior parte dei problemi dell Ingegneria Geotecnica non si può prescindere dalla presenza
GEOTECNICA LEZIONE 3 FILTRAZIONE MONODIMENSIONALE Ing. Alessandra Nocilla 1 ACQUA NEL TERRENO Nell affrontare la maggior parte dei problemi dell Ingegneria Geotecnica non si può prescindere dalla presenza
Patologia edilizia e diagnostica
 Patologia edilizia e diagnostica CASO DI STUDIO INDIVIDUALE: Perizia diagnostica Sommario INTRODUZIONE... 3 CASO DI STUDIO... 4 SOLUZIONI PROPOSTE... 5 INTRODUZIONE La seguente perizia ha come scopo l
Patologia edilizia e diagnostica CASO DI STUDIO INDIVIDUALE: Perizia diagnostica Sommario INTRODUZIONE... 3 CASO DI STUDIO... 4 SOLUZIONI PROPOSTE... 5 INTRODUZIONE La seguente perizia ha come scopo l
Lezione Circolazione idrica sotterranea
 Lezione Circolazione idrica sotterranea Obiettivi La lezione pone l attenzione sulle modalità di circolazione idrica sotterranea, partendo dalla scala dei pori fino a giungere alla scala di bacino, attraverso
Lezione Circolazione idrica sotterranea Obiettivi La lezione pone l attenzione sulle modalità di circolazione idrica sotterranea, partendo dalla scala dei pori fino a giungere alla scala di bacino, attraverso
IN.TEC. Soc. Cooperativa
 L I S T I N O E T A R I F F E Decorrenza : 04-05-2015 Pagina : 21 CC001 CC002 CC003 PRELIEVO, in cantiere o all'impianto, di CALCESTRUZZO FRESCO, determinazione della TEMPERATURA del calcestruzzo ( UNI
L I S T I N O E T A R I F F E Decorrenza : 04-05-2015 Pagina : 21 CC001 CC002 CC003 PRELIEVO, in cantiere o all'impianto, di CALCESTRUZZO FRESCO, determinazione della TEMPERATURA del calcestruzzo ( UNI
FACOLTA DI INGEGNERIA ESERCITAZIONI. Prof. Ing. Luigi Coppola. L. Coppola Concretum Esercitazioni
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA ESERCITAZIONI Prof. Ing. Luigi Coppola APPELLO GENNAIO 2009 Le Isole Tremiti (Foggia) non dispongono di approvvigionamenti idrici dal sottosuolo.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA ESERCITAZIONI Prof. Ing. Luigi Coppola APPELLO GENNAIO 2009 Le Isole Tremiti (Foggia) non dispongono di approvvigionamenti idrici dal sottosuolo.
IDROSEAL. Malte osmotiche ad elevate prestazioni. materiali protettivi milano
 IDROSEAL Malte osmotiche ad elevate prestazioni. materiali protettivi milano IDROSEAL INTONACO Malta cementizia impermeabilizzante ad azione osmotica, applicabile anche con intonacatrice. IDROSEAL funziona
IDROSEAL Malte osmotiche ad elevate prestazioni. materiali protettivi milano IDROSEAL INTONACO Malta cementizia impermeabilizzante ad azione osmotica, applicabile anche con intonacatrice. IDROSEAL funziona
Termoigrometria. Massimo Garai. DIN - Università di Bologna
 Termoigrometria Massimo Garai DIN - Università di Bologna http://acustica.ing.unibo.it Copyright (C) 2004-2014 Massimo Garai - Università di Bologna 1 Abitazione nella stagione fredda - Produzione di vapor
Termoigrometria Massimo Garai DIN - Università di Bologna http://acustica.ing.unibo.it Copyright (C) 2004-2014 Massimo Garai - Università di Bologna 1 Abitazione nella stagione fredda - Produzione di vapor
BARRIERA A MURETTO IN CAV PROFILO TRAPEZIA MODELLO ET98BL
 BARRIERA A MURETTO IN CAV PROFILO TRAPEZIA MODELLO ET98BL TESTATA IN CLASSE DI CONTENIMENTO H2 CON LA NORMA EUROPEA EN 1317 parte 1-2-3-4-5 Pagina 1 di 6 VOCE DI CAPITOLATO Barriera di sicurezza stradale
BARRIERA A MURETTO IN CAV PROFILO TRAPEZIA MODELLO ET98BL TESTATA IN CLASSE DI CONTENIMENTO H2 CON LA NORMA EUROPEA EN 1317 parte 1-2-3-4-5 Pagina 1 di 6 VOCE DI CAPITOLATO Barriera di sicurezza stradale
LA DIFFUSIONE. M At 1 A. dm dt
 LA DIFFUSIONE Il trasferimento di massa, all interno di un solido, di un liquido o di un gas o di un altra fase solida è detto diffusione ( trasporto di materiale mediante movimento di atomi). La diffusione
LA DIFFUSIONE Il trasferimento di massa, all interno di un solido, di un liquido o di un gas o di un altra fase solida è detto diffusione ( trasporto di materiale mediante movimento di atomi). La diffusione
SCUOLA DELL INFANZIA S.MARIA GORETTI - FARRA D ALPAGO (BL) - 1 STRALCIO 1. CEMENTO ARMATO... 2
 SOMMARIO 1. CEMENTO ARMATO... 2 1.1. CALCESTRUZZI... 2 1.2. PROSPETTO CLASSI DI ESPOSIZIONE E COMPOSIZIONE UNI EN 206-1... 5 2. ACCIAIO PER C.A.... 7 3. ACCIAIO PER CARPENTERIA... 8 4. ACCIAIO PER BULLONERIA...
SOMMARIO 1. CEMENTO ARMATO... 2 1.1. CALCESTRUZZI... 2 1.2. PROSPETTO CLASSI DI ESPOSIZIONE E COMPOSIZIONE UNI EN 206-1... 5 2. ACCIAIO PER C.A.... 7 3. ACCIAIO PER CARPENTERIA... 8 4. ACCIAIO PER BULLONERIA...
Degrado delle strutture in c.a.: gli ambienti aggressivi per il calcestruzzo e l acciaio
 In Concreto n 104 Calcestruzzo di Qualità Degrado delle strutture in c.a.: gli ambienti aggressivi per il calcestruzzo e l acciaio Gianluca Pagazzi Introduzione La durabilità, definita nel D.M. 14.01.2008,
In Concreto n 104 Calcestruzzo di Qualità Degrado delle strutture in c.a.: gli ambienti aggressivi per il calcestruzzo e l acciaio Gianluca Pagazzi Introduzione La durabilità, definita nel D.M. 14.01.2008,
#smartfiber. Calcestruzzi strutturali fibrorinforzati DESCRIZIONE E APPLICAZIONI
 DESCRIZIONE E APPLICAZIONI I calcestruzzi denominati commercialmente con il termine #smartfiber sono confezionati mediante l impiego di un rinforzo discreto in forma di fibre in aggiunta ai tradizionali
DESCRIZIONE E APPLICAZIONI I calcestruzzi denominati commercialmente con il termine #smartfiber sono confezionati mediante l impiego di un rinforzo discreto in forma di fibre in aggiunta ai tradizionali
DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA UNITARIA "U" DI UNA PARETE IN MURATURA secondo UNI EN 1745:2005
 Consorzio ALVEOLATER Viale Aldo Moro, 16 40127 BOLOGNA 051 509873 fax 051 509816 consorzio@alveolater.com DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA UNITARIA "U" DI UNA PARETE IN MURATURA secondo UNI EN 1745:2005
Consorzio ALVEOLATER Viale Aldo Moro, 16 40127 BOLOGNA 051 509873 fax 051 509816 consorzio@alveolater.com DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA UNITARIA "U" DI UNA PARETE IN MURATURA secondo UNI EN 1745:2005
43 LA MATURAZIONE DEI GETTI
 43 LA MATURAZIONE DEI GETTI L a realizzazione di strutture in calcestruzzo armato eccellenti dal punto di vista della durabilità, delle capacità portanti e dei livelli di sicurezza generali dell opera
43 LA MATURAZIONE DEI GETTI L a realizzazione di strutture in calcestruzzo armato eccellenti dal punto di vista della durabilità, delle capacità portanti e dei livelli di sicurezza generali dell opera
Ossature portanti di calcestruzzo armato. Generalità
 Generalità Generalità Generalità / il telaio Generalità / il telaio I vincoli esterni devono essere sovrabbondanti TELAI TRAVI (A PORTALE) Generalità / comportamento del telaio soggetto al carico P P P
Generalità Generalità Generalità / il telaio Generalità / il telaio I vincoli esterni devono essere sovrabbondanti TELAI TRAVI (A PORTALE) Generalità / comportamento del telaio soggetto al carico P P P
PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL OPERA
 PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL OPERA (Ai sensi del D.M. 14.01.2008, art. 10.1) 1. Premessa. Il presente Piano di manutenzione della parte strutturale dell opera è relativo alle opere
PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL OPERA (Ai sensi del D.M. 14.01.2008, art. 10.1) 1. Premessa. Il presente Piano di manutenzione della parte strutturale dell opera è relativo alle opere
Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali Sommario 1. Calcestruzzi semplici e armati...2 1.1. Calcestruzzo...2 o Classi di resistenza...2 o Dimensioni aggregati...3 o Composizione del calcestruzzo...3
Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali Sommario 1. Calcestruzzi semplici e armati...2 1.1. Calcestruzzo...2 o Classi di resistenza...2 o Dimensioni aggregati...3 o Composizione del calcestruzzo...3
Tariffario: Laboratorio di Diagnostica e Analisi sui Materiali del Costruito
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE Tariffario: Laboratorio di Diagnostica e Analisi sui Materiali del Costruito Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE Tariffario: Laboratorio di Diagnostica e Analisi sui Materiali del Costruito Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" Materiali Cementizi e Durabilità TARIFFARIO 2011
 Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" Materiali Cementizi e Durabilità Milano, 30 Maggio 2011 TARIFFARIO 2011 1) Condizioni generali 1.1 Rapporti di prova (fino a 3 pagine)
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" Materiali Cementizi e Durabilità Milano, 30 Maggio 2011 TARIFFARIO 2011 1) Condizioni generali 1.1 Rapporti di prova (fino a 3 pagine)
ASP Associazione Svizzera delle Piastrelle Sezione Ticino
 bm engineering sa ASP Associazione Svizzera delle Piastrelle Sezione Ticino Serata d informazione Origlio, 21 gennaio 2009 Marco Bernasconi 2009 1 Sommario Impermeabilità, concetto e scopo Norma SIA 271
bm engineering sa ASP Associazione Svizzera delle Piastrelle Sezione Ticino Serata d informazione Origlio, 21 gennaio 2009 Marco Bernasconi 2009 1 Sommario Impermeabilità, concetto e scopo Norma SIA 271
R.02.D.8 - Relazione sui materiali
 Via XXV Aprile, 18 - Rovato COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI FLERO PROGETTO DEFINITIVO R.02.D.8 - Relazione sui materiali Rovato,
Via XXV Aprile, 18 - Rovato COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI FLERO PROGETTO DEFINITIVO R.02.D.8 - Relazione sui materiali Rovato,
