Aspetti Epistemologici dell Informatica
|
|
|
- Ottavia Bucci
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel gianluca.colombo@disco.unimib.it tel
2 La demarcazione TESI II Realtà 2) L osservazione è carica di Teoria Teorie Scientifiche Osservazione Demarcazione Metafisica Controllo sperimentale Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture Non è più tra senso e non senso, ma tra Scienza e Metafisica Deduzione di conseguenze osservative Criterio di Falsificabiità Devono essere accettate come scientifiche Ipotesi e Teorie Falsificabili
3 La demarcazione TESI II PROBLEMI Il criterio di falsificabilità mette al riparo dalle stesse obiezioni che Popper mosse alla verificabilità? Sfortunatamente no!! (1) Non esclude asserti metafisici ovvi (2) Esclude i più importanti ed interessanti asserti scientifici
4 La demarcazione TESI II (1) Non esclude asserti metafisici ovvi I pianeti descrivono intorno al Sole orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno dei fuochi Sia T una Teoria falsificabile (ES: Prima Legge di Keplero) Sia M un asserto metafisico Sia T = T & M Essendo T falsificabile, esiste un asserto osservativo O che segue logicamente da T. Se tramite l osservazione sperimentale noi scoprissimo che O è falso, allora avremmo falsificato T. Ma poiché O segue logicamente da T seguirà anche da T & M. Quindi T è falsificabile Ne segue che se disponiamo di una Teoria falsificabile possiamo sempre aggiungere un asserto metafisico e avere ancora una Teoria falsificabile PARADOSSO DELL AGGIUNZIONE
5 La demarcazione TESI II (2) Esclude i più importanti ed interessanti asserti scientifici Un Esempio: La prima Legge di Newton asserisce che tutti i corpi mantengono il loro stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non vengano sottoposti all azione pertubatrice di una forza Se osserviamo un corpo che non è in stato di quiete nè in moto rettilineo uniforme e che non è apparentemente soggetto all azione di alcuna forza, allora possiamo pur sempre postulare una forza invisibile che agisce su di esso. Ciò è precisamente quanto fece Newton nel caso dei pianeti, i quali descrivono ellissi e non linee rette Newton ipotizzò che tali pianeti fossero sottoposti all azione di una forza invisibile di gravitazione universale. Uno stratagemma di questo tipo potrebbe essere utilizzato nel caso di ogni apparente eccezione alla principio di inerzia, la quale finirebbe per non apparire scientifica secondo il criterio di falsificabilità
6 La demarcazione Anche la falsificabilità come criterio di demarcazione è inadeguata Una possibile soluzione razionale La corroborabilità Una teoria è scientifica se e solo se è capace di acquisire un certo grado di sostegno empirico da qualche eventuale asserto osservativo
7 La demarcazione Anche la falsificabilità come criterio di demarcazione è inadeguata Una possibile soluzione razionale La corroborabilità Una teoria è scientifica se e solo se è capace di acquisire un certo grado di sostegno empirico da qualche eventuale asserto osservativo Classificazione di asserti nei Livelli 0,1,2 e 3 Status Criterio Esempio Livello Metafisico Non corroborabile Atomismo greco 3 Scientifico Corroborabile ma non Falsificabile Prima Legge di Newton 2 Scientifico Corroborabile e Falsificabile Prima Legge di Keplero 1 Asserto osservativo Valore di verità determinabile per mezzo dell osservazione Asserto che registra la posizione di Marte in un dato momento 0
8 La demarcazione TESI II Realtà Linguaggio Livello 0 Teorie Scientifiche Livello 1 Livello 2 Osservazione Corroborabile e Falsificabile Corroborabile ma non Falsificabile Metafisica Controllo sperimentale Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture Prima Legge di Keplero Prima Legge di Newton Livello 3 Non corroborabile Deduzione di conseguenze osservative I pianeti descrivono intorno al Sole orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno dei fuochi
9 Estensione del Metodo scientifico La metodologia del Surplus Esplicativo A determinare il grado di corroborazione di un ipotesi non è tanto il numero dei casi corroboranti, quanto piuttosto la severità dei controlli ai quali l ipotesi può essere, ed è stata sottoposta Se e segue logicamente da h ciò automaticamente non significa che e fornisce supporto ad h. Il teorico di successo è come l imprenditore di successo. Per avere successo l imprenditore deve scegliere investimenti per il proprio capitale in modo da ottenere un surplus. Ovvero un eccedenza delle entrate rispetto alle uscite
10 Estensione del Metodo scientifico La metodologia del Surplus Esplicativo A determinare il grado di corroborazione di un ipotesi non è tanto il numero dei casi corroboranti, quanto piuttosto la severità dei controlli ai quali l ipotesi può essere, ed è stata sottoposta Se e segue logicamente da h ciò automaticamente non significa che e fornisce supporto ad h. Analogamente il teorico dovrà scegliere assunzioni teoriche T...Tn in modo da generare un surplus, Ovvero un eccedenza dei fatti spiegati rispetto alle assunzioni teoriche impiegate
11 Estensione del Metodo scientifico La metodologia del Surplus Esplicativo Risolve il paradosso dell aggiunzione Sia T una Teoria falsificabile (ES: Prima Legge di Keplero) Sia M un asserto metafisico I pianeti descrivono intorno al Sole orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno dei fuochi Sia T = T & M Accettato il principio del Surplus Esplicativo T sarà sostenuta dai fatti sempre meglio di T & M
12 Estensione del Metodo scientifico La metodologia del Surplus Esplicativo Le Leggi di Newton Se Newton avesse spiegato le leggi di Keplero e di Galileo e null altro, egli non avrebbe generato un surplus esplicativo e la sua teoria non sarebbe stata corroborata. In realtà le leggi di Newton spiegano le maree, le irregolarità dei moti lunari, alcune perturbazioni planetarie, etc che Keplero e Galileo non spiegavano Hanno maggior contenuto empirico
13 ...e questo problema?? TESI II...altro problema: quale ipotesi scartare? La prima Legge di Newton non può essere controllata come un ipotesi isolata, ma solo come componente di un sistema di Teorie. Indichiamo con T la prima Legge di Newton. Per ottenere delle conseguenze osservabili dobbiamo aggiungere a T: Ulteriori assunzioni teoriche come la seconda e la terza legge del moto e la legge di gravità (chiamiamo T* la loro congiunzione) Alcune assunzioni ausiliari del tipo: le forze non gravitazionali non hanno effetti apprezzabili sulmoto del Sole e dei pianeti, la massa del Sole è molto superiore alla massa di ciascun pianeta, etc (chiamiamo A la congiunzione di Ipotesi Ausialiri) Da T & T* & A, possiamo dedurre conseguenze osservative Indichiamo con O una di conseguenze osservative Supponiamo di osservare Non-O: cosa è stato falsificato? T, T* o A??? Non si falsifica mai una Congettura e nemmeno una Teoria, bensì un Sistema di Teorie
14 ...e questo problema?? TESI II...altro problema: quale ipotesi scartare? Affronteremo una possibile soluzione razionale nell ultima lezione del modulo!!
15 ...e questo problema?? TESI II...altro problema: quale ipotesi scartare? Passiamo ora a considerare un altro approccio a questi stessi temi: da una visione razionalistica sui temi della demarcazione, ad una visione storicistica dei temi della crescita della conoscenza THOMAS KHUN
16 Questo è il modello razionalistico ad ora definito TESI II Realtà Linguaggio Livello 0 Teorie Scientifiche Livello 1 Livello 2 Osservazione Corroborabile e Falsificabile Corroborabile ma non Falsificabile Metafisica Controllo sperimentale Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture Prima Legge di Keplero Prima Legge di Newton Livello 3 Non corroborabile Deduzione di conseguenze osservative Surplus Esplicativo
17 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti Quando dalle Teorie popperiane ci si sposta ai paradigmi khuniani L impostazione generale di Thomas Khun Il limite più grave che secondo Khun caratterizza le impostazioni fin ora considerate è costituito dal fatto che in esse sono le esigenze filosofiche a decidere ciò che deve essere il sapere scientifico, molto più di quanto non siano le effettive vicende della scienza a mostrare ciò che la scienza è nella concretezza del suo svolgersi come fenomeno umano Nel corso della seconda metà degli 50 si è affermata la tendenza a studiare la struttura delle teorie scientifiche in forte unione con la struttura del divenire delle scienze, riducendo la rilevanza di considerazioni di carattere normativo
18 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti Questa tendenza ha avuto la prima espressione di alta risonanza nella concezione di Thomas Khun espressa nel libro La struttura delle Rivoluzioni Scientifiche. Qui appare l esplicita convinzione che la teorizzazione scientifica risulta intramata di componenti irrazionali oltre che di componenti razionali e che l affermarsi dell una o dell altra delle sue forme è più una questione di fatto che di diritto Secondo Khun l evoluzione delle scienze avrebbe luogo attraverso un alternarsi di periodi Scienza normale e momenti di Scienza rivoluzionaria La scienza normale è caratterizzata dalla quasi totale accettazione da parte delle scienziati competenti di un certo paradigma
19 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi I paradigmi sono schemi o modelli concettuali di organizzazione di interpretazione della realtà e della esperienza Paradigma Osservazione Verifica sperimentale Ipotesi Deduzione di conseguenze osservative
20 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi I paradigmi sono conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerche. Paradigma Osservazione Verifica sperimentale Ipotesi Deduzione di conseguenze osservative
21 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi 1) Sono sufficientemente nuovi per attrarre uno stabile numero di seguaci, distogliendoli da forme di attività scientifica contrastanti con essi 2) Sono sufficientemente aperti da lasciare la gruppo di scienziati costituitosi su queste basi la possibilità di risolvere problemi di ogni genere Paradigma Osservazione Verifica sperimentale Ipotesi Deduzione di conseguenze osservative
22 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi? Falsificata Teoria Scientifica? Osservazione Controllo sperimentale Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture Deduzione di conseguenze osservative Popper Surplus Esplicativo
23 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi Khun PARADIGMA Falsificata Teoria Scientifica Osservazione Controllo sperimentale Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture Deduzione di conseguenze osservative Popper Surplus Esplicativo
24 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi Realtà PARADIGMA Livello 0 Teorie Scientifiche Livello 1 Livello 2 Osservazione Corroborabile e Falsificabile Corroborabile ma non Falsificabile Metafisica Controllo sperimentale Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture Prima Legge di Keplero Prima Legge di Newton Livello 3 Non corroborabile Deduzione di conseguenze osservative Surplus Esplicativo
25 UN ESEMPIO DI PARADIGMA TRA QUELLI CHE ABBIAMO DISCUSSO IN AULA
26 PARADIGMA La dimensione del ragionamento puro Logica formale Teoria del sillogismo = Come generare ragionamenti veri a partire da premesse vere Metafisica (Qual è il contenuto di verità delle proposizioni) Teoria delle Categorie = la Struttura della Verità DEDUZIONE Teoria delle Forme Teoria delle Cause Estensione delle proposizioni vere sul Mondo proposizioni Principi generali dell Essere Mobile (Realtà) esperienza La dimensione della Scienza Mondo INDUZIONE La dimensione dell opinione Parvenze memoria Osservazione sensazioni La struttura del Mondo in cui domina il cambiamento, è data da un insieme di cause fra loro eterogenee Oggetti sensibili Realtà Sensibile = FALSITA Concetto di Natura Fisica Qualitativa
27 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi Le Rivoluzioni L invisibilità delle Rivoluzioni La scienza normale La pardita nel passaggio di paradigma Rompicapo come criterio di demarcazione
28 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi Rivoluzione Esperienza falsificante Si cambia Teoria?? Teoria Tolemaica Teoria Scientifica Teoria Copernicana Teoria Scientifica Osservazione Osservazione Controllo Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture Controllo Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Congetture sperimentale sperimentale Deduzione di Deduzione di conseguenze conseguenze osservative osservative Surplus Surplus Esplicativo Esplicativo
29 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi Le Rivoluzioni scientifiche Nel 1543 Copernico propose di migliorare la precisione e la semplicità delle teorie astronomiche trasferendo al Sole molte funzioni astronomiche attribuite in precedenza alla Terra. Prima della sua proposta, la Terra aveva sempre costituito il centro fisso attorno a cui gli astronomi calcolavano i movimenti delle stelle e dei pianeti. Un secolo dopo il Sole aveva rimpiazzato la Terra, almeno nel campo astronomico, come centro dei moti planetari e la Terra, divenuta uno fra i pianeti in movimento, aveva perso la sua funzione astronomica eccezionale LE RIVOUZIONI SONO EVENTI SPORADICI NELLA STORIA DELLA SCIENZA I mutamenti scientifici non sono il risultato di una lotta di idee, bensì sono il risultato di una lotta tra scienziati che accettano certe idee e credono in esse
30 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi L invisibilità delle Rivoluzioni Un paradigma non è un idea audace o una sfida alla conoscenza di sfondo, ma un idea incarnata in uno o più testi sui quali si formano generazioni di ricercatori Se guardiamo ai testi capostipite ed ai manuali eventualmente derivati per individuare storicamente i vari paradigmi, constatiamo che per un certo lasso di tempo dopo Copernico l insegnamento e la formazione degli esperti venne condotta ancora su testi tolemaici CRITERIO DEL LIBRO Getta luce sul lento emergere del nuovo paradigma e sulla persistenza [TENACIA METODOLOGICA] di quello vecchio e induce lo storico a valorizzare non solo l elemento di rottura presente nei padri fondatori di qualsiasi nuova scienza, ma anche sulle scelte di quei membri della comunità scientifica che ad un certo punto hanno isolato in quel dato testo gli aspetti che giudicavano più innovativi e ne hanno fatto il punto di partenza della loro ricerca rivoluzionaria
31 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi L invisibilità delle Rivoluzioni E la ricognizione dei testi e dei manuali, ovvero il CRITERIO DEL LIBRO, che spiega il fenomeno delle invisibilità delle rivoluzioni Solitamente i manuali mirano ad informare rapidamente uno studente su quello che la comunità scientifica contemporanea crede di sapere In questo modo accade che la deformazione che essi inducono nel lettore consiste nel dare l impressione che anche i ricercatori che hanno operato prima dell avvento di quel particolare paradigma abbiano rivolto i loro sforzi verso li argomenti particolari che in tale paradigma sono stati incorporati. [PROIEZIONE PARADIGMATICA, o FALSO STORICO] Nasce così lo stereotipo della scienza come sapere cumulativo
32 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi L invisibilità delle Rivoluzioni Per quanto dunque nelle stesse opere i padri fondatori cerchino di nascondere la novità, il criterio del libro mostra che il sovvertimento dello status quo è più raro di quanto si creda. Un episodio rivoluzionario richiede in genere un lungo periodo: solo quando un problema resiste un certo lasso di tempo all assalto dei migliori esperti, il paradigma entra in crisi [TENACIA METODOLOGICA] Quando ciò accade cominciano le indagini straordinarie che finiscono col condurre i professionisti ad abbracciare un nuovo insieme di impegni i quali andranno a costituire la base della nuova pratica scientifica La lotta tra sezioni della comunità scientifica è l unico processo storico che abbia effettivamente avuto come risultato l abbandono di una teoria precedentemente accettata o l adozione di una nuova Concettualmente le Rivoluzione sono rotture Storicamente avvengono nell invisibilità omertosa dei manuali
33 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi Un esempio di TENACIA Un Esempio: La prima Legge di Newton asserisce che tutti i corpi mantengono il loro stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non vengano sottoposti all azione pertubatrice di una forza Se osserviamo un corpo che non è in stato di quiete nè in moto rettilineo uniforme e che non è apparentemente soggetto all azione di alcuna forza, allora possiamo pur sempre postulare una forza invisibile che agisce su di esso. Ciò è precisamente quanto fece Newton nel caso dei pianeti, i quali descrivono ellissi e non linee rette Newton ipotizzò che tali pianeti fossero sottoposti all azione di una forza invisibile di gravitazione universale. Uno stratagemma di questo tipo potrebbe essere utilizzato nel caso di ogni apparente eccezione alla principio di inerzia, la quale finirebbe per non apparire scientifica secondo il criterio di falsificabilità Uno stratagemma di questo tipo è invece pienamente compreso dalla definizione di Khun di Tenacia
34 La crescita della conoscenza scientifica: i paradigmi La perdita nel passaggio di paradigma Una rivoluzione è una trasformazione di risultati strumenti e linguaggi preesistenti Per farsi capire dalla comunità del suo tempo Copernico non aveva altri mezzi che l apparato linguistico e di calcolo familiare agli esperti della tradizione tolemaica e sotto questo aspetto egli fu solo l iniziatore della rivoluzione che doveva soppiantare quella particolare tradizione Una perdita è inevitabile!!! INCOMMENSURABILITA
35 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti La scienza normale Paradigma Soluzioni di Rompicapo Osservazione Verifica sperimentale Scienza Normale Ipotesi Deduzione di conseguenze osservative
36 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti In questa fase gli scienziati si dedicano alla soluzione di rompicapo (puzzles), cioè di problemi che possono essere formulati in relazione ai concetti ed agli strumenti propri del paradigma prevalente, e che hanno una soluzione al suo interno. La prevalenza di un paradigma caratterizza una fase di "scienza normale" Criterio di demarcazione khuniano Soluzioni di Rompicapo Osservazione Verifica sperimentale Scienza Normale Ipotesi Deduzione di conseguenze osservative
37 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti Ma la ricerca scientifica guidata da un paradigma può imbattersi in una serie di anomalie in violazione delle aspettative create dal paradigma. Rivoluzione Invisibilità Perdita Criterio del libro Sfondo metafisico Comunità scientifica Anomalie Crisi Il paradigma dominante può così cadere in crisi e si apre la strada alla proliferazione di varianti teoriche. Paradigma Paradigma Soluzioni di Rompicapo Osservazione Osservazione Verifica Scienza Normale Soluzioni di Rompicapo Ipotesi Incommensurabilità Verifica Scienza Normale Ipotesi Deduzione Deduzione
38 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti LEGGIAMO KHUN Nell impresa scientifica la severità dei criteri di controllo è solo una faccia della medaglia: l altra faccia è una tradizione di soluzione di rompicapo. Ecco perché la linea di demarcazione di Popper e la mia coincidono così frequentemente. La coincidenza è tuttavia solo negli esiti. Il processo di applicazione è molto diverso e isola aspetti diversi dell attività circa la quale si deve prendere la decisione: scienza o non-scienza. L astrologia, al contrario di quanto penserebbe qualsiasi razionalista critico, non può venire relegata tra le pseudo-scienze per il modo in cui coloro che la praticano spiegavano i fallimenti, per il fatto cioè che gli astrologi si appellavano alla complessità nel pronosticare il futuro di un individuo ed alla sensibilità della cosa ai più piccoli errori nei dati iniziali: queste stesse scuse sono infatti regolarmente usate oggi per spiegare, per esempio, gli errori in medicina o in meteorologia...
39 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti LEGGIAMO KHUN...Tuttavia, l astrologia non era una scienza. Era invece un arte, una delle arti pratiche, con strette somiglianze con l ingegneria e la medicina come queste discipline erano praticate fino poco più di un secolo fa. Il parallelismo con la medicina più antica e con al moderna psicoanalisi è, credo, particolarmente stretto. In ognuno di questi campi una teoria condivisa era adeguata soltanto per stabilire la plausibilità della disciplina e per fornire un fondamento logico per le varie regole delle arti che governano la pratica. Queste regole hanno dimostrato la loro utilità nel passato, ma nessun professionista ha mai supposto che esse fossero sufficienti per prevenire ricorrenti fallimenti. Una teoria e delle regole più potenti erano necessarie ma sarebbe stato assurdo abbandonare una disciplina plausibile con una tradizione di limitato successo semplicemente perché questi desiderata non erano ancora a disposizione. In mancanza di questi, tuttavia, nè l astrologo nè il medico potevano fare tale ricerca. Benché avessero regole da applicare essi non avevano rompicapo da risolvere e perciò scienza da praticare. [...] E senza rompicapo, capaci, prima di sfidare e poi di testimoniare l ingegnosità del singolo professionista, l astrologia non sarebbe potuta diventare una scienza anche se le stelle avessero controllato il destino umano...
40 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti LEGGIAMO KHUN Benchè gli astrologi facessero predizioni controllabili e riconoscessero che queste predizioni talvolta fallivano, essi non si impegnarono e non poterono impegnarsi nel genere di attività che normalmente caratterizza tutte le scienze riconosciute come tali. Popper ha ragione nell escludere l astrologia dalle scienze, ma la sua superconcentrazione sulle occasionali rivoluzione della scienza [le falsificazioni], gli impedisce di vedere le ragioni più sicure per farlo. Khun non identifica le sue esperienze anomale con le esperienze falsificanti di Popper 1 Nessuna teoria (nel senso di Popper, ovvero insieme di asserti falsificabili) risolve mai i tutti i rompicapo in cui si imbatte 2 Soluzioni proposte ai problemi che affrontano una data teoria sono spesso insoddisfacenti
41 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti Per Khun è assai poco interessante ricercare se una data teoria abbia o no conseguito un accordo perfetto con i fatti pertinenti. Diversamente stanno le cose quando due o più teorie rivali vengono considerate collettivamente. Allora e solo allora per Khun è legittimo chiedersi quale delle due si adatta meglio ai fatti [PROLIFERAZIONE DELLE TEORIE] Quando dalle teorie popperiane si passa ai paradigmi khuniani in cui elementi costitutivi sono non soltanto le teorie intese come sistemi ipotetico deduttivi, ma anche le tecniche osservative e sperimentali adottate dagli specialisti nonché le credenze anche più speculative e i valori che sorreggono la ricerca si scorge con maggiore evidenza che i sostenitori di paradigmi in concorrenza tra loro hanno sempre propositi ed orientamenti almeno leggermente divergenti. Ovvero, nessuna delle scuole riconoscerà come validi tutti i presupposti empirici di cui l altra ha bisogno per sostenere la propria tesi Dunque per Khun la competizione tra paradigmi non è una battaglia il cui esito possa essere deciso sulla base delle dimostrazioni
42 La crescita della conoscenza scientifica: la gestione storicista dei fallimenti Khun e Popper Esperienza falsificante Soluzioni di Rompicapo TENACIA Paradigma Rivoluzione Competizione Osservazione Osserv Controllo sperimentale Il METODO SCIENTIFICO FALSIFICAZIONISMO Severità dei controlli Congetture Controllo sperimentale Il METODO FALSIFI Deduzione di conseguenze osservative Proliferazione Dedu cons osse Surplus Esplicativo Surp Esplic
Lezione 6. Il positivismo logico
 Il positivismo logico Lezione 6 Critica e crescita della conoscenza scientifica La funzione del dogmatismo scientifico secondo Kuhn Paradigmi e scienza normale Crisi e rivoluzioni scientifiche: l esempio
Il positivismo logico Lezione 6 Critica e crescita della conoscenza scientifica La funzione del dogmatismo scientifico secondo Kuhn Paradigmi e scienza normale Crisi e rivoluzioni scientifiche: l esempio
LA CRITICA DI POPPER ALL INDUTTIVISMO
 LA CRITICA DI POPPER ALL INDUTTIVISMO L induttivista pensa che la scienza parta da una iniziale raccolta di osservazioni in assenza di uno sfondo teorico Popper argomenta che non è possibile compiere osservazioni
LA CRITICA DI POPPER ALL INDUTTIVISMO L induttivista pensa che la scienza parta da una iniziale raccolta di osservazioni in assenza di uno sfondo teorico Popper argomenta che non è possibile compiere osservazioni
Il metodo scientifico
 Il metodo scientifico Alcune conoscenze sono considerate vere altre solo opinioni Relazione fra teoria e prassi Teoria che non si confronta con l esperienza non può sussistere Evoluzione delle conoscenze
Il metodo scientifico Alcune conoscenze sono considerate vere altre solo opinioni Relazione fra teoria e prassi Teoria che non si confronta con l esperienza non può sussistere Evoluzione delle conoscenze
La filosofia della scienza nel XX secolo. Editori Laterza
 Donale! Gillies Giulio Giorello La filosofia della scienza nel XX secolo Editori Laterza INDICE DEL VOLUME Prefazione Ringraziamenti ix xi Parte prima L'induttivismo e i suoi critici 1. Breve profilo storico:
Donale! Gillies Giulio Giorello La filosofia della scienza nel XX secolo Editori Laterza INDICE DEL VOLUME Prefazione Ringraziamenti ix xi Parte prima L'induttivismo e i suoi critici 1. Breve profilo storico:
Le leggi di Keplero e la gravitazione universale. Enrico Degiuli Classe Terza
 Le leggi di Keplero e la gravitazione universale Enrico Degiuli Classe Terza Giovanni Keplero Keplero è stato un astronomo tedesco vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Ha condotto lunghi studi sul
Le leggi di Keplero e la gravitazione universale Enrico Degiuli Classe Terza Giovanni Keplero Keplero è stato un astronomo tedesco vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Ha condotto lunghi studi sul
POPPER. 1.Vita e opere
 POPPER 1.Vita e opere Ad avanzare negli anni Trenta, una teoria della conoscenza scientifica alternativa a quella dei neopositivisti è stato Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper nasce nel 1902 a Vienna,
POPPER 1.Vita e opere Ad avanzare negli anni Trenta, una teoria della conoscenza scientifica alternativa a quella dei neopositivisti è stato Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper nasce nel 1902 a Vienna,
Lezione 11. Corso di comunicazione scientifica A.A Prof. Paolo Lattanzio.
 Lezione 11 Corso di comunicazione scientifica A.A. 2010 2011 Prof. Paolo Lattanzio www.paololattanzio.net plattanzio@unite.it Critica all induttivismo di Popper Induttivismo da osservazioni per poi inferire
Lezione 11 Corso di comunicazione scientifica A.A. 2010 2011 Prof. Paolo Lattanzio www.paololattanzio.net plattanzio@unite.it Critica all induttivismo di Popper Induttivismo da osservazioni per poi inferire
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN
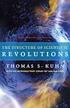 I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
FILOSOFIA DELLA SCIENZA Problemi del verificazionismo L argomento dell olismo della conferma (Quine-Duhem)
 FILOSOFIA DELLA SCIENZA 17-18 Problemi del verificazionismo L argomento dell olismo della conferma (Quine-Duhem) Induttivismo Derivare dai dati osservativi le ipotesi e le leggi Derivazione induttiva,
FILOSOFIA DELLA SCIENZA 17-18 Problemi del verificazionismo L argomento dell olismo della conferma (Quine-Duhem) Induttivismo Derivare dai dati osservativi le ipotesi e le leggi Derivazione induttiva,
Modelli geometrici del sistema planetario, dalla visione geocentrica all eliocentrismo
 Modelli geometrici del sistema planetario, dalla visione geocentrica all eliocentrismo Edoardo Maggiore Noelle Kcrajcman Lucia Lanfiuti Baldi Corso di Storia della Matematica, Maggio 2018 Modelli Cosmologici
Modelli geometrici del sistema planetario, dalla visione geocentrica all eliocentrismo Edoardo Maggiore Noelle Kcrajcman Lucia Lanfiuti Baldi Corso di Storia della Matematica, Maggio 2018 Modelli Cosmologici
1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello
 La gravitazione 1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico); i corpi celesti, sferici e perfetti,
La gravitazione 1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico); i corpi celesti, sferici e perfetti,
Le leggi di Keplero modello geocentrico modello eliocentrico
 Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
La Matematica nell Astronomia. Una (breve) introduzione. Roberto Ferretti
 La Matematica nell Astronomia Una (breve) introduzione Roberto Ferretti Il cielo: un fascino intramontabile Come si puó parlare di astronomia senza fermarsi un attimo a guardare il cielo? E un fascino
La Matematica nell Astronomia Una (breve) introduzione Roberto Ferretti Il cielo: un fascino intramontabile Come si puó parlare di astronomia senza fermarsi un attimo a guardare il cielo? E un fascino
Aspetti Epistemologici dell Informatica
 Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.
Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.
VERIFICA FILOSOFIA. ESERCIZIO 1 (quesiti a risposta multipla) (valutazione max 30 punti)
 nome ------------------------------ cognome ------------------------------ classe 4C VERIFICA FILOSOFIA ESERCIZIO 1 (quesiti a risposta multipla) (valutazione max 30 punti) A) Aristotele spiega il divenire
nome ------------------------------ cognome ------------------------------ classe 4C VERIFICA FILOSOFIA ESERCIZIO 1 (quesiti a risposta multipla) (valutazione max 30 punti) A) Aristotele spiega il divenire
La rivoluzione scientifica. Copernico, Galileo, Newton
 La rivoluzione scientifica Copernico, Galileo, Newton La rivoluzione scientifica è quel movimento di idee che nel corso del XVI e XVII secolo portò all abbandono della precedente immagine della realtà,
La rivoluzione scientifica Copernico, Galileo, Newton La rivoluzione scientifica è quel movimento di idee che nel corso del XVI e XVII secolo portò all abbandono della precedente immagine della realtà,
PIANO DI LAVORO. Anno Scolastico ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE con sez. Commerciale annessa Leonardo da Vinci BORGOMANERO
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE con sez. Commerciale annessa Leonardo da Vinci BORGOMANERO PIANO DI LAVORO Anno Scolastico 2018 2019 Materia: Fisica e Laboratorio Classe: PRIMA Sezione A-H Data di presentazione:
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE con sez. Commerciale annessa Leonardo da Vinci BORGOMANERO PIANO DI LAVORO Anno Scolastico 2018 2019 Materia: Fisica e Laboratorio Classe: PRIMA Sezione A-H Data di presentazione:
E.Nagel: Capitolo 1 Scienza e Senso Comune. Gianluigi Bellin
 E.Nagel: Capitolo 1 Scienza e Senso Comune Gianluigi Bellin October 18, 2011 Che cosa dà di più la conoscenza scientifica di quella del senso comune? Non possiamo dire la scienza ci dà la verità ultima
E.Nagel: Capitolo 1 Scienza e Senso Comune Gianluigi Bellin October 18, 2011 Che cosa dà di più la conoscenza scientifica di quella del senso comune? Non possiamo dire la scienza ci dà la verità ultima
FINALMENTE L ELIOCENTRISMO (CIOÈ, QUASI...)
 FINALMENTE L ELIOCENTRISMO (CIOÈ, QUASI...) Prime osservazioni astronomiche precise e sistematiche La supernova che videro Tycho e Galileo (allora bimbo di 8 anni) nel 1572. Tycho calcolò che era immobile
FINALMENTE L ELIOCENTRISMO (CIOÈ, QUASI...) Prime osservazioni astronomiche precise e sistematiche La supernova che videro Tycho e Galileo (allora bimbo di 8 anni) nel 1572. Tycho calcolò che era immobile
Elementi di Teoria degli Errori
 1 Elementi di Teoria degli Errori Corso di Esperimentazioni di Fisica I Laurea triennale in Astronomia Queste dispense sono state elaborate utilizzando diverso materiale didattico disponibile in letteratura.
1 Elementi di Teoria degli Errori Corso di Esperimentazioni di Fisica I Laurea triennale in Astronomia Queste dispense sono state elaborate utilizzando diverso materiale didattico disponibile in letteratura.
Gravità e moti orbitali. Lezione 3
 Gravità e moti orbitali Lezione 3 Sommario Brevi cenni storici. Le leggi di Keplero e le leggi di Newton. La forza di gravitazionale universale e le orbite dei pianeti. 2 L Universo Geocentrico La sfera
Gravità e moti orbitali Lezione 3 Sommario Brevi cenni storici. Le leggi di Keplero e le leggi di Newton. La forza di gravitazionale universale e le orbite dei pianeti. 2 L Universo Geocentrico La sfera
FILOSOFIA DELLA SCIENZA Kuhn e le rivoluzioni, seconda parte
 FILOSOFIA DELLA SCIENZA 17-18 Kuhn e le rivoluzioni, seconda parte Esempio di rivoluzione: la rivoluzione copernicana Galileo Galilei difende la teoria copernicana contro la chiesa cattolica all inizio
FILOSOFIA DELLA SCIENZA 17-18 Kuhn e le rivoluzioni, seconda parte Esempio di rivoluzione: la rivoluzione copernicana Galileo Galilei difende la teoria copernicana contro la chiesa cattolica all inizio
Storia della Scienza e Filosofia della Scienza
 Storia della Scienza e Filosofia della Scienza Arturo Russo Dottorato di ricerca in Storia e didattica delle matematiche, della fisica e della chimica Il compito della filosofia della scienza e il rapporto
Storia della Scienza e Filosofia della Scienza Arturo Russo Dottorato di ricerca in Storia e didattica delle matematiche, della fisica e della chimica Il compito della filosofia della scienza e il rapporto
1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello
 La gravitazione 1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico); i corpi celesti, sferici e perfetti,
La gravitazione 1. Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico); i corpi celesti, sferici e perfetti,
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE. 9.1 Introduzione.
 CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
Le leggi di Keplero modello geocentrico modello eliocentrico
 Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Cap. 6 del manuale La natura e i suoi modelli
 Cap. 6 del manuale La natura e i suoi modelli 1. In questa stanza c è una lavagna 2. Gli atomi di sodio hanno 11 protoni e 11 elettroni Consideriamo vere queste due affermazioni? Perché? Aff. 1: Perché
Cap. 6 del manuale La natura e i suoi modelli 1. In questa stanza c è una lavagna 2. Gli atomi di sodio hanno 11 protoni e 11 elettroni Consideriamo vere queste due affermazioni? Perché? Aff. 1: Perché
La scienza e le scienze
 La scienza e le scienze Scienza: definizioni Insieme di conoscenze rigorosamente controllate e sistematicamente ordinate che consente di giungere a verità obiettive intorno a un determinato ordine di fenomeni
La scienza e le scienze Scienza: definizioni Insieme di conoscenze rigorosamente controllate e sistematicamente ordinate che consente di giungere a verità obiettive intorno a un determinato ordine di fenomeni
DIETRO LE QUINTE DELLA MATEMATICA
 DIETRO LE QUINTE DELLA MATEMATICA TEKNOTRE Anno Accademico 2016-2017 Lezione n. 6 (10-2-2017) PERUCCO Pieraldo Dalla Logica alla Geometria Da regole empiriche a una rigorosa costruzione fondata sulla sistematica
DIETRO LE QUINTE DELLA MATEMATICA TEKNOTRE Anno Accademico 2016-2017 Lezione n. 6 (10-2-2017) PERUCCO Pieraldo Dalla Logica alla Geometria Da regole empiriche a una rigorosa costruzione fondata sulla sistematica
EVOLUZIONE EPISTEMOLOGICA IN FUNZIONE DEL PROGRESSO STORICO CULTURALE. Diplomando: Andrea Masiero A.S. 2016/2017
 EVOLUZIONE EPISTEMOLOGICA IN FUNZIONE DEL PROGRESSO STORICO CULTURALE Diplomando: Andrea Masiero A.S. 2016/2017 SOMMARIO Seconda Rivoluzione Industriale: caratteristiche e conseguenze Positivismo - Auguste
EVOLUZIONE EPISTEMOLOGICA IN FUNZIONE DEL PROGRESSO STORICO CULTURALE Diplomando: Andrea Masiero A.S. 2016/2017 SOMMARIO Seconda Rivoluzione Industriale: caratteristiche e conseguenze Positivismo - Auguste
(4 π 2 /kt) m t / r 2 = (4 π 2 /ks) m s / r 2
 Le leggi di Keplero Lo studio del moto dei pianeti, tramite accurate misure, permise a Keplero tra il 1600 ed il 1620 di formulare le sue tre leggi: I legge: I pianeti percorrono orbite ellittiche intorno
Le leggi di Keplero Lo studio del moto dei pianeti, tramite accurate misure, permise a Keplero tra il 1600 ed il 1620 di formulare le sue tre leggi: I legge: I pianeti percorrono orbite ellittiche intorno
Perché scegliere il liceo A. B. Sabin?
 Perché scegliere il liceo A. B. Sabin? I nostri indirizzi Liceo Scientifico e relativi indirizzi: Scienze Applicate, Sportivo Potenziamento di fisica sperimentale con laboratorio digitale in una sez. di
Perché scegliere il liceo A. B. Sabin? I nostri indirizzi Liceo Scientifico e relativi indirizzi: Scienze Applicate, Sportivo Potenziamento di fisica sperimentale con laboratorio digitale in una sez. di
Programmazione di fisica Classe 3B a.s Contenuti
 Programmazione di fisica Classe 3B a.s.2017-2018 Titolo del tema Modulo 1 La Misura Modulo 2 Il moto rettilineo Modulo 3 Le forze e l equilibrio Modulo 4 Le forze e il movimento Modulo 5 Energia e quantità
Programmazione di fisica Classe 3B a.s.2017-2018 Titolo del tema Modulo 1 La Misura Modulo 2 Il moto rettilineo Modulo 3 Le forze e l equilibrio Modulo 4 Le forze e il movimento Modulo 5 Energia e quantità
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
 Pagina 1 di 5 INGRESSO PROFILO CLASSE USCITA Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per
Pagina 1 di 5 INGRESSO PROFILO CLASSE USCITA Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per
Storia della teoria della gravitazione universale
 Storia della teoria della gravitazione universale Prof. Daniele Ippolito Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia Lo studio dell'astronomia è cominciato con lo sviluppo delle prime civiltà umane.
Storia della teoria della gravitazione universale Prof. Daniele Ippolito Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia Lo studio dell'astronomia è cominciato con lo sviluppo delle prime civiltà umane.
La modernità: 3 elementi
 La modernità: 3 elementi Forme di governo (ad es: monarchia parlamentare) Cultura (mentalità, scienza, arte, letteratura) Economia e classi sociali (ad es: ascesa della borghesia) La cultura: nuove teorie
La modernità: 3 elementi Forme di governo (ad es: monarchia parlamentare) Cultura (mentalità, scienza, arte, letteratura) Economia e classi sociali (ad es: ascesa della borghesia) La cultura: nuove teorie
Lezione 3. Okasha, cap. 2
 Lezione 3 Il problema della giustificazione Deduzione e induzione La dimostrazione scientifica Hume e il problema dell induzione Induzione e probabilità Okasha, cap. 2 Il problema della giustificazione
Lezione 3 Il problema della giustificazione Deduzione e induzione La dimostrazione scientifica Hume e il problema dell induzione Induzione e probabilità Okasha, cap. 2 Il problema della giustificazione
Un nuovo schema dell Universo. La teoria eliocentrica
 Un nuovo schema dell Universo La teoria eliocentrica Il sistema tolemaico si adattava perfettamente alla dottrina della Chiesa che quindi fece propri molti dei suoi concetti. Per circa quattordici secoli
Un nuovo schema dell Universo La teoria eliocentrica Il sistema tolemaico si adattava perfettamente alla dottrina della Chiesa che quindi fece propri molti dei suoi concetti. Per circa quattordici secoli
Studio della malattia cronica. Procedura e autovalutazione dell allievo
 Studio della malattia cronica Procedura e autovalutazione dell allievo Prima di continuare Applicazione e limite del criterio di similitudine Conoscenza della natura delle malattie acute e croniche Studio
Studio della malattia cronica Procedura e autovalutazione dell allievo Prima di continuare Applicazione e limite del criterio di similitudine Conoscenza della natura delle malattie acute e croniche Studio
Tempi Moduli Unità /Segmenti. 2.1 La conservazione dell energia meccanica
 PERCORSO FORMATIVO DEL 3 ANNO - CLASSE 3 A L LSSA A. S. 2015/2016 Tempi Moduli Unità /Segmenti MODULO 0: Ripasso e consolidamento di argomenti del biennio MODULO 1: Il moto dei corpi e le forze. (Seconda
PERCORSO FORMATIVO DEL 3 ANNO - CLASSE 3 A L LSSA A. S. 2015/2016 Tempi Moduli Unità /Segmenti MODULO 0: Ripasso e consolidamento di argomenti del biennio MODULO 1: Il moto dei corpi e le forze. (Seconda
Metodologia della ricerca 1
 Metodologia della ricerca 1 METODOLOGIA Riflessione critica sulle regole, i principi, le condizioni formali che sono alla base della ricerca scientifica e che consentono di ordinare, sistemare e accrescere
Metodologia della ricerca 1 METODOLOGIA Riflessione critica sulle regole, i principi, le condizioni formali che sono alla base della ricerca scientifica e che consentono di ordinare, sistemare e accrescere
La sintesi a priori e la rivoluzione copernicana
 La sintesi a priori e la rivoluzione copernicana La domanda sull uso puro della ragione porta Kant a compiere un indagine sulla natura, le condizioni e i limiti della conoscenza umana. Caratteri della
La sintesi a priori e la rivoluzione copernicana La domanda sull uso puro della ragione porta Kant a compiere un indagine sulla natura, le condizioni e i limiti della conoscenza umana. Caratteri della
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO MATERIA: FILOSOFIA. PROF. Paola Battisti. MSQ 07/D 02 Programmazione docente
 PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017 2018 CLASSE V SEZ. C MATERIA: FILOSOFIA PROF. Paola Battisti LIVELLI DI PARTENZA Conoscenze Discrete Competenze Discrete Comportamento sociale e di lavoro Discreto OBIETTIVI
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017 2018 CLASSE V SEZ. C MATERIA: FILOSOFIA PROF. Paola Battisti LIVELLI DI PARTENZA Conoscenze Discrete Competenze Discrete Comportamento sociale e di lavoro Discreto OBIETTIVI
LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei VERONA
 LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei PROGRAMMA PREVISTO Anno Scolastico 2006-2007 Testo di riferimento: "Le Vie della Fisica" vol. 1-2 (Battimelli - Stilli) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili.
LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei PROGRAMMA PREVISTO Anno Scolastico 2006-2007 Testo di riferimento: "Le Vie della Fisica" vol. 1-2 (Battimelli - Stilli) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili.
Galileo Galilei. Pisa, 15 febbraio 1564 Arcetri, 8 gennaio 1642
 Galileo Galilei Pisa, 15 febbraio 1564 Arcetri, 8 gennaio 1642 Galileo intende sgomberare la via della scienza dagli ostacoli della tradizione Contro il Mondo di carta di Aristotele Contro l autorità ecclesiastica
Galileo Galilei Pisa, 15 febbraio 1564 Arcetri, 8 gennaio 1642 Galileo intende sgomberare la via della scienza dagli ostacoli della tradizione Contro il Mondo di carta di Aristotele Contro l autorità ecclesiastica
PIANO ANNUALE DI FISICA Classe III Liceo Classico sez. C A.S. 2018/2019
 Programmazione annuale di Fisica per le classi III A.S. 2018/2019 PIANO ANNUALE DI FISICA Classe III Liceo Classico sez. C A.S. 2018/2019 Docente Diana Trasatti Situazione iniziale della classe La classe,
Programmazione annuale di Fisica per le classi III A.S. 2018/2019 PIANO ANNUALE DI FISICA Classe III Liceo Classico sez. C A.S. 2018/2019 Docente Diana Trasatti Situazione iniziale della classe La classe,
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI - Verona Anno Scolastico
 PROGRAMMA PREVISTO Testo di riferimento: "L indagine del mondo fisico Vol. B (Bergamaschini, Marazzini, Mazzoni) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili. Le unità didattiche a fondo scuro
PROGRAMMA PREVISTO Testo di riferimento: "L indagine del mondo fisico Vol. B (Bergamaschini, Marazzini, Mazzoni) Le unità didattiche a fondo chiaro sono irrinunciabili. Le unità didattiche a fondo scuro
Notiamo che, per una massa che rotorivoluisca sull orbita senza scorrimento, per la componente giroscopica, con V n. v p
 Natura fisica ed espressione della forza di Lorentz, calcolo del campo magnetico nucleare Abbiamo visto che, se applichiamo il principio di conservazione del momento angolare nello spazio, se la massa
Natura fisica ed espressione della forza di Lorentz, calcolo del campo magnetico nucleare Abbiamo visto che, se applichiamo il principio di conservazione del momento angolare nello spazio, se la massa
Programmazione di Dipartimento Disciplina Asse Matematica e Fisica Fisica Scientifico-Tecnologico
 Programmazione di Dipartimento Disciplina Asse Matematica e Fisica Fisica Scientifico-Tecnologico PROGRAMMAZIONE CLASSE 3 LICEO SCIENTIFICO Competenze Abilità Conoscenze UdA Osservare, descrivere ed analizzare
Programmazione di Dipartimento Disciplina Asse Matematica e Fisica Fisica Scientifico-Tecnologico PROGRAMMAZIONE CLASSE 3 LICEO SCIENTIFICO Competenze Abilità Conoscenze UdA Osservare, descrivere ed analizzare
Astronomia Lezione 27/10/2016
 Astronomia Lezione 27/10/2016 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail: alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Sito web per le slides delle lezioni: oberon.roma1.infn.it/alessandro/astro2016 Astronomia Lezione
Astronomia Lezione 27/10/2016 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail: alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Sito web per le slides delle lezioni: oberon.roma1.infn.it/alessandro/astro2016 Astronomia Lezione
1 LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO G. Novello Via Giovanni XXIII Codogno P.O.F. Curricoli disciplinari Liceo Linguistico - Fisica
 1 FISICA classe terza Indicazioni nazionali ministeriali Competenze 1. OSSERVARE ED IDENTIFICARE FENOMENI 2. RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI DI FISICA E UTILIZZANDO STRUMENTI MATEMATICI CONOSCIUTI 3. AVERE
1 FISICA classe terza Indicazioni nazionali ministeriali Competenze 1. OSSERVARE ED IDENTIFICARE FENOMENI 2. RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI DI FISICA E UTILIZZANDO STRUMENTI MATEMATICI CONOSCIUTI 3. AVERE
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE LICEO SCIENZE APPLICATE SCIENZE NATURALI
 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE LICEO SCIENZE APPLICATE SCIENZE NATURALI CLASSE PRIMA 1. 1. Competenze: le specifiche competenze di base disciplinari previste dalla Riforma (Linee
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE LICEO SCIENZE APPLICATE SCIENZE NATURALI CLASSE PRIMA 1. 1. Competenze: le specifiche competenze di base disciplinari previste dalla Riforma (Linee
Gravità e moti orbitali. Lezione 3
 Gravità e moti orbitali Lezione 3 Sommario Brevi cenni storici. Le leggi di Keplero e le leggi di Newton. La forza di gravitazionale universale e le orbite dei pianeti. 2 L Universo Geocentrico La sfera
Gravità e moti orbitali Lezione 3 Sommario Brevi cenni storici. Le leggi di Keplero e le leggi di Newton. La forza di gravitazionale universale e le orbite dei pianeti. 2 L Universo Geocentrico La sfera
FONDAZIONE MALAVASI Scuola secondaria di 2 grado A. MANZONI Liceo Sportivo
 FONDAZIONE MALAVASI Scuola secondaria di 2 grado A. MANZONI Liceo Sportivo PIANO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINA: Scienze Naturali DOCENTE: Maria Giovanna Mosca CLASSE I SEZ. SPORTIVO A.S.2017
FONDAZIONE MALAVASI Scuola secondaria di 2 grado A. MANZONI Liceo Sportivo PIANO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINA: Scienze Naturali DOCENTE: Maria Giovanna Mosca CLASSE I SEZ. SPORTIVO A.S.2017
I.I.S. N. BOBBIO di CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S
 I.I.S. N. BOBBIO di CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S. 2016-17 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (Indirizzi Liceo scientifico tradizionale e sportivo) CLASSE: PRIMA (tutte le sezioni) COMPETENZE DI BASE
I.I.S. N. BOBBIO di CARIGNANO - PROGRAMMAZIONE PER L A. S. 2016-17 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (Indirizzi Liceo scientifico tradizionale e sportivo) CLASSE: PRIMA (tutte le sezioni) COMPETENZE DI BASE
I.S.I.S.S. Pacifici e De Magistris di Sezze Liceo scientifico Classe IV B. Corso di Filosofia Prof. Giancarlo Onorati
 I.S.I.S.S. Pacifici e De Magistris di Sezze Liceo scientifico Classe IV B Corso di Filosofia Prof. Giancarlo Onorati 1. La rivoluzione scientifica 2. La rivoluzione astronomica 3. Galileo Galilei 1. La
I.S.I.S.S. Pacifici e De Magistris di Sezze Liceo scientifico Classe IV B Corso di Filosofia Prof. Giancarlo Onorati 1. La rivoluzione scientifica 2. La rivoluzione astronomica 3. Galileo Galilei 1. La
Aristotele a. C.
 Aristotele 384-322 a. C. La differenza con Platone Platone: le idee sono separate dalla realtà Aristotele: le idee si trovano all interno degli oggetti L esempio dello Stato ideale Il problema dell essere
Aristotele 384-322 a. C. La differenza con Platone Platone: le idee sono separate dalla realtà Aristotele: le idee si trovano all interno degli oggetti L esempio dello Stato ideale Il problema dell essere
LEZIONE N. 13. Moti dei pianeti Un po di storia Keplero Orbite ellittiche
 LEZIONE N. 13 Moti dei pianeti Un po di storia Keplero Orbite ellittiche Mercoledì 7 Maggio 2014 Astronomia x Matematica - Lezione N. 13 2 Il moto errante di Marte Mercoledì 7 Maggio 2014 Astronomia x
LEZIONE N. 13 Moti dei pianeti Un po di storia Keplero Orbite ellittiche Mercoledì 7 Maggio 2014 Astronomia x Matematica - Lezione N. 13 2 Il moto errante di Marte Mercoledì 7 Maggio 2014 Astronomia x
Corso di Storia della Psicologia
 Corso di Storia della Psicologia Anno accademico 2017/18 Turno 1 Prof. Mauro Antonelli Presentazione del corso Ø Finalità del corso Ø Argomenti del corso Ø Bibliografia Ø Modalità d esame Finalità del
Corso di Storia della Psicologia Anno accademico 2017/18 Turno 1 Prof. Mauro Antonelli Presentazione del corso Ø Finalità del corso Ø Argomenti del corso Ø Bibliografia Ø Modalità d esame Finalità del
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
 ARGOMENTI SCIENZA MODERNA: DEFINIZIONE E CARATTERI SCIENZA MODERNA SCIENZA ANTICA: UN CONFRONTO ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA MODERNA LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA GALILEO GALILEI ED IL METODO SCIENTIFICO BACONE:
ARGOMENTI SCIENZA MODERNA: DEFINIZIONE E CARATTERI SCIENZA MODERNA SCIENZA ANTICA: UN CONFRONTO ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA MODERNA LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA GALILEO GALILEI ED IL METODO SCIENTIFICO BACONE:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità: Obiettivo dello studio della fisica è
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI Programmazione didattica annuale Materia: FISICA classi: PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO a.s. 2017/2018 Finalità: Obiettivo dello studio della fisica è
PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCIENZE NATURALI della classe 1 A Scienze applicate A.S Prof.ssa Pruna Simonetta
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCIENZE NATURALI della classe 1 A Scienze applicate A.S. 2014-15 Prof.ssa Pruna Simonetta La realizzazione del progetto educativo del percorso liceale richiede che nel primo biennio
PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCIENZE NATURALI della classe 1 A Scienze applicate A.S. 2014-15 Prof.ssa Pruna Simonetta La realizzazione del progetto educativo del percorso liceale richiede che nel primo biennio
 1 anno fisica -potenze di 10, equivalenze e notazione scientifica -misure ed incertezze -grandezze scalari e vettoriali e relative operazioni -esprimere il risultato di una misura e saper rappresentare
1 anno fisica -potenze di 10, equivalenze e notazione scientifica -misure ed incertezze -grandezze scalari e vettoriali e relative operazioni -esprimere il risultato di una misura e saper rappresentare
Le prove INVALSI del 2018 Novità e caratteristiche
 Le prove INVALSI del 2018 Novità e caratteristiche Anna Maria Ajello Presidente INVALSI Roma, MIUR - 5 luglio 2018 Le novità Introduzione della prova di Inglese (grado 5 e 8) Prove al computer (CBT: grado
Le prove INVALSI del 2018 Novità e caratteristiche Anna Maria Ajello Presidente INVALSI Roma, MIUR - 5 luglio 2018 Le novità Introduzione della prova di Inglese (grado 5 e 8) Prove al computer (CBT: grado
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE
 ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SUPERIORE G.V. GRAVINA CROTONE PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE Anno Scolastico 2010/2011 MATERIA D INSEGNAMENTO SCIENZE DELLA TERRA CLASSE I SEZ. A Liceo delle Scienze Umane opzione
ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SUPERIORE G.V. GRAVINA CROTONE PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE Anno Scolastico 2010/2011 MATERIA D INSEGNAMENTO SCIENZE DELLA TERRA CLASSE I SEZ. A Liceo delle Scienze Umane opzione
Se torturate abbastanza i dati, essi confesseranno. T. Mayer, 1980
 Se torturate abbastanza i dati, essi confesseranno T. Mayer, 1980 IL FALSIFICAZIONISMO DI POPPER Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni
Se torturate abbastanza i dati, essi confesseranno T. Mayer, 1980 IL FALSIFICAZIONISMO DI POPPER Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni
Marco Panareo. Appunti di Fisica. Meccanica e Termodinamica. Università degli Studi del Salento, Facoltà di Ingegneria
 Marco Panareo Appunti di Fisica Meccanica e Termodinamica Università degli Studi del Salento, Facoltà di Ingegneria ii iii INTRODUZIONE Questa raccolta di appunti originati dalle lezioni di Fisica Generale
Marco Panareo Appunti di Fisica Meccanica e Termodinamica Università degli Studi del Salento, Facoltà di Ingegneria ii iii INTRODUZIONE Questa raccolta di appunti originati dalle lezioni di Fisica Generale
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof. Rossi Manuela A.S. 2015/2016 CLASSE: 1ALL MATERIA: Scienze Naturali
 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof. Rossi Manuela A.S. 2015/2016 CLASSE: 1ALL MATERIA: Scienze Naturali Modulo n.1 - Introduzione alle scienze: il metodo scientifico e misure e grandezze. Collocazione temporale:
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof. Rossi Manuela A.S. 2015/2016 CLASSE: 1ALL MATERIA: Scienze Naturali Modulo n.1 - Introduzione alle scienze: il metodo scientifico e misure e grandezze. Collocazione temporale:
Cap. 4 del manuale La natura e i suoi modelli
 Cap. 4 del manuale La natura e i suoi modelli Confrontiamo i seguenti enunciati: 1. Tutte le volte che Luigi va a Parigi, piove. 2. I metalli, se scaldati, si dilatano. Quale delle due generalizzazioni
Cap. 4 del manuale La natura e i suoi modelli Confrontiamo i seguenti enunciati: 1. Tutte le volte che Luigi va a Parigi, piove. 2. I metalli, se scaldati, si dilatano. Quale delle due generalizzazioni
Logica e filosofia della scienza (P) 6 CFU
 Logica e filosofia della scienza (P) 6 CFU Anno Accademico 2010-2011 Corso di laurea in Scienze della comunicazione Ivan Valbusa ivan.valbusa@univr.it Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Logica e filosofia della scienza (P) 6 CFU Anno Accademico 2010-2011 Corso di laurea in Scienze della comunicazione Ivan Valbusa ivan.valbusa@univr.it Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Bagnasco, Barbagli, Cavalli, Corso di sociologia, Il Mulino, 2007 Capitolo IX. Scienza e tecnica. Scienza e tecnica
 Scienza e tecnica 1 La scienza è l attività umana orientata in modo primario e sistematico alla conoscenza, cioè alla descrizione e spiegazione degli eventi, sia singolari sia ricorrenti, del mondo naturale
Scienza e tecnica 1 La scienza è l attività umana orientata in modo primario e sistematico alla conoscenza, cioè alla descrizione e spiegazione degli eventi, sia singolari sia ricorrenti, del mondo naturale
3.2. Falsificabilità e Tesi di Duhem
 compatibilità con altre fonti storiche e, in generale, con altre parti del Mondo 3. Ora, supponiamo che F venga confutata, in quanto incompatibile con altre fonti, o con altre componenti del Mondo 3 meglio
compatibilità con altre fonti storiche e, in generale, con altre parti del Mondo 3. Ora, supponiamo che F venga confutata, in quanto incompatibile con altre fonti, o con altre componenti del Mondo 3 meglio
La fisica alla fine dell 800
 La fisica alla fine dell 800 Alla fine del 1800 tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità interpretata da Newton (1686) L elettromagnetismo espresso
La fisica alla fine dell 800 Alla fine del 1800 tutti i fenomeni naturali si spiegano tramite l azione di due forze fondamentali: La forza di gravità interpretata da Newton (1686) L elettromagnetismo espresso
Che cos'è una teoria?
 Una teoria è: Che cos'è una teoria? un sistema di riferimento, una mappa mentale, uno schema concettuale che cerca di organizzare e spiegare i fenomeni in termini di principi generale o di leggi. Una teoria
Una teoria è: Che cos'è una teoria? un sistema di riferimento, una mappa mentale, uno schema concettuale che cerca di organizzare e spiegare i fenomeni in termini di principi generale o di leggi. Una teoria
Logica filosofica. L induzione
 Logica filosofica L induzione Definizione L induzione si può definire come un modo di ragionare che, partendo da molti casi singolari, si aggiunge ad una conclusione generale. La deduzione si può definire
Logica filosofica L induzione Definizione L induzione si può definire come un modo di ragionare che, partendo da molti casi singolari, si aggiunge ad una conclusione generale. La deduzione si può definire
Che cos è una teoria scientifica?
 Temi filosofici dell ingegneria e della scienza/informatica B[1] Politecnico di Milano, II Facoltà di ingegneria, a.a. 2009-10 Che cos è una teoria scientifica? Viola Schiaffonati Dipartimento di elettronica
Temi filosofici dell ingegneria e della scienza/informatica B[1] Politecnico di Milano, II Facoltà di ingegneria, a.a. 2009-10 Che cos è una teoria scientifica? Viola Schiaffonati Dipartimento di elettronica
BACONE SIR FRANCIS BACON (LONDRA ) FONTI ABBAGNANO FORNERO MASSARO LA VERGATA TRABATTONI
 BACONE SIR FRANCIS BACON (LONDRA 1561-1626) FONTI ABBAGNANO FORNERO MASSARO LA VERGATA TRABATTONI LA SCIENZA AL SERVIZIO DELL UOMO AVEVA PROGETTATO UN ENCICLOPEDIA DEL SAPERE CHE AVREBBE RINNOVATO COMPLETAMENTE
BACONE SIR FRANCIS BACON (LONDRA 1561-1626) FONTI ABBAGNANO FORNERO MASSARO LA VERGATA TRABATTONI LA SCIENZA AL SERVIZIO DELL UOMO AVEVA PROGETTATO UN ENCICLOPEDIA DEL SAPERE CHE AVREBBE RINNOVATO COMPLETAMENTE
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PUL ISTITUTO PASTORALE A.A
 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE - 60187 PUL ISTITUTO PASTORALE A.A. 2015-2016 MARCO ACCORINTI PRIMA PARTE 2 TEMI E TEMATICHE AFFRONTATE Disegno di una ricerca, Paradigmi di ricerca sociale, Osservazione
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE - 60187 PUL ISTITUTO PASTORALE A.A. 2015-2016 MARCO ACCORINTI PRIMA PARTE 2 TEMI E TEMATICHE AFFRONTATE Disegno di una ricerca, Paradigmi di ricerca sociale, Osservazione
Classe II A (SCIENZE APPLICATE)
 PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE A.S.2018/2019 Classe II A (SCIENZE APPLICATE) Prof. TUCCI Clemente Marco ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE La classe composta da 17 alunni si presenta vivace ma corretta
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE A.S.2018/2019 Classe II A (SCIENZE APPLICATE) Prof. TUCCI Clemente Marco ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE La classe composta da 17 alunni si presenta vivace ma corretta
Che cos è la filosofia analitica?
 Che cos è la filosofia analitica? Sascia Pavan sascia.pavan@gmail.com 31 marzo 2011 Sommario 1 Introduzione I padri fondatori Logica matematica 2 La filosofia analitica prima maniera: dalle origini agli
Che cos è la filosofia analitica? Sascia Pavan sascia.pavan@gmail.com 31 marzo 2011 Sommario 1 Introduzione I padri fondatori Logica matematica 2 La filosofia analitica prima maniera: dalle origini agli
Filosofia della scienza
 Filosofia della scienza Anno Accademico 2009-2010 Corso di laurea in programmazione e gestione dei servizi formativi Ivan Valbusa ivan.valbusa@univr.it Dipartimento di Filosofia Università degli Studi
Filosofia della scienza Anno Accademico 2009-2010 Corso di laurea in programmazione e gestione dei servizi formativi Ivan Valbusa ivan.valbusa@univr.it Dipartimento di Filosofia Università degli Studi
). 1 ; ) &.,<=$ &'+! ', ') )() -(,'*+.(,,,)/ 0,,')+ 1+' ', 0 )02! )/4)+ '' '00 ' &!0 -,( +,) '(( ' ! 8+),+7+ )!
 !"#$%% & '()*!"!#"$"" &'+! ', ') )() -(,'*+.(,,,)/ 0,,')+ +' ', 0 )02!3 0 0 - )/4)+ '' '00 ' &!0 -,( +,) '(( '2+ 05+6 7+! 8+),+7+ )! -)/,-0 ) 6 %"$!"& '($""'!%"!%"!")*")*""+!, &$'!"&- ) 7+) +8 0!'2 *&"$'!"&-
!"#$%% & '()*!"!#"$"" &'+! ', ') )() -(,'*+.(,,,)/ 0,,')+ +' ', 0 )02!3 0 0 - )/4)+ '' '00 ' &!0 -,( +,) '(( '2+ 05+6 7+! 8+),+7+ )! -)/,-0 ) 6 %"$!"& '($""'!%"!%"!")*")*""+!, &$'!"&- ) 7+) +8 0!'2 *&"$'!"&-
RICHIAMI DELLA FISICA DI BASE. 2) I temi fondamentali della fisica classica e della fisica moderna.
 PROGRAMMA di FISICA CLASSE 3^ A 3^F AS 2017-18 ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: Al fine del raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati scelti i seguenti argomenti: RICHIAMI DELLA FISICA DI BASE 1)
PROGRAMMA di FISICA CLASSE 3^ A 3^F AS 2017-18 ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: Al fine del raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati scelti i seguenti argomenti: RICHIAMI DELLA FISICA DI BASE 1)
mio indirizzo 1 Sarò lieto di ricevere commenti o segnalazioni di errori presso il
 INTRODUZIONE Purtroppo questo libro è rappresentato molto più dal sottotitolo che dal titolo. Infatti è una semplice trascrizione di miei appunti per vari corsi di logica che ho tenuto in passato all Università
INTRODUZIONE Purtroppo questo libro è rappresentato molto più dal sottotitolo che dal titolo. Infatti è una semplice trascrizione di miei appunti per vari corsi di logica che ho tenuto in passato all Università
Competenze Abilità Conoscenze
 CLASSI: TERZE fondamentali della disciplina acquisendo consapevolmente il suo valore culturale, la sua epistemologica. fenomeni. strumenti matematici del suo percorso didattico. * Avere consapevolezza
CLASSI: TERZE fondamentali della disciplina acquisendo consapevolmente il suo valore culturale, la sua epistemologica. fenomeni. strumenti matematici del suo percorso didattico. * Avere consapevolezza
4.3. Altri aspetti della metodologia bayesiana
 va assegnata probabilità 0 (per una breve introduzione storica al probabilismo, culminante nel bayesianesimo, si veda Morini, 2003). 4.3. Altri aspetti della metodologia bayesiana Oltre a fornire un criterio
va assegnata probabilità 0 (per una breve introduzione storica al probabilismo, culminante nel bayesianesimo, si veda Morini, 2003). 4.3. Altri aspetti della metodologia bayesiana Oltre a fornire un criterio
Elementi di Meccanica Celeste
 Elementi di Meccanica Celeste 2015-2016 1a lezione 23 Settembre 2015: Presentazione dettagliata del programma del corso, del metodo didattico e delle modalità d esame Lista degli studenti interessati e
Elementi di Meccanica Celeste 2015-2016 1a lezione 23 Settembre 2015: Presentazione dettagliata del programma del corso, del metodo didattico e delle modalità d esame Lista degli studenti interessati e
Modellazione di sistemi ingegneristici (parte 1 di 2)
 Corso di Teoria dei Sistemi Modellazione di sistemi ingegneristici (parte 1 di 2) Prof. Ing. Daniele Testi DESTeC, Dipartimento di Ingegneria dell Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
Corso di Teoria dei Sistemi Modellazione di sistemi ingegneristici (parte 1 di 2) Prof. Ing. Daniele Testi DESTeC, Dipartimento di Ingegneria dell Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 FILOSOFIA DELLA SCIENZA a.a 2017/18 Testi per l esame: S. Okasha, Il primo libro di filosofia della scienza, Einaudi, 2006 (o ed. succ.), capp. 1, 2, 3, 5, 7; P. Greco, N. Pitrelli, Scienza e media ai
FILOSOFIA DELLA SCIENZA a.a 2017/18 Testi per l esame: S. Okasha, Il primo libro di filosofia della scienza, Einaudi, 2006 (o ed. succ.), capp. 1, 2, 3, 5, 7; P. Greco, N. Pitrelli, Scienza e media ai
Il movimento. Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani
 Il movimento Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GIOSTRA 11 MOTO ARMONICO LINK 12
Il movimento Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GIOSTRA 11 MOTO ARMONICO LINK 12
Anno scolastico 2016/17. Piano di lavoro individuale ISS BRESSANONE-BRIXEN LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ITE. Classe: V liceo linguistico
 Anno scolastico 2016/17 Piano di lavoro individuale ISS BRESSANONE-BRIXEN LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ITE Classe: V liceo linguistico Insegnante: Prof. Nicola Beltrani Materia: Fisica ISS BRESSANONE-BRIXEN
Anno scolastico 2016/17 Piano di lavoro individuale ISS BRESSANONE-BRIXEN LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ITE Classe: V liceo linguistico Insegnante: Prof. Nicola Beltrani Materia: Fisica ISS BRESSANONE-BRIXEN
SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
 ISTITUTO PARITARIO GARDEN HOUSE PROGETTO DI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Percorso didattico scientifico / Astronomico SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA : L universo con gli occhi di un bambino La costruzione
ISTITUTO PARITARIO GARDEN HOUSE PROGETTO DI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Percorso didattico scientifico / Astronomico SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA : L universo con gli occhi di un bambino La costruzione
