Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista
|
|
|
- Virginio Messina
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d Aquino Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista Rev. Prof. Emeritus Reginaldo M. Pizzorni O.P. Pontificia Università Lateranense, Roma (Italia) Fra i tanti titoli che hanno onorato S. Tommaso d Aquino ( ), credo che uno dei migliori sia quello dato da Giovanni Paolo II (n. 1920, Papa 1978 f.r.) di Doctor Humanitatis, il 13 settembre Infatti, come egli dice: La base del suo atteggiamento, comprensivo verso tutti, senza mancare di essere schiettamente critico, ogni volta che sentiva di doverlo fare, e lo fece coraggiosamente in molti casi, sta nella concezione stessa della verità. Licet sint multae veritates participatae est una sapientia absoluta supra omina elevata, scilicet sapientia divina, per cuius partecipationem omnes sapientes sunt sapientes (Super Job, lect. I, n. 33). Questo metodo realistico e storico, fondamentalmente ottimistico e aperto, fa di San Tommaso non soltanto il Doctor Communis Ecclesiae come lo chiama Paolo VI, nella sua bella lettera Lumen Ecclesiae ma il Doctor Humanitatis, perché è sempre pronto e disponibile a recepire i valori umani di tutte le culture. A buon diritto l Angelico può affermare: Veritas in seipsa fortis est et nulla impugnatione convellitur (C. Gent., III, c.10, n. 3460). 1 Contro tutte le accuse fatte a S. Tommaso, come alla dottrina cristiana di essere disumana, di non tener conto dei valori umani, dobbiamo affermare che proprio con la dottrina cristiana si è avuta la prima e piena affermazione della dignità della persona umana, Immagine di Dio, Icona di Dio, non solo existens, ma existens per se, in se, e soprattutto propter se e, in quanto libera, è causa sui, 2 1 Giovanni Paolo II, Discorso in occasione dell VIII Congresso Tomistico Internazionale, Castelgandolfo 13 settembre 1980, in Atti del Congresso su L Enciclica Aeterni Patris (8-12 settembre 1980), Studi Tomistici n. 10, Pont. Accademia di s. Tommaso, Città del Vaticano 1981, vol. I, pp S. Tommaso d Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. I, a. 83: Liberum est quod est causa sui. Copyright 2003 INSTITUTO UNIVERSITARIO VIRTUAL SANTO TOMÁS Fundación Balmesiana Universitat Abat Oliba CEU
2 R. M. PIZZORNI, Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista principio del suo agire interiore, 3 fine del proprio agire, 4 per cui l uomo è provvidenza per sé e per gli altri, 5 e S. Tommaso è stato sempre pronto e disponibile a recepire i valori umani di tutte le culture. 6 Riguardo alla dottrina cristiana ricordiamo che la Chiesa può intervenire su questi problemi a pieno titolo, proprio perché ha la migliore dottrina dell uomo, è esperta in umanità, 7 in quanto solo Cristo ha svelato pienamente l uomo all uomo ; 8 si tratta, in fondo, nota Maritain ( ), di sapere chi ha dell uomo un immagine fedele e chi un immagine sfigurata. 9 Ora la dottrina cristiana ha posto per prima il concetto della priorità dell individuo di fronte allo Stato, come centro di valore, cioè che ogni uomo è persona, soggetto di diritti e di doveri, concetto del tutto ignorato nel mondo antico e che è tornato a riemergere come guida di ogni organizzazione sociale-politica, in quanto riconoscimento del valore autonomo dell uomo, della sua nativa e indeclinabile affermazione della libertà e della sua dignità morale e sacra in quanto persona e figlio di Dio, creato a sua immagine e somiglianza, e redento dal sacrificio di Cristo, per cui non vi sono più né Ebrei né Gentili, né padroni né schiavi: tutti gli uomini sono fratelli in quanto tutti figli di Dio, come dice S. Paolo: Non c è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti siete un sol uomo in Cristo Gesù. 10 Allora, all interno della comunità cristiana non hanno più rilevanza le peculiari differenze etniche (Giudeo o Greco), sociali (liberi o schiavi), perfino sessuali (uomo o donna): tutti ormai hanno lo stesso valore, la stessa dignità, la stessa uguaglianza, quella che deriva loro dal costituire in Cristo e per Cristo il popolo della nuova alleanza, erede delle promesse fatte ad Abramo. Forse noi oggi non abbiamo presente la novità di questa affermazione paolina, che poneva fine a numerosi privilegi, religiosi per i Giudei, politici per i cittadini, sociali per gli uomini. Con la venuta di Cristo l umanità non è più divisa in gruppi antagonistici, ma si caratterizza per una perfetta uguaglianza di diritto fra tutti gli esseri umani, e per la fine della tirannia dello stato sociale, 3 S.Th., I-II, q. I, a. 1: Principium radicale ab intus procedens. 4 Cf. S.Th. I-II, prol. 3; In Joan., c. 15, lect. 3, n. 2015: Nam liber propter se operator sicut propium finem, et a se quia propria voluntate movetur ad opus. 5 S.Th., I-II, q. 91, a. 2: [Homo] ipse est sibi providens; sibi ipsi et aliis providens ; cf. C. Gent., III, cc. 81 e Giovanni Paolo II, Discorso, cit., p Paolo VI, Discorso all Assemblea delle Nazioni Unite, (4 ottobre 1965), in Insegnamenti di Paolo VI, vol. III, p. 508, tr. it., p Giovanni Paolo II, Encicl. Redemptor hominis (4 marzo 1979), n J. Maritain, Introduzione a AA.VV., Dei diritti dell uomo, Milano 1952, p Gal 3,28: Non est Judeus, neque Graecus, non est servus, neque liber, non est masculus, neque femina: omnes enim vos unum estis in Christo Jesu. p. 2
3 Congresso Tomista Internazionale politico, economico o religioso, come mezzo di affermazione o di riconoscimento: Pensare che secondo il rabbi Yehuda (sec. III) si devono recitare ogni giorno queste tre benedizioni: Benedetto Colui che non mi ha fatto goy (pagano), né donna, né ignorante, perché i goyim non sono niente davanti a te, perché la donna non è tenuta a osservare i comandamenti, perché gli ignoranti non hanno paura di peccare. 11 E i maestri di Israele dicevano che era preferibile bruciare le parole della Legge piuttosto che perdere tempo a insegnarle alle donne. Riguardo poi a quel passo di S. Paolo è interessante notare anche quello che riporta Diogene Laerzio (III sec. d.c.) nelle sue Vite dei filosofi, 12 dove parlando di Talete ( a.c.) dice che Ermippo (III-II sec. a.c.) nelle sue Vite attribuisce a quel filosofo ciò che da alcuni è detto di Socrate ( a.c.): Si tramanda che era solito dire di essere grato alla Sorte per questi tre motivi: primo perché nacqui uomo e non bestia; secondo perché uomo e non donna; terzo perché greco e non barbaro. Anche Plutarco (46-125) nella Vita Marii 13 dice che Platone ( a.c.) soleva dire che ringraziava la natura, primo, perché era nato uomo e non animale muto; secondo, perché maschio e non femmina; poi, perché greco e non barbaro, e, infine anche perché era nato ateniese e ai tempi di Socrate. Questo testo è riportato anche da Lattanzio (IV sec.). Per i Greci e i Romani, quindi, l uomo valeva più in quanto cittadino greco o romano, libero e maschio, e non in quanto essere umano; in pratica valeva più l aggettivo greco, romano, libero e maschio che il sostantivo uomo. Ora la grandezza e la centralità dell essere umano èproprio nel riconoscimento e nella tutela di questa dignità dell uomo in quanto uomo, che è stata rivelata in pieno dal Cristianesimo: Ricordati, o cristiano, la tua dignità, e divenuto partecipe della natura divina, non tornare con vita degenere all antica bassezza. Ricordati di quale capo e di quale corpo sei membro Testo citato da D. Marguerat, Saint Paul contre les femmes? Essor et déclin de la femme chrétienne au premier siècle, in Le Dieu des premiers chrétiens, Ginevra 1990, pp ; cf. G. Theissen, Valeur et statut de l être humain au sens du christianisme, in Histoire sociale du Christianisme primitif, Ginevra 1996, pp , tr. it., Sociologia del cristianesimo primitivo, Genova 1997; P. Debergé, Inchiesta sul potere. Approccio biblico e teologico, tr. it. Milano 2000, pp Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, tr. it., a cura di M. Gigante, Bari 1975, p Plutarco, Vita Marii, S. Leone Magno, Sermo I de Nativitate Domini; PL, LIV, Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divinae consors factus naturae, noli in veteram vilitatem degeneri conversatione redire. Memento cuius capitis et cuius corporis sis membrum. p. 3
4 R. M. PIZZORNI, Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista Vogliamo inoltre ricordare anche la Lettera di S. Paolo a Filemone che affronta il problema della schiavitù. Lo schiavo era sempre una cosa (res) del padrone, priva di diritto singolo, e rientrava nei beni del padrone che poteva disporne a suo piacimento. S. Paolo vuole trasformare questi rapporti tra schiavo e padrone all interno di questo ordine stabilito, insegnando a vedere anche nello schiavo il fratello, di uguale grandezza morale e dignità del Signore, e a ridare una personalità allo schiavo anche sul piano dei beni spirituali. La emancipazione di questo sterminato gregge di schiavi si doveva fare prima negli spiriti, quindi sarebbe venuto anche nella prassi e nelle leggi civili. E proprio, infatti, del lievito cristiano non agire per la rivoluzione ma per lenta e interiore trasformazione. Così la comune uguaglianza spirituale cristiana di Filemone (il padrone) e di Onesimo (lo schiavo) innescava nella storia del mondo pagano una dialettica nuova circa la carta dei diritti dell uomo, che doveva naturalmente condurre alla graduale abolizione della schiavitù. 15 Il Cristianesimo quindi non organizzò rivoluzioni contro la schiavitù, ma creò le premesse e l ambiente favorevole perché fosse nel tempo eliminata dalla società, predicando i principi evangelici di uguaglianza, fratellanza e carità. In un epoca in cui lo sforzo manuale umano era la sorgente principale dell energia, la schiavitù non veniva considerata contraria ai diritti dell uomo, e anche i cristiani dell epoca non potevano neppure immaginare un altro sistema economico. Ecco perché all inizio la Chiesa ha trattato il problema della schiavitù non sul piano politico dei diritti civili dell uomo, non condannandola come istituzione sociale, ma su quello della morale solo a livello interpersonale. Solo in un epoca più tarda per la stessa esigenza etica ha potuto e dovuto tradursi in termini sociali e giuridici. Da questa nuova concezione dell uomo e dei suoi diritti è sorto anche un nuovo diritto naturale che possiamo giustamente chiamare diritto naturale cristiano, termine questo che indica una intera visione della filosofia e anche della vita pratica, riconosce il diritto come giustizia (ius quia iustum, non ius quia iussum), ed esprime un affermazione originaria di libertà, che si connette a un ordine di doveri che ha le radici ultime in Dio e nel Dio cristiano. 16 Risulta quindi evidente che, in fondo, la dottrina dei diritti dell uomo trova la sua 15 Cf. Philem 10,15-16: Obsecro te ut illum reciperes, iam non ut servum, sed pro servo charissimum fratrem, maxime mihi, quanto autem magis tibi, et in carne, et in Domino ; cf. M. Sordi, Paolo a Filemone o Della Schiavitù, Milano 1987; S. Cipriani, Le Lettere di Paolo, Assisi 1991, pp ; A. Léonard, Il fondamento della morale. Saggio di etica filosofica, tr. it., Cinisello Balsamo (MI) 1990, pp ; G. Ferrari, La Lettera a Filemone e libertà nel mondo greco, romano e cristiano, Salerno Cf. G. Ambrosetti, Diritto naturale e cristiano, Milano p. 4
5 Congresso Tomista Internazionale ispirazione originaria possa piacere o meno in quella antropologia che affonda le sue radici nella rivelazione cristiana. Il cristianesimo ha così il duplice merito di aver affermato per primo il valore assoluto dell uomo, di ogni uomo, e di aver introdotto il concetto di persona, ignoto alla cultura pagana, per designare tutte quelle realtà che hanno in se stesse un valore assoluto. La cultura pagana greco-romana non riconosceva il valore assoluto dell individuo in quanto tale, ma faceva dipendere il suo valore esclusivamente dal ceto, dal sesso, dalla razza. Grazie a questo concetto rivoluzionario di persona un essere dotato di dignità infinita e di un valore assoluto e che fa di tutti gli uomini delle immagini di Dio, i filosofi cristiani, specialmente con S. Tommaso, come vedremo, potranno sviluppare, al posto dell umanesimo aristocratico e razzista dei pagani, un umanesimo veramente universale. Giustamente quindi Croce ( ) ha potuto dire che il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l umanità abbia mai compiuta In tutti essi [gli uomini] si desidera quel proprio accento che ci accomuna e ci affratella, e che il cristianesimo ha dato esso solo alla vita umana B. Croce, Perché non possiamo dirci cristiani, in La Critica, 20 settembre 1942; estratto, Bari 1944, pp. 5, 7. Questo saggio fu scritto in polemica con B. Russell ( ) e il suo saggio Perché non sono cristiano (Londra 1927, tr. it., Milano 1962) nel quale dichiara di non essere cristiano perché non crede in Dio e nell immortalità, e ritiene che Cristo non è stato altro che un uomo eccezionale (p. 14), anche se sotto certi aspetti Budda e Socrate gli appaiono molto superiori (p. 25). Inoltre Russell ricorda che in ogni tempo si è manifestata una ferma opposizione da parte della Chiesa contro ogni forma di progresso in campo morale e umanitario, per cui può affermare che il cristianesimo, così come è organizzato, è stato ed è tuttora il più grande nemico del progresso morale del mondo (p. 26). Di conseguenza chiunque abbia un poco di cervello, e non sia annebbiato da dogmi, deve riconoscere quanto iniqui siano certi rigori (p. 27) della Chiesa nel campo morale. La Chiesa quindi ha ritardato il progresso (p. 26). Così, mentre Russell si ferma a constatare quello che per lui era il superamento storico del cristianesimo nella civiltà moderna e sottolineava gli errori e i peccati del cristianesimo, Croce assume come metro di giudizio i valori morali affermatisi nel corso della vicenda umana. Il cristianesimo ha elaborato principi e valori che fanno ormai parte strutturalmente del modo di essere e di pensare dell uomo, che hanno agito nella genesi dello spirito moderno e non sono certo un passato inerte. Notiamo inoltre che una decina di anni dopo l articolo di Croce, Ugo Spirito ( ) scriveva un libro dal titolo La vita come amore, e vi poneva come sottotitolo Il tramonto della civiltà cristiana (Firenze 1953), pretendendo dimostrare come il cristianesimo nonostante la sua più profonda esigenza, non sia riuscito a essere una concezione della vita come amore. Infatti, per Ugo Spirito, per poter amare occorre una acrisia assoluta, cioè eliminare la dualità e opposizione di bene e male, e conseguentemente il giudizio di valore da cui l opposizione è espressa. Per amare non p. 5
6 R. M. PIZZORNI, Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista Anche per S. Tommaso l uomo ha valore di per sé, e questa sua dignità scaturisce dalla creazione dell uomo a immagine di Dio e della redenzione operata dal sacrificio di Cristo: da qui il valore irripetibile e unico di ogni essere umano senza distinzione alcuna. Di conseguenza, l ordinazione verso la società, di cui l uomo è parte, è relativa, secundum quid, e perciò la persona non può essere assorbita tutta dalla società proprio per la sua peculiare e alta dignità umana che consiste nell essere liberi e nell esistere per se stessi ; 18 in quanto l uomo attraverso la sua volontà libera ed efficace è padrone di se stesso. 19 Di conseguenza, secondo la bella definizione di S. Tommaso, e credo non si possa dire nulla di più grande dell uomo, la persona [rationalis naturae individua substantia] 20 significa quanto c è di più perfetto o nobile (id quod est perfectissimum) in tutto l universo, e aggiunge che è una grande dignità (magnae dignitatis) sussistere come soggetto di natura ragionevole, 21 cioè esiste in sé e per sé ; di qui la sua altissima dignità. E ci piace qui ricordare anche quello che si legge nel Salmo VIII, ove non è detto che Dio ha fatto l uomo superiore agli altri esseri, ma: lo hai fatto per poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore: e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. 22 Da notare inoltre che nel testo ebraico si legge meelohim, ossia: di poco inferiore a Dio. Si tratta però di un iperbole per indicare che l uomo dotato di intelligenza e di volontà è fatto a immagine e somiglianza con Dio. 23 si deve più distinguere tra peccatore da amare e peccato da odiare, come vuole la dottrina cristiana; così entrerebbe il logos, il giudizio che distrugge l agape, l amore. 18 S.Th., II-II, q. 64, a. 2, ad 3: Homo peccando ab ordine rationis recedit: et ideo decidit a digitate humana, prout scilicet homo est naturaliter liber et propter seipsum existens. 19 S.Th., II-II, q. 64, a. 5, ad 3: Homo constituitur dominus sui ipsius per liberum arbitrium. 20 S. Boezio, De duabus naturis, c. 3; PL, LXIV, 1343; cf. S. Tommaso, S.Th., I, q. 29, a S.Th., I, q. 29, a. 3 e ad 2: Persona significati d quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura ; Magnae dignitatis est in rationali creatura subsistere. 22 Ps 8,6: Minuisti eum paulo minus ab angelis; gloria et honore coronasti eum; et constituisti eum super omnia opera manuum tuarum. 23 Notiamo che in greco la parola persona (, letteralmente ciò che è posto dinanzi agli occhi, quindi vuol dire viso, faccia, volto), indicava la maschera che gli attori teatrali ponevano sul loro volto e che variava secondo i personaggi che dovevano rappresentare. Il primo che introdusse il concetto di persona in filosofia fu lo storico Epitteto (50-139). Anche in latino persona (da per sonum, cioè far passare la voce attraverso la maschera) indicava la maschera con cui gli attori comunicavano con il pubblico, e denotava il suo ruolo nell azione scenica. Nel diritto romano persona p. 6
7 Congresso Tomista Internazionale Per questo, come ci ricorda il Concilio Vaticano II (11 ottobre dicembre 1965), Principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana. 24 Di qui il limite dell autorità statale e del diritto positivo, che essendo ordinamento della comunità umana, non può essere diritto e perde il suo carattere giuridico quando si volga contro le stesse persone umane che costituiscono la comunità, perché perde la sua funzione essenziale, la sua legittimità e la sua giustificazione finalistica. Ora, riguardo a S. Tommaso, potrebbe far sorgere una certa difficoltà il testo nel quale dice: Totus homo ordinatur ut ad finem ad totam communitatem cuius es pars. 25 Certamente egli non pensa che l uomo sia solamente parte e organo della società, ma vuol dire che esso è subordinato alla società in quanto ne è parte ed organo, e quando celebra l indipendenza dell individuo, non gli concede il diritto alla piena autarchia od anarchia, ma lo riconosce indipendente solo in quanto portatore di quei valori che eccedono la società. indicava colui che in virtù di un nome era riconoscibile e poteva svolgere il proprio ruolo nella società. Notiamo, inoltre, che proprio il cristianesimo ha creato una nuova dimensione dell uomo: quella della persona umana. Tale nozione era così estranea al razionalismo classico che i padri greci non erano capaci di trovare nella filosofia greca le categorie e le parole per esprimere questa nuova realtà. Il pensiero ellenico non era in grado di concepire che l infinito e l universale potessero esprimersi in una persona (R. Garaudy, Qu est-ce que la morale marxiste?, Paris 1963, p. 63). Infatti, sia in greco che in latino, fino a Tertulliano, il significato che si dava al termine persona era quello di maschera, oppure di volto. Il concetto di persona, come lo intendiamo noi oggi, non c era affatto nella cultura pagana. L uomo antico è assorbito dalla città e dalla famiglia sottoposto a un destino cieco, senza nome, superiore agli stessi dei. L istituto della schiavitù non offende gli spiriti più nobili di quei tempi. I filosofi non prendono in considerazione se non il pensiero impersonale, il cui ordine immobile regola la natura come le idee. La comparsa del singolare è come un incrinatura nella natura e nella coscienza. Il cristianesimo in mezzo a incertezze porta all improvviso una nozione della persona. Non sempre si comprende oggi lo scandalo che essa costituì per il pensiero e la sensibilità greca (E. Mounier, Il personalismo, tr. it., Roma 1966, p. 16). Cf. Editoriale, Difendere e promuovere la dignità della persona umana, in La Civiltà cattolica, CXLIII (7 novembre 1992), IV, pp ; O. Bucci, La formazione del concetto di persona nel Cristianesimo delle origini: Avventura semantica e itinerario storico, in Lateranum, LIV (1988), II, pp : C. Sepe, Persona e storia. Per una teologia della persona, Cinisello Balsamo (MI) La Chiesa e il mondo contemporaneo (Gaudium et Spes), nn ; cf. J. Courtney Murray, Noi crediamo in queste verità, tr. it., Brescia 1965, pp S.Th., II-II, q. 65, a. 1: Ipse totus homo ordinatur ut ad finem ad totam communitatem cuius est pars. p. 7
8 R. M. PIZZORNI, Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista Infatti, la persona umana non è pars propter totum (lo Stato) perché lo Stato è ordinato al bene della persona: Societas pro persona, e non persona pro societate. Perciò, tutto quello che appartiene all uomo, e quindi anche all essere membro della società, è ordinato alla vita dell uomo e si deve giudicare in ordine a lui, 26 perché l uomo non cerca la società per la vita, che già possiede, ma per una vita migliore. La società non è un tutto sostanziale, fuori del quale le parti non avrebbero nessun valore; ma un tutto integrale in cui l uomo entra a far parte per conseguire quel bene esse (benessere) o bene vivere, 27 quella prosperità, quella sufficientia vitae, che nell isolamento sarebbe impossibile. Quindi, se come semplice cittadino, l uomo fa parte della società e deve rispettarne le leggi, come persona umana è il fine della società, che esiste per lui come necessaria al suo perfezionamento e mezzo della sua libertà. Di conseguenza, l uomo è sì nello Stato e si riferisce all intera comunità come la parte al tutto : sicut pars ad totum, 28 ma non è tutto e totalmente dello Stato. 26 S.Th., II-II, q. 65, a. 1, ad 2: Totius hominis vita non ordinatur ad aliquid proprium ipsius hominis: sed ad ipsam potius omnia quae sunt hominis ordinatur ; ibidem, I-II, q. 21, a. 2, ad 2: In moralibus attenditur ordo rationis ad finem communem humanae vitae. 27 Cf. In I Politic., lect. I, n. 31: Ex eius esse provenit, quod homines non solum vivant, sed quod bene vivant, inquantum per leges civitatis ordinatur vita hominum ad virtutem. In I Ethic., lect. I, n. 4: Sciendum est autem, quod quia homo naturaliter est animal sociale, utpote qui indiget ad suam vitam multis, quae sibi ipse solus praeparare non potest: consequens est, quod homo naturaliter sit pars alicuius multitudinis, per quam praestetur sibi auxilium ad bene vivendum. Quo quidem auxilio indiget ad duo. Primo quidam ad ea quae sunt vitae necessaria, sine quibus praesens vita transigi non potest: et ad hoc auxiliatur homini domestica multitudo, cuius est pars. Nam quilibet homo a parentibus habet generationem et nutrimentum et disciplinam et similiter etiam singuli, qui sunt partes domesticae familiae, se invicem iuvant ad necessaria vitae. Alio modo iuvatur homo a multitudine, cuius est pars, ad vitae sufficientiam perfectam; scilicet ut homo non solum vivat, sed et bene vivat, habens omnia quae sibi sufficiunt ad vitam: et sic homini auxiliatur multitudo civilis, cuius ipse est pars, non solum quantum ad corporalia, prout scilicet in civitate sunt multa artificia, ad quae una domus sufficere non potest, sed etiam quantum ad moralia: inquantum scilicet per publicam potestatem coërcentur insolentes iuvenes metu poenae, quos paterna monitio corrigere non valet ; In I Politic., Proemium n. 4: Quarum quidem communitatum cum diversi sint gradus et ordines, ultima est communitas civitatis ordinata ad per se sufficientia vitae humanae ; ibid., I, lect. I, n. 31: [Civitas] ordinatur ad hoc quod homo habeat sufficienter quicquid est necessarium ad vitam. Est enim de ratione civitatis, quod in ea inveniantur omnia quae sufficient ad vitam humanam, sicut contingit esse ; cf. M. Cordovani, Cattolicismo e idealismo, Milano 1928, pp ; Id., Spunti di sociologia, cit., pp ; S.Th., II-II, q. 64, a. 2: Quaelibet autem persona singularis comparatur ad totam communitatem sicut pars ad totum ; cf. ibid., I-II, q. 96, a. 4; est et quod habet, est multitudinis: sicut et quaelibet pars id quod est, est totius ; II-II, q. 61, a. 1: [Privata p. 8
9 Congresso Tomista Internazionale Ed allora, è la società che deve essere ordinata tota et totaliter alla persona, al bene integrale e assoluto dell uomo, in quanto il bene comune deve riversarsi su tutti i cittadini, ragion per cui la persona umana non si consegna totalmente allo Stato, ma deve restare custode vigile della sua personale dignità e tensioni verso la trascendenza divina, che gli stessi governanti devono rispettare e tutelare nel sacrario delle opzioni delle singole coscienze. Perciò, l uomo come persona è ordinato sì alla società, ma non totaliter, cioè non in senso totale : non secundum omnia sua. Infatti, dice sempre S. Tommaso, in senso totale l uomo è ordinato, come al suo fine ultimo e assoluto, soltanto a Dio, principio e fine di tutte le cose, e questa ordinazione diretta a Dio trascende ogni bene comune per cui: totum quod homo est, et quod potest et habet, ordinandum est ad Deum, 29 perché l uomo vivente risulta essere davvero la gloria di Dio, e a rovescio, la vita dell uomo risulta finalizzata alla visione di Dio, come dice S. Ireneo di Lione (+c. 202), la gloria di Dio è l uomo vivente : Gloria enim Dei vivens homo, e la vita dell uomo è la visione di Dio. 30 Per questo, nota S. Tommaso, non c è niente di più alto dell uomo, se non Dio stesso : Nihil homine altius nisi solus Deus, 31 per cui, dice Tertulliano ( ), l uomo appartiene solo a Dio : solius autem Dei homo. 32 Solo così la persona umana ha un vero fondamento e un sicuro ancoraggio davanti ai deboli riferimenti del pensiero contemporaneo, incapaci di fondare e orientare la dottrina e la pratica dei diritti umani. Di qui la trascendenza della persona umana nell ordine naturale stesso. Infatti, nota Maritain, l uomo è costituito persona, fatta per Dio e per la vita eterna, prima di essere costituito parte della città; ed è costituito parte della società politica. Donde i diritti primordiali persona] comparatur ad communitatem sicut pars ad totum ; q. 64, a. 5: Quaelibet pars id quod est, est totius. Quilibet autem homo est pars communitatis: et ita id quod est, est communitatis. 29 S.Th., I-II, q. 21, a. 4, ad 3: Homo non ordinatur ad communitatem politicam secudum se totum, et secundum omnia sua: et ideo non oportet quod quilibet actus eius sit meritorius vel demeritorious per ordinem ad communitatem politicam. Sed totum quod homo est, et poteste t habet, ordinandum est ad Deum: et ideo omnis actus hominis bonus vel malus habet rationem meriti vel demeriti apud Deum, quantum est ex ipsa ratione actus. 30 S. Ireneo, Aversus haereses, IV, 20; PG, VII, II, C. Gent., IV, c. 54: Secundum ordinem finis, nihil hominis existit altius, nisi solus Deus, in quo solo perfecta beatitudo hominis consistit. 32 Tertulliano, Scorpiace, c. 14; PL, II, 173. p. 9
10 R. M. PIZZORNI, Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista che questa deve rispettare, e che non può ledere quando richiede per sé il servizio dei suoi membri. 33 Per questo quando gli Apostoli rispondevano al Sinedrio, che voleva impedire loro di predicare il nome di Gesù: E meglio per noi ubbidire a Dio che agli uomini [Act. 5, 29], affermavano e la libertà della parola di Dio e la trascendenza della persona umana salvata e riscattata da Lui, e chiamata all adorazione divina; ma implicitamente e nello stesso tempo affermavano così la trascendenza della persona umana nell ordine naturale stesso, in quanto essa è una totalità spirituale fatta per l assoluto. Importa insistere sul fatto che già nell ordine naturale stesso la persona umana trascende lo Stato, in quanto l uomo ha un destino superiore al tempo e mette in gioco ciò che in lui interessa tale destino. 34 E questo va riaffermato contro il processo di secolarizzazione antireligiosa che continua ancora oggi a influire sulla concezione del diritto e della laicità statuale, fondati sul giusnaturalismo razionalistico o sul positivismo giuridico, incapaci di ripetere la loro fondazione da un preciso statuto ontologico della persona umana e dal suo destino metastorico, che non si esaurisce nella vicenda terrena. Allora, se si vuole salvare l uomo dal potere assoluto e onnipotente dell autorità dello Stato e del Diritto come volontà e non come ragione, bisogna ritornare alla dottrina del diritto naturale che riconosce il primato dell uomo: Prima l uomo poi il resto, come diceva Paolo VI. Ed è bello notare come la religione cristiana, la quale proclama il primato di Dio su tutte le cose, mette perciò stesso, nel campo delle realtà temporali, il primato dell uomo. 35 E questo è tanto più necessario in questa nostra epoca nella quale gli uomini sono diventati sensibilissimi a tutto ciò che tocca la loro dignità e i loro diritti; non appena avvertono o anche solo sospettano di essere fatti strumenti di interessi altrui o di essere utilizzati come mezzi in ordine a fini ad essi estranei, reagiscono con irruenza. Di qui la irriducibilità dell uomo stesso a essere totalmente incorporato e asservito al potere dello Stato, la cui missione si esprime con la parola giustizia, per cui la sana politica non può prescindere da quei principi di moralità e di giustizia che sono impressi nello spirito umano per sua razionale natura, e allora l autorità dello Stato è determinata da una legge (riflesso, secondo la Teologia, della lex aeterna), che gli assegna una propria missione e ne limita conseguentemente la sfera di 33 J. Maritain, La persona e il bene comune, tr. it., Brescia , p J. Maritain, I diritti dell uomo e la legge naturale, tr. it., 1991, p Paolo VI, Discorso all Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, giugno 1964, in Insegnamenti di Paolo VI, Città del Vaticano, vol. II, p p. 10
11 Congresso Tomista Internazionale azione. Lo stato razionalmente concepito è il punto ideale di convergenza dei diritti individuali, che sono ad esso logicamente anteriori, anche se da esso attendono il positivo riconoscimento e la positiva conferma. In ogni momento della sua azione, lo Stato non può prescindere da quel presupposto, senza privarsi del titolo che ne giustifica l esistenza; perché appunto la protezione dei diritti naturali dell essere umano è la ragione prima e immanente della sua attività, e la condizione essenziale della sua legittima autorità sopra gli individui. 36 Concludendo, riaffermiamo che la società non è fine a se stessa; il suo fine è la persona umana. Per questo a nessuno è lecito violare impunemente la dignità dell uomo di cui Dio stesso dispone con grande riverenza, 37 ne attraversagli la vita verso quel perfezionamento che è ordinato all acquisto della vita eterna. La società è per la garanzia di ordine e di difesa della persona umana, garanzia che è allo stesso tempo morale, giuridica e coattiva: e si esprime coi caratteri di potere-diritto-forza. 38 Dottrina questa che trova la sua formula semplice nel principio di sussidiarietà della società rispetto alle persone nei confronti di una eccessiva ingerenza dello Stato, il cui intervento è legittimato solo in quanto ausiliare e integrativo dell attività dei singoli e dei gruppi sociali. Aiutare gli uomini in quanto, come diceva Pio XI (n. 1857, Papa ), che per primo formulò il principio di sussidiarietà, punto fermo della Dottrina della Chiesa: l oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di dare aiuto (subsidium, donde sussidiarietà) in maniera suppletiva alle membra del corpo sociale, non già di distruggerle e di assorbirle. 39 Quindi non assorbire, che significa l idea di dominio, di controllo, di assorbimento della persona reale dei singoli nella persona artificiale dello Stato, ma aiutare, che significa sostegno, incremento, integrazione, perché non è giusto che le persone siano assorbite dallo Stato. Aiutare gli uomini ad aiutare se stessi; non fare ma aiutare a fare, cioè intervento dell azione dello Stato laddove l iniziativa personale è insufficiente, sempre ai fini del bene comune, e cioè per uno sviluppo produttivo in funzione del progresso sociale a beneficio di tutti i cittadini. Sussidiarietà che vuol dire responsabilità partecipata e, sino a un certo rado, autorità partecipata, contro ogni forma di paternalismo, di centralissimo o di autoritarismo, incoraggiando il massimo d iniziativa con il massimo di 36 G. Del Vecchio, Lo Stato moderno e i suoi problemi, Torino 1957, pp ; cf. ibidem, pp Sap. 12,18: Cum magna reverentia disponis nos. 38 L. Sturzo, La società, sua natura e leggi, Bergamo 1949, p Pio XI, Encicl. Quadragesimo anno (15 maggio 1931), n. 35; in I. Giordani, Le Encicliche sociali dei Papi, vol. I, Roma , p. 462; cf. Giovanni XXIII, Encicl. Pacem in terris (11 aprile 1963), n. 51, in I. Giordani, op. cit., vol. II, Roma 1969, p. 135; Congregazione per la Dottrina della Fede, Libertà cristiana e liberazione: Libertas conscientiae (22 marzo 1986); Giovanni Paolo II, Encicl. Centesimus annus (1 maggio 1991), n. 15. p. 11
12 R. M. PIZZORNI, Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista responsabilità per l intera società. La responsabilità, resa così consapevole, dovrà però trasformarsi in attiva partecipazione. E questa la dottrina del personalismo sociale cristiano-tomista, secondo la quale la persona umana come fine in sé preordina ogni finalità sociale, e di conseguenza i diritti delle persone prevalgono su ogni disposizione sociale e ne condizionano la legittimità; infatti, non l essere sociale determina l essere uomo, ma l essere umano connota umanamente la società a cui partecipa. Con questo non si vuole sminuire il valore della società: qui si intende la società come endogena nella persona, non nel senso immanentistico e monistico dell idealismo assoluto ma nel senso che la persona contiene in sé la sua destinazione sociale, e nemmeno potrebbe compiersi come persona se contravvenisse a tale sua destinazione. 40 Allora, come abbiamo già visto, la prima e fondamentale limitazione ai poteri dello Stato ed ai poteri del diritto statuale è il primato e la dignità della persona umana, con la sua inviolabile autonomia, per cui non può essere assunta come mezzo per i fini di un altro uomo o dello Stato, essendo essa non solo causa efficiente o soggetto, ma anche causa finale o fine del diritto, in quanto l uomo stesso è fine di tutto e appartiene a se stesso, è ens sibi, e un centro di valori, che esigono riconoscimento, e ogni individuo umano è persona fin dal suo concepimento, perché, creato ad imaginem Dei, reca in sé l elemento divino che la informa. 41 Di conseguenza, la nuova società e il nuovo ordine, più giusti e più umani, nasceranno dalla attribuzione di un valore supremo all uomo riconosciuto come persona (aspetto filosofico-antropologico), e come immagine o icona di Dio (aspetto biblico-teologico). Persona e immagine o icona di Dio definiscono i mistero dell uomo, cioè la sua verità e n fondano la sua insopprimibile dignità. L obnubilazione dell immagine di Dio nell uomo è la radice metafisica di ogni politica di potenza e di ogni totalitarismo politico, e porta ad una scissione profonda e una separazione irrimediabile tra politica e morale, che fa della politica l arte di procurare l infelicità degli uomini. Infatti, come afferma Stefanini ( ), l uomo abbandonato dei nostri giorni è l uomo che non si sente più contenuto in una intenzione divina: l uomo che va perdendo il rispetto della persona in sé e negli altri, in quanto va perdendo il senso del suo rapporto, lieto di confidenza e grave d impegno, che lo lega al Principio spirituale e personale dell essere Cf. L. Stefanini, Personalismo sociale, Roma , pp Cf. A. Rosmini, Filosofia del diritto, ed. a cura di R. Orecchia, vol. III, Padova 1968, p L. Stefanini, op. cit., p. 2. p. 12
13 Congresso Tomista Internazionale E questo ci spiega come la dottrina cristiano-tomista sia rimasta quasi sola a difendere il primato dell uomo, anche se per questo viene spesso ricusata e tacciata d invadenza, di oscurantismo, di antiumanesimo. E allora, solo con questo umanesimo giuridico, cristiano-tomista, che pone al centro del diritto l uomo, per cui il ius non è solo un dato tecnico asservito alla politica dello Stato, ma espressione della dignità e spiritualità umana, potremo assistere alla nascita di un nuovo umanesimo in cui l uomo si definisce anzitutto per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia, 43 un umanesimo [che] giovi alla causa della persona umana e al riconoscimento del suo specifico valore e della sua inalienabile dignità, 44 che va salvaguardata da quel relativismo etico che contraddistingue tanta parte della cultura contemporanea, e ciò è possibile solo col riconoscimento di una legge morale obiettiva che, in quanto legge naturale inscritta nel cuore dell uomo, è punto di riferimento normativo della stessa legge civile. 45 Legge naturale, che come dice ancora Giovanni Paolo II, è una dottrina appartenente al grande patrimonio della sapienza umana, purificato e portato alla sua pienezza alla luce della Rivelazione. La legge naturale è la partecipazione della creatura razionale alla legge eterna [S.Th., I-II, q.91, a.2]. Dottrina di difesa della dignità e dei diritti dell uomo. 46 Solo così, ammettendo questo umanesimo cristiano-tomista potremo salvaguardare e difendere la Persona umana, la sua dignità e i suoi diritti fondamentali contro lo strapotere dell autorità dello Stato, per la vera pace dei popoli, delle nazioni e del mondo intero, per una civiltà più perfetta, cioè più perfettamente umana ed universale, in altre parole cristiana: la civiltà dell amore, basata sulla giustizia e sulla carità Concilio Vaticano II, La Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes), n Giovanni Paolo II, Discorso alla Seconda Sessione pubblica delle Pontificie Accademie (3 novembre 1997), in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Città del Vaticano, vol. XX/2, p Giovanni Paolo II, Encicl. Evangelium vitae (2 marzo 1995), n Giovanni Paolo II, Discorso all Assemblea plenaria della Congregazione della Fede (18 gennaio 2001), n. 3, in L Osservatore romano, 19 gennaio 2001, p Cf. Paolo VI, Discorso: Sentire profundamente il dovere di promuovere la civiltà dell amore (31 dicembre 1975), in Insegnamenti..., cit., vol. XIII, p. 1577; Discorso (18 febbraio 1976), ibidem, vol. XIV, pp ; Giovanni Paolo II, Omelia della S. Messa di Beatificazione a Cracovia (18 agosto 202), in L Osservatore romano, agosto 2002, n. 3, p. 8. Per un maggiore sviluppo di questi problemi cf. i nostri lavori: Giustizia e carità, Bologna ; Diritto naturale e diritto positico in S. Tommaso d Aquino, Bologna ; La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d Aquino, Bologna ; e i nostri articoli: Il diritto p. 13
14 R. M. PIZZORNI, Il valore della persona umana nella dottrina cristiano-tomista naturale salvaguardia della persona umana contro lo strapotere dello Stato in Apollinaris LX(1987), pp ; La dignità della persona umana e l autorità dello Stato, in ibidem, LXIX(1996), pp Cf. inoltre AA.VV., L uomo via della Chiesa, Studi in onore di Giovanni Paolo II, Studia Univ. S. Thomae in Urbe, Massimo Milano 1991, in particolare A. Lobato, Juan Pablo II y Santo Thomas Doctor Humanitatis, pp p. 14
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno Classe 1 A
 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2017-2018 Classe 1 A 1. Questioni di morale sociale: matrimonio e famiglia. 2. La realtà antropologica dell uomo e della donna: differenza e diversità. 3. Il progetto di Dio
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2017-2018 Classe 1 A 1. Questioni di morale sociale: matrimonio e famiglia. 2. La realtà antropologica dell uomo e della donna: differenza e diversità. 3. Il progetto di Dio
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno Classe 1 A
 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2018-2019 Classe 1 A 1. Il senso religioso: le domande esistenziali dell uomo - partire da se stessi - L uomo composto di corpo e anima. Inscindibilità della natura umana.
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2018-2019 Classe 1 A 1. Il senso religioso: le domande esistenziali dell uomo - partire da se stessi - L uomo composto di corpo e anima. Inscindibilità della natura umana.
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI. Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA
 UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
INDICE GENERALE. Introduzione parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ
 INDICE GENERALE Introduzione...005 parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ I. La fede cristiana nella stagione della postmodernità...015 1.1. Il mondo culturale contemporaneo...015
INDICE GENERALE Introduzione...005 parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ I. La fede cristiana nella stagione della postmodernità...015 1.1. Il mondo culturale contemporaneo...015
RELIGIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELL IRC
 RELIGIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELL IRC CLASSE PRIMA - Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa - L uomo e la ricerca della verità: proposta di
RELIGIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELL IRC CLASSE PRIMA - Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa - L uomo e la ricerca della verità: proposta di
Pastorale Familiare. Animatori Filippo e Graziella Anfuso.
 ritardo Pastorale Familiare Animatori Filippo e Graziella Anfuso www.parrocchiadellaguardia.it Parrocchia Santa Maria della Guardia - CT Ordine Frati Minori LA CHIESA E LA DOTTRINA SOCIALE Allegoria del
ritardo Pastorale Familiare Animatori Filippo e Graziella Anfuso www.parrocchiadellaguardia.it Parrocchia Santa Maria della Guardia - CT Ordine Frati Minori LA CHIESA E LA DOTTRINA SOCIALE Allegoria del
SAN PAOLO. lettera ai Romani
 SAN PAOLO La lettera ai Romani Il peccato dell umanità 1,18-3,20 La giustizia di Dio 3,21-4,25 Dalla giustificazione alla salvezza 5,1-8,39 Qual è la situazione dell uomo giustificato? Quale la sua condotta?
SAN PAOLO La lettera ai Romani Il peccato dell umanità 1,18-3,20 La giustizia di Dio 3,21-4,25 Dalla giustificazione alla salvezza 5,1-8,39 Qual è la situazione dell uomo giustificato? Quale la sua condotta?
La bellezza dell amore negli scritti di Giovanni Paolo II: Etica ed estetica
 La bellezza dell amore negli scritti di Giovanni Paolo II: Etica ed estetica Angela Anna Tozzi LA BELLEZZA DELL AMORE NEGLI SCRITTI DI GIOVANNI PAOLO II: ETICA ED ESTETICA www.booksprintedizioni.it Copyright
La bellezza dell amore negli scritti di Giovanni Paolo II: Etica ed estetica Angela Anna Tozzi LA BELLEZZA DELL AMORE NEGLI SCRITTI DI GIOVANNI PAOLO II: ETICA ED ESTETICA www.booksprintedizioni.it Copyright
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno)
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
Il Presidente della Repubblica
 VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
DIOCESI DI JESI SCUOLA DI TEOLOGIA CORSO DI ECCLESIOLOGIA
 DIOCESI DI JESI SCUOLA DI TEOLOGIA CORSO DI ECCLESIOLOGIA 3. LA CHIESA E L ECCLESIOLOGIA LUNGO LA STORIA - CANONISTICA - TRATTATI E APOLOGETICA - VATICANO I È necessario che questa dottrina certa ed immutabile,
DIOCESI DI JESI SCUOLA DI TEOLOGIA CORSO DI ECCLESIOLOGIA 3. LA CHIESA E L ECCLESIOLOGIA LUNGO LA STORIA - CANONISTICA - TRATTATI E APOLOGETICA - VATICANO I È necessario che questa dottrina certa ed immutabile,
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
 Giovanni Ancona ANTROPOLOGIA TEOLOGICA Temi fondamentali QUERINIANA Indice generale Introduzione........................................... 5 1. La riflessione teologica intorno al l uomo (antropologia
Giovanni Ancona ANTROPOLOGIA TEOLOGICA Temi fondamentali QUERINIANA Indice generale Introduzione........................................... 5 1. La riflessione teologica intorno al l uomo (antropologia
Liceo G. Galilei Trento
 Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico
 Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico 1 TERZO INCONTRO LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME SAPERE TEORICO PRATICO L epistemologia della DSC Dimensione
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico 1 TERZO INCONTRO LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME SAPERE TEORICO PRATICO L epistemologia della DSC Dimensione
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica
 PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
IL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO
 IL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO COSCIENZA E SUA FORMAZIONE COSCIENZA SEDE DEL DISCERNIMENTO Credere significa mettersi in ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola che è via, verità e vita
IL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO COSCIENZA E SUA FORMAZIONE COSCIENZA SEDE DEL DISCERNIMENTO Credere significa mettersi in ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola che è via, verità e vita
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Andrea Guarise. PROGETTO DIDATTICO CLASSE 3 a E scientifico
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE. Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo
 PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach
 Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. Questioni principali: RELIGIONE POLITICA. All origine c è il
Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. Questioni principali: RELIGIONE POLITICA. All origine c è il
RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas
 RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006
 Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006 Comandamento di Dio Comandamento = mezzo per entrare nella Vita (quella vera quella eterna) => Costruire il Regno di
Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006 Comandamento di Dio Comandamento = mezzo per entrare nella Vita (quella vera quella eterna) => Costruire il Regno di
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE
 PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
SERVIZIO NAZIONALE PER L IRC della Conferenza Episcopale Italiana
 SERVIZIO NAZIONALE PER L IRC della Conferenza Episcopale Italiana OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PROPRI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL'AMBITO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI del secondo
SERVIZIO NAZIONALE PER L IRC della Conferenza Episcopale Italiana OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PROPRI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL'AMBITO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI del secondo
Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto
 Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e
Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e
Giannino Piana introduzione all ETiCa CRiSTiana 367 QUERiniana
 Giannino Piana INTRODUZIONE ALL ETICA CRISTIANA 367 QUERINIANA Indice Prefazione.... 5 parte prima I FONDAMENTI 1. Crisi e attualità della domanda etica... 9 1. Alla radice della crisi: la ricerca delle
Giannino Piana INTRODUZIONE ALL ETICA CRISTIANA 367 QUERINIANA Indice Prefazione.... 5 parte prima I FONDAMENTI 1. Crisi e attualità della domanda etica... 9 1. Alla radice della crisi: la ricerca delle
La persona umana e i molteplici profili del suo mistero e della sua dignità
 La persona umana e i molteplici profili del suo mistero e della sua dignità don Paolo Fontana Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute Arcidiocesi di Milano 0. Introduzione ANTICHITÀ Persona
La persona umana e i molteplici profili del suo mistero e della sua dignità don Paolo Fontana Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute Arcidiocesi di Milano 0. Introduzione ANTICHITÀ Persona
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA. I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche
 ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
CURRICULUM DI RELIGIONE
 CURRICULUM DI RELIGIONE INTRODUZIONE L Insegnamento della Religione Cattolica contribuisce, con le altre discipline, al pieno sviluppo della personalità di ogni studente. In particolare risponde all esigenza
CURRICULUM DI RELIGIONE INTRODUZIONE L Insegnamento della Religione Cattolica contribuisce, con le altre discipline, al pieno sviluppo della personalità di ogni studente. In particolare risponde all esigenza
RELIGIONE CATTOLICA. Conoscenze Abilità Competenze. Cogliere nelle domande fondamentali dell uomo tracce di una ricerca religiosa
 Competenza specifica: DIO E L UOMO La ricerca religiosa dell uomo La definizione di religione soprannaturale e di monoteismo Le categorie bibliche di rivelazione, promessa, alleanza, storia della salvezza
Competenza specifica: DIO E L UOMO La ricerca religiosa dell uomo La definizione di religione soprannaturale e di monoteismo Le categorie bibliche di rivelazione, promessa, alleanza, storia della salvezza
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA
 JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI
 TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità
 Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
indice 1.1 Religione: di che cosa si tratta? Configurazioni della religione 15
 indice Introduzione 7 1. Religione 11 1.1 Religione: di che cosa si tratta? 11 1.1.1 Religione: un fenomeno controverso 11 1.1.2 La religione non è ciò che ciascuno ritiene che sia 11 1.1.3 Religione:
indice Introduzione 7 1. Religione 11 1.1 Religione: di che cosa si tratta? 11 1.1.1 Religione: un fenomeno controverso 11 1.1.2 La religione non è ciò che ciascuno ritiene che sia 11 1.1.3 Religione:
CREDO IN CREDO LA PROFESSO ASPETTO DIO PADRE UN SOLO CREATORE GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CHIESA
 DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
II DOMENICA DOPO NATALE
 II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
Il ruolo dello Spirito Santo nella fecondità della vita trinitaria. Giulio Maspero PUSC
 Il ruolo dello Spirito Santo nella fecondità della vita trinitaria Obiettivi Ripasso dei concetti fondamentali del trattato su Dio ed in particolare della pneumatologia Cogliere in questo contesto l'importanza
Il ruolo dello Spirito Santo nella fecondità della vita trinitaria Obiettivi Ripasso dei concetti fondamentali del trattato su Dio ed in particolare della pneumatologia Cogliere in questo contesto l'importanza
dubbi e attese del paziente
 10 febbraio 2018 XXVI Giornata Mondiale del Malato Associazione Medici Cattolici Italiani Novara Nuova Carta degli Operatori Sanitari dubbi e attese del paziente ROBERTO MARI MISTERI DELLA VITA pg 11 La
10 febbraio 2018 XXVI Giornata Mondiale del Malato Associazione Medici Cattolici Italiani Novara Nuova Carta degli Operatori Sanitari dubbi e attese del paziente ROBERTO MARI MISTERI DELLA VITA pg 11 La
Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I
 CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è
 Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
OGNI AMORE VERO È INDISSOLUBILE
 JEAN-PAUL VESCO OGNI AMORE VERO È INDISSOLUBILE Considerazioni in difesa dei divorziati risposati Editoriale di Andrea Grillo 374 QUERINIANA Introduzione L indissolubilità di un alleanza matrimoniale vera
JEAN-PAUL VESCO OGNI AMORE VERO È INDISSOLUBILE Considerazioni in difesa dei divorziati risposati Editoriale di Andrea Grillo 374 QUERINIANA Introduzione L indissolubilità di un alleanza matrimoniale vera
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Il percorso
 Il percorso 2009-2010 X X Voi siete qui 22/05/10 http://incoscienza.wordpress.com/ 1 La coscienza nel magistero della Chiesa Cattolica Casa Le quattro del pomeriggio Seminario Vescovile, Cremona 22/05/10
Il percorso 2009-2010 X X Voi siete qui 22/05/10 http://incoscienza.wordpress.com/ 1 La coscienza nel magistero della Chiesa Cattolica Casa Le quattro del pomeriggio Seminario Vescovile, Cremona 22/05/10
PROGRAMMA a.s
 1 Istituto Professionale di Stato Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera Bernardo Buontalenti Sede e Segreteria: Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055 462781 Fax: 055
1 Istituto Professionale di Stato Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera Bernardo Buontalenti Sede e Segreteria: Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055 462781 Fax: 055
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA
 IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
INDICE. 1. Una Scuola di ispirazione cristiana nella storia e nell oggi. 2. La nostra Scuola: la sua Mappa Valoriale: la Costituzione.
 1 INDICE PROGETTO EDUCATIVO 1. Una Scuola di ispirazione cristiana nella storia e nell oggi. 2. La nostra Scuola: la sua Mappa Valoriale: la Costituzione. 3. La Scuola e i Diritti del Bambino. 4. La Scuola
1 INDICE PROGETTO EDUCATIVO 1. Una Scuola di ispirazione cristiana nella storia e nell oggi. 2. La nostra Scuola: la sua Mappa Valoriale: la Costituzione. 3. La Scuola e i Diritti del Bambino. 4. La Scuola
Progetto Etica e Politica
 Progetto Etica e Politica Laboratorio svolto dalla classe del biennio 2 E Anno 2007 INTRODUZIONE Etica Deriva dal greco έθος, ossia "condotta", carattere", consuetudine. È una parte della filosofia che
Progetto Etica e Politica Laboratorio svolto dalla classe del biennio 2 E Anno 2007 INTRODUZIONE Etica Deriva dal greco έθος, ossia "condotta", carattere", consuetudine. È una parte della filosofia che
Progettazione IRC 2A MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio Testo: Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 1. IL GESU DELLA STORIA
 Progettazione IRC 2A MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio : Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 1. IL GESU DELLA STORIA Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica L immagine di Gesù storicamente
Progettazione IRC 2A MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio : Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 1. IL GESU DELLA STORIA Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica L immagine di Gesù storicamente
Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la
 Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la rinascita che riguarda il rapporto fra Gesù, lo Spirito Santo
Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la rinascita che riguarda il rapporto fra Gesù, lo Spirito Santo
Programma svolto Anno scolastico 2012/2013
 Classe: 1E S L IRC e la scuola. o Il perché di questa materia o L utilità di questa materia o Brevi accenni alla storia dell IRC La dimensione religiosa della vita. o Il fatto religioso nella (mia) storia
Classe: 1E S L IRC e la scuola. o Il perché di questa materia o L utilità di questa materia o Brevi accenni alla storia dell IRC La dimensione religiosa della vita. o Il fatto religioso nella (mia) storia
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA- FERRANDINA LICEO SCIENTIFICO M. PARISI CLASSE I A PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA A.S.
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA- FERRANDINA LICEO SCIENTIFICO M. PARISI CLASSE I A PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2015\16 1) CULTURA E RELIGIONE. LA SCUOLA, LO STUDIO E L IRC 1. -Cultura
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA- FERRANDINA LICEO SCIENTIFICO M. PARISI CLASSE I A PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2015\16 1) CULTURA E RELIGIONE. LA SCUOLA, LO STUDIO E L IRC 1. -Cultura
5 gennaio Liturgia del giorno
 5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE ANNO SCOLASTICO Classe: I - Sez.: B Liceo
 PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. MARTIS ROSSANO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Classe: I - Sez.: B Liceo I. CULTURA E RELIGIONE. L=IRC 1. Cos=è la cultura? - Aprirsi al mondo; - il contributo
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. MARTIS ROSSANO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Classe: I - Sez.: B Liceo I. CULTURA E RELIGIONE. L=IRC 1. Cos=è la cultura? - Aprirsi al mondo; - il contributo
Papa Francesco: non confondiamo la famiglia con altri tipi di unione
 Papa Francesco: non confondiamo la famiglia con altri tipi di unione Non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione così Papa Francesco nel discorso tenuto stamani
Papa Francesco: non confondiamo la famiglia con altri tipi di unione Non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione così Papa Francesco nel discorso tenuto stamani
BARTOLOMEO SORGE INTRODUZIONE ALLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. Nuova edizione rivista e aumentata. Queriniana
 BARTOLOMEO SORGE INTRODUZIONE ALLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Nuova edizione rivista e aumentata Queriniana Indice Avvertenza: Per una civiltà dell amore... 7 Prefazione: Con adulta fedeltà.... 9 Fonti....
BARTOLOMEO SORGE INTRODUZIONE ALLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Nuova edizione rivista e aumentata Queriniana Indice Avvertenza: Per una civiltà dell amore... 7 Prefazione: Con adulta fedeltà.... 9 Fonti....
Pastorale delle famiglie
 Pastorale delle famiglie Animatori Filippo e Graziella Anfuso Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it La ragionevolezza della fede in Dio Benedetto
Pastorale delle famiglie Animatori Filippo e Graziella Anfuso Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it La ragionevolezza della fede in Dio Benedetto
Omelia di Pentecoste. 8 giugno Tutti furono colmati di Spirito Santo (At 2, 4).
 Omelia di Pentecoste 8 giugno 2014 Tutti furono colmati di Spirito Santo (At 2, 4). Parlando agli Apostoli nell Ultima Cena, Gesù disse che, dopo la sua partenza da questo mondo, avrebbe inviato loro il
Omelia di Pentecoste 8 giugno 2014 Tutti furono colmati di Spirito Santo (At 2, 4). Parlando agli Apostoli nell Ultima Cena, Gesù disse che, dopo la sua partenza da questo mondo, avrebbe inviato loro il
Socrate. Atene a.c.
 Socrate Atene 470-399 a.c. La sofistica Movimento filosofico, e più ampiamente etico e culturale, affermatosi nella Grecia antica, e soprattutto in Atene, tra il 5 e il 4 sec. a.c. L insegnamento sofistico
Socrate Atene 470-399 a.c. La sofistica Movimento filosofico, e più ampiamente etico e culturale, affermatosi nella Grecia antica, e soprattutto in Atene, tra il 5 e il 4 sec. a.c. L insegnamento sofistico
- Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano)
 GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
 LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Fabio Baggio Scalabrini International Migration Institute Introduzione La dottrina sociale della Chiesa: Insegnamenti e dettami su questioni relative
LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Fabio Baggio Scalabrini International Migration Institute Introduzione La dottrina sociale della Chiesa: Insegnamenti e dettami su questioni relative
1. Programma di Teologia Fondamentale I IT /2010. Teologia Fondamentale I IT
 1. Programma di Teologia Fondamentale I IT - 2009/2010 Teologia Fondamentale I IT Schema sintetico del corso 2009-2010 INTRODUZIONE: ESSERE CREDENTI OGGI PRIMA PARTE LA DIVINA RIVELAZIONE E LA SUA TRASMISSIONE
1. Programma di Teologia Fondamentale I IT - 2009/2010 Teologia Fondamentale I IT Schema sintetico del corso 2009-2010 INTRODUZIONE: ESSERE CREDENTI OGGI PRIMA PARTE LA DIVINA RIVELAZIONE E LA SUA TRASMISSIONE
Attualità del pensiero politico di Dante?
 Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
I.T.C.G.S. C. MATTEUCCI Via Delle Vigne Nuove, ROMA. Disciplina: Religione. Docente: Michele Mansueti. Anno Scolastico:
 Classe II A Costruzioni, Ambiente e Territorio 1. L adolescente tra desiderio e realtà. 2. I limiti esistenziali e morali inerenti alla condizione umana. 3. L interpretazione nichilista e religiosa dell
Classe II A Costruzioni, Ambiente e Territorio 1. L adolescente tra desiderio e realtà. 2. I limiti esistenziali e morali inerenti alla condizione umana. 3. L interpretazione nichilista e religiosa dell
Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione Prima Parte
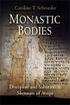 Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione... 7 Prima Parte teologia biblica: Itinerari Capitolo 1 itinerario teoretico.............. 13 Una definizione... 14 1. Fondazione epistemologica e legittimità
Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione... 7 Prima Parte teologia biblica: Itinerari Capitolo 1 itinerario teoretico.............. 13 Una definizione... 14 1. Fondazione epistemologica e legittimità
RELIGIONE: TERZO BIENNIO. classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE
 RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
SPIRITUALITÀ E BIBBIA
 GIANFRANCO RAVASI SPIRITUALITÀ E BIBBIA 404 QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 parte prima Due premesse 1. Cultura, spiritualità e mistica.... 9 Agnosticismo e spiritualità 9 Il realismo della spiritualità
GIANFRANCO RAVASI SPIRITUALITÀ E BIBBIA 404 QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 parte prima Due premesse 1. Cultura, spiritualità e mistica.... 9 Agnosticismo e spiritualità 9 Il realismo della spiritualità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO. Scuola Secondaria di Primo Grado. Proff. Alessandro Parmigiani e Davide Pezzali
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO Scuola Secondaria di Primo Grado Proff. Alessandro Parmigiani e Davide Pezzali CLASSE PRIMA Conoscenze Abilità Contenuti Sa cogliere l esistenza come un percorso di
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO Scuola Secondaria di Primo Grado Proff. Alessandro Parmigiani e Davide Pezzali CLASSE PRIMA Conoscenze Abilità Contenuti Sa cogliere l esistenza come un percorso di
LA COSTITUZIONE E LA SUA NASCITA (gennaio 1944 gennaio 1948)
 LA COSTITUZIONE E LA SUA NASCITA (gennaio 1944 gennaio 1948) ITALIA 1944 CONGRESSO CLN (29 GENNAIO 1944) Il Congresso [ ] ritenuto che le condizioni attuali del Paese non consentono la immediata soluzione
LA COSTITUZIONE E LA SUA NASCITA (gennaio 1944 gennaio 1948) ITALIA 1944 CONGRESSO CLN (29 GENNAIO 1944) Il Congresso [ ] ritenuto che le condizioni attuali del Paese non consentono la immediata soluzione
Preghiera universale Venerdì santo
 1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
Robert Codjo Sastre. Vita evangelica e fede cristiana in Africa
 Robert Codjo Sastre Vita evangelica e fede cristiana in Africa Célestin Coomlan Avocan ROBERT CODJO SASTRE Vita evangelica e fede cristiana in Africa biografia www.booksprintedizioni.it Copyright 2013
Robert Codjo Sastre Vita evangelica e fede cristiana in Africa Célestin Coomlan Avocan ROBERT CODJO SASTRE Vita evangelica e fede cristiana in Africa biografia www.booksprintedizioni.it Copyright 2013
PROGRAMMA di FILOSOFIA
 PROGRAMMA di FILOSOFIA CLASSE IV C a. s. 2015/2016 Testi: Reale, Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico voll. 1B,2A, 2B. Parte quarta La Scolastica fra XI e XIII secolo Cap. 9 Anselmo d
PROGRAMMA di FILOSOFIA CLASSE IV C a. s. 2015/2016 Testi: Reale, Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico voll. 1B,2A, 2B. Parte quarta La Scolastica fra XI e XIII secolo Cap. 9 Anselmo d
2 Timoteo 2: 2 Siamo capaci
 2 Timoteo 2: 2 Siamo capaci Spesso la riunione della domenica ci dice il Cosa, ma non il Come, quindi spesso ci si sente impotenti di cambiare e frustrati e alcuni per tali motivi si allontanano dalla
2 Timoteo 2: 2 Siamo capaci Spesso la riunione della domenica ci dice il Cosa, ma non il Come, quindi spesso ci si sente impotenti di cambiare e frustrati e alcuni per tali motivi si allontanano dalla
RELIGIONE IRC Monoennio. Competenza 1. - DIO E L UOMO Scoprire che per la religione Dio è Creatore e Padre.
 RELIGIONE IRC Monoennio Scoprire che per la religione Dio è Creatore e Padre. -IL LINGUAGGIO i segni cristiani nell ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare. - Comprendere che il creato,
RELIGIONE IRC Monoennio Scoprire che per la religione Dio è Creatore e Padre. -IL LINGUAGGIO i segni cristiani nell ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare. - Comprendere che il creato,
IL CRITERIO MISERICORDIA
 GIOVANNI FERRETTI IL CRITERIO MISERICORDIA Sfide per la teologia e la prassi della Chiesa 402 QUERINIANA Presentazione Da quando papa Francesco ha posto la misericordia al centro della missione della chiesa
GIOVANNI FERRETTI IL CRITERIO MISERICORDIA Sfide per la teologia e la prassi della Chiesa 402 QUERINIANA Presentazione Da quando papa Francesco ha posto la misericordia al centro della missione della chiesa
La Chiesa cattolica romana al vaglio della Bibbia
 La Chiesa cattolica romana al vaglio della Bibbia BWHEBB, BWHEBL, BWTRANSH [Hebrew]; BWGRKL, BWGRKN, and BWGRKI [Greek] PostScript Type 1 and TrueType fonts Copyright 1994-2015 BibleWorks, LLC. All rights
La Chiesa cattolica romana al vaglio della Bibbia BWHEBB, BWHEBL, BWTRANSH [Hebrew]; BWGRKL, BWGRKN, and BWGRKI [Greek] PostScript Type 1 and TrueType fonts Copyright 1994-2015 BibleWorks, LLC. All rights
Programmazione IRC 1B MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio Testo: Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei)
 Programmazione IRC 1B MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio : Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 1. INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA Motivazioni dell IRC nella scuola Differenza fra IRC e catechesi
Programmazione IRC 1B MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio : Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 1. INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA Motivazioni dell IRC nella scuola Differenza fra IRC e catechesi
Nel nome del Padre. Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli.
 C - T - Nel nome del Padre Amen T - Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen Ti aspettiamo, Signore Gesù! Attendiamo con pazienza
C - T - Nel nome del Padre Amen T - Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen Ti aspettiamo, Signore Gesù! Attendiamo con pazienza
Omelia S. Messa Epifania 2016
 Omelia S. Messa Epifania 2016 1 Carissimi fratelli e sorelle, oggi noi celebriamo la decisione del Padre di chiamare ogni uomo a conoscere Cristo Gesù. L opera della divina misericordia che celebriamo
Omelia S. Messa Epifania 2016 1 Carissimi fratelli e sorelle, oggi noi celebriamo la decisione del Padre di chiamare ogni uomo a conoscere Cristo Gesù. L opera della divina misericordia che celebriamo
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
RELIGIONE - CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 RELIGIONE - CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; Sa riconoscere i segni della presenza
RELIGIONE - CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; Sa riconoscere i segni della presenza
Prof. Monti a.s
 Conclusioni sulla Patristica ti e considerazioni generali > I PERIODI DELLA PATRISTICA < Abbiamo visto come l avvento del Cristianesimo abbia deviato la filosofia, dandole un nuovo aspetto. Agostino è
Conclusioni sulla Patristica ti e considerazioni generali > I PERIODI DELLA PATRISTICA < Abbiamo visto come l avvento del Cristianesimo abbia deviato la filosofia, dandole un nuovo aspetto. Agostino è
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER DISCIPLINA
 Pag 1 di 6 DIPARTIMENTO 1 : Scienze umane- Filosofia- Storia- RC. Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA - IRC. Responsabile di dipartimento: Prof.ssa Marina Germani Responsabile disciplina: prof.ssa Mariolina
Pag 1 di 6 DIPARTIMENTO 1 : Scienze umane- Filosofia- Storia- RC. Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA - IRC. Responsabile di dipartimento: Prof.ssa Marina Germani Responsabile disciplina: prof.ssa Mariolina
Introduzione Religione e senso della vita
 Introduzione Religione e senso della vita La religione propone le risposte più forti, più antiche e più credute alla questione del senso della vita. A questo titolo essa non può non interessare la filosofia
Introduzione Religione e senso della vita La religione propone le risposte più forti, più antiche e più credute alla questione del senso della vita. A questo titolo essa non può non interessare la filosofia
CULTURA Studium 167. Biblioteca Moreana. La luce della coscienza.indd 1 07/05/19 14:17
 CULTURA Studium 167. Biblioteca Moreana La luce della coscienza.indd 1 07/05/19 14:17 La luce della coscienza.indd 2 07/05/19 14:17 MIGUEL CUARTERO SAMPERI TOMMASO MORO La luce della coscienza Prefazione
CULTURA Studium 167. Biblioteca Moreana La luce della coscienza.indd 1 07/05/19 14:17 La luce della coscienza.indd 2 07/05/19 14:17 MIGUEL CUARTERO SAMPERI TOMMASO MORO La luce della coscienza Prefazione
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - INDICE GENERALE
 INDICE GENERALE compendio DS:http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA
INDICE GENERALE compendio DS:http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA
Kierkegaard l esistenza come possibilità e fede
 l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative
L alleanza tra l uomo e la terra
 L alleanza tra l uomo e la terra 1. Per capire la questione. Secondo le Scritture, è Dio che ha creato il mondo in tutta la sua ricchezza, la sua varietà e il suo ordine. Anche l uomo è una creatura inserita
L alleanza tra l uomo e la terra 1. Per capire la questione. Secondo le Scritture, è Dio che ha creato il mondo in tutta la sua ricchezza, la sua varietà e il suo ordine. Anche l uomo è una creatura inserita
Credo la Chiesa. Conversazioni sulla comunità credente. QUALE CHIESA? Introduzione alla questione.
 QUALE CHIESA? Introduzione alla questione. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate
QUALE CHIESA? Introduzione alla questione. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate
L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi
 Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico
 Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico Prima Lezione LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME ANNUNCIO DI CRISTO NELLE REALTA TEMPORALI Premesse per capirci
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico Prima Lezione LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME ANNUNCIO DI CRISTO NELLE REALTA TEMPORALI Premesse per capirci
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
