MANUALE OPERATIVO IN CASO DI UNA DELLE MALATTIE ESOTICHE DEI CROSTACEI ELENCATE NELL ALLEGATO IV PARTE II DEL D.LGS 148/2008 e s.m.
|
|
|
- Cipriano Baldini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MANUALE OPERATIVO IN CASO DI UNA DELLE MALATTIE ESOTICHE DEI CROSTACEI ELENCATE NELL ALLEGATO IV PARTE II DEL D.LGS 148/2008 e s.m.i
2 INDICE Scheda 1: Eziologia della Sindrome di Taura e della Malattia della testa gialla Scheda 2: Epidemiologia, patogenesi e segni clinici della Sindrome di Taura e della Malattia della testa gialla Scheda 3: Caratteristiche di resistenza del virus della sindrome di Taura e della Malattia della testa gialla Scheda 4: Caratteristiche cliniche e anatomopatologiche del virus della sindrome di Taura e della Malattia della testa gialla Scheda 5: Criteri clinici, anatomopatologici ed epidemiologici per avanzare sospetto di sindrome di Taura e della Malattia della testa gialla Scheda 6: Fondatezza del sospetto e conferma di infezione da Taura Syndrome virus o Yellow Head virus Scheda 7: Misure da applicare in allevamento in caso di conferma e procedure per l abbattimento Scheda 8: Pulizia e disinfezione terminato l abbattimento Scheda 9: Fermo dell impianto e ripopolamento Allegato 1: Scheda di notifica
3 SCHEDA N. 1 SINDROME DI TAURA (O MALATTIA DELLA CODA ROSSA) Eziologia Il virus della sindrome di Taura (TSV), appartenente alla famiglia dei Dicistroviridae, genere Cripavirus, ha morfologia icosaedrica, diametro di 32 nm, è privo di envelope e ha il genoma costituito da un singolo filamento di RNA. Sono stati identificati 4 gruppi genotipici (Belize, America, Venezuela e Sud-Est Asia) con diversa virulenza, in relazione alla sequenza della proteina strutturale piu grande e dominante (VP1). Le due specie maggiormente sensibili alla malattia sono: P. vannamei e P. stylirostris, appartenenti al subgenere Litopenaeus. Infezioni sperimentali o naturali sono descritte in: P. setiferus, P. schmitti, P. aztecus, P. duorarum, P. chinensis, P. monodon, Macrobrachium rosenbergii, Metapenaeus ensis e P. japonicus. MALATTIA DELLA TESTA GIALLA O YHD (YELLOW HEAD DISEASE) Eziologia L agente eziologico della malattia della testa gialla è il cosiddetto Yellow Head Virus genotipo 1 (il primo dei sei genotipi conosciuti nel complesso di YHV), un corona-like RNA virus appartenente al genere Okavirus, della famiglia Roniviridae dell ordine Nidovirales. Il virione ha morfologia bastoncellare, dimensioni comprese tra nm di diametro e nm di lunghezza ed è dotato di envelope.
4 SCHEDA N. 2 SINDROME DI TAURA (O MALATTIA DELLA CODA ROSSA) Epidemiologia, patogenesi e segni clinici La Sindrome di Taura o malattia della coda rossa prende nome dal fiume Taura presso Guyaquil (Ecuador), dove e stata riscontrata per la prima volta nel Le cause di mortalità furono erroneamente attribuite all uso di fungicidi impiegati nelle piantagioni di banane e solo successivamente e stata dimostrata l eziologia virale. La malattia di Taura è presente in aree a produzione di peneidi dell America e del Sud-Est Asiatico; nel continente americano è diffusa: negli Stati Uniti (Hawaii, Florida, Sud Carolina e Texas), in Messico, Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Belize, Venezuela, Ecuador, Perù e Brasile; in Asia e riscontrata: in Cina, Taiwan, Thailandia, Malesia, Indonesia, Corea, Vietnam e Birmania. Il virus è molto virulento e provoca mortalità comprese tra il 5 e il 100% in post larve, stadi giovanili ed adulti di P. vannamei, mentre non è riscontrato in uova, embrioni e larve. La malattia più frequentemente si manifesta in stadi giovanili (0,1-5 grammi), entro giorni dalla stabulazione, in vasche di svezzamento o in stagni di preingrasso. Tre fasi distinte e progressive caratterizzano la sindrome di Taura. La malattia compare in forma acuta, nella quale si manifesta la mortalità ed i gamberi presentano una colorazione pallida rossastra ad esclusione di telson e pleopodi marcatamente rossi, da cui la denominazione di malattia della coda rossa. L accentuata pigmentazione è dovuta all espansione dei cromatofori. La cuticola dell esoscheletro e tipicamente morbida, l intestino vuoto ed i crostacei infetti possono non sopravvivere alla muta. I gamberi moribondi si raggruppano in superficie, ai margini degli stagni, attirando uccelli ittiofagi. I soggetti che sopravvivono manifestano una fase di transizione con lesioni cuticolari (non sempre presenti) melaniche, disseminate, multifocali e di forma irregolare, conseguenti ad aggregazione emocitaria. Segue la fase cronica dell infezione, con assenza di segni clinici, che può durare da 12 mesi a tutta la vita. La trasmissione orizzontale avviene per contatto di soggetti sani con individui infetti, per via alimentare o mediante contaminazione ambientale. La trasmissione verticale è sospettata ma non dimostrata. Portatori di malattia possono essere: uccelli acquatici, gamberi infetti in fase cronica ed insetti acquatici. Prodotti di scarto della lavorazione di crostacei sono stati imputati all origine di epidemie. Il virus può sopravvivere alcuni anni in gamberi congelati.
5 MALATTIA DELLA TESTA GIALLA O YHD (YELLOW HEAD DISEASE) Epidemiologia Patogenesi e segni clinici YHV è altamente infettivo per la maggior parte dei peneidi allevati. Il primo caso di malattia della testa gialla è stato descritto nel 1991 in Tailandia, dove in seguito si è ripresentata sporadicamente. Attualmente la patologia è segnalata in Malesia, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, India, Cina, Taipei, Indonesia, Vietnam, Messico, Texas, Stati Uniti d America. Episodi naturali di malattia sono stati riportati in: P. monodon e P. vannamei. Infezioni naturali o sperimentali sono segnalate in peneidi, palemonidi e krill: Penaeus monodon, P. merguiensis, Palaemon styliferus, P. setiferus, Metapeneus ensis, Ascetes sp, Euphasia superba, Palaemon serrifer, P. esculentus, Metapeneus bennettae, P. japonicus, P. aztecus, P.duorarum, P.stylirostris, P. vannamei, Machrobrachium sintangense. Diverse specie di peneidi selvatici e palemonidi suscettibili all infezione sono indicate come potenziali vettori e diffusori della malattia. La trasmissione può avvenire per via orizzontale: per contatto con gamberi portatori, attraverso l acqua e per ingestione di organismi infetti; per via verticale, tramite i gameti dei genitori o per contaminazione della superficie dell uovo. La dinamica d infezione in stagno non è stata studiata approfonditamente, ma la rapida mortalità fa ritenere che la trasmissione avvenga per via orizzontale. La forma acuta della malattia può manifestarsi in intere popolazioni allevate di P. monodon, con tassi di mortalità fino al 100%, in 3-5 giorni. I soggetti sopravvissuti possono rimanere portatori asintomatici. Le postlarve di età inferiore ai 15 giorni (PL 15) sono più resistenti dei gamberi in stadi biologici più avanzati (da PL a subadulti). Il periodo di incubazione è di 2 o 3 giorni, seguito dalla comparsa dei segni clinici della malattia ed elevata mortalità. A questa fase segue un intervallo in cui si osserva nei gamberi un aumento dell appetito e successivamente digiuno con ripresa della mortalità. I gamberi moribondi si concentrano ai margini del bacino di allevamento. Il tasso di mortalità può innalzarsi in seguito a stress, indotto da improvvise modificazioni del ph, riduzione di ossigeno disciolto ed altri fattori ambientali. I peneidi ammalati presentano colorazione pallida del cefalotorace, che appare giallastro o biancastro. E possibile osservare l epatopancreas in trasparenza, che risulta più soffice. Le branchie assumono una colorazione giallo-brunastra.
6 SCHEDA N. 3 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEL VIRUS DELLA SINDROME DI TAURA Agenti chimici Agenti fisici Resistenza in condizioni naturali Non esistono dati specifici a riguardo. Per analogia con altri patogeni virali viene può essere inattivato con concentrazioni di Cloro > 100 ppm oppure con idrato di sodio NaOH (soda caustica) al 10 % Non esistono dati specifici a riguardo. Per analogia con altri patogeni virali può essere inattivato a 70 C per 15 min TSV può sopravvivere nel tratto intestinale di uccelli per alcuni giorni. Resiste per più di 2 anni in tessuti animali congelati CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEL VIRUS DELLA TESTA GIALLA Agenti chimici Agenti fisici Resistenza in condizioni naturali E sensibile al trattamento con cloro a 30 ppm. E inattivato al calore a 60 C per 15 minuti Il virus rimane vitale in acqua marina fino a 72 ore
7 SCHEDA N. 4 CARATTERISTICHE CLINICHE E ANATOMOPATOLOGICHE I segni clinici delle malattie non sono strettamente specifici poiché alcuni dei sintomi e delle lesioni che si riscontrano negli animali malati e morti sono comuni anche ad altre malattie infettive dei crostacei. In linea generale i segni clinici e le lesioni anatomo-patologiche associati alla Sindrome di Taura sono riassunti nelle tabelle sottostanti. Sindrome di Taura SPECIE SENSIBILI T /salinità dell acqua SEGNI CLINICI ANATOMIA PATOLOGICA Gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei), gambero bianco del golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) > 20 C > 20 %o Letargia Nuoto superficiale(facile preda degli uccelli ittiofagi). Leggero arrossamento Episodi di elevata mortalità (soprattutto nei giovanili e durante la muta) Intestino vuoto. Leggero arrossamento della cuticola Forte arrossamento della coda Presenza di macchie nerastre Cuticola morbida Virus della Testa Gialla SPECIE SENSIBILI Gambero nero del Golfo (P. aztecus), Gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei), gambero bianco del golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris). T /salinità dell acqua > 20 C > 20 %o SEGNI CLINICI Letargia Nuoto irregolare lungo i bordi della vasca. Aumento dell appetito e poi inappetenza. Porzione anteriore giallastra Episodi di elevata mortalità (soprattutto nei giovanili > PL 20 e adulti). ANATOMIA PATOLOGICA Intestino vuoto. Porzione anteriore (cefalotorace o testa) pallida o giallastra Epatopancreas molto evidente Branchie bluastre
8 SCHEDA N. 5 CRITERI CLINICI, ANATOMOPATOLOGICI ED EPIDEMIOLOGICI PER AVANZARE SOSPETTO DI SINDROME DI TAURA Criteri Clinici Rilievi Anatomopatologici Epidemiologia Laboratorio Misure di controllo Rilievi Non ci sono segni clinici specifici. In corso di infezione si possono osservare i seguenti segni clinici: Letargia. Scarso appetito. Nuoto superficiale, anziché stare sul fondo gli animali si raggruppano in superficie o vicino all acqua di entrata (facile preda degli uccelli ittiofagi). Leggero arrossamento della cuticola, talvolta coda rossa. Episodi di elevata mortalità (soprattutto nei giovanili e durante la muta). Intestino vuoto. Leggero arrossamento della cuticola Forte arrossamento della coda Presenza di macchie di melanina nerastre sulla cuticola (pepper disease). Cuticola morbida anche in soggetti dopo la muta o adulti. Introduzioni illegali o da aziende infette. Diffusione per via orizzontale tramite feci, soggetti morti (cannibalismo), uccelli ittiofagi o insetti vettori. Utilizzo di attrezzature o mezzi di trasporto contaminati. Necessarie temperature e salinità elevate. La diagnosi della sindrome di Taura si effettua mediante: esami istologici, ibridazione in situ, RT-PCR e sequenziamento su post larve (PL), giovanili e soggetti adulti che vanno consegnati al laboratorio in giornata. Attualmente non sono disponibili trattamenti vaccinali e terapeutici. E possibile utilizzare in allevamento linee selezionate di P. vannamei resistenti all infezione e SPF (specific pathogen free). In caso di focolaio svuotare le vasche, distruggere gli animali morti e destinare al consumo umano quelli vivi, disinfettare le vasche con ipoclorito di sodio > 100 ppm o con calce in polvere (0.75 kg/mq)..
9 CRITERI CLINICI, ANATOMOPATOLOGICI ED EPIDEMIOLOGICI PER AVANZARE SOSPETTO DI MALATTIA DELLA TESTA GIALLA Criteri Rilievi Clinici Non ci sono segni clinici specifici. In corso di infezione si possono osservare i seguenti segni clinici: Letargia. Aumento dell appetito seguito da digiuno improvviso. Nuoto irregolare con gli animali lungo i bordi della vasca. Improvvisa mortalità (soprattutto nei giovanili > PL e negli adulti). Rilievi Anatomopatologici Epidemiologia Laboratorio Misure di controllo Intestino vuoto. Porzione anteriore (cefalotorace o testa) pallida o giallastra Epatopancreas molto evidente Branchie bluastre Introduzioni illegali o da aziende infette. Diffusione per via orizzontale tramite feci, soggetti morti (cannibalismo), uccelli ittiofagi o insetti vettori. Trasmissione verticale da riproduttori infetti. Utilizzo di attrezzature o mezzi di trasporto contaminati. Necessarie temperature e salinità elevate. L istopatologia può essere utilizzata come diagnosi preliminare durante episodi di malattia della testa gialla. Corpi inclusi intracitoplasmatici possono essere osservati in preparati a fresco di branchie, tessuto sottocuticolare ed in strisci di emolinfa. Gli emociti di soggetti non moribondi possono presentare picnosi e carioressi. La diagnosi di conferma richiede analisi specifiche tramite RT-PCR, Western blot, ibridazione in situ e TEM. Attualmente non sono disponibili trattamenti vaccinali e terapeutici. Introdurre solo animali provenienti da zone indenni dotati di certificato sanitario. Evitare stress negli animali durante il trasporto e la manipolazione. In caso di focolaio svuotare le vasche, distruggere gli animali morti e destinare al consumo umano quelli vivi, disinfettare le vasche con ipoclorito di sodio > 30 ppm o con calce in polvere (0.5 kg/mq)
10 SCHEDA N. 6 FONDATEZZA DEL SOSPETTO E CONFERMA DI INFEZIONE DA TAURA SYNDROME VIRUS O YELLOW HEAD VIRUS In ottemperanza all art. 26 punto 1 del D.Lgs. n. 148 dell 8 agosto 2008, in caso di sospetto o conferma della presenza di una delle malattie esotiche dei crostacei elencate nell allegato IV, parte II del sopracitato decreto, il servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale competente per territorio deve informare immediatamente il Ministero e la Regione mediante la compilazione della scheda in allegato 1. Inoltre, così come previsto al punto 2 del sopracitato articolo, se si osserva un aumento del tasso di mortalità, i casi di decesso devono essere denunciati al servizio veterinario. Al momento della segnalazione del sospetto, il veterinario ufficiale identifica colui che ha effettuato la segnalazione. Così come previsto dall art. 26 punto 3, la segnalazione del sospetto all Autorità competente, può essere effettuata da qualsiasi persona incaricata della cura degli animali. Qualora si sospetti la presenza di una malattia esotica o emergente dei crostacei, è necessario, così come previsto dall art. 28 punto 1 del D.lgs 148/2008, che il veterinario ufficiale proceda al prelievo dei campioni necessari per la conferma; i soggetti campionati devono essere inviati vivi e vitali oppure refrigerati al Centro di Referenza Nazionale per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei (CRN). Il materiale necessario per il prelievo è il seguente: - Contenitore isotermico: Temperatura di trasporto, max 10 C - Sacchetti in plastica La conferma del sospetto di infezione può essere fatta solo a seguito di esecuzione di esame RT- PCR secondo metodica OIE e/o EURL per le malattie dei crostacei, seguita da sequenziamento del prodotto di amplificazione. La conferma della diagnosi effettuata dal CRN viene fatta dal EURL per le malattie dei crostacei (CEFAS - Weymouth, UK), al quale il CRN invia i campioni risultati positivi. In attesa dei risultati degli esami di conferma, conformemente all art. 28 punto 2 del D.lgs 148/2008 è necessario che: a) l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia sia posta sotto controllo ufficiale e vengano adottate misure di lotta idonee a prevenire la diffusione della malattia ad altri animali acquatici; b) sia vietata la movimentazione in entrata e in uscita di animali d'acquacoltura dall azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, senza l'autorizzazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio; c) venga avviata l'indagine epidemiologica. L obiettivo dell indagine epidemiologica è quello di: a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia; b) accertare se animali di acquacoltura abbiano lasciato la zona o la zona destinata a molluschicoltura nel periodo precedente alla notifica del caso sospetto; c) indagare se sono state infettate altre aziende
11 SCHEDA n. 7 MISURE DA APPLICARE IN ALLEVAMENTO IN CASO DI CONFERMA E PROCEDURE PER L ABBATTIMENTO Prodotto in fase di allevamento In questo caso l autorità sanitaria competente per territorio interviene per evitare che il prodotto allevato venga spostato in altre aree. Gli animali clinicamente sani, a fine ciclo di allevamento, possono essere venduti per scopi alimentari. I crostacei non sono soggetti a norme specifiche relative al benessere animale. La morte dell animale avviene per asfissia una volta estratto dall acqua. Successivamente gli animali vengono smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa riguardante lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale ( reg. CE 1069/2009 e s.m.i). SCHEDA n. 8 PULIZIA E DISINFEZIONE TERMINATO L ABBATTIMENTO In caso di focolaio svuotare le vasche e disinfettarle con: ipoclorito di sodio > 100 ppm o con calce in polvere 0.75 kg/mq (Malattia di Taura) ipoclorito di sodio > 30 ppm o con calce in polvere 0.5 kg/mq (Malattia della testa gialla) SCHEDA n. 9 FERMO DELL IMPIANTO E RIPOPOLAMENTO L impianto può essere riavviato dopo eliminazione di tutto l effettivo presente e previo trattamento di pulizia e disinfezione secondo le modalità della scheda n. 12. Se nell impianto sono presenti altri gruppi di animali allevati in vasche nettamente separate, è possibile continuarne l allevamento previo sopraluogo e relativo parere dell autorità sanitaria competente, in collaborazione con il CRN delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei in attesa di destinare gli animali al consumo umano.
12 ALLEGATO 1 SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA (Decisione 2008/650/CE del 30/07/08) (Da compilare già in fase di sospetto e da inviare al Ministero della Salute via fax o via mail, all Ufficio Veterinario Regionale competente e via fax al Centro di Referenza Nazionale 1. Data dell'invio 2. Ora dell'invio 3. Stato d'origine 4. Nome della malattia e, se del caso, tipo di virus 5. Numero di serie del focolaio 6. Tipo di focolaio (primario/secondario) 7. Numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa 8. Regione e ubicazione geografica dell'azienda 9. Altre regioni cui si applicano restrizioni 10. Data di conferma 11. Data di insorgenza del sospetto di malattia 12. Data presunta della prima infezione nell'azienda 13. Origine della malattia 14. Misure di controllo 15. Numero di animali suscettibili alla malattia presenti nell'azienda: crostacei (peso o numero) 16. Numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) crostacei (peso o numero) 17. Numero di animali morti nell'azienda: a) crostacei (peso o numero) 18. Numero di animali macellati: a) crostacei (peso o numero) 19. Numero di carcasse distrutte: a) crostacei (peso o numero) 20. Data (stimata) per il termine dell'abbattimento (se del caso) 21. Data (stimata) per il termine della distruzione (se del caso) N.B. I punti 1, 2, 3 e 5 sono di competenza del Ministero della Salute.
Malattia Vescicolare del Suino
 1 MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO La malattia Malattia Vescicolare del Suino La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale (genere Enterovirus appartenente
1 MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO La malattia Malattia Vescicolare del Suino La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale (genere Enterovirus appartenente
Anna Padovani, Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti RER
 Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d acquacoltura e ai relativi prodotti Capo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni:
Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d acquacoltura e ai relativi prodotti Capo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni:
controllo delle malattie dei pesci
 Epidemiologia nel controllo delle malattie dei pesci Dr Ignacio de Blas Facoltà di Veterinaria Università di Zaragoza (Spagna) Erice, 24 ottobre 2008 Workshop Acquacoltura mediterranea: aspetti normativi
Epidemiologia nel controllo delle malattie dei pesci Dr Ignacio de Blas Facoltà di Veterinaria Università di Zaragoza (Spagna) Erice, 24 ottobre 2008 Workshop Acquacoltura mediterranea: aspetti normativi
14/04/2014. EZIOLOGIA Fam. Picornaviridae gen. Enterovirus RNA 1, nm sprovvisto di envelope molto resistente
 Malattia Vescicolare del Suino EZIOLOGIA Fam. Picornaviridae gen. Enterovirus RNA 1, 28-30 nm sprovvisto di envelope molto resistente 1 sierotipo 4 gruppi Malattia Vescicolare del Suino (MVS) Il virus
Malattia Vescicolare del Suino EZIOLOGIA Fam. Picornaviridae gen. Enterovirus RNA 1, 28-30 nm sprovvisto di envelope molto resistente 1 sierotipo 4 gruppi Malattia Vescicolare del Suino (MVS) Il virus
ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE -AIS -
 ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE -AIS - Centro di Referenza Nazionale per le Patologie dei Pesci, Molluschi e Crostacei Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell Università, 10 35020 Legnaro-
ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE -AIS - Centro di Referenza Nazionale per le Patologie dei Pesci, Molluschi e Crostacei Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell Università, 10 35020 Legnaro-
IRIDOVIROSI DEL PESCE GATTO
 IRIDOVIROSI DEL PESCE GATTO Bovo G., Selli L. e Manfrin A. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE Viale dell Università, 10-35020 Legnaro -PD. IRIDOVIROSI DEL PESCE GATTO Denominazione e storia
IRIDOVIROSI DEL PESCE GATTO Bovo G., Selli L. e Manfrin A. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE Viale dell Università, 10-35020 Legnaro -PD. IRIDOVIROSI DEL PESCE GATTO Denominazione e storia
SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER PESTI SUINE
 ALLEGATO 14: fac - simile scheda di indagine epidemiologica SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER PESTI SUINE sospetto n.: data codice allevamento conferma n.: data Pag. 66 di 75 L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
ALLEGATO 14: fac - simile scheda di indagine epidemiologica SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER PESTI SUINE sospetto n.: data codice allevamento conferma n.: data Pag. 66 di 75 L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE E PESTE SUINA CLASSICA DEL SUINO 1. ANAGRAFE DELL AZIENDA
 INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE E PESTE SUINA CLASSICA DEL SUINO La malattia è stata diagnosticata/sospettata in seguito a: SOSPETTO CLINICO/ANATOMO-PATOLOGICO SIEROPOSITIVITA ISOLAMENTO
INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE E PESTE SUINA CLASSICA DEL SUINO La malattia è stata diagnosticata/sospettata in seguito a: SOSPETTO CLINICO/ANATOMO-PATOLOGICO SIEROPOSITIVITA ISOLAMENTO
Charvensod 12/02/2001
 Charvensod 12/02/2001 1 Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili Gruppo di malattie degenerative che colpiscono il Sistema Nervoso Centrale dell uomo e degli animali 2 Forme nell uomo Malattia di Creutzfeldt-
Charvensod 12/02/2001 1 Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili Gruppo di malattie degenerative che colpiscono il Sistema Nervoso Centrale dell uomo e degli animali 2 Forme nell uomo Malattia di Creutzfeldt-
Malattia del Becco e delle Penne degli Psittacidi (PBFD) Dr. Ludovico Dipineto Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II
 Malattia del Becco e delle Penne degli Psittacidi (PBFD) Dr. Ludovico Dipineto Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II PBFD Una delle principali patologie infettive ad eziologia
Malattia del Becco e delle Penne degli Psittacidi (PBFD) Dr. Ludovico Dipineto Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II PBFD Una delle principali patologie infettive ad eziologia
ALLEGATO. Modalità di attuazione del piano di sorveglianza per Aethina tumida sul territorio italiano
 ALLEGATO Modalità di attuazione del piano di sorveglianza per Aethina tumida sul territorio italiano Criteri per l esecuzione di un piano di sorveglianza negli apiari per la ricerca di Aethina tumida Il
ALLEGATO Modalità di attuazione del piano di sorveglianza per Aethina tumida sul territorio italiano Criteri per l esecuzione di un piano di sorveglianza negli apiari per la ricerca di Aethina tumida Il
REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE
 24.10.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 280/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
24.10.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 280/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
APPROCCIO DIAGNOSTICO ALL ABORTO BOVINO. Giovanni Filippini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche
 APPROCCIO DIAGNOSTICO ALL ABORTO BOVINO Giovanni Filippini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche Latina 2 Ottobre 2009 Applicazione di di strategie Patologia in in allevamento
APPROCCIO DIAGNOSTICO ALL ABORTO BOVINO Giovanni Filippini Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche Latina 2 Ottobre 2009 Applicazione di di strategie Patologia in in allevamento
PESTE SUINA AFRICANA. African Swine Fever. Peste suina africana. Peste suina africana
 PESTE SUINA AFRICANA African Swine Fever Peste suina africana Grave malattia infettiva virale e contagiosa del suino domestico e selvatico trasmessa anche da zecche caratterizzata da febbre e coinvolgimento
PESTE SUINA AFRICANA African Swine Fever Peste suina africana Grave malattia infettiva virale e contagiosa del suino domestico e selvatico trasmessa anche da zecche caratterizzata da febbre e coinvolgimento
Blue tongue aggiornamenti epidemiologici LEBANA BONFANTI IZSVE
 Blue tongue aggiornamenti epidemiologici LEBANA BONFANTI IZSVE Blue tongue - 2015 In data 21 Agosto 2015 è stato segnalato un sospetto clinico di BT in un allevamento nella regione di Allier, nella Francia
Blue tongue aggiornamenti epidemiologici LEBANA BONFANTI IZSVE Blue tongue - 2015 In data 21 Agosto 2015 è stato segnalato un sospetto clinico di BT in un allevamento nella regione di Allier, nella Francia
West Nile Disease. Situazione epidemiologica. N Ottobre 2008 ore 17:00
 West Nile Disease N. 13 7 Ottobre 2008 ore 17:00 Situazione epidemiologica 7 Ottobre 2008 Ad oggi sono stati segnalati 20 cavalli che hanno avuto sintomatologia clinica riferibile a West Nile disease (WND)
West Nile Disease N. 13 7 Ottobre 2008 ore 17:00 Situazione epidemiologica 7 Ottobre 2008 Ad oggi sono stati segnalati 20 cavalli che hanno avuto sintomatologia clinica riferibile a West Nile disease (WND)
PIANO NAZIONALE PER LE EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO
 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali PIANO NAZIONALE PER LE EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO MANUALE
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali PIANO NAZIONALE PER LE EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO MANUALE
Definizione ed obiettivi dell Igiene. Concetto di salute e malattia. Epidemiologia delle malattie infettive
 Obiettivi dell igiene CONTENUTI CORSO DI Definizione ed obiettivi dell Igiene. Concetto di salute e malattia Epidemiologia delle malattie infettive IGIENE Catena di contagio, sorgenti e serbatoi di infezione,
Obiettivi dell igiene CONTENUTI CORSO DI Definizione ed obiettivi dell Igiene. Concetto di salute e malattia Epidemiologia delle malattie infettive IGIENE Catena di contagio, sorgenti e serbatoi di infezione,
Ministero della Salute. Mixomatosi Aspetti legislativi e di polizia veterinaria. Verso una revisione della normativa?
 Ministero della Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Mixomatosi Aspetti
Ministero della Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Mixomatosi Aspetti
Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI
 Ministero della Salute Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI CEA IZS-TORINO COVEPI IZS-TERAMO
Ministero della Salute Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI CEA IZS-TORINO COVEPI IZS-TERAMO
LA SCRAPIE: programma 2010 2012 e identificazione degli animali
 LA SCRAPIE: programma 2010 2012 e identificazione degli animali CARATTERISTICHE DELLA MALATTIA Caratterizzata da lungo periodo di incubazione Dura a lungo ed è mortale Colpisce gli animali di età compresa
LA SCRAPIE: programma 2010 2012 e identificazione degli animali CARATTERISTICHE DELLA MALATTIA Caratterizzata da lungo periodo di incubazione Dura a lungo ed è mortale Colpisce gli animali di età compresa
PRODUCT NOTICE Segnalazione di un potenziale problema relativo ad un prodotto
 Product Safety Group 1201 South Second Street Milwaukee, WI USA 53204 productsafety@ra.rockwell.com PRODUCT NOTICE Segnalazione di un potenziale problema relativo ad un prodotto Serie 20A, Inverter PowerFlex
Product Safety Group 1201 South Second Street Milwaukee, WI USA 53204 productsafety@ra.rockwell.com PRODUCT NOTICE Segnalazione di un potenziale problema relativo ad un prodotto Serie 20A, Inverter PowerFlex
Anagrafe delle aziende di acquacoltura: aspetti pratici
 Gaetano Trevisi U.O. Attività Veterinarie A.U.S.L. FERRARA Anagrafe delle aziende di acquacoltura: aspetti pratici Imprese di acquacoltura: anagrafe e autorizzazione ai sensi della DGR 601/2013 Ferrara,
Gaetano Trevisi U.O. Attività Veterinarie A.U.S.L. FERRARA Anagrafe delle aziende di acquacoltura: aspetti pratici Imprese di acquacoltura: anagrafe e autorizzazione ai sensi della DGR 601/2013 Ferrara,
problematiche S.O.A. in ambito urbano Angela Soriani Ferrara, 28 ottobre 2014
 problematiche S.O.A. in ambito urbano Angela Soriani Ferrara, 28 ottobre 2014 Aspetti particolari della gestione di S.O.A. in ambito urbano Raccolta e smaltimento carcasse/resti di animali da compagnia
problematiche S.O.A. in ambito urbano Angela Soriani Ferrara, 28 ottobre 2014 Aspetti particolari della gestione di S.O.A. in ambito urbano Raccolta e smaltimento carcasse/resti di animali da compagnia
Il decreto D.lgs. 148/2008 ha voluto completare il quadro interno dal punto di vista della polizia sanitaria includendo nuove specie di animali, in
 Il decreto D.lgs. 148/2008 ha voluto completare il quadro interno dal punto di vista della polizia sanitaria includendo nuove specie di animali, in particolare marine, allevate dal settore dell acquacoltura
Il decreto D.lgs. 148/2008 ha voluto completare il quadro interno dal punto di vista della polizia sanitaria includendo nuove specie di animali, in particolare marine, allevate dal settore dell acquacoltura
INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA:
 CENTRO REGIONALE EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA: 1999 2003 Stefano Marangon Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
CENTRO REGIONALE EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA: 1999 2003 Stefano Marangon Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (82/894/CEE)
 1982L0894 IT 01.01.2013 012.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 concernente
1982L0894 IT 01.01.2013 012.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 concernente
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER MALATTIA DI AUJESZKY DEL SUINO SIEROPOSITIVITA * CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA SINTOMI CLINICI
 INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER MALATTIA DI AUJESZKY DEL SUINO L INFEZIONE E STATA DIAGNOSTICATA/SOSPETTATA IN SEGUITO A: SIEROPOSITIVITA * CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA SINTOMI CLINICI * controllo eseguito
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER MALATTIA DI AUJESZKY DEL SUINO L INFEZIONE E STATA DIAGNOSTICATA/SOSPETTATA IN SEGUITO A: SIEROPOSITIVITA * CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA SINTOMI CLINICI * controllo eseguito
SCHMALLENBERG: DISPOSIZIONI NORMATIVE E MISURE DI CONTROLLO IN ITALIA
 SCHMALLENBERG: DISPOSIZIONI NORMATIVE E MISURE DI CONTROLLO IN ITALIA MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale
SCHMALLENBERG: DISPOSIZIONI NORMATIVE E MISURE DI CONTROLLO IN ITALIA MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale
Bordetellosi. Prof. Alessandro FIORETTI Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II
 Prof. Alessandro FIORETTI Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II Patologia infettiva altamente contagiosa che colpisce prevalentemente il tacchino EZIOLOGIA Inizialmente identificato
Prof. Alessandro FIORETTI Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II Patologia infettiva altamente contagiosa che colpisce prevalentemente il tacchino EZIOLOGIA Inizialmente identificato
Decreto Ministeriale 27 marzo 2002
 Per garantire un efficace sistema di rintracciabilità il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha istituito un sistema di controllo con requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti
Per garantire un efficace sistema di rintracciabilità il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha istituito un sistema di controllo con requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti
VACCINAZIONI E REQUISITI DOCUMENTALI CONNESSI: LA STORIA E L'ATTUALITA'
 LE NUOVE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INERENTI LA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA VACCINAZIONI E REQUISITI DOCUMENTALI CONNESSI: LA STORIA E L'ATTUALITA'
LE NUOVE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INERENTI LA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA VACCINAZIONI E REQUISITI DOCUMENTALI CONNESSI: LA STORIA E L'ATTUALITA'
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE REGIONE LAZIO
 OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE REGIONE LAZIO BRUCELLOSI DEGLI OVINI E DEI CAPRINI SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO La scheda debitamente compilata deve essere consegnata all'osservatorio
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE REGIONE LAZIO BRUCELLOSI DEGLI OVINI E DEI CAPRINI SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO La scheda debitamente compilata deve essere consegnata all'osservatorio
Sistema di sorveglianza nazionale della ROSOLIA IN GRAVIDANZA e della ROSOLIA CONGENITA
 Sistema di sorveglianza nazionale della ROSOLIA IN GRAVIDANZA e della ROSOLIA CONGENITA Il sistema di sorveglianza nazionale - dal 2005 D.M. del 14 ottobre 2004: a partire dal 1 gennaio 2005, l infezione
Sistema di sorveglianza nazionale della ROSOLIA IN GRAVIDANZA e della ROSOLIA CONGENITA Il sistema di sorveglianza nazionale - dal 2005 D.M. del 14 ottobre 2004: a partire dal 1 gennaio 2005, l infezione
LA GUIDA FACILE ALL HACCP. Guida all analisi e controllo dei rischi nel trattamento degli alimenti
 LA GUIDA FACILE ALL HACCP Guida all analisi e controllo dei rischi nel trattamento degli alimenti INTRODUZIONE In qualsiasi tipo di attività ogni singolo passo che parte dalla preparazione dei cibi e
LA GUIDA FACILE ALL HACCP Guida all analisi e controllo dei rischi nel trattamento degli alimenti INTRODUZIONE In qualsiasi tipo di attività ogni singolo passo che parte dalla preparazione dei cibi e
PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE.
 PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Con Dispositivo Dirigenziale del Ministero
PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Con Dispositivo Dirigenziale del Ministero
West Nile Disease. Situazione epidemiologica. N Novembre 2008 ore 16:00. hanno permesso di evidenziare ulteriori 98 focolai d infezione.
 West Nile Disease N. 45 24 Novembre 28 ore 6: Situazione epidemiologica 24 Novembre 28 I focolai confermati fino ad oggi sono 7, distribuiti in 8 province (Figura e Tabella ). Le seguenti azioni di sorveglianza
West Nile Disease N. 45 24 Novembre 28 ore 6: Situazione epidemiologica 24 Novembre 28 I focolai confermati fino ad oggi sono 7, distribuiti in 8 province (Figura e Tabella ). Le seguenti azioni di sorveglianza
MALATTIA DI NEWCASTLE
 Allegato 6 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - Regione Veneto MALATTIA DI NEWCASTLE SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA 2003 Data compilazione.../.../...
Allegato 6 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - Regione Veneto MALATTIA DI NEWCASTLE SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA 2003 Data compilazione.../.../...
ALLEVAMENTO OVICAPRINO CON METODO BIOLOGICO. Giovanna Nicastro Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia
 ALLEVAMENTO OVICAPRINO CON METODO BIOLOGICO Giovanna Nicastro Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia 12 novembre 2014 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reg. (CE) n 834/2007 del Consiglio Reg 889/2008
ALLEVAMENTO OVICAPRINO CON METODO BIOLOGICO Giovanna Nicastro Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia 12 novembre 2014 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reg. (CE) n 834/2007 del Consiglio Reg 889/2008
DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLE MALATTIE INFETTIVE
 DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLE MALATTIE INFETTIVE L isolamento di un virus o di un batterio implica l impiego di particolari tecniche che richiedono giorni o settimane prima dell identificazione Ne consegue
DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLE MALATTIE INFETTIVE L isolamento di un virus o di un batterio implica l impiego di particolari tecniche che richiedono giorni o settimane prima dell identificazione Ne consegue
Linee guida per la applicazione del D.Lvo 148 FERRARA 10 GIUGNO 2013. Anna Padovani & Silvano Natalini
 Linee guida per la applicazione del D.Lvo 148 FERRARA 10 GIUGNO 2013 Anna Padovani & Silvano Natalini 1 D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia
Linee guida per la applicazione del D.Lvo 148 FERRARA 10 GIUGNO 2013 Anna Padovani & Silvano Natalini 1 D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia
REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA
 REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA Approvato con deliberazione Consiliare n. 66 del 30 dicembre 2013 Pag. 1 di 5 ART 1. FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina l allevamento, la detenzione,
REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA Approvato con deliberazione Consiliare n. 66 del 30 dicembre 2013 Pag. 1 di 5 ART 1. FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina l allevamento, la detenzione,
Patogeni emergenti nel latte: il ruolo di Salmonella spp. Salmonellosi. Salmonellosi nei bovini
 5 Congresso annuale Mastitis Council Italia LODI 9 febbraio 2007 Patogeni emergenti nel latte: il ruolo di Salmonella spp Dott. Antonio Barberio Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sezione
5 Congresso annuale Mastitis Council Italia LODI 9 febbraio 2007 Patogeni emergenti nel latte: il ruolo di Salmonella spp Dott. Antonio Barberio Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sezione
AUTORIZZAZIONE SANITARIA IMPRESE ACQUACOLTURA E STABILIMENTI DI LAVORAZIONE
 Pagina 1 di 6 Rev. 0 1. SCOPO Definire le modalità e le responsabilità relative all delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti dell acquacoltura. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Pagina 1 di 6 Rev. 0 1. SCOPO Definire le modalità e le responsabilità relative all delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti dell acquacoltura. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE
I rischi in piscina:dalle infezioni all incidente in vasca.
 I rischi in piscina:dalle infezioni all incidente in vasca. Seminari regionali per gestori di piscine 2007 Garda 13/04, Jesolo 03/05, Caorle 10/05, Chioggia 22/06 Giacomo Marchese Azienda Ulss 12 - Servizio
I rischi in piscina:dalle infezioni all incidente in vasca. Seminari regionali per gestori di piscine 2007 Garda 13/04, Jesolo 03/05, Caorle 10/05, Chioggia 22/06 Giacomo Marchese Azienda Ulss 12 - Servizio
REGIONE COD PROVINCIA COD COMUNE COD ASL COD. COGNOME NOME (iniziali) SESSO M F CONIUGATO si no N conviventi
 Allegato 1 MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO III MALATTIE INFETTIVE E PROFILASSI INTERNAZIONALE - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE SCHEDA PER LA NOTIFICA DI MORBO
Allegato 1 MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO III MALATTIE INFETTIVE E PROFILASSI INTERNAZIONALE - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE SCHEDA PER LA NOTIFICA DI MORBO
La sorveglianza della legionellosi
 La sorveglianza ed il controllo della legionellosi: le linee guida regionali Flussi informativi per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi Bianca Maria Borrini Dipartimento di Sanità Pubblica
La sorveglianza ed il controllo della legionellosi: le linee guida regionali Flussi informativi per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi Bianca Maria Borrini Dipartimento di Sanità Pubblica
Il Piano BVD in provincia di Trento -Stato dell arte-
 Il Piano BVD in provincia di Trento -Stato dell arte- Dr. Enrico Francione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Folgaria, 04-03-2015 Vet Neve - La diarrea virale del bovino (BVD-MD) è una
Il Piano BVD in provincia di Trento -Stato dell arte- Dr. Enrico Francione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Folgaria, 04-03-2015 Vet Neve - La diarrea virale del bovino (BVD-MD) è una
SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
 Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - Regione Veneto SCHEDA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA POSITIVITA
Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - Regione Veneto SCHEDA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA POSITIVITA
REGIONE PIEMONTE Assessorato alla Sanità Direzione Sanità Pubblica
 REGIONE PIEMONTE Assessorato alla Sanità Direzione Sanità Pubblica Marzo 2010 La bluetongue (BT), malattia della lingua blu o febbre catarrale ovina, è una malattia di origine virale che colpisce bovini,
REGIONE PIEMONTE Assessorato alla Sanità Direzione Sanità Pubblica Marzo 2010 La bluetongue (BT), malattia della lingua blu o febbre catarrale ovina, è una malattia di origine virale che colpisce bovini,
Malattia Vescicolare del Suino
 Malattia Vescicolare del Suino Malattia contagiosa causata da un enterovirus Colpisce solo il suino Indistinguibile clinicamente da afta epizootica Spesso asintomatica (solo sieroconversione) Non mortale
Malattia Vescicolare del Suino Malattia contagiosa causata da un enterovirus Colpisce solo il suino Indistinguibile clinicamente da afta epizootica Spesso asintomatica (solo sieroconversione) Non mortale
RELAZIONE TECNICA (Allegato a NOTIFICA ai sensi dell art. 6 del Reg. CE n. 852/2004)
 RELAZIONE TECNICA (Allegato a NOTIFICA ai sensi dell art. 6 del Reg. CE n. 852/2004) Denominazione della Ditta Sede legale Indirizzo dell attività Descrizione dettagliata dell attività svolta: Numero addetti:
RELAZIONE TECNICA (Allegato a NOTIFICA ai sensi dell art. 6 del Reg. CE n. 852/2004) Denominazione della Ditta Sede legale Indirizzo dell attività Descrizione dettagliata dell attività svolta: Numero addetti:
Piano di sorveglianza BSE 2002 - pagina 1 di 5
 Allegato A ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA Piano di segnalazione dei casi sospetti di infezione Il presente programma di emergenza per l Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) considera le situazioni
Allegato A ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA Piano di segnalazione dei casi sospetti di infezione Il presente programma di emergenza per l Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) considera le situazioni
I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi
 I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi Franco Mutinelli Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro di referenza nazionale per l apicoltura I controlli ufficiali
I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi Franco Mutinelli Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro di referenza nazionale per l apicoltura I controlli ufficiali
Toxoplasma gondii Un problema ispettivo attuale? Indagine epidemiologica in suini macellati a domicilio in Toscana.
 Toxoplasma gondii Un problema ispettivo attuale? Indagine epidemiologica in suini macellati a domicilio in Toscana. Dati preliminari Daniela Gianfaldoni e Francesca Mancianti Dipartimento di Patologia
Toxoplasma gondii Un problema ispettivo attuale? Indagine epidemiologica in suini macellati a domicilio in Toscana. Dati preliminari Daniela Gianfaldoni e Francesca Mancianti Dipartimento di Patologia
CENTRO ITTICO VALDASTICO Veneto Agricoltura Forme Cerati n. 1 Valdastico (VI)
 Riconoscimento azienda di acquacoltura indenne da VHS e IHN CENTRO ITTICO VALDASTICO Veneto Agricoltura Forme Cerati n. 1 Valdastico (VI) Caratteristiche strutturali essenziali dell Azienda (Allegato C
Riconoscimento azienda di acquacoltura indenne da VHS e IHN CENTRO ITTICO VALDASTICO Veneto Agricoltura Forme Cerati n. 1 Valdastico (VI) Caratteristiche strutturali essenziali dell Azienda (Allegato C
Zoonosi nei selvatici: le nuove linee guida del piano nazionale di sorveglianza
 Fauna selvatica in Liguria: valutazione dell'attività svolta e nuove prospettive Pontedassio, (IM) 16-12-16 Zoonosi nei selvatici: le nuove linee guida del piano nazionale di sorveglianza Riccardo Orusa
Fauna selvatica in Liguria: valutazione dell'attività svolta e nuove prospettive Pontedassio, (IM) 16-12-16 Zoonosi nei selvatici: le nuove linee guida del piano nazionale di sorveglianza Riccardo Orusa
CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER
 CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER Crimean-Congo haemorrhagic fever Riconosciuta per la prima volta in Crimea nel 1944, poi più tardi in Congo nel 1969. Infezione virale di ruminanti ed erbivori domestici
CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER Crimean-Congo haemorrhagic fever Riconosciuta per la prima volta in Crimea nel 1944, poi più tardi in Congo nel 1969. Infezione virale di ruminanti ed erbivori domestici
LINEE-GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL MRSA
 AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE LINEE-GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL MRSA (STAFILOCOCCO AUREO METICILLINO RESISTENTE) aggiornate ad Agosto 2001 DEFINIZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE LINEE-GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL MRSA (STAFILOCOCCO AUREO METICILLINO RESISTENTE) aggiornate ad Agosto 2001 DEFINIZIONE
Il controllo del Benessere Animale durante il trasporto. Macellazione d urgenzad. Ferrara, 31 maggio 2013 dott. Andrea Poli
 Il controllo del Benessere Animale durante il trasporto Macellazione d urgenzad Ferrara, 31 maggio 2013 dott. Andrea Poli Macellazione d urgenza al di fuori del 5. Definizioni Stordimento: qualsiasi processo
Il controllo del Benessere Animale durante il trasporto Macellazione d urgenzad Ferrara, 31 maggio 2013 dott. Andrea Poli Macellazione d urgenza al di fuori del 5. Definizioni Stordimento: qualsiasi processo
Dr. Francesco MARUCCI
 1 Malattia infettiva che può aversi nei daini, cervi, in casi eccezionali nei caprioli provocata da micobatteri in particolare Mycobacterium bovis (bovino e ungulati selvatici) ma anche: Mycobacterium
1 Malattia infettiva che può aversi nei daini, cervi, in casi eccezionali nei caprioli provocata da micobatteri in particolare Mycobacterium bovis (bovino e ungulati selvatici) ma anche: Mycobacterium
Sistema di sorveglianza nazionale della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita
 Sistema di sorveglianza nazionale della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita Bianca Maria Borrini Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della Rosolia congenita. Corso ROSOLIA CONGENITA
Sistema di sorveglianza nazionale della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita Bianca Maria Borrini Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della Rosolia congenita. Corso ROSOLIA CONGENITA
15/10/2015 MRSA MRSA. Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Resistenza codificata dal gene meca
 Caratteristiche di antibioticoresistenza in Staphylococcus aureus isolati negli allevamenti intensivi di bovini e suini nel Veneto: aspetti di Sanità Pubblica MRSA Methicillin-Resistant Staphylococcus
Caratteristiche di antibioticoresistenza in Staphylococcus aureus isolati negli allevamenti intensivi di bovini e suini nel Veneto: aspetti di Sanità Pubblica MRSA Methicillin-Resistant Staphylococcus
IL PROBLEMA DELLA VIROSI DA GPGV IN VITICOLTURA. Alessandro Raiola
 IL PROBLEMA DELLA VIROSI DA GPGV IN VITICOLTURA Alessandro Raiola LA SCOPERTA DI UN NUOVO VIRUS DELLA VITE 2012 GPGV: Grapevine pinot gris virus Il GPGV, Virus del Pinot Grigio, è stato identificato per
IL PROBLEMA DELLA VIROSI DA GPGV IN VITICOLTURA Alessandro Raiola LA SCOPERTA DI UN NUOVO VIRUS DELLA VITE 2012 GPGV: Grapevine pinot gris virus Il GPGV, Virus del Pinot Grigio, è stato identificato per
Eziologia e diagnosi della malattia di Aujeszky
 Scuola di Specializzazione di atologia suina Situazione attuale della Malattia di Aujeszky Salone polifunzionale S. Giovanni Moretta (TO) 23 ovembre 2007 Eziologia e diagnosi della malattia di Aujeszky
Scuola di Specializzazione di atologia suina Situazione attuale della Malattia di Aujeszky Salone polifunzionale S. Giovanni Moretta (TO) 23 ovembre 2007 Eziologia e diagnosi della malattia di Aujeszky
Rischio Biologico D.lgs. 81/08
 Rischio Biologico D.lgs. 81/08 TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 266 - Campo di applicazione 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività
Rischio Biologico D.lgs. 81/08 TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 266 - Campo di applicazione 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività
PRODUCT NOTICE Notifica di una possibile anomalia del prodotto. Controllori GuardLogix 1756-L6xS, serie B
 Product Safety Group 1201 South Second Street Milwaukee, WI USA 53204 productsafety@ra.rockwell.com PRODUCT NOTICE Notifica di una possibile anomalia del prodotto Controllori GuardLogix 1756-L6xS, serie
Product Safety Group 1201 South Second Street Milwaukee, WI USA 53204 productsafety@ra.rockwell.com PRODUCT NOTICE Notifica di una possibile anomalia del prodotto Controllori GuardLogix 1756-L6xS, serie
BLUE TONGUE: LA PROFILASSI VACCINALE IN SARDEGNA
 Gli indicatori macrostrutturali di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie BLUE TONGUE: LA PROFILASSI VACCINALE IN SARDEGNA di Fausto Sulis, Renato Uleri, Cristiana Patta e Sandro Rolesu Il 1
Gli indicatori macrostrutturali di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie BLUE TONGUE: LA PROFILASSI VACCINALE IN SARDEGNA di Fausto Sulis, Renato Uleri, Cristiana Patta e Sandro Rolesu Il 1
CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI : UN RISCHIO o UN OPPORTUNITA
 Ordine Medici Veterinari di Verona 10 maggio 2011 CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI : UN RISCHIO o UN OPPORTUNITA Loris Alborali, Mariagrazia Zanoni, Paolo Cordioli Istituto
Ordine Medici Veterinari di Verona 10 maggio 2011 CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI : UN RISCHIO o UN OPPORTUNITA Loris Alborali, Mariagrazia Zanoni, Paolo Cordioli Istituto
Informativa in base all art. 43, comma 1, Nr. 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (Abbr. ted. IfSG)
 Timbro dell Ufficio sanitario Informativa in base all art. 43, comma 1, Nr. 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (Abbr. ted. IfSG) Informazioni sanitarie per la manipolazione degli alimenti Le
Timbro dell Ufficio sanitario Informativa in base all art. 43, comma 1, Nr. 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (Abbr. ted. IfSG) Informazioni sanitarie per la manipolazione degli alimenti Le
Proposta campionamento a seguito di positività per Blue tongue in Regione Veneto
 Proposta campionamento a seguito di positività per Blue tongue in Regione Veneto In data 31 agosto 2016 è stato confermato da parte del CRN un sospetto Blue tongue in un gregge che effettua il pascolo
Proposta campionamento a seguito di positività per Blue tongue in Regione Veneto In data 31 agosto 2016 è stato confermato da parte del CRN un sospetto Blue tongue in un gregge che effettua il pascolo
REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE
 16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni
16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni
LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
 LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 1 OMS : 10 punti alla base della prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti: 1. Scegliere i prodotti che abbiano subito trattamenti idonei ad assicurarne l innocuità
LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 1 OMS : 10 punti alla base della prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti: 1. Scegliere i prodotti che abbiano subito trattamenti idonei ad assicurarne l innocuità
ACQUACOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA: ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LVO 148/2008. Silvano Natalini
 ACQUACOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA: ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LVO 148/2008 FERRARA 24 GIUGNO 2015 Silvano Natalini Quadro normativo nazionale/oggi DLgs n.148/2008 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa
ACQUACOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA: ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LVO 148/2008 FERRARA 24 GIUGNO 2015 Silvano Natalini Quadro normativo nazionale/oggi DLgs n.148/2008 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa
definizione (definizione sorveglianza in sanità pubblica, CDC) definizione Terrestrial Animal Health Code OIE
 SORVEGLIANZA definizione sistematica raccolta, archiviazione, analisi e interpretazione di dati, seguita da una diffusione delle informazioni a tutte le persone che le hanno fornite e a coloro che devono
SORVEGLIANZA definizione sistematica raccolta, archiviazione, analisi e interpretazione di dati, seguita da una diffusione delle informazioni a tutte le persone che le hanno fornite e a coloro che devono
Compiti del responsabile dell impresa
 Linee guida regionali per l applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011 Compiti del responsabile dell impresa 1. Presenta domanda di autorizzazione al Servizio Veterinario dell Az- A.U.L.S.S.
Linee guida regionali per l applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011 Compiti del responsabile dell impresa 1. Presenta domanda di autorizzazione al Servizio Veterinario dell Az- A.U.L.S.S.
Materiale didattico validato da: Il Rischio Biologico. Rev. 2 ott Rischio biologico slide 1 di 16
 Il Rischio Biologico Rev. 2 ott. 2009 Rischio biologico slide 1 di 16 Definizione Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito all esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e muffe),
Il Rischio Biologico Rev. 2 ott. 2009 Rischio biologico slide 1 di 16 Definizione Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito all esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e muffe),
* Utilizzare punteggi intermedi per situazioni non contemplate
 Manuale PTBC-VacVit Rev. 0 All. SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE DELL INFEZIONE PARATUBERCOLARE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA CARNE (linea vacca-vitello) A. ZONA PARTO Dal momento
Manuale PTBC-VacVit Rev. 0 All. SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE DELL INFEZIONE PARATUBERCOLARE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA CARNE (linea vacca-vitello) A. ZONA PARTO Dal momento
PRESENZA DI MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS NEL SUD ITALIA: PREVALENZA E CONTAMINAZIONE DEL LATTE
 PRESENZA DI MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS NEL SUD ITALIA: PREVALENZA E CONTAMINAZIONE DEL LATTE Andrea Serraino, Giacomo Marchetti, Federica Giacometti Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
PRESENZA DI MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS NEL SUD ITALIA: PREVALENZA E CONTAMINAZIONE DEL LATTE Andrea Serraino, Giacomo Marchetti, Federica Giacometti Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
COME DEVE ESSERE TENUTO IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO ai sensi D.Lgs. 148/08 art. 9 (Allegato A Decreto Ministeriale 3 agosto 2011)
 NOTE ESPLICATIVE Il presente registro integrato è conforme alla lettera circolare del Ministero della Salute DGSA 0015496-P del 06.09.2011 ed alla nota dell Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa,
NOTE ESPLICATIVE Il presente registro integrato è conforme alla lettera circolare del Ministero della Salute DGSA 0015496-P del 06.09.2011 ed alla nota dell Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa,
L attività del Consorzio del Prosciutto Toscano
 L attività del Consorzio del Prosciutto Toscano Regione Toscana 26 febbraio 2013 Il Prosciutto Toscano Riconoscimento della DOP nel 1996 Inizio produzione tutelata: settembre 1997 Materia prima: cosce
L attività del Consorzio del Prosciutto Toscano Regione Toscana 26 febbraio 2013 Il Prosciutto Toscano Riconoscimento della DOP nel 1996 Inizio produzione tutelata: settembre 1997 Materia prima: cosce
Influenza pandemica (A/H1N1p)
 Influenza pandemica (A/H1N1p) Aggiornamento del 20.05.11 1 INFLUENZA UMANA PANDEMICA - A/H1N1p Aggiornamento al 20 Maggio 2011 A seguito degli ultimi comunicati emessi dall Organizzazione Mondiale della
Influenza pandemica (A/H1N1p) Aggiornamento del 20.05.11 1 INFLUENZA UMANA PANDEMICA - A/H1N1p Aggiornamento al 20 Maggio 2011 A seguito degli ultimi comunicati emessi dall Organizzazione Mondiale della
LA LARINGOTRACHEITE. profonde (polmoni e sacchi aerei) micoplasmosi, colibacillosi, bronchite infettiva, pseudopeste
 LA LARINGOTRACHEITE INFETTIVA Le malattie respiratorie sono patologie molto importanti negli allevamenti Possono essere distinte superficiali corizza, laringotracheite profonde (polmoni e sacchi aerei)
LA LARINGOTRACHEITE INFETTIVA Le malattie respiratorie sono patologie molto importanti negli allevamenti Possono essere distinte superficiali corizza, laringotracheite profonde (polmoni e sacchi aerei)
PROTOCOLLO OPERITIVO PER LA GESTIONE DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI INTERESSANTI LA ASL RM A
 Sede Legale: Via Ariosto, 3 00185 Roma P.I. 04735671002 Prot. N. Del Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P U.O.S.Epidemiologia e Profilassi Malattie Infettive Responsabile: Dr.ssa ERCOLE Andreina Sede: Via
Sede Legale: Via Ariosto, 3 00185 Roma P.I. 04735671002 Prot. N. Del Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P U.O.S.Epidemiologia e Profilassi Malattie Infettive Responsabile: Dr.ssa ERCOLE Andreina Sede: Via
IL CONCETTO DI ZOONOSI CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI. Zoonosi dirette. Ciclozoonosi. Metazoonosi. Saprozoonosi
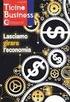 IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
Aggiornamento del
 Influenza pandemica (A/H1N1p) Aggiornamento del 12.09.11 1 INFLUENZA UMANA PANDEMICA - A/H1N1p Aggiornamento al 12 Settembre 2011 A seguito degli ultimi comunicati emessi dall Organizzazione Mondiale della
Influenza pandemica (A/H1N1p) Aggiornamento del 12.09.11 1 INFLUENZA UMANA PANDEMICA - A/H1N1p Aggiornamento al 12 Settembre 2011 A seguito degli ultimi comunicati emessi dall Organizzazione Mondiale della
FONTE :
 FONTE : http://www.msd-italia.it/altre/manuale/sez01/0040059e.html MALATTIA DI WILSON Tossicosi da rame Il morbo di Wilson è una malattia progressiva e costantemente fatale del metabolismo del rame che
FONTE : http://www.msd-italia.it/altre/manuale/sez01/0040059e.html MALATTIA DI WILSON Tossicosi da rame Il morbo di Wilson è una malattia progressiva e costantemente fatale del metabolismo del rame che
L efficacia dei sistemi di sorveglianza
 L efficacia dei sistemi di sorveglianza Dr. Angelo Ferrari IZS Piemonte, Liguria e Valle d'aosta 9 Giugno 2010 Migliorare con l esperienza La pandemia influenzale A (H1N1) 2009: Modello di gestione delle
L efficacia dei sistemi di sorveglianza Dr. Angelo Ferrari IZS Piemonte, Liguria e Valle d'aosta 9 Giugno 2010 Migliorare con l esperienza La pandemia influenzale A (H1N1) 2009: Modello di gestione delle
Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica
 Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica I miei riferimenti per questa relazione: le linee-guida nazionali e internazionali Clinical Practice Guidelines
Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica I miei riferimenti per questa relazione: le linee-guida nazionali e internazionali Clinical Practice Guidelines
Il Morbo di Aujeszky
 Ordine dei Medici Veterinari di Verona Isola della Scala -Verona 22 marzo 2007 Il Morbo di Aujeszky Situazione italiana e programmi di eradicazione 100 nm Loris ALBORALI Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Ordine dei Medici Veterinari di Verona Isola della Scala -Verona 22 marzo 2007 Il Morbo di Aujeszky Situazione italiana e programmi di eradicazione 100 nm Loris ALBORALI Istituto Zooprofilattico Sperimentale
ISTRUZIONE OPERATIVA CAMPIONAMENTO ACQUA
 Pagina 1 di 5 ISTRUZIONE OPERATIVA REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR VERIFICATA DA RAQ APPROVATA DA AMM PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO MOTIVO 00 15-01-09 Prima emissione 01 22-04-13 4.1.2 01 22-04-13
Pagina 1 di 5 ISTRUZIONE OPERATIVA REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR VERIFICATA DA RAQ APPROVATA DA AMM PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO MOTIVO 00 15-01-09 Prima emissione 01 22-04-13 4.1.2 01 22-04-13
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME. Marco Martini, Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Generale e Igiene Veterinaria Università di Padova
 SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME Marco Martini, Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Generale e Igiene Veterinaria Università di Padova Probable cases of SARS by country, 01/11/2002 31/07/2003.
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME Marco Martini, Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Generale e Igiene Veterinaria Università di Padova Probable cases of SARS by country, 01/11/2002 31/07/2003.
Dott. Pierpaolo Piva Consorzio Pescatori di Goro
 Dott. Pierpaolo Piva Consorzio Pescatori di Goro il legislatore vuole indirizzare sempre più l azione di controllo sulla componente preventiva, attribuendo al produttore la responsabilità primaria della
Dott. Pierpaolo Piva Consorzio Pescatori di Goro il legislatore vuole indirizzare sempre più l azione di controllo sulla componente preventiva, attribuendo al produttore la responsabilità primaria della
Febbre Periodica con Aftosi, Adenite e Faringite (PFAPA)
 www.printo.it/pediatric-rheumatology/ch_it/intro Febbre Periodica con Aftosi, Adenite e Faringite (PFAPA) Versione 2016 1. CHE COS È LA SINDROME PFAPA 1.1 Che cos è? PFAPA è l acronimo che sta per febbri
www.printo.it/pediatric-rheumatology/ch_it/intro Febbre Periodica con Aftosi, Adenite e Faringite (PFAPA) Versione 2016 1. CHE COS È LA SINDROME PFAPA 1.1 Che cos è? PFAPA è l acronimo che sta per febbri
I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
 I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni MinisterodellaSalute Dipartimento della sanità
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni MinisterodellaSalute Dipartimento della sanità
Blue Tongue situazione epidemiologica in Italia e aspetti normativi. Treviso 30 aprile 2008
 Blue Tongue situazione epidemiologica in Italia e aspetti normativi Treviso 30 aprile 2008 Situazione epidemiologica Analisi del rischio introduzione e circolazione 1 Flussi animali da zone a rischio Consistenza
Blue Tongue situazione epidemiologica in Italia e aspetti normativi Treviso 30 aprile 2008 Situazione epidemiologica Analisi del rischio introduzione e circolazione 1 Flussi animali da zone a rischio Consistenza
I nematodi a cisti della patata. Alba Cotroneo
 I nematodi a cisti della patata Alba Cotroneo Globodera spp È uno dei principali parassiti delle regioni temperate e fredde Larva STORIA G. rostochiensis e G. pallida sono originari delle montagne andine;
I nematodi a cisti della patata Alba Cotroneo Globodera spp È uno dei principali parassiti delle regioni temperate e fredde Larva STORIA G. rostochiensis e G. pallida sono originari delle montagne andine;
1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)
 Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all acquisto e all uso e all attività di consulenza sull impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Premessa La direttiva
Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all acquisto e all uso e all attività di consulenza sull impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Premessa La direttiva
ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA VETERINARIA
 CORSO DI ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA VETERINARIA Insegnamento del Corso integrato di Anatomia Patologica Veterinaria Docente P. Maiolino E-mail: maiolino@unina.it -Dipartimento di Patologia e Sanità
CORSO DI ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA VETERINARIA Insegnamento del Corso integrato di Anatomia Patologica Veterinaria Docente P. Maiolino E-mail: maiolino@unina.it -Dipartimento di Patologia e Sanità
Biodiversità e salute. Flavia Caretta
 Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
