ELIO PAGLIARANI ELIO PAGLIARANI, DA LA RAGAZZA CARLA, CARLA DONDI FU AMBROGIO 1 ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
|
|
|
- Amando Bartolini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ELIO PAGLIARANI La vita, le opere Elio Pagliarani, nato a Viserba presso Rimini nel 1927, dopo gli studi superiori si trasferì a Milano. Frequentò l università a Padova e dopo la laurea si dedicò all insegnamento e al giornalismo. Si trasferì poi a Roma, dove svolse attività di consulente editoriale e di critico teatrale. Collaborò alle riviste Verri e Quindici. Fino al 1968 fu redattore del quotidiano Avanti; curò, inoltre, una rubrica di critica teatrale sul giornale Paese Sera. Oltre alle raccolte letterarie, scrisse testi per musica e testi teatrali. Tra le opere giovanili ricordiamo Cronache e altre poesie (1954) e Inventario privato, raccolte di versi in cui già si delinea la vera vena di Pagliarani, caratterizzata dall intreccio di rivoluzionari sperimentalismi e di toni epici, narrativi. Sulla rivista di Calvino e di Vittorini, Menabò, egli pubblicò, nel 1960, La ragazza Carla, che si fece subito notare per l audace sperimentalismo linguistico. Seguirono Lezione di fisica (1964) e Lezione di fisica e Fecaloro (1968). Forme meno rivoluzionarie, più distese, compaiono nelle opere Rosso corpo lingua oro pope-papa scienza (1977), La bella addormentata nel bosco (1988). Tuttora vivente, risiede a Roma. La poetica Nelle sue pagine migliori Pagliarani appare uno degli scrittori più significativi della Neoavanguardia, un movimento culturale operante in Italia negli anni Sessanta, che si proponeva di stabilire un rapporto tra letteratura e industria e di denunciare la stritolante piovra della civiltà consumistica. Nelle opere di Pagliarani si avverte l eco del Neorealismo, dal quale ereditò l inclinazione a cogliere situazioni geografiche e sociali molto veristiche. Ne è un esempio la città che entra nelle sue pagine con lo squallore dei quartieri periferici e l anonimato delle vie del centro. È pure presente nelle composizioni la povera gente dei sobborghi urbani, operai e impiegati, colti nei tetri ambienti in cui sono costretti a vivere e a lavorare: misere case, uffici grigi e opprimenti, squallide scuole serali, tram sovraffollati costituiscono la desolata cornice entro la quale si muovono personaggi intristiti e delusi. Sperimentalismo linguistico e realismo danno origine ad uno stile singolare, assolutamente originale, definito appunto sperimentalismo realistico, in cui il linguaggio parlato si mescola con quello impiegatizio, pubblicitario e commerciale. Da alcuni grandi delle letterature straniere come Eliot, Majakovskij e Brecht Pagliarani eredita l inclinazione ad utilizzare un registro epico, sempre tuttavia sfumato di quotidianità. Ne nasce una miscela molto particolare, una sorta di lingua variegata, espressione di una società nevrotica, alienata, accoratamente delusa. Il poemetto La ragazza Carla È un poemetto in versi, diviso in tre parti, che presenta una struttura prevalentemente narrativa. La prima parte è costituita di nove strofe, a ciascuna delle quali corrisponde una scena, mentre le altre due parti sono formate di sette strofe, di varia lunghezza. Il poemetto narra le prime esperienze lavorative di una ragazza diciassettenne, di modesta estrazione sociale. La vicenda si svolge a Milano alla fine degli anni Cinquanta, epoca della ricostruzione dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale. Carla abita in una povera casa, con la madre, la vedova Dondi, la sorella maggiore Nerina e il marito di lei, Angelo. Vissuta sempre nell ambiente degradato della periferia, la ragazza affronta per la prima volta il mondo degli adulti e la grande città industriale. Ma le sue aspettative e i suoi entusiasmi giovanili vengono delusi; in una sorta di autoanalisi la ragazza si scopre incapace di accettare la vita adulta, di adeguarsi alla metropoli ostile e fredda, all ambiente di lavoro, vissuto come luogo opprimente, spersonalizzante. Numerose voci narranti si confondono intrecciandosi tra monologhi, dialoghi, didascalie, flashback, in cui entrano anche linguaggi settoriali, familiari, codici pubblicitari e impiegatizi. ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS ELIO PAGLIARANI, DA LA RAGAZZA CARLA, CARLA DONDI FU AMBROGIO 1
2 Elio Pagliarani Carla Dondi fu Ambrogio da La ragazza Carla Nelle scene qui presentate appartenenti alla seconda parte del poemetto, Pagliarani tratteggia il mondo del lavoro in una luce apparentemente familiare e accattivante, di fatto disumana e ostile. Nella Milano grigia ed efficiente del boom economico, sotto un cielo d acciaio, le speranze e le attese di Carla vengono deluse ed ella si trova a vivere lo sgomento di una società che ha smarrito i valori e mira unicamente al profitto. Metro: versi liberi, raggruppati in strofe di varia lunghezza. I Carla Dondi fu Ambrogio di anni diciassette primo impiego stenodattilo all ombra del Duomo Sollecitudine e amore 1, amore ci vuole al lavoro 5 sia svelta, sorrida e impari le lingue le lingue qui dentro le lingue oggigiorno capisce dove si trova? TRANSOCEAN LIMITED 2 qui tutto il mondo... è certo che sarà orgogliosa. 10 Signorina, noi siamo abbonati alle Pulizie Generali, due volte la settimana, ma il Signor Praték 3 è molto esigente amore al lavoro è amore all ambiente così nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino 15 sarà sua prima cura la mattina. UFFICIO A UFFICIO B UFFICIO C. Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno adesso che lavori ne hai diritto molto di più. [ ] II 20 All ombra del Duomo, di un fianco del Duomo i segni colorati dei semafori le polveri idriz elettriche 4 mobili sulle facciate del vecchio casermone d angolo fra l infelice corso Vittorio Emanuele e Camposanto, Santa Radegonda 5, Odeon bar cinema e teatro 25 un casermone sinistrato e cadente che sarà la Rinascente 6 cento targhe d ottone come quella TRANSOCEAN LIMITED IMPORT EXPORT COMPANY le nove di mattina al 3 febbraio. Carla Dondi diciassette: la protagonista viene presentata col linguaggio burocratico, ricavato dal certificato anagrafico. Ciò pone in risalto fin dall inizio il tema della spersonalizzazione dell individuo, coinvolto nell ingranaggio produttivo. sollecitudine al lavoro: il tono concitato e astioso delle parole è trasmesso dalla particolare tipologia della punteggiatura, scarsa, approssimativa, talora del tutto assente. L evidente forzatura grammaticale vuole esprimere il modo in cui la protagonista recepisce le ammonizioni: ella appare, infatti, preoccupata e confusa. Ufficio A Ufficio B Ufficio C: questo inserimento di targhe di ufficio testimonia l uso di termini tecnici, tipici del mondo impiegatizio, voluti per creare il particolare impasto di vari linguaggi. Perché di più: è avvenuto qui un mutamento di luogo e di punto di vista. La ragazza ora è a casa; la voce è quella della madre. È un esempio di quella mescolanza di voci narranti che caratterizza il poemetto. All ombra del Duomo al 3 febbraio: è il passo più celebre del racconto in versi di Pagliarani. Si tratta di una lunga frase, costruita mediante l accostamento di termini ricavati dalla vita urbana e dal mondo commerciale. La mancanza di una logica nell enunciato è l immagine della disintegrazione della personalità dell uomo contemporaneo. 1. Sollecitudine e amore: parlano qui i dirigenti dell azienda che ha assunto Carla come impiegata addetta alla stenografia (un tipo di scrittura veloce realizzata mediante rapidi segni convenzionali) e alla dattilografia (scrittura a macchina). 2. TRANSOCEAN LIMITED: il nome dell azienda è allusivo di traffici a largo raggio, di dimensioni internazionali. 3. il signor Praték: il proprietario dell azienda. 4. polveri idriz elettriche: insegna al neon che reclamizza una polverina per rendere l acqua gasata. 5. corso Vittorio Emanuele e Camposanto, Santa Radegonda: vie e quartieri milanesi. 6. casermone sinistrato Rinascente: costruzione danneggiata dalla guerra; dopo il restauro ospiterà i grandi magazzini Rinascente. 2 ELIO PAGLIARANI, DA LA RAGAZZA CARLA, CARLA DONDI FU AMBROGIO ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
3 La civiltà si è trasferita al nord 30 come è nata nel sud, per via del clima, quante energie distilla alla mattina il tempo di febbraio, qui in città? Carla spiuma 7 i mobili Aldo Lavagnino 8 coi codici traduce telegrammi night letters 9 35 una signora bianca 10 ha cominciato i calcoli sulla calcolatrice svedese. Sono momenti belli: c è silenzio e il ritmo d un polmone, se guardi dai cristalli quella gente che marcia al suo lavoro 40 diritta interessata necessaria che ha tanto fiato caldo nella bocca quando dice buongiorno è questa che decide e son dei loro 45 non c è altro da dire. E questo cielo contemporaneo in alto, tira su la schiena, in alto ma non tanto questo cielo colore di lamiera sulla piazza a Sesto a Cinisello 11 alla Bovisa sopra tutti i tranvieri ai capolinea Sono momenti silenzio: qui il registro è ironicamente lirico. Carla trova un attimo di pace nei momenti iniziali della giornata, illudendosi di appartenere ad un mondo efficiente e ordinato. è questa da dire: spicca la particolare collocazione dei versi, dimezzati e disposti alternativamente sulla pagina. Sono percorsi dalla allitterazione della d che li rende lapidari. cielo: la ripetizione del termine (vv. 46, 54 e 56) cielo è l elemento più rilevante della strofa che racchiude la visione del mondo della protagonista. Solo il cielo di acciaio della metropoli non illude l uomo, non lo inganna promettendogli un falso paradiso, ma gli mostra la desolazione della sua sorte senza scampo. non prolunga all infinito i fianchi le guglie i grattacieli i capannoni Pirelli coperti di lamiera? È nostro questo cielo d acciaio che non finge 55 Eden 13 e non concede smarrimenti 14, è nostro ed è morale il cielo che non promette scampo dalla terra, proprio perché sulla terra non c è scampo da noi nella vita. da La ragazza Carla e altre poesie, Mondadori, Milano, spiuma: spolvera col piumino. 8. Aldo Lavagnino: un impiegato dell azienda. 9. telegrammi night letters: telegrammilettera notturni, cioè trasmessi di notte, quando il costo è minore. 10. una signora bianca: che indossa un camice bianco. 11. a Sesto a Cinisello: comuni nei pressi di Milano. 12. Bovisa: quartiere periferico di Milano. 13. Eden: paradiso terrestre. 14. smarrimenti: sogni, fantasie che consentono di mitigare la tristezza della vita cittadina. ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS ELIO PAGLIARANI, DA LA RAGAZZA CARLA, CARLA DONDI FU AMBROGIO 3
4 ANALISI DEL TESTO Claes Oldenburg, Macchina da scrivere molle, Tutta l arte di Oldenburg si concentra sul culto dell oggetto e sul tradimento delle sue funzioni. Qui, in particolare, la macchina da scrivere diventa molle per sottolineare il valore di alienazione che essa produce in chi era costretto, per lavoro, a usarla continuamente. Temi e motivi Il mondo del lavoro: un ambiente disumano Nei brani presentati Carla Dondi, dopo aver frequentato un corso di dattilografia, entra per la prima volta in un azienda commerciale e affronta il mondo del lavoro. Sono narrati il primo giorno del suo impiego, l impatto con il nuovo mondo e con le sue contraddizioni e lo sgomento del rientro a casa, la sera. Davanti a lei si apre la squallida realtà di un universo che ha distrutto i valori umani, sostituendoli con la produttività e la legge del profitto, un mondo massificato e nevrotico che la schiaccia. Accanto a Carla, l altra protagonista della composizione è la metropoli industrializzata: sconvolta dalla tecnologia, essa cela sotto i falsi bagliori delle insegne pubblicitarie e delle targhe commerciali un tessuto urbano inquinato alle radici, lacerato dalle disuguaglianze sociali ed economiche, dall incomunicabilità e dalla solitudine. Il tema dominante del racconto in versi è dunque il malessere della società neocapitalistica nell Italia del dopoguerra, imprigionata nell ingranaggio produttivo e avviata verso il degrado del consumismo. Questo motivo conduttore si manifesta nel ritorno martellante di termini e di aggettivi assunti dal mondo affaristico e competitivo ed incastrati a spezzoni, senza alcuna apparente coesione. La dattilografa Carla: una ragazza simbolo Nella ovvietà del parlare quotidiano, emerge il tema dell annientamento della personalità. Carla, ridotta ad una marionetta, compie ogni azione con una gestualità fissa e in qualche modo prevista. Privata di ogni energia interiore, la protagonista riflette l inerzia morale della folla mattutina di lavoratori che compiono ogni giorno una marcia priva di meta. Non solo la protagonista avverte un senso di tristezza e di vuoto interiore, di solitudine e meschinità, ma non riesce neppure ad esserne cosciente; l efficienza produttiva schiaccia a tal punto gli individui da cancellare in loro l immaginazione e i sentimenti. Svilita in un infimo ruolo di subordinazione, è costretta a svolgere indotta da una sorta di ricatto morale oltre ai compiti di stenodattilografa, il lavoro di donna delle pulizie. Neppure la famiglia comprende il suo intimo malessere, il disagio del suo animo: la madre, ad esempio, pienamemente imbevuta della mentalità capitalistica, pensa che sia il lavoro ad attribuire alla persona il diritto a mangiare: dunque colui che lavora ha più diritto al cibo e, in ultima analisi, alla vita. Milano: la babelica efficienza urbana La città è descritta con tratti volutamente caotici, tesi a mettere in risalto l assurdo meccanismo affaristico all apparenza ben funzionante, di fatto ossessivamente babelico. Tra le tragiche rovine della guerra da poco conclusa (casermone sinistrato), tra un intrico di vie, di bar, di scritte, accostate in totale accozzaglia, Milano si staglia come simbolo della moderna metropoli, invivibile, alienante. L annotazione sul clima, concepito in ultima analisi come spinta e motore di tanto fervore imprenditoriale, chiude il desolante flash sulla città, con una velata allusione all improduttività del Sud. In questo contesto, la gente esercito perfettamente allineato e obbediente si illude di essere libera e necessaria alla collettività; in realtà è strumento inconsapevole della fredda legge del mercato. L inquietante, successivo interrogativo circa il prolungarsi all infinito di un cielo opprimente come una lamiera, sembra precludere alla persona ogni scampo, ogni speranza. 4 ELIO PAGLIARANI, DA LA RAGAZZA CARLA, CARLA DONDI FU AMBROGIO ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
5 ANALISI DEL TESTO Gianfranco Ferroni, Città, Questo dipinto di Ferroni si riferisce proprio alla città di Milano, in cui l artista viveva. L immagine rende il senso di caos che la caratterizzava nel periodo in cui si stava trasformando in una moderna metropoli invivibile e alienante. Tecniche stilistiche Una miscela di stili Il linguaggio è il vero protagonista del racconto in versi : un impasto di stili, di registri, presi dalla pubblicità, dal gergo impiegatizio, familiare, commerciale, e non amalgamati tra di loro. Il frantumarsi della musicalità e della coesione del verso e il trasformarsi del ritmo poetico in un fraseggio meccanico vogliono comunicare la sensazione di un io spaccato, il senso di smarrimento e di perdita dell identità. A ciò concorre l uso trasgressivo della punteggiatura, ridotto rispetto alle regole tradizionali della grammatica, in alcuni casi incoerente e approssimativo. Si nota spesso l assenza del punto a separare due proposizioni principali, ed è rara la virgola. L effetto è un disordinato sovrapporsi, un ammassarsi di immagini slegate, mirate a riprodurre l ansia di una vita imposta e non accettata. Nonostante la struttura in versi, il poemetto presenta le caratteristiche della prosa, ossia un timbro discorsivo antilirico, che talora però assume toni ironicamente epici, caricaturalmente mitizzati. Ne è esempio la strofa che descrive la gente che marcia al suo lavoro / diritta interessata, quasi un drappello proteso verso nobili ideali. A questo fine Pagliarani si avvale di versi differenti, i quali si riducono, si prolungano, si flettono, si spezzano, in un gioco all apparenza insensato. La molteplicità dei punti di vista Un elemento che connota fortemente la composizione è la molteplicità dei punti di vista, delle voci narranti che si alternano incessantemente e disordinatamente. Un narratore esterno, i colleghi dell ufficio, il capo ufficio, la madre di Carla e Carla stessa si succedono in modo nevrotico, creando un testo fortemente spezzato e incoerente. Tutte le voci appaiono egualmente distaccate, non coinvolte nella vicenda; ne deriva un senso amaro di solitudine, di impossibile comunicazione tra le persone, che non lascia intravedere alcuna via d uscita. ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS ELIO PAGLIARANI, DA LA RAGAZZA CARLA, CARLA DONDI FU AMBROGIO 5
6 ESERCIZI COMPRENSIONE DEL TESTO 1. Dopo aver letto l introduzione al poemetto La ragazza Carla e i passi dell opera qui presentati, rispondi alle seguenti domande. a. In quante parti è diviso il poemetto? Perché è definito un racconto in versi? b. Chi è la protagonista? c. Dove si svolge la vicenda? Come è presentato l ambiente urbano? d. Come è presentato l ufficio in cui Carla lavora? e. Quali compiti deve svolgere la ragazza? 2. Il testo affronta vari temi, relativi alla desolata esistenza di chi è costretto a vivere e a lavorare in una città affaristica e industrializzata. Scegli quello che ti ha maggiormente interessato, illustralo e commentalo. 3. Nella prima parte della prima strofa è descritto il giorno dell inizio dell attività di Carla come dattilografa. Da lei si pretende non solo lo svolgimento del normale lavoro, ma anche un insieme di comportamenti che qui di seguito elenchiamo. Accanto a ciascun comportamento indica i versi in cui viene descritto o alluso: amore al lavoro... conoscenza delle lingue... sollecitudine... orgoglio di appartenere ad una azienda efficiente Nei versi finali, 46-59, è delineata la desolata visione di Carla, cui non resta scampo sulla terra, né via d uscita nella vita. Quali sono le espressioni che, secondo te, esprimono con maggior intensità questo triste punto di vista? Motiva adeguatamente la tua scelta. cielo color di lamiera cielo che non promette scampo dalla terra i capannoni Pirelli coperti di lamiera non c è scampo da noi nella vita cielo d acciaio ANALISI DEL TESTO 5. Come sono i versi del poemetto? Quale carattere li contraddistingue? 6. Nel racconto in versi Pagliarani cambia spesso la voce poetante, ossia la persona che parla e pensa. Indica i versi in cui si avverte la presenza delle seguenti voci poetanti: il capoufficio... Carla... la madre di Carla... i colleghi dell ufficio Pagliarani fa un uso assai trasgressivo della punteggiatura, che mira a comunicare lo smarrimento di Carla. Una punteggiatura più rispettosa delle regole normali muterebbe profondamente il messaggio che traspare dalla pagina. Prova ora ad inserire i segni di interpunzione normali nei seguenti versi: 33-36, 39-45, APERTURE 8. Inventa un espressione, affine al cielo d acciaio, che sia adatta ad evocare il degrado delle nostre città, invase dal cemento, dal traffico, dai rumori, dallo smog. 6 ELIO PAGLIARANI, DA LA RAGAZZA CARLA, CARLA DONDI FU AMBROGIO ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
GRUPPO '63. Un'avanguardia da vagone letto (Maria Luisa Spaziani) Corso di aggiornamento 2016 Donata Figarolo 3 Maggio 2016
 GRUPPO '63 Un'avanguardia da vagone letto (Maria Luisa Spaziani) Corso di aggiornamento 2016 3 Maggio 2016 U. ECO Codificazione di una KOINÈ dell'illuminismo PADANO che coincide con il triangolo industriale.
GRUPPO '63 Un'avanguardia da vagone letto (Maria Luisa Spaziani) Corso di aggiornamento 2016 3 Maggio 2016 U. ECO Codificazione di una KOINÈ dell'illuminismo PADANO che coincide con il triangolo industriale.
Il Neorealismo movimento culturale Italia fine Seconda Guerra Mondiale problemi bisogni rappresentazione realtà Verismo
 Il Neorealismo Questo movimento culturale si sviluppa in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1945 e il 1955. Nasce dal bisogno di interpretare i problemi e i bisogni reali della società,
Il Neorealismo Questo movimento culturale si sviluppa in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1945 e il 1955. Nasce dal bisogno di interpretare i problemi e i bisogni reali della società,
La scrittura e la memoria (seconda parte) La letteratura sulla Resistenza. Lezioni d'autore
 La scrittura e la memoria (seconda parte) La letteratura sulla Resistenza Lezioni d'autore http://genova.mentelocale.it/ La produzione in prosa sulla lotta partigiana Racconti di forte matrice autobiografica.
La scrittura e la memoria (seconda parte) La letteratura sulla Resistenza Lezioni d'autore http://genova.mentelocale.it/ La produzione in prosa sulla lotta partigiana Racconti di forte matrice autobiografica.
ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI
 ASCOLTARE E PARLARE - Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti
ASCOLTARE E PARLARE - Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti
Natale. Ho tanta stanchezza sulle spalle
 Natale Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata Qui non si sente altro che il caldo buono Sto
Natale Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata Qui non si sente altro che il caldo buono Sto
O MENINO E O MUNDO (Il bambino e il mondo) Brasile 2013
 O MENINO E O MUNDO (Il bambino e il mondo) Brasile 2013 Scheda a cura di Giancarlo Zappoli Avvertenza per i docenti Castellinaria propone il film a un ampia fascia di classi con una duplice consapevolezza:
O MENINO E O MUNDO (Il bambino e il mondo) Brasile 2013 Scheda a cura di Giancarlo Zappoli Avvertenza per i docenti Castellinaria propone il film a un ampia fascia di classi con una duplice consapevolezza:
LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
 Classe Seconda ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL USO DELLA LINGUA Settembre Prove d ingresso
Classe Seconda ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL USO DELLA LINGUA Settembre Prove d ingresso
Compiti per le vacanze IV^ Ginnasio sez. B ITALIANO. Grammatica:
 Compiti per le vacanze IV^ Ginnasio sez. B ITALIANO Grammatica: Letture per le vacanze estive Lettura obbligatoria: Virgilio, Eneide, edizione con testo latino a fronte Scegliere tre libri tra
Compiti per le vacanze IV^ Ginnasio sez. B ITALIANO Grammatica: Letture per le vacanze estive Lettura obbligatoria: Virgilio, Eneide, edizione con testo latino a fronte Scegliere tre libri tra
Programmazione annuale a. s
 Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO
 Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI ASCOLTO E PARLATO Prestare attenzione in varie situazioni comunicative
Istituto Comprensivo Francesco D'Assisi TEZZE SUL BRENTA Scuola Primaria CLASSE 2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ITALIANO OBIETTIVI ASCOLTO E PARLATO Prestare attenzione in varie situazioni comunicative
III Circolo di Rho. Programmazione annuale. Lingua Italiana. Classe III
 III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
GIOVANNI PASCOLI. contatto con la natura, poi c è il tema della morte e delle sventure familiari.
 GIOVANNI PASCOLI Giovanni Pascoli, nato a San Mauro di Romagna nel 855, visse un infanzia lieta e spensierata, ma l assassinio del padre lasciò tracce in tutta la sua opera. La precoce esperienza di dolore
GIOVANNI PASCOLI Giovanni Pascoli, nato a San Mauro di Romagna nel 855, visse un infanzia lieta e spensierata, ma l assassinio del padre lasciò tracce in tutta la sua opera. La precoce esperienza di dolore
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre
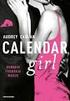 U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
TRA FANGO E POESIA: LA GUERRA DEI 99
 TRA FANGO E POESIA: LA GUERRA DEI 99 Con la attuale classe seconda del liceo Scientifico Romano Bruni abbiamo preparato l allestimento di una mostra in occasione del Centenario della Grande Guerra. Tale
TRA FANGO E POESIA: LA GUERRA DEI 99 Con la attuale classe seconda del liceo Scientifico Romano Bruni abbiamo preparato l allestimento di una mostra in occasione del Centenario della Grande Guerra. Tale
Come si analizza un opera d arte. 5 PASSI NELL ARTE un metodo per la lettura di un testo visivo
 Come si analizza un opera d arte 5 PASSI NELL ARTE un metodo per la lettura di un testo visivo CONOSCERE E CAPIRE IL LINGUAGGIO VISIVO E LE SUE REGOLE Un opera d arte trasmette sensazioni, emozioni e significati
Come si analizza un opera d arte 5 PASSI NELL ARTE un metodo per la lettura di un testo visivo CONOSCERE E CAPIRE IL LINGUAGGIO VISIVO E LE SUE REGOLE Un opera d arte trasmette sensazioni, emozioni e significati
PROGETTAZIONE ANNUALE - ITALIANO
 PROGETTAZIONE ANNUALE - ITALIANO classe I Finalità educative. Capacità di comunicare ed esprimere l esperienza di sé e della realtà naturale e culturale attraverso la padronanza delle abilità linguistiche
PROGETTAZIONE ANNUALE - ITALIANO classe I Finalità educative. Capacità di comunicare ed esprimere l esperienza di sé e della realtà naturale e culturale attraverso la padronanza delle abilità linguistiche
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO AREE DA SVILUPPARE. Riflettere sulla lingua
 Riflettere sulla lingua 1. Consolidare ed approfondire la conoscenza degli obiettivi affrontati in prima classe. 2. Conoscere l'alfabeto e le lettere straniere. 3. Affrontare le seguenti difficoltà: -
Riflettere sulla lingua 1. Consolidare ed approfondire la conoscenza degli obiettivi affrontati in prima classe. 2. Conoscere l'alfabeto e le lettere straniere. 3. Affrontare le seguenti difficoltà: -
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA - DENNO PIANO DI STUDIO DI ITALIANO CLASSE SECONDA
 ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA - DENNO PIANO DI STUDIO DI ITALIANO CLASSE SECONDA Competenza 1: Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura. Interagire e comunicare verbalmente
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA - DENNO PIANO DI STUDIO DI ITALIANO CLASSE SECONDA Competenza 1: Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura. Interagire e comunicare verbalmente
Caratteristiche della poesia ermetica
 Corrente ermetica È da inquadrare nel periodo che va più o meno dal 1915 al 1930. Si parla di corrente perché non ne sono definite le tecniche e gli autori non partecipano coscientemente ad un progetto
Corrente ermetica È da inquadrare nel periodo che va più o meno dal 1915 al 1930. Si parla di corrente perché non ne sono definite le tecniche e gli autori non partecipano coscientemente ad un progetto
Dialogiche. Descrittive
 ANALISI DI UN TESTO NARRATIVO Modello narrativo In ogni testo narrativo sono presenti: Situazione di equilibrio iniziale Esordio Avventure e peripezie Climax e spannung Scioglimento Tipologie delle sequenze
ANALISI DI UN TESTO NARRATIVO Modello narrativo In ogni testo narrativo sono presenti: Situazione di equilibrio iniziale Esordio Avventure e peripezie Climax e spannung Scioglimento Tipologie delle sequenze
MARINO MORETTI. L ore non passavan mai. TEST D INGRESSO 3 II anno. Nome: Cognome: Classe: Data:
 TEST D INGRESSO 3 II anno Nome: Cognome: Classe: Data: MARINO MORETTI L ore non passavan mai Ero un fanciullo, andavo a scuola, e un giorno dissi a me stesso: «Non ci voglio andare» e non andai. Mi misi
TEST D INGRESSO 3 II anno Nome: Cognome: Classe: Data: MARINO MORETTI L ore non passavan mai Ero un fanciullo, andavo a scuola, e un giorno dissi a me stesso: «Non ci voglio andare» e non andai. Mi misi
ÉPREUVE D'ACCÈS À SIXIÈME POUR L'ANNEÉ SCOLAIRE
 Collège Marseilleveyre Sezione internazionale italiana ÉPREUVE D'ACCÈS À SIXIÈME POUR L'ANNEÉ SCOLAIRE 2010-2011 Marseille 26 mai 2010 Nom... Prènom... Prova scritta (45 punti) Prova orale (15 punti) Punteggio
Collège Marseilleveyre Sezione internazionale italiana ÉPREUVE D'ACCÈS À SIXIÈME POUR L'ANNEÉ SCOLAIRE 2010-2011 Marseille 26 mai 2010 Nom... Prènom... Prova scritta (45 punti) Prova orale (15 punti) Punteggio
ANNO SCOLASTICO
 ANNO SCOLASTICO 2016-2017 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE II O PROF.SSA IOLANDA DI BERNARDO POESIA E LETTERATURA I METODI DELLA POESIA IL SIGNIFICATO: il linguaggio della poesia Le caratteristiche della poesia
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE II O PROF.SSA IOLANDA DI BERNARDO POESIA E LETTERATURA I METODI DELLA POESIA IL SIGNIFICATO: il linguaggio della poesia Le caratteristiche della poesia
Natale è poesia Classe 4 B Anno scolastico 2015/2016
 Natale è poesia Classe 4 B Anno scolastico 2015/2016 Poesia è il mondo, l umanità la propria vita, fioriti nelle parole; è la meraviglia di un delirante fermento. Poesia è Arte ancora prima che,
Natale è poesia Classe 4 B Anno scolastico 2015/2016 Poesia è il mondo, l umanità la propria vita, fioriti nelle parole; è la meraviglia di un delirante fermento. Poesia è Arte ancora prima che,
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
Laboratorio di scrittura creativa nelle scuole
 Laboratorio di scrittura creativa nelle scuole LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA NELLE SCUOLE LA FORZA DELL IMMAGINAZIONE La scrittura non è solo una modalità espressiva per poter analizzare un testo,
Laboratorio di scrittura creativa nelle scuole LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA NELLE SCUOLE LA FORZA DELL IMMAGINAZIONE La scrittura non è solo una modalità espressiva per poter analizzare un testo,
ITALIANO CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI S. GIUSTINA E MEANO CLASSE PRIMA
 ISTITUTO COMPRENSIVO G. Rodari 32035 SANTA GIUSTINA (Belluno) Telefono e Fax 0437/858165-858182 C.F. 82003030259 segreteria@rodari.org - dirigenza@rodari.org - www.rodari.org ITALIANO CURRICOLO DELLA SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. Rodari 32035 SANTA GIUSTINA (Belluno) Telefono e Fax 0437/858165-858182 C.F. 82003030259 segreteria@rodari.org - dirigenza@rodari.org - www.rodari.org ITALIANO CURRICOLO DELLA SCUOLA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 Istituto Comprensivo Luciano Manara Scuola Primaria Luciano Manara - Carlo Poma - San Giusto ***** PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO CLASSI SECONDE A.S. 2016/17 I BIMESTRE NUCLEI TEMATICI ASCOLTO E PARLATO
Istituto Comprensivo Luciano Manara Scuola Primaria Luciano Manara - Carlo Poma - San Giusto ***** PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO CLASSI SECONDE A.S. 2016/17 I BIMESTRE NUCLEI TEMATICI ASCOLTO E PARLATO
Indice. Università Telematica Pegaso. 2 di 6. 1 L adultità... 3
 L ADULTITÀ PROF. NICOLA PAPARELLA Indice 1... 3 2 di 6 1 In questa lezione riprenderemo un tema già annunciato: il tema dell adultità. Nella prima lezione abbiamo detto che sotto la nozione di adulto c
L ADULTITÀ PROF. NICOLA PAPARELLA Indice 1... 3 2 di 6 1 In questa lezione riprenderemo un tema già annunciato: il tema dell adultità. Nella prima lezione abbiamo detto che sotto la nozione di adulto c
CLASSE SECONDA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ITALIANO A) ASCOLTARE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1. Ascoltare e comprendere vari messaggi 1. Ascoltare messaggi orali di vario genere e individuare l'argomento centrale 2. Ascoltare
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA ITALIANO A) ASCOLTARE 1 1. Ascoltare e comprendere vari messaggi 1. Ascoltare messaggi orali di vario genere e individuare l'argomento centrale 2. Ascoltare
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
Premessa. Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza presso Fondazione Collegio delle Università Milanesi. a cura di Stefano Zecchi
 Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza presso Fondazione Collegio delle Università Milanesi a cura di Stefano Zecchi Didattica a cura di: Elena Salem Coordinamento organizzativo: Simone Sferrazza
Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza presso Fondazione Collegio delle Università Milanesi a cura di Stefano Zecchi Didattica a cura di: Elena Salem Coordinamento organizzativo: Simone Sferrazza
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in
PIANO DIDATTICO. Si fa riferimento alla programmazione educativa depositata in segreteria NUCLEI TEMATICI
 PIANO DIDATTICO DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE 4^ COMPETENZE DI CITTADINANZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di
PIANO DIDATTICO DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE 4^ COMPETENZE DI CITTADINANZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di
L Ermetismo Italia anni comune atteggiamento critico Francesco Flora difficoltà comprendere dio greco Ermes
 L Ermetismo In Italia, tra gli anni 20 e 30 del XX secolo, si affermò l Ermetismo, non un movimento letterario ma un comune atteggiamento assunto da poeti. La denominazione fu coniata dal critico Francesco
L Ermetismo In Italia, tra gli anni 20 e 30 del XX secolo, si affermò l Ermetismo, non un movimento letterario ma un comune atteggiamento assunto da poeti. La denominazione fu coniata dal critico Francesco
PERCORSO. Colori in contrasto Colori in armonia. Riferimento al testo base: Destinatari: di Elena Ballarin
 PERCORSO 2 Colori in Colori in armonia di Elena Ballarin Riferimento al testo base: E. Tornaghi, A colpo d occhio, volume A, pp. 90-91 Destinatari: Scuola secondaria di Primo grado In classe 1. Osserva
PERCORSO 2 Colori in Colori in armonia di Elena Ballarin Riferimento al testo base: E. Tornaghi, A colpo d occhio, volume A, pp. 90-91 Destinatari: Scuola secondaria di Primo grado In classe 1. Osserva
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri. ABILITÀ Obiettivi di apprendimento
 Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
Scuola statale italiana di Madrid Anno scolastico 2016/17 LINGUA ITALIANA Classe 2C Insegnante: Cristina Contri NUCLEI FONDANTI ASCOLTO E PARLATO COMPETENZE Ascoltare e comprendere messaggi in contesti
Filippo Anelli LE ONDE DEL MARE
 Le onde del mare Filippo Anelli LE ONDE DEL MARE Poesie e racconti www.booksprintedizioni.it Copyright 2017 Filippo Anelli Tutti i diritti riservati A mia moglie Maria con tanto amore. La vita è una poesia,
Le onde del mare Filippo Anelli LE ONDE DEL MARE Poesie e racconti www.booksprintedizioni.it Copyright 2017 Filippo Anelli Tutti i diritti riservati A mia moglie Maria con tanto amore. La vita è una poesia,
Comunicare intervenendo con pertinenza e con rispetto dei tempi. Distinguere un testo in prosa da un testo poetico.
 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO SCRITTURA LETTURA ASCOLTO E PARLATO ITALIANO classe prima Ascoltare per un tempo adeguato e comprendere il messaggio in modo globale, distinguendo
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO SCRITTURA LETTURA ASCOLTO E PARLATO ITALIANO classe prima Ascoltare per un tempo adeguato e comprendere il messaggio in modo globale, distinguendo
SCUOLA PRIMARIA MUSICA. Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione
 SCUOLA PRIMARIA MUSICA Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Classe 1 Descrittori Classe 2 Descrittori Classe 3 Descrittori Classe 4 Descrittori Classe 5 il significato
SCUOLA PRIMARIA MUSICA Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Classe 1 Descrittori Classe 2 Descrittori Classe 3 Descrittori Classe 4 Descrittori Classe 5 il significato
La poesia crepuscolare
 novembre 13, 2011 La poesia crepuscolare e la tradizione pascoliana Luca Gervasutti - 2009 - L'eredità pascoliana Giovanni Pascoli fu tra i principali ispiratori della poesia cosiddetta crepuscolare: nei
novembre 13, 2011 La poesia crepuscolare e la tradizione pascoliana Luca Gervasutti - 2009 - L'eredità pascoliana Giovanni Pascoli fu tra i principali ispiratori della poesia cosiddetta crepuscolare: nei
La maschera del cuore
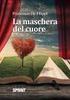 La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
BOZZA DEL CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE DELLA LETTURA: SCUOLA DELL INFANZIA
 BOZZA DEL CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE DELLA LETTURA: SCUOLA DELL INFANZIA 1 COMPETENZE Il piacere e la scelta di leggere - All'interno di un ambiente motivante e stimolante, sviluppare la consapevolezza
BOZZA DEL CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE DELLA LETTURA: SCUOLA DELL INFANZIA 1 COMPETENZE Il piacere e la scelta di leggere - All'interno di un ambiente motivante e stimolante, sviluppare la consapevolezza
ARTE E IMMAGINE NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA. riconoscere ed usare i linguaggi visivi. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi.
 ARTE E IMMAGINE NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA Capacità di vedere osservare e comprendere riconoscere ed usare i linguaggi visivi. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. Produzione e rielaborazione
ARTE E IMMAGINE NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA Capacità di vedere osservare e comprendere riconoscere ed usare i linguaggi visivi. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. Produzione e rielaborazione
ITALIANO CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI NARRATIVI.
 ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
3 anno BOMBE E SOFFERENZA
 3 anno narrat I V a storica scuola second. di I grado BOMBE E SOFFERENZA LA SECONDA GUERRA MONDIALE Le privazioni della guerra, il fronte che si avvicina, il pericolo dei tedeschi, la presenza dei partigiani...
3 anno narrat I V a storica scuola second. di I grado BOMBE E SOFFERENZA LA SECONDA GUERRA MONDIALE Le privazioni della guerra, il fronte che si avvicina, il pericolo dei tedeschi, la presenza dei partigiani...
PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO a. s / 2015
 PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO a. s. 2014 / 2015 DOCENTE : ANTONIO SALVATORE MUZZUPAPPA CLASSE : 2^ IB DISCIPLINA : ITALIANO UDA che sono stati effettivamente trattati nel corso del corrente
PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO a. s. 2014 / 2015 DOCENTE : ANTONIO SALVATORE MUZZUPAPPA CLASSE : 2^ IB DISCIPLINA : ITALIANO UDA che sono stati effettivamente trattati nel corso del corrente
CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE
 Obiettivi generali del processo formativo CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE La comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
Obiettivi generali del processo formativo CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE La comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
Il signor Rigoni DAL MEDICO
 5 DAL MEDICO Per i giornali, Aristide Rigoni è l uomo più strano degli ultimi cinquant anni, dal giorno della sua nascita. È un uomo alto, forte, con due gambe lunghe e con una grossa bocca. Un uomo strano,
5 DAL MEDICO Per i giornali, Aristide Rigoni è l uomo più strano degli ultimi cinquant anni, dal giorno della sua nascita. È un uomo alto, forte, con due gambe lunghe e con una grossa bocca. Un uomo strano,
PROGETTAZIONE ANNUALE - CLASSE II
 PROGETTAZIONE ANNUALE - CLASSE II ITALIANO 1. Prerequisiti: 1 - Saper leggere e decodificare un testo 2 - Saper ricodificare secondo modalità e tempi stabiliti 3 - Saper leggere e manipolare un testo 4
PROGETTAZIONE ANNUALE - CLASSE II ITALIANO 1. Prerequisiti: 1 - Saper leggere e decodificare un testo 2 - Saper ricodificare secondo modalità e tempi stabiliti 3 - Saper leggere e manipolare un testo 4
ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO Villa Ranchibile LICEO SCIENTIFICO. PROGRAMMA DI ITALIANO Svolto nella classe 1 a sez. A
 ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO Villa Ranchibile Via Libertà, 199 90143 PALERMO LICEO SCIENTIFICO Anno scolastico 2016/2017 PROGRAMMA DI ITALIANO Svolto nella classe 1 a sez. A Docente: Prof.ssa MICELI Angela
ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO Villa Ranchibile Via Libertà, 199 90143 PALERMO LICEO SCIENTIFICO Anno scolastico 2016/2017 PROGRAMMA DI ITALIANO Svolto nella classe 1 a sez. A Docente: Prof.ssa MICELI Angela
PERMESSO, SCUSA, GRAZIE
 PERMESSO, SCUSA, GRAZIE Misericordia e famiglia dall incontro con Franco Miano e Pina De Simone Imola, 11 marzo 2016 suggerimenti per riflessioni personali e di gruppo PROBLEMA = OPPORTUNITÀ Nei luoghi
PERMESSO, SCUSA, GRAZIE Misericordia e famiglia dall incontro con Franco Miano e Pina De Simone Imola, 11 marzo 2016 suggerimenti per riflessioni personali e di gruppo PROBLEMA = OPPORTUNITÀ Nei luoghi
ITALIANO. RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati. VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
 ITALIANO UNITA DI APPRENDIMENTO 1 Ascoltare e parlare. Conoscenze: Lessico attivo e passivo adeguato agli scambi sociali e culturali. Rapporti di significato tra le parole. Natura e funzione delle parole.
ITALIANO UNITA DI APPRENDIMENTO 1 Ascoltare e parlare. Conoscenze: Lessico attivo e passivo adeguato agli scambi sociali e culturali. Rapporti di significato tra le parole. Natura e funzione delle parole.
Quale Russell? APPROFONDIMENTO DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO. a cura del prof. Flaviano Scorticati
 Quale Russell? APPROFONDIMENTO DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO a cura del prof. Flaviano Scorticati Un piccolo gioco per riscaldare l atmosfera CHE COSA HANNO IN COMUNE QUESTE IMMAGINI? BABBO NATALE IL QUADRATO
Quale Russell? APPROFONDIMENTO DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO a cura del prof. Flaviano Scorticati Un piccolo gioco per riscaldare l atmosfera CHE COSA HANNO IN COMUNE QUESTE IMMAGINI? BABBO NATALE IL QUADRATO
L ILIADE DI OMERO. Un introduzione PERCHE STUDIARLA?
 L ILIADE DI OMERO Un introduzione PERCHE STUDIARLA? L ILIADE È UNO DEI PIÙ GRANDI POEMI MAI SCRITTI, CHE È ALLA BASE DELLA NOSTRA CULTURA E DELLA NOSTRA CONCEZIONE DEL MONDO. LEGGENDO QUESTO POEMA SI RIESCE
L ILIADE DI OMERO Un introduzione PERCHE STUDIARLA? L ILIADE È UNO DEI PIÙ GRANDI POEMI MAI SCRITTI, CHE È ALLA BASE DELLA NOSTRA CULTURA E DELLA NOSTRA CONCEZIONE DEL MONDO. LEGGENDO QUESTO POEMA SI RIESCE
La struttura del testo narrativo. Prof. Valentina Felici
 La struttura del testo narrativo Prof. Valentina Felici http://felicidistudiare.com Gli elementi del testo narrativo IL NARRATORE Chi racconta i fatti. I PERSONAGGI Chi è coinvolto negli eventi e agisce
La struttura del testo narrativo Prof. Valentina Felici http://felicidistudiare.com Gli elementi del testo narrativo IL NARRATORE Chi racconta i fatti. I PERSONAGGI Chi è coinvolto negli eventi e agisce
DIDATTICA DELL ITALIANO L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA. Dott.ssa Fallea Floriana
 DIDATTICA DELL ITALIANO (L1-L2) L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO Un testo narrativo è, un testo nel quale la storia narrata ha in se stessa la sua ragione d'essere,
DIDATTICA DELL ITALIANO (L1-L2) L2) PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO Un testo narrativo è, un testo nel quale la storia narrata ha in se stessa la sua ragione d'essere,
PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO
 PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO TRAMA PERSONAGGI TEMPO TESTO NARRATIVO SPAZIO NARRATORE TESTO NARRATIVO: un testo è narrativo quando è caratterizzato dallo sviluppo di una trama, dalla presenza di un
PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO TRAMA PERSONAGGI TEMPO TESTO NARRATIVO SPAZIO NARRATORE TESTO NARRATIVO: un testo è narrativo quando è caratterizzato dallo sviluppo di una trama, dalla presenza di un
Curricolo di Italiano- classe prima. Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti
 Curricolo di Italiano- classe prima Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti Ascoltare 1. Presta attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto
Curricolo di Italiano- classe prima Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti Ascoltare 1. Presta attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto
EUGENIO MONTALE (Genova 1896 Milano 1981)
 EUGENIO MONTALE (Genova 1896 Milano 1981) «Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni.»
EUGENIO MONTALE (Genova 1896 Milano 1981) «Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni.»
REMAKE. è sempre la stessa storia?
 REMAKE è sempre la stessa storia? IL FANTASMA DELL OPERA di Rupert Julian USA 1925 92 b/n con Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry di Joel Schumacher USA / GB 2004 143 colore con Gerard Butler, Emmy
REMAKE è sempre la stessa storia? IL FANTASMA DELL OPERA di Rupert Julian USA 1925 92 b/n con Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry di Joel Schumacher USA / GB 2004 143 colore con Gerard Butler, Emmy
Un corpo che non mente/ Stupidity testi originali del gruppo regia Silvia Scotti, Cosimo Gigante/ Francesco Marchi
 PREMIO SPECIALE TEATRO CIVILE LICEO G. MARCONI PARMA Un corpo che non mente/ Stupidity testi originali del gruppo regia Silvia Scotti, Cosimo Gigante/ Francesco Marchi Il Liceo Scientifico Marconi di Parma
PREMIO SPECIALE TEATRO CIVILE LICEO G. MARCONI PARMA Un corpo che non mente/ Stupidity testi originali del gruppo regia Silvia Scotti, Cosimo Gigante/ Francesco Marchi Il Liceo Scientifico Marconi di Parma
MOSTRA DA GIOTTO A DE CHIRICO, I TESORI NASCOSTI
 Allegato 1 MOSTRA DA GIOTTO A DE CHIRICO, I TESORI NASCOSTI Progetto espositivo da Giotto a de Chirico I T E S O R I N A S C O S T I U N P R O G E T T O D I R E G I O N E L O M B A R D I A a cura di V
Allegato 1 MOSTRA DA GIOTTO A DE CHIRICO, I TESORI NASCOSTI Progetto espositivo da Giotto a de Chirico I T E S O R I N A S C O S T I U N P R O G E T T O D I R E G I O N E L O M B A R D I A a cura di V
MOMENTO MAGICO CON LE POESIE DI ANNA LIPPOLIS. Scritto da Katia Balbo Mercoledì 04 Luglio :40
 L incommensurabile fede e la devozione per la Madonna, la poesia come cura dell angolo oscuro dell anima, la scrittura come rifugio e mezzo di autoanalisi sono i temi affrontati nel pomeriggio di giovedì
L incommensurabile fede e la devozione per la Madonna, la poesia come cura dell angolo oscuro dell anima, la scrittura come rifugio e mezzo di autoanalisi sono i temi affrontati nel pomeriggio di giovedì
Analisi e comprensione del testo ( GRUPPO 1)
 Analisi e comprensione del testo ( GRUPPO 1) 1. Rispondi con una x Il testo è : un racconto realistico perché personaggi, luoghi e fatti sono reali o verosimili. una fiaba perché c è un incantesimo un
Analisi e comprensione del testo ( GRUPPO 1) 1. Rispondi con una x Il testo è : un racconto realistico perché personaggi, luoghi e fatti sono reali o verosimili. una fiaba perché c è un incantesimo un
COMPETENZE DISCIPLINARI Religione
 COMPETENZE DISCIPLINARI Religione AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO RELIGIONE COMPETENZA ABILITA L alunno è in grado di CONOSCENZE L alunno conosce Esperienze di vita - Universalità/molteplicità del fatto religioso
COMPETENZE DISCIPLINARI Religione AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO RELIGIONE COMPETENZA ABILITA L alunno è in grado di CONOSCENZE L alunno conosce Esperienze di vita - Universalità/molteplicità del fatto religioso
Educazione Linguistica (lingua come codice) ortografia e punteggiatura morfologia sintassi della frase semplice e complessa
 Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
Liceo B. Russell VIA IV NOVEMBRE 35, 38023 CLES Tutti gli indirizzi Anno scolastico Disciplina: Lingua e letteratura italiana CLASSE 1 1. comunicare e interagire verbalmente in contesti di varia natura
Gli elementi della comunicazione
 Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo Gli elementi della comunicazione App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Il processo di comunicazione La
Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo Gli elementi della comunicazione App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Il processo di comunicazione La
AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO
 AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO Area disciplinare: LINGUA ITALIANA LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 1, 2 e 3 anno della Scuola Primaria l'alunno è in grado di leggere in modo scorrevole;
AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO Area disciplinare: LINGUA ITALIANA LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 1, 2 e 3 anno della Scuola Primaria l'alunno è in grado di leggere in modo scorrevole;
Competenza : 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione
 SCUOLA DELL INFANZIA LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE Gestualità, arte, musica, multimedialità Competenza : 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Descrittori Descrittori
SCUOLA DELL INFANZIA LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE Gestualità, arte, musica, multimedialità Competenza : 1. Comunicazione efficace Indicatore: 1.1 Comprensione Descrittori Descrittori Descrittori
UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l interazione
 CPIA PALERMO 2 PROGETTAZIONE PER UNITA DI APPRENDIMENTO PERCORSO DI ISTRUZIONE DI I LIVELLO - SECONDO PERIODO DIDATTICO a.s. 2016/2017 ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO) UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01:
CPIA PALERMO 2 PROGETTAZIONE PER UNITA DI APPRENDIMENTO PERCORSO DI ISTRUZIONE DI I LIVELLO - SECONDO PERIODO DIDATTICO a.s. 2016/2017 ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO) UDA n.1 STUDIARE LA GRAMMATICA C1_01:
Noi e gli altri in una terra di pace
 D IREZIONE IDATTICA STATALE - BASTIA UMBRA - Via Roma, 54 Tel. e Fax 075/8000583 E mail: dir.bastiadonbosco@libero.it - C.F.80009260540 Noi e gli altri in una terra di pace Laudato sii, mi Signore per
D IREZIONE IDATTICA STATALE - BASTIA UMBRA - Via Roma, 54 Tel. e Fax 075/8000583 E mail: dir.bastiadonbosco@libero.it - C.F.80009260540 Noi e gli altri in una terra di pace Laudato sii, mi Signore per
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE
 DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
DIREZIONE DIDATTICA DI RACCONIGI CURRICOLO DI LINGUA INGLESE PREMESSA Il Curricolo di lingua straniera attualmente in uso nel nostro circolo è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni del Progetto
Prof. Alessandro Rizzi Laboratorio di Multimedia II
 CHI E UNO SCENEGGIATORE (scriptwriter; nel cinema: screenwriter) E uno autore che scrive per il cinema e ha il compito di trasformare un idea in linguaggio cinematografico. La sua funzione principale è
CHI E UNO SCENEGGIATORE (scriptwriter; nel cinema: screenwriter) E uno autore che scrive per il cinema e ha il compito di trasformare un idea in linguaggio cinematografico. La sua funzione principale è
LA LINGUA DEL TEATRO CIVILE ANALISI DEI TESTI DI MARCO PAOLINI
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE LA LINGUA DEL TEATRO CIVILE ANALISI DEI TESTI DI MARCO PAOLINI RELATORE Prof.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE LA LINGUA DEL TEATRO CIVILE ANALISI DEI TESTI DI MARCO PAOLINI RELATORE Prof.
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.I.S. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel: 035 250547 035 253492 Fax: 035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.I.S. CATERINA CANIANA Via Polaresco 19 24129 Bergamo Tel: 035 250547 035 253492 Fax: 035 4328401 http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Il narratore e la storia
 Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo Il narratore e la storia App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Il narratore L autore, dopo aver strutturato
Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo Il narratore e la storia App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM Il narratore L autore, dopo aver strutturato
A rebours NOME... COGNOME... CLASSE... DATA...
 NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... A rebours 5 10 15 Si potrebbe raccontare la mia vita dai denti che ho perduto o dalle volte che ho visto la neve. Si potrebbe scegliere fra le foto quelle dove sorrido
NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... A rebours 5 10 15 Si potrebbe raccontare la mia vita dai denti che ho perduto o dalle volte che ho visto la neve. Si potrebbe scegliere fra le foto quelle dove sorrido
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÁ
 ASCOLTARE E PARLARE - Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta; - Intervenire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione
ASCOLTARE E PARLARE - Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta; - Intervenire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione
NUCLEI FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 DAI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AGLI OBIETTIVI D APPRENDIMENTO -CURRICOLO DI Religione.. - SCUOLA PRIMARIA FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
DAI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AGLI OBIETTIVI D APPRENDIMENTO -CURRICOLO DI Religione.. - SCUOLA PRIMARIA FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
 SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI RACCONIGI CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE INDICATORE I Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI RACCONIGI CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE INDICATORE I Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
ATTIVITA GUIDATA PER LA PRODUZIONE DEL TESTO IL TESTO DESCRITTIVO
 ATTIVITA GUIDATA PER LA PRODUZIONE DEL TESTO IL TESTO DESCRITTIVO Materiale elaborato dall ins. Luisa Vantini per alunni della scuola secondaria di primo grado Fonti: Detto e fatto Fabbri e Binario 9 e
ATTIVITA GUIDATA PER LA PRODUZIONE DEL TESTO IL TESTO DESCRITTIVO Materiale elaborato dall ins. Luisa Vantini per alunni della scuola secondaria di primo grado Fonti: Detto e fatto Fabbri e Binario 9 e
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
IL DIAVOLO NELLA BOTTIGLIA
 IL DIAVOLO NELLA BOTTIGLIA autore : Robert Louis Stevenson nasce a Edimburgo nel 1850. Dopo una giovinezza ribelle, segnata da profondi conflitti col padre e con la borghesia puritana del suo ambiente,
IL DIAVOLO NELLA BOTTIGLIA autore : Robert Louis Stevenson nasce a Edimburgo nel 1850. Dopo una giovinezza ribelle, segnata da profondi conflitti col padre e con la borghesia puritana del suo ambiente,
È VERO, L HO LETTO SUL GIORNALE! Il linguaggio dei mass media nei casi di violenza alle donne e ai minori
 È VERO, L HO LETTO SUL GIORNALE! Il linguaggio dei mass media nei casi di violenza alle donne e ai minori IL GRUPPO DI LAVORO SUI MASS MEDIA DI LINEA ROSA Dal 1996 Rassegna Stampa provinciale, regionale
È VERO, L HO LETTO SUL GIORNALE! Il linguaggio dei mass media nei casi di violenza alle donne e ai minori IL GRUPPO DI LAVORO SUI MASS MEDIA DI LINEA ROSA Dal 1996 Rassegna Stampa provinciale, regionale
FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA
 FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA 1 ADVERTISING LEZIONE 8 2 IL LINGUAGGIO DELLA CREATIVITA 3 IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO Segue il linguaggio sancito dallo sviluppo dei media, da quelli di settore a quelli di
FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA 1 ADVERTISING LEZIONE 8 2 IL LINGUAGGIO DELLA CREATIVITA 3 IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO Segue il linguaggio sancito dallo sviluppo dei media, da quelli di settore a quelli di
Leggere per studiare
 Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
MODELO DE CORRECCIÓN
 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO JUNIO 2016 COMPRENSIÓN ORAL MODELO DE CORRECCIÓN HOJA DE RESPUESTAS EJERCICIO 1:
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO JUNIO 2016 COMPRENSIÓN ORAL MODELO DE CORRECCIÓN HOJA DE RESPUESTAS EJERCICIO 1:
PROGETTO LIBRIAMOCI A SCUOLA
 PROGETTO LIBRIAMOCI A SCUOLA Leggere l Orlando Furioso è come vivere un avventura fra dame, cavalieri, essere magici e misteriosi. Sei abbastanza coraggioso/a? CINZIA CAPITANIO cinzia.capitanio@alice.it
PROGETTO LIBRIAMOCI A SCUOLA Leggere l Orlando Furioso è come vivere un avventura fra dame, cavalieri, essere magici e misteriosi. Sei abbastanza coraggioso/a? CINZIA CAPITANIO cinzia.capitanio@alice.it
Il Mahabharata di Jean-Claude Carriére - Vallardi Industrie Grafiche ( )
 Il Mahabharata di Jean-Claude Carriére - Vallardi Industrie Grafiche (1989-2003) Per chi non ne sa nulla è bene ricordare che il Mahabharata non è un romanzo scritto da Jean-Claude Carriére, bensì il più
Il Mahabharata di Jean-Claude Carriére - Vallardi Industrie Grafiche (1989-2003) Per chi non ne sa nulla è bene ricordare che il Mahabharata non è un romanzo scritto da Jean-Claude Carriére, bensì il più
L età cortese XI-XIII secolo. Pearson Italia S.p.a.
 L età cortese XI-XIII secolo Cultura e mentalità in Francia verso la fine dell XI secolo rafforzamento della cavalleria esigenza di una nuova produzione letteraria in lingua volgare cavalleria: classe
L età cortese XI-XIII secolo Cultura e mentalità in Francia verso la fine dell XI secolo rafforzamento della cavalleria esigenza di una nuova produzione letteraria in lingua volgare cavalleria: classe
LINGUA ITALIANA. Classe SECONDA SCUOLA PRIMARIA. SEZIONE A: Traguardi formativi e percorsi didattici
 LINGUA ITALIANA Classe SECONDA SCUOLA PRIMARIA SEZIONE A: Traguardi formativi e percorsi didattici COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA CONOSCENZE PERCORSI DIDATTICI (compiti significativi, esperienze irrinunciabili)
LINGUA ITALIANA Classe SECONDA SCUOLA PRIMARIA SEZIONE A: Traguardi formativi e percorsi didattici COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA CONOSCENZE PERCORSI DIDATTICI (compiti significativi, esperienze irrinunciabili)
 Tema socioculturale: Omofobia Strutture della lingua: discorso indiretto, congiuntivo presente Destinatari: livello B1 Testo letterario: Giorgio Bassani 1980, Gli occhiali d oro, Milano, p. 16,17 Film:
Tema socioculturale: Omofobia Strutture della lingua: discorso indiretto, congiuntivo presente Destinatari: livello B1 Testo letterario: Giorgio Bassani 1980, Gli occhiali d oro, Milano, p. 16,17 Film:
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO a. s. 2015/ 2016
 PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO a. s. 2015/ 2016 DOCENTE TARSITANO ADELE CLASSE 1MA DISCIPLINA ITALIANO TESTO IN USO: Sciogliere i nodi 2.0 C. Savigliano Garzanti Scuola 1) RIFLESSIONE SULLA LINGUA I fonemi,
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO a. s. 2015/ 2016 DOCENTE TARSITANO ADELE CLASSE 1MA DISCIPLINA ITALIANO TESTO IN USO: Sciogliere i nodi 2.0 C. Savigliano Garzanti Scuola 1) RIFLESSIONE SULLA LINGUA I fonemi,
VIAGGI NELLE STORIE. Frammenti di cinema. per narrare. L incontro. Percorso di italiano L2 per donne straniere
 VIAGGI NELLE STORIE Frammenti di cinema per narrare L incontro Percorso di italiano L2 per donne straniere Claudia Barlassina e Marilena Del Vecchio Aprile Maggio 2009 1 VIAGGI NELLE STORIE I PARTE GUARDA
VIAGGI NELLE STORIE Frammenti di cinema per narrare L incontro Percorso di italiano L2 per donne straniere Claudia Barlassina e Marilena Del Vecchio Aprile Maggio 2009 1 VIAGGI NELLE STORIE I PARTE GUARDA
Denotazione e connotazione sono termini con i quali si designano due diversi valori del significato di una parola.
 Denotazione e connotazione sono termini con i quali si designano due diversi valori del significato di una parola. Denotazione è la caratteristica che identifica il significato di base di ogni parola,
Denotazione e connotazione sono termini con i quali si designano due diversi valori del significato di una parola. Denotazione è la caratteristica che identifica il significato di base di ogni parola,
Protocollo dei saperi imprescindibili a.s Ordine di scuola: professionale Indirizzi Servizi Commerciali
 INDICE PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 1 P. 2 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 2 P. 3 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 3 P. 4 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 4 P. 5 PROTOCOLLO
INDICE PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 1 P. 2 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 2 P. 3 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 3 P. 4 PROTOCOLLO SAPERI IMPRESCINDIBILI CLASSE 4 P. 5 PROTOCOLLO
Giuseppe Parini e il neoclassicismo. XVIII secolo
 Giuseppe Parini e il neoclassicismo XVIII secolo classico Scrittore esemplare, superiore alla media, le cui opere servono da modello di riferimento relativo alla cultura greca e romana, intesa come modello
Giuseppe Parini e il neoclassicismo XVIII secolo classico Scrittore esemplare, superiore alla media, le cui opere servono da modello di riferimento relativo alla cultura greca e romana, intesa come modello
