Augusto Ponzio. Trentuno tesi sulla linguistica generale
|
|
|
- Placido Carella
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Augusto Ponzio Trentuno tesi sulla linguistica generale 1) La pragmatica, insieme alla sintattica e alla semantica, è anch essa una dimensione fondamentale del segno, che, come tale, è presente nella lingua ed inseparabile dalle altre due, così come ciascuna di queste è inseparabile da essa. 2) Alla sintattica corrisponde, nella linguistica, non solo il componente sintattico della lingua, ma anche quello fonologico, perché in entrambi i casi entra in gioco l articolazione, la connessione, la composizione di elementi (fonemi, monemi, morfemi). 3) Il componente semantico nel senso linguistico è anch esso compreso nella sintattica, perché presuppone anch esso, nell enunciazione, operazioni di selezione e di connessione che si realizzano su un duplice asse, sintagmatico e paradigmatico. 4) La semantica linguistica rientra evidentemente nella semantica semiotica, ma con quest ultima, cioè con la dimensione del significato come dimensione del segno in generale, hanno a che fare anche la fonologia e la sintassi, perché in ogni caso interviene un rapporto interpretante- interpretato e dunque l interpretazione di qualcosa come segno, cioè come avente significato. Anche al livello dell identificazione fonologica o grafologica e dell identificazione logico-sintattica, cioè al livello della identificazione formale, come fase distinta da quella contenutistica, entra in gioco un problema di significato, perché si presenta pur sempre un problema di interpretazione. Oltre che della semantica in senso ristretto, ordinario, distinta dalla fonologia e dalla sintassi, bisogna tener conto dunque di una semantica che ingloba la stessa fonologia e la stessa sintassi. Il comportamento verbale è un atto interpretativo e, come tale, ha a che fare sempre, e non solo al livello semantico, con questioni di significato. 5) Il significato di un segno verbale, sia esso un unità fonematica, o una struttura sintattica, o una frase, o l enunciazione intera, non è un rapporto interpretativo circoscrivibile all interno della lingua. In realtà, ogni volta che qualcosa ha significato, non c è tipo di segno che possa essere escluso dal percorso interpretativo in cui tale qualcosa si colloca. Possiamo allora dire che il significato è un fatto semiotico, perché coinvolge, ogni volta in cui sussiste, tutti i tipi di segni: non ci sono, propriamente parlando, significati verbali, o significati non verbali. Né ci sono significati esclusivi di una lingua o di un linguaggio considerati come sistemi o codici autosufficienti. Ciò comporta anche il carattere semiotico e non semplicemente linguistico-verbale delle procedure generative dell identificazione del segno verbale e della sua disambiguazione. I limiti della grammatica generativa della lingua sono dati dal fatto che essa deve fare ricorso a interpretanti che non rientrano in essa e che sono anche interpretanti non-verbali.
2 6) In base a (1), i componenti della linguistica non sono tre (fonologia, sintattica, semantica), ma quattro, dato che il segno verbale, come ogni segno, richiede non solo un interpretante di identificazione, ma anche un interpretante di comprensione rispondente o pragmatico. Sicché, riepilogando, il rapporto tra le tre dimensioni del segno e i componenti della lingua è il seguente: Componenti linguistici fonologico e sintattico semantico pragmatico Dimensioni del segno sintattica (+ semantica e pragmatica) semantica (+ sintattica e pragmatica) pragmatica (+ sintattica e semantica) 7) La teoria linguistica chomskiana resta limitata alla considerazione della produzione di interpretanti di identificazione, anzi riducel interpretazione alla sola identificazione. Inoltre, dicendo che la grammatica generativa di una lingua dovrebbe contenere, idealmente, un componente sintattico centrale e due componenti interpretative (un componente fonologico e un componente semantico), Chomsky nega il carattere interpretativo del componente sintattico, relegando l interpretazione al solo componente fonologico e al componente semantico. Così facendo, distingue il generare (che riguarda il rapporto fra strutture superficiali e strutture profonde e le regole di trasformazione) dall interpretare. Il privilegiamento della sintassi da parte di Chomsky fino a farne un fondamento infondato, un a priori innatisticamente inteso, consiste nel sottrarla all interpretazione, nel considerarla esente da rapporti interpretato-interpretante. Tali rapporti, invece, riguardano tutti i livelli del segnico in generale. La capacità di disambiguazione, che Chomsky attribuisce a strutture profonde, consiste nella funzione generativa di interpretanti che non sono previsti nel sistema linguistico della lingua, ma che derivano dalla com- prensione dell enunciazione nel suo contesto verbale e situazionale, nei suoi rapporti di traduzione endosemiotica e intersemiotica. 8) La molteplicità delle lingue (e il plurilinguismo interno ad ogni lingua), l enigma di Babele che, malgrado l insistenza sul carattere creativo del linguaggio (verbale), la linguistica di Chomsky, che fa ricorso al presupposto di una innata (cartesianamente) Grammatica universale, non può riuscire a spiegare, è l espressione della capacità della modellazione umana di inventare più mondi, ossia della sua disposizione al gioco del fantasticare (Peirce) o, come direbbe Vico, della logica poetica propria dell essere umano. 9) Il linguaggio oltre a, e prima ancora di, presentarsi come verbale e di svolgere, attraverso il verbale, funzioni comunicative che incrementano e rinnovano qualitativamente anche quelle dei comportamenti segnici non verbali (che dunque si presentano anch essi come linguaggi ), è una procedura preferiamo questa espressione a quella di sistema, ripresa da Thomas A. Sebeok dalla semiotica di Mosca-Tartu modellizzante, un modello di costruzione del mondo. La sua funzione specifica è quella di significare, di interpretare, di
3 conferire senso. 10) Tutti gli animali hanno modelli di costruzione del mondo, e il linguaggio è quello dell uomo, che però differisce totalmente dale procedure di modellazione degli altri animali, mentre non differiscono i tipi di segno che esso impiega (icone, indici, simboli, ecc.). La sua caratteristica specifica è l articolazione, la sintattica, una procedura combinatoria che permette di utilizzare un numero finito di elementi per produrre un numero illimitato di sensi e di significati. 11) L articolazione del linguaggio verbale (la doppia articolazione di Martinet) è un aspetto della procedura modellizzante del linguaggio, che articola il mondo per differenziazione e differimento. 12) In quanto sintattica, la modellazione del linguaggio si serve di pezzi che possono essere messi insieme in un numero infinito di modi. In tale maniera, essa può dar luogo a un numero indeterminato di modelli che si possono smontare per costruire con gli stessi pezzi modelliì diversi. Perciò, come dice Sebeok, in virtù del loro linguaggio gli uomini possono non solo produrre il loro mondo, come gli altri animali, ma anche un numero infinito di mondi possibili: è il gioco del fantasticare (espressione di Peirce divenuta il titolo di un libro di Sebeok), che svolge un ruolo importante nella ricerca scientifica e in ogni forma di investigazione, come pure nella simulazione, dalla menzogna alla fiction, e in ogni forma di creazione artistica. La creatività che Chomsky considera come carattere specifico del linguaggio verbale è invece in esso derivata, mentre è propria del linguaggio come procedura primaria di modellazione. L a priori non è il parlare. L a priori è il linguaggio come modellazione primaria. 13) Il linguaggio è un congegno di modellazione (modelling device), di cui era già dotato, anche se certamente in maniera non sviluppata, il primo ominide, ed è questa originaria dotazione della specie umana a spiegarne lo sviluppo fino all Homo sapiens (v. Sebeok 1994, pp ). Il linguaggio (il sistema primario di modellazione della specie Homo) è apparso e si evoluto per adattamento, molto prima del parlare, nel corso dell evoluzione della specie umana fino all Homo sapiens. Il linguaggio non fu in origine un congegno comunicativo. Anche Chomsky sostiene il carattere non essenzialmente comunicativo del linguaggio, ma dicendo linguaggio Chomsky vuol dire linguaggio verbale, parlare, ciò che Sebeok chiama speech. Per Sebeok invece il linguaggio verbale ha, fin dalla sua apparizione per adattamento, una specifica funzione comunicativa. La teoria del linguaggio verbale di Chomsky non tiene conto della differenza tra linguaggio come modellazione primaria e linguaggio verbale, e senza questa differenza non è possibile spiegare adeguatamente né l origine, né il funzionamento del linguaggio verbale.
4 14) Il linguaggio verbale, il parlare, si sviluppò dal linguaggio inteso come dispositivo modellizzante in seguito all evoluzione delle capacità fisiche e neurologiche, che resero possibile l impiego del linguaggio per la comunicazione vocale. Il parlare, come il linguaggio, è apparso anch esso per adattamento, ma con funzione comunicativa, e molto tempo dopo rispetto al linguaggio, precisamente con la comparsa dell Homo sapiens. 15) Nel corso dell evoluzione della specie umana per un processo di exattamento (exaptation) anche il linguaggio assunse funzioni comunicative potenziando quelle del parlare, e il parlare assunse funzioni di modellazione potenziando quelle del linguaggio e realizzandosi quindi in ciascuna delle molteplici lingue. Exattato per la comunicazione verbale prima nella forma di linguaggio verbale orale e poi di linguaggio verbale scritto, il linguaggio permise anche il rafforzamento delle capacità umane di comunicazione non verbale dando luogo a un ampio e complesso sviluppo di linguaggi non verbali. Il parlare, a sua volta, fu exattato per la modellazione e quindi per funzionare, in quanto lingua, come sistema secondario di modellazione. In tal modo, il parlare, oltre a incrementare la capacità di comunicazione e a potenziare quelle dei linguaggi non verbali favorendone anche la specializzazione e proliferazione, sviluppò la capacità semiotica dell uomo sul piano conoscitivo, organizzativo, inventivo, ecc. 16) Come abbiamo già accennato in (13), c è una certa confusione nella tesi di Chomsky secondo cui la comunicazione non è la funzione specifica del linguaggio. Quando Chomsky nega al linguaggio la funzione comunicativa come funzione specifica non si riferisce affatto al linguaggio come modellazione primaria. Chomsky quando dice linguaggio dice linguaggio verbale, anzi si riferisce particolarmente al parlare, la cui funzione originaria, che ne ha determinato la formazione e lo sviluppo, è invece proprio quella comunicativa. 17) A Chomsky manca il concetto di modellazione, che invece è presente nella teoria, diametralmente opposta a quella chomskiana, di Sapir e Whorf, nota come teoria della relatività linguistica, la quale però non facendo risalire la modellazione (secondaria) delle lingue a quella (primaria) del linguaggio non spiega la diversità e la molteplicità delle lingue e inoltre tende presentarle come universi chiusi. 18) Quando per spiegare le grammatiche particolari delle lingue, risale dalle lingue al linguaggio, Chomsky descrive il linguaggio in termini di facoltà innata, piuttosto che di sistema specie-specifico di modellazione, di raffigurazione del mondo; e anche quando usa l espressione grammatica per riferirsi al linguaggio ( grammatica universale distinta dalle grammatiche delle diverse lingue), termine che andrebbe bene per indicare il carattere modellizzante e la funzione trascendentale del linguaggio, pensa alla grammatica nel senso di quella secondo lui deputata alla generazione delle frasi delle diverse lingue, e che quindi è dotata, come questa, di un componente fonologico, un componente sintattico e un
5 componente semantico, con la sola differenza che si tratta di una grammatica universale. 19) Chomsky nega la funzione comunicativa al linguaggio verbale per isolare le lingue dal contesto storico-sociale (non è casuale la sua negazione del valore di scienza alla sociolinguistica) e per attribuire loro un assoluta autonomia dai linguaggi non verbali, come se fossero possibili percorsi interpretativi fatti unicamente di segni verbali, di rinvii da interpretanti verbali a interpretanti verbali (le sue strutture superficiali e profonde). 20) La mancanza di distinzione fra linguaggio e linguaggio verbale dà luogo, in chi come Lieberman (1975) cerca di spiegare l origine del linguaggio impiegando concetti della teoria chomskiana, a forme di riduzionismo psicologico, secondo il quale complessi processi antropogenici vengono riassunti nello sviluppo lineare di certe capacità cognitive, descritte per giunta nel linguaggio della sintattica tradizionale (Rossi-Landi). 21) Come con la sua teoria del linguaggio come lavoro propone Rossi-Landi a partire dai suoi scritti degli anni Sessanta, si tratta di passare, nello studio del linguaggio, dal livello della descrizione del comportamento linguistico (comportamentismo), dal livello dell uso linguistico (Wittgenstein), dal livello del linguaggio ordinario (filosofia oxoniense), dal livello dello stato di una lingua determinata (Saussure), dal livello dell analisi tassonomica (Martinet) e da quello della visione del mondo di una data lingua (teoria della relatività linguistica di Sapir e Whorf) al livello della esplicitazione delle strutture e dei processi di cui le lingue sono il prodotto. Si tratta della questione del superamento delle teorie del linguaggio di tipo descrittivistico, ma anche della teoria chomskiana, che, pur orientata in senso esplicativo e genealogico, ritiene di dover descrivere una grammatica universale innata che è in effetti il risultato dell ipostatizzazione della stessa lingua che dovrebbe spiegare. Usando la terminologia ripresa dalla critica di Marx all economia politica, Rossi- Landi imposta il problema come necessità di uno spostamento dello studio del linguaggio verbale dal livello del mercato linguistico a quello del lavoro linguistico. 22) La modellazione lavora ciò che Hjelmslev chiama materia (purport), cioè un continuum amorfo sia sul piano acustico sia su quello semantico, sul quale vengono tracciati dei confini e ritagliati tratti e forme tramite l azione formativa del linguaggio. Il linguaggio articola l indistinta materia dell espressione e del contenuto in differenti modi a seconda delle differenti lingue. Per usare la terminologia di Rossi-Landi, il lavoro linguistico produce differenti paradigmi corrispondenti ai vari mondi delle diverse lingue. La stessa cosa avviene nell articolazione e organizzazione del continuum sociale delle diverseculture, per esempio nei sistemi di parentela analizzati da Lévi-Strauss. Sulla materia nel senso di Hjelmslev, il linguaggio umanocome procedura modellizzante, come scrittura ante litteram, produce interpretati e interpretanti sul piano del contenuto e sul piano dell espressione. Così, per il lavoro linguistico depositato nelle diverse lingue, come la stessa sabbia si può mettere in stampi diversi, come la stessa nuvola può assumere sempre
6 nuove forme, così la stessa materia può essere formata o ristrutturata diversamente in lingue diverse (Hjelmslev). 23) La creatività del linguaggio verbale e la sua capacità di autonomizzarsidalla funzione comunicativa, come pure la capacità dellascrittura di affrancarsi dalla sua funzione (mnemotecnica) di trascrizione del linguaggio verbale orale e di presentarsi come scrittura creative (la scrittura letteraria), dipendono dal loro essere impiantate sulla modellazione del linguaggio che si caratterizza per la sua capacità di innovazione e inventiva senza limiti interni. 24) La riflessione sul linguaggio e sul parlare permette di comprendere in che cosa consista l essere sapiens, anzi sapiens sapiens, con cui viene caratterizzato l uomo nella stadio più elevato della sua evoluzione. L uomo è l unico animale capace di semiotica, cioè di riflessione sull uso dei segni, sulla semiosi, mentre condivide quest ultima con tutti gli esseri viventi (v. Deely, Petrilli, Ponzio, Semiotic Animal, 2005). 25) Il linguaggio verbale gioca in tutto questo un ruolo fondamentale. Esso è la forma di esistenza della coscienza e del pensiero, ma non è la sua origine (Rossi- Landi,). 26) In quanto strutturale ed esplicativa, la teoria linguistica è ipotetico- deduttiva, ovvero abduttiva (Peirce), nel senso che si presenta come un insieme di ipotesi, le quali, pur avendo a che fare con oggetti, proprietà e rapporti non immediatamente dati all osservazione diretta, cioè con costrutti, con strutture, partono tuttavia dalla osservazione di fenomeni empirici e devono essere verificate in base ad essi. 27) Il carattere ipotetico-deduttivo della teoria linguistica comporta che essa debba essere bigraduale (Shaumjan, 1965) nel senso che non può immediatamente, direttamente specificare, caratterizzare aspetti, rapporti e proprietà del linguaggio verbale, ma deve procedere in due momenti distinti, assumendo, nel primo, come oggetto d analisi oggetti linguistici ideali per il fatto stesso che si considera il linguaggio verbale dal punto di vista semiotico e dunque in base a modelli generali di segno e di linguaggio e, nel secondo, verificando la validità di tali oggetti per l analisi di fenomeni linguistici concreti. Uno dei limiti fondamentali della teoria linguistica chomskiana consiste appunto nella confusione di questi due piani di astrazione linguistica attribuendo al linguaggio verbale caratteristiche che invece riguardano il piano della idealizzazione e, viceversa, scambiando, per leggi e strutture universali del linguaggio verbale modalità e caratteristiche specifiche di una lingua particolare, precisamente della lingua inglese (ne è prova il fatto che le frasi-esempio di Chomsky, che sono in lin- gua inglese, non funzionano più come tali se tradotte in un altra lingua). 28) I limiti delle teorie generative sia di Chomsky sia di Shaumjan (1965) consistono soprattutto nel fatto che il loro carattere esplicativo si riduce alla deduzione
7 degli oggetti linguistici astratti del livello tassonomico dell analisi linguistica facendo derivare gli uni dagli altri, cioè attraverso un gioco di rinvii che resta sul piano della linguistica tassonomica stessa. Entrambe le teorie non prendono in esame altra dimensione del linguaggio verbale se non quella della lingua quale è data nella prospettiva delle grammatiche tassonomiche. Nella teoria del linguaggio verbale, la lingua va considerata nella totalità alla quale di fatto appartiene, cioè nell universo segnico sociale. Ciò non soltanto perché nello studio del verbale non si può prescindere dalla sua dimensione semiotica e dunque da un modello generale di segno, ma anche perché la lingua si produce e si sviluppa in rapporto agli altri sistemi segnici sociali con i quali di fatto si trova ad operare (v. Shaumjan, 1987) 29) Oltre che strutturale, esplicativa, ipotetico-deduttiva (abduttiva), la teoria del linguaggio verbale deve svolgere una funzione critica. Si stabilisce così uno stretto rapporto fra studio del linguaggio verbale e critica dell ideologia intesa come progettazione sociale, che invece in Chomsky vengono mantenuti separati. Ciò vale anche per lo studio dei linguaggi non verbali, ma il segno verbale ha un maggiore ruolo in rapporto all ideologia, perché è il materiale stesso di cui sono fatte le nostre idee e la nostra coscienza. Una teoria esplicativa del linguaggio verbale non può esserlo fino in fondo se non presentandosi anche come critica dell ideologia. 30) Nella situazione sociale odierna, l ideologia che risulta dalla progettazione più ampia e più aderente alla comunicazione-produzione della fase attuale del capitalismo è quella che si presenta come ideo-logica della globalizzazione. Una teoria del linguaggio non può quindi oggi prescindere da un analisi critica di tale ideologia alla quale le lingue, contestualizzate come sono nella globalizzazione, tendono ad essere rese funzionali. 31) Ciò che Rossi-Landi chiama produzione linguistica, lavoro linguistico, capitale linguistico, considerandone i rapporti di omologia con la produzione materiale, risulta oggi fattore fondamentale della riproduzione sociale. Ad esso si riferiscono espressioni ormai di uso commune come risorsa immateriale, capitale immateriale, investimento immateriale. La produzione materiale e la produzione linguistica, che non molto tempo fa apparivano separate sotto forma di lavoro manuale e lavoro intellettuale, al punto da doverne ricercare il rapporto in termini di omologia a livelli profondi di ordine genetico e strutturale, si sono oggi congiunte saldamente. Il computer, unità di hardware e software, rende ormai eclatante la connessione di lavoro e artefatti materiali e di lavoro e artefatti linguistici, ed evidenzia, al tempo stesso, la superiorità valorizzante e il carattere trainante, nella produzione e nello sviluppo, del lavoro linguistico, del lavoro immateriale.
28. Apprendimento linguistico e genesi della proposizione predicativa... Esperienza e competenza linguistica... Genesi della proposizione predicativa
 Introduzione. Linguistica del silenzio e linguistica del tacere... 1. Due condizioni dell interpretabilità del verbale: il silenzio e il tacere... 2. Dalla linguistica del silenzio alla linguistica del
Introduzione. Linguistica del silenzio e linguistica del tacere... 1. Due condizioni dell interpretabilità del verbale: il silenzio e il tacere... 2. Dalla linguistica del silenzio alla linguistica del
Italiano Funzioni del linguaggio.
 Italiano 2012 Funzioni del linguaggio http://www.federicopellizzi.it/custodi/terze/funzioni_linguaggio.pdf 1 Il linguaggio Il linguaggio complesso è una prerogativa degli esseri umani. Solo noi possiamo
Italiano 2012 Funzioni del linguaggio http://www.federicopellizzi.it/custodi/terze/funzioni_linguaggio.pdf 1 Il linguaggio Il linguaggio complesso è una prerogativa degli esseri umani. Solo noi possiamo
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
Pregiudizio logocentrico
 Pregiudizio logocentrico L idea infinite volte ripetuta o presupposta nella storia occidentale, e quasi solo nella storia occidentale, che la parola sia condizione di ogni pensare e quindi di ogni agire
Pregiudizio logocentrico L idea infinite volte ripetuta o presupposta nella storia occidentale, e quasi solo nella storia occidentale, che la parola sia condizione di ogni pensare e quindi di ogni agire
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Linguaggio e Comunicazione
 Linguaggio e Comunicazione ò LINGUAGGIO: sistema per comunicare con altri individui usando segnali che trasmettono un signifcato e che sono combinati secondo regole di grammatica ò Ogni lingua umana consiste
Linguaggio e Comunicazione ò LINGUAGGIO: sistema per comunicare con altri individui usando segnali che trasmettono un signifcato e che sono combinati secondo regole di grammatica ò Ogni lingua umana consiste
Indice. 1. Pittogrammi e ideogrammi Ilogogrammi 35. Premessa 11. Le origini del linguaggio 13. II. Gli animali e il linguaggio umano 21
 Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
Indice Premessa 11 Le origini del linguaggio 13 1. L'origine divina 13 2. La teoria dei suoni naturali 14 3. La teoria dell'adattamento fisico 15 4. Denti, labbra, bocca, laringe e faringe 16 5. Il cervello
Alle origini del pensiero formale: IL REGNO DEI SEGNI. Di ROBERTA MARCOLI LICEO SCIENTIFICO ORAZIO GRASSI (Savona)
 + Alle origini del pensiero formale: IL REGNO DEI SEGNI Di ROBERTA MARCOLI LICEO SCIENTIFICO ORAZIO GRASSI (Savona) + Limiti e dubbi il linguaggio può completare la necessità di espressione? Teorie sulla
+ Alle origini del pensiero formale: IL REGNO DEI SEGNI Di ROBERTA MARCOLI LICEO SCIENTIFICO ORAZIO GRASSI (Savona) + Limiti e dubbi il linguaggio può completare la necessità di espressione? Teorie sulla
parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica
 Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica Sommario Quadro storico 3. 4. 5. Quadro storico
Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica Sommario Quadro storico 3. 4. 5. Quadro storico
Informatica e Comunicazione Digitale Crediti formativi 9. No, ma la frequenza è fortemente consigliata Lingua di erogazione
 Principali informazioni sull insegnamento Titolo insegnamento Linguaggi di Programmazione Corso di studio Informatica e Comunicazione Digitale Crediti formativi 9 Denominazione inglese Programming Languages
Principali informazioni sull insegnamento Titolo insegnamento Linguaggi di Programmazione Corso di studio Informatica e Comunicazione Digitale Crediti formativi 9 Denominazione inglese Programming Languages
CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE
 Obiettivi generali del processo formativo CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE La comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
Obiettivi generali del processo formativo CLASSI TERZE LA PROGRAMMAZIONE La comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
Semiotica Lumsa a.a. 2014/2015 Piero Polidoro. 10 novembre lezione 9 charles sanders peirce
 Semiotica Lumsa a.a. 2014/2015 Piero Polidoro 10 novembre 2014 lezione 9 charles sanders peirce Sommario 1. Le inferenze 2. La semiotica di Peirce 2 di 23 Charles Sanders Peirce (1839-1914) 3 Le inferenze
Semiotica Lumsa a.a. 2014/2015 Piero Polidoro 10 novembre 2014 lezione 9 charles sanders peirce Sommario 1. Le inferenze 2. La semiotica di Peirce 2 di 23 Charles Sanders Peirce (1839-1914) 3 Le inferenze
Bruner Il viaggio verso la mente
 Bruner 1915-2016 Il viaggio verso la mente Laureatosi in Psicologia nel 1941, si dedicò allo studio dell intelligenza cercando di scoprire i meccanismi della mente che seleziona ed ordina l esperienza
Bruner 1915-2016 Il viaggio verso la mente Laureatosi in Psicologia nel 1941, si dedicò allo studio dell intelligenza cercando di scoprire i meccanismi della mente che seleziona ed ordina l esperienza
Linguistica Generale. Docente: Paola Monachesi. Contents First Last Prev Next
 Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Contents 1 La linguistica e i suoi settori............................... 3 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica...............................................
I Disturbi Specifici di Linguaggio. Percorsi Evolutivi Dei DSL
 I Disturbi Specifici di Linguaggio Percorsi Evolutivi Dei DSL Il motore dell apprendimento linguistico, come acquisizione di un sistema basato su molte competenze, è il seguente: utilizzare come risolutive
I Disturbi Specifici di Linguaggio Percorsi Evolutivi Dei DSL Il motore dell apprendimento linguistico, come acquisizione di un sistema basato su molte competenze, è il seguente: utilizzare come risolutive
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1
 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1 La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi» 2 Linguistica: Scienza cognitiva (cfr. lezioni introduttive) Lo studio
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio A L C U N E I D E E B A S I L A R I 1 La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi» 2 Linguistica: Scienza cognitiva (cfr. lezioni introduttive) Lo studio
Teorie sull acquisizione del linguaggio
 Teorie sull acquisizione del linguaggio I principali problemi intorno al linguaggio sono: 1. Ruolo dei fattori genetici e di quelli ambientali 2. Rapporti tra il linguaggio e il pensiero/cognizione 3.
Teorie sull acquisizione del linguaggio I principali problemi intorno al linguaggio sono: 1. Ruolo dei fattori genetici e di quelli ambientali 2. Rapporti tra il linguaggio e il pensiero/cognizione 3.
Psicologia della comunicazione Fondamenti. Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1
 Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
Psicologia della comunicazione Fondamenti Psicologia della comunicazione I. Riccioni 1 Psicologia della comunicazione Settore scientifico-disciplinare: Psicologia generale Campo di ricerca interdisciplinare
Sommario. Perché la comunicazione per gli ingegneri?... xi Paolo Paolini. La comunicazione e le sue scienze... xvii Eddo Rigotti. Prefazione...
 Sommario Perché la comunicazione per gli ingegneri?... xi Paolo Paolini La comunicazione e le sue scienze... xvii Eddo Rigotti Prefazione... xxi Parte 1. Segno, lingua e testo... 1 1. Elementi di semiotica...
Sommario Perché la comunicazione per gli ingegneri?... xi Paolo Paolini La comunicazione e le sue scienze... xvii Eddo Rigotti Prefazione... xxi Parte 1. Segno, lingua e testo... 1 1. Elementi di semiotica...
Corso di Semiotica. a.a
 Corso di Semiotica a.a. 2014-2015 Linguistica e Semiotica: La linguistica è una scienza particolare nel generale universo (semiotico) della comunicazione. Il linguaggio verbale come codice semiotico più
Corso di Semiotica a.a. 2014-2015 Linguistica e Semiotica: La linguistica è una scienza particolare nel generale universo (semiotico) della comunicazione. Il linguaggio verbale come codice semiotico più
Corso di laurea in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (B184) PSICOLOGIA GENERALE (2CFU)
 Corso di laurea in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (B184) PSICOLOGIA GENERALE (2CFU) COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO: La comunicazione è un attività sociale: per definizione, si ha comunicazione
Corso di laurea in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (B184) PSICOLOGIA GENERALE (2CFU) COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO: La comunicazione è un attività sociale: per definizione, si ha comunicazione
Corso di Semiotica. Louis Hjelmslev. (Copenaghen )
 Corso di Semiotica Louis Hjelmslev (Copenaghen 1899-1965) 1 Opere principali I fondamenti della teoria del linguaggio, 1943 Saggi di linguistica generale, 1959 La struttura fondamentale del linguaggio,
Corso di Semiotica Louis Hjelmslev (Copenaghen 1899-1965) 1 Opere principali I fondamenti della teoria del linguaggio, 1943 Saggi di linguistica generale, 1959 La struttura fondamentale del linguaggio,
Lezione 2 La semantica
 Corso di laurea specialistica Formazione, comunicazione e innovazione nei contesti sociali e organizzativi Facoltà di Psicologia 2 Università La Sapienza di Roma Corso di Semiotica prof. Piero Polidoro
Corso di laurea specialistica Formazione, comunicazione e innovazione nei contesti sociali e organizzativi Facoltà di Psicologia 2 Università La Sapienza di Roma Corso di Semiotica prof. Piero Polidoro
L intelligenza artificiale
 L intelligenza artificiale Le macchine possono pensare? Le macchine sono intelligenti? AI (IA) La storia Il termine Intelligenza Artificiale (IA)) venne introdotto per la prima volta nel 1956 da John McCarthy,,
L intelligenza artificiale Le macchine possono pensare? Le macchine sono intelligenti? AI (IA) La storia Il termine Intelligenza Artificiale (IA)) venne introdotto per la prima volta nel 1956 da John McCarthy,,
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata
 Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Le due anime della semiotica: come si giustificano Il modello peirciano Il concetto di inferenza Deduzione/Induzione/Abduzione Icona/Indice/Simbolo Il modello
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Macerata Le due anime della semiotica: come si giustificano Il modello peirciano Il concetto di inferenza Deduzione/Induzione/Abduzione Icona/Indice/Simbolo Il modello
LE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE
 LE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE PROF. FRANCESCO PETRILLO Indice 1 LE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE ---------------------------------------------------------- 3 2.1. L ARGUMENTUM A
LE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE PROF. FRANCESCO PETRILLO Indice 1 LE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE ---------------------------------------------------------- 3 2.1. L ARGUMENTUM A
Claude Lévi-Strauss Formazione filosofica Scuola etnologica francese durkheimiana Scuola di Boas Linguistica strutturale (Jakobson)
 Claude Lévi-Strauss 1908-2009 Formazione filosofica Scuola etnologica francese durkheimiana Scuola di Boas Linguistica strutturale (Jakobson) Bricolage teorico Ricerca scientifica e ricerca esistenziale
Claude Lévi-Strauss 1908-2009 Formazione filosofica Scuola etnologica francese durkheimiana Scuola di Boas Linguistica strutturale (Jakobson) Bricolage teorico Ricerca scientifica e ricerca esistenziale
Cosa sono le organizzazioni?
 Cosa sono le organizzazioni? è Pensare alle organizzazioni come entità a se stanti, è concettualmente improprio! è Fa dimenticare che ad agire sono gli individui e i gruppi L ORGANIZZAZIONE Concetto Risultato
Cosa sono le organizzazioni? è Pensare alle organizzazioni come entità a se stanti, è concettualmente improprio! è Fa dimenticare che ad agire sono gli individui e i gruppi L ORGANIZZAZIONE Concetto Risultato
Insiemi di numeri reali
 Capitolo 1 1.1 Elementi di teoria degli insiemi Se S è una totalità di oggetti x, si dice che S è uno spazio avente gli elementi x. Se si considerano alcuni elementi di S si dice che essi costituiscono
Capitolo 1 1.1 Elementi di teoria degli insiemi Se S è una totalità di oggetti x, si dice che S è uno spazio avente gli elementi x. Se si considerano alcuni elementi di S si dice che essi costituiscono
Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico. Loredana La Vecchia Lezione 1 aprile 2009 Corso di Laurea Scienze dell educazione
 Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico Loredana La Vecchia Lezione 1 aprile 2009 Corso di Laurea Scienze dell educazione definizione Linguaggio = capacità, facoltà mentale di cui
Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico Loredana La Vecchia Lezione 1 aprile 2009 Corso di Laurea Scienze dell educazione definizione Linguaggio = capacità, facoltà mentale di cui
Premesse a un corso di Filosofia del linguaggio. Prof. Stefano Gensini ( )
 Premesse a un corso di Filosofia del linguaggio Prof. Stefano Gensini (2013-2014) Le discipline filosofiche tradizionali Filosofia teoretica Logica e Filosofia della scienza Filosofia morale Estetica (o
Premesse a un corso di Filosofia del linguaggio Prof. Stefano Gensini (2013-2014) Le discipline filosofiche tradizionali Filosofia teoretica Logica e Filosofia della scienza Filosofia morale Estetica (o
Programmi e Oggetti Software
 Corso di Laurea Ingegneria Civile Fondamenti di Informatica Dispensa 06 Programmi e Oggetti Software Marzo 2010 Programmi e Oggetti Software 1 Contenuti Cosa è un programma Cosa significa programmare Il
Corso di Laurea Ingegneria Civile Fondamenti di Informatica Dispensa 06 Programmi e Oggetti Software Marzo 2010 Programmi e Oggetti Software 1 Contenuti Cosa è un programma Cosa significa programmare Il
Storia della psicologia IV. Il Comportamentismo
 Storia della psicologia IV Il Comportamentismo Il comportamentismo Il Comportamentismo (o behaviorismo ) è la corrente che domina la psicologia sperimentale nordamericana, in particolare negli anni tra
Storia della psicologia IV Il Comportamentismo Il comportamentismo Il Comportamentismo (o behaviorismo ) è la corrente che domina la psicologia sperimentale nordamericana, in particolare negli anni tra
Programmi e Oggetti Software
 Corso di Laurea Ingegneria Informatica Fondamenti di Informatica 1 Dispensa 2 Programmi e Oggetti Software Alfonso Miola Settembre 2007 http://www.dia.uniroma3.it/~java/fondinf1/ Programmi e Oggetti Software
Corso di Laurea Ingegneria Informatica Fondamenti di Informatica 1 Dispensa 2 Programmi e Oggetti Software Alfonso Miola Settembre 2007 http://www.dia.uniroma3.it/~java/fondinf1/ Programmi e Oggetti Software
Università degli Studi della Repubblica di San Marino Corso di laurea triennale in Design. Anno Accademico 2016/17. I anno primo semestre
 Università degli Studi della Repubblica di San Marino Corso di laurea triennale in Design Anno Accademico 2016/17 I anno primo semestre LABORATORIO DI DISEGNO PER IL PROGETTO lo studente acquisisce, attraverso
Università degli Studi della Repubblica di San Marino Corso di laurea triennale in Design Anno Accademico 2016/17 I anno primo semestre LABORATORIO DI DISEGNO PER IL PROGETTO lo studente acquisisce, attraverso
Peirce, Grammatica speculativa. Peirce. La definizione di «segno» La definizione di «segno» Il segno o representamen. La definizione di «segno»
 Peirce, Grammatica speculativa Peirce Grammatica speculativa Note di lettura per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 materiali dai Collected papers scritti fra il 1893 e il 1910 Anche
Peirce, Grammatica speculativa Peirce Grammatica speculativa Note di lettura per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 materiali dai Collected papers scritti fra il 1893 e il 1910 Anche
Peirce. Grammatica speculativa Note di lettura per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica
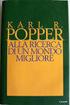 Peirce Grammatica speculativa Note di lettura per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Peirce, Grammatica speculativa materiali dai Collected papers scritti fra il 1893 e il 1910 Anche
Peirce Grammatica speculativa Note di lettura per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Peirce, Grammatica speculativa materiali dai Collected papers scritti fra il 1893 e il 1910 Anche
Modelli comunicativi e micro-macro link
 Modelli comunicativi e micro-macro link Le nuove tecnologie modificano i profili attuali della comunicazione e del sociale È necessario integrarle nelle teorie comunicative Nell analisi dei rapporti fra
Modelli comunicativi e micro-macro link Le nuove tecnologie modificano i profili attuali della comunicazione e del sociale È necessario integrarle nelle teorie comunicative Nell analisi dei rapporti fra
Linguaggi, Traduttori e le Basi della Programmazione
 Corso di Laurea in Ingegneria Civile Politecnico di Bari Sede di Foggia Fondamenti di Informatica Anno Accademico 2011/2012 docente: Prof. Ing. Michele Salvemini Sommario Il Linguaggio I Linguaggi di Linguaggi
Corso di Laurea in Ingegneria Civile Politecnico di Bari Sede di Foggia Fondamenti di Informatica Anno Accademico 2011/2012 docente: Prof. Ing. Michele Salvemini Sommario Il Linguaggio I Linguaggi di Linguaggi
SPM. TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI
 SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
SPM TEST di ABILITA di SOLUZIONE dei PROBLEMI MATEMATICI CAPACITA di RISOLVERE I PROBLEMI È una delle principali competenze del sistema cognitivo KATONA e WURTHEIMER (Gestaltisti) Una mente strategica
de Saussure Note di lettura dal Corso di Linguistica Generale per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11
 de Saussure Note di lettura dal Corso di Linguistica Generale per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Il Corso di Linguistica Generale Si tratta di lezioni tenute a Ginevra fra il
de Saussure Note di lettura dal Corso di Linguistica Generale per il corso di Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Il Corso di Linguistica Generale Si tratta di lezioni tenute a Ginevra fra il
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo
 Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
Elementi di Psicologia dello Sviluppo (II modulo) Mirco Fasolo mirco.fasolo@unimib.it Bibliografia Testi obbligatori - D amico, Devescovi (2003). Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci: Roma.
La semiotica generativa di Algirdas J. Greimas con riferimento a J.M. Floch, Concetti della semiotica generale
 La semiotica generativa di Algirdas J. Greimas con riferimento a J.M. Floch, Concetti della semiotica generale Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Espressione e contenuto Un linguaggio (nella
La semiotica generativa di Algirdas J. Greimas con riferimento a J.M. Floch, Concetti della semiotica generale Filosofia del linguaggio e semiotica 2010-11 Espressione e contenuto Un linguaggio (nella
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE. - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni
 CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
CLASSI SECONDE LA PROGRAMMAZIONE ITALIANO - Potenziare il possesso di una lingua sempre più ricca lessicalmente nella molteplicità delle sue espressioni - Potenziare l ascolto reciproco, il rispetto e
LOGICA E PSICOLOGIA DEL PENSIERO. Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva
 titolo LOGICA E PSICOLOGIA DEL PENSIERO Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici logica Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire
titolo LOGICA E PSICOLOGIA DEL PENSIERO Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici logica Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire
Metodologia della ricerca 1
 Metodologia della ricerca 1 METODOLOGIA Riflessione critica sulle regole, i principi, le condizioni formali che sono alla base della ricerca scientifica e che consentono di ordinare, sistemare e accrescere
Metodologia della ricerca 1 METODOLOGIA Riflessione critica sulle regole, i principi, le condizioni formali che sono alla base della ricerca scientifica e che consentono di ordinare, sistemare e accrescere
La semiotica del progetto
 Salvatore Zingale La semiotica del progetto: il senso delle cose e il senso del progettare D&H Milano 19 maggio 2010 1 / 34 Salvatore Zingale La semiotica del progetto Il senso delle cose e il senso del
Salvatore Zingale La semiotica del progetto: il senso delle cose e il senso del progettare D&H Milano 19 maggio 2010 1 / 34 Salvatore Zingale La semiotica del progetto Il senso delle cose e il senso del
PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE. Tavola di sintesi delle unità di apprendimento da svolgere nel corrente a.s. 2015/16 PROGETTAZIONE ANNAULE DIDATTICA
 Docente PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE Plessi SBRANA-LAMBRUSCHINI-TENUTA Classe IV Disciplina ITALIANO Tavola di sintesi delle unità di apprendimento da svolgere nel corrente a.s. 2015/16 PROGETTAZIONE
Docente PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE Plessi SBRANA-LAMBRUSCHINI-TENUTA Classe IV Disciplina ITALIANO Tavola di sintesi delle unità di apprendimento da svolgere nel corrente a.s. 2015/16 PROGETTAZIONE
Modellazione di sistemi ingegneristici (parte 1 di 2)
 Corso di Teoria dei Sistemi Modellazione di sistemi ingegneristici (parte 1 di 2) Prof. Ing. Daniele Testi DESTeC, Dipartimento di Ingegneria dell Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
Corso di Teoria dei Sistemi Modellazione di sistemi ingegneristici (parte 1 di 2) Prof. Ing. Daniele Testi DESTeC, Dipartimento di Ingegneria dell Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
Applicazioni:la traduzione automatica
 Applicazioni:la traduzione automatica Il problema di tradurre automaticamente un testo da una lingua all altra è stato affrontato ancora prima della nascita dell IA. Negli anni Cinquanta diversi ricercatori,
Applicazioni:la traduzione automatica Il problema di tradurre automaticamente un testo da una lingua all altra è stato affrontato ancora prima della nascita dell IA. Negli anni Cinquanta diversi ricercatori,
LINEE DI SVILUPPO DELLA SEMIOTICA EUROPEA. Prof. S. Gensini ( ) Dispensa n. 1
 LINEE DI SVILUPPO DELLA SEMIOTICA EUROPEA Prof. S. Gensini (2017-2018) Dispensa n. 1 FERDINAND DE SAUSSURE (1916, 1922) COME APRIPISTA IMPLICAZIONI EPISTEMOLOGICHE DELLA LEZIONE DI SAUSSURE Significante
LINEE DI SVILUPPO DELLA SEMIOTICA EUROPEA Prof. S. Gensini (2017-2018) Dispensa n. 1 FERDINAND DE SAUSSURE (1916, 1922) COME APRIPISTA IMPLICAZIONI EPISTEMOLOGICHE DELLA LEZIONE DI SAUSSURE Significante
Analisi del linguaggio
 Analisi del linguaggio 3 livelli: SINTASSI: si occupa della relazione dei segni linguistici tra loro; SEMANTICA: si occupa della relazione dei segni linguistici con qualcosa di esterno al linguaggio; PRAGMATICA:
Analisi del linguaggio 3 livelli: SINTASSI: si occupa della relazione dei segni linguistici tra loro; SEMANTICA: si occupa della relazione dei segni linguistici con qualcosa di esterno al linguaggio; PRAGMATICA:
Mente e cervello Dal rappresentazionalismo alla stanza cinese
 Mente e cervello Dal rappresentazionalismo alla stanza cinese 20 aprile 2011 Dalle macchine alla mente 2 Rappresentazionalismo Sistemi simbolici e sistemi connessionisti L argomento della stanza cinese
Mente e cervello Dal rappresentazionalismo alla stanza cinese 20 aprile 2011 Dalle macchine alla mente 2 Rappresentazionalismo Sistemi simbolici e sistemi connessionisti L argomento della stanza cinese
Il tubo del tempo. Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica
 Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
Il tubo del tempo Dalla descrizione grammaticale alla cognizione della grammatica Parte prima: La situazione attuale Il posto della grammatica cognitiva A che cosa serve la grammatica? Tante risposte:
Lo sviluppo cognitivo secondo J. Piaget
 Lo sviluppo cognitivo secondo J. Piaget Jean Piaget La conoscenza umana può essere considerata come un organo biologico della mente e l acquisizione della conoscenza può essere un processo evolutivo. Conoscenza
Lo sviluppo cognitivo secondo J. Piaget Jean Piaget La conoscenza umana può essere considerata come un organo biologico della mente e l acquisizione della conoscenza può essere un processo evolutivo. Conoscenza
Linguistica Generale
 Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Aprile-Maggio 2003 Contents 1 La linguistica e i suoi settori 2 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica 2 3 Le componenti della
Linguistica Generale Docente: Paola Monachesi Aprile-Maggio 2003 Contents 1 La linguistica e i suoi settori 2 2 La grammatica come mezzo per rappresentare la competenza linguistica 2 3 Le componenti della
Introduzione. Esempio n. 3. Fuoco! Non sporgersi dal finestrino. Peter non è andato a scuola ieri. Il tempo era molto brutto.
 Introduzione 1. In un libro che ha lo scopo di trattare aspetti dell analisi e dell interpretazione di oggetti verbali che possono o meno essere considerati testi, il primo compito è quello di formulare
Introduzione 1. In un libro che ha lo scopo di trattare aspetti dell analisi e dell interpretazione di oggetti verbali che possono o meno essere considerati testi, il primo compito è quello di formulare
Critica del Giudizio
 Critica del Giudizio Dalle due Critiche ( Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica) emerge l opposizione tra il mondo naturale, dominato dalla necessità ed estraneo alla morale e allo spirito,
Critica del Giudizio Dalle due Critiche ( Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica) emerge l opposizione tra il mondo naturale, dominato dalla necessità ed estraneo alla morale e allo spirito,
014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria
![014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria 014 5 Pragmatica Lingue per scopi speciali. [014 8] Abbreviazioni e simboli Filosofia e teoria](/thumbs/54/33772292.jpg) T4 T4 014 301 Filosofia e teoria 014 301 8 Scuole, teorie, metodologie 014 301 82 Linguistica formale Notazione 01 dalla Tavola 1 come di seguito modificata Da non usare per scuole e teorie semantiche;
T4 T4 014 301 Filosofia e teoria 014 301 8 Scuole, teorie, metodologie 014 301 82 Linguistica formale Notazione 01 dalla Tavola 1 come di seguito modificata Da non usare per scuole e teorie semantiche;
La definizione degli obiettivi
 Docimologia Prof. Giovanni Arduini Lezione n.5 Anno Accademico 2013/2014 La definizione degli obiettivi La necessità di definire sul piano dell attività didattica determinati obiettivi nasce da tre ordine
Docimologia Prof. Giovanni Arduini Lezione n.5 Anno Accademico 2013/2014 La definizione degli obiettivi La necessità di definire sul piano dell attività didattica determinati obiettivi nasce da tre ordine
INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
 INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA DESCRIZIONE SINTETICA INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA L Interprete in lingua dei segni italiana è in grado di effettuare la traduzione e l interpretazione
INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA DESCRIZIONE SINTETICA INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA L Interprete in lingua dei segni italiana è in grado di effettuare la traduzione e l interpretazione
definizione Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico comunicare definizione
 Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico definizione Linguaggio = capacità, facoltà mentale di cui è dotata la nostra specie Lingua = è ciò che ci consente di esercitare la facoltà
Il messaggio: tra linguaggio digitale e linguaggio analogico definizione Linguaggio = capacità, facoltà mentale di cui è dotata la nostra specie Lingua = è ciò che ci consente di esercitare la facoltà
Corso di Informatica Modulo T2 1 - Linguaggi e macchine
 Corso di Informatica Modulo T2 1 - Linguaggi e macchine 1 Prerequisiti Principi della comunicazione Rappresentazione simbolica Calcolo delle combinazioni di n oggetti a gruppi di k Dati e istruzioni Utilizzo
Corso di Informatica Modulo T2 1 - Linguaggi e macchine 1 Prerequisiti Principi della comunicazione Rappresentazione simbolica Calcolo delle combinazioni di n oggetti a gruppi di k Dati e istruzioni Utilizzo
Educazione linguistica. SILSIS Scienze Naturali e FIM a.a
 Educazione linguistica SILSIS Scienze Naturali e FIM a.a. 2007-08 Linguaggio scientifico Il tema del linguaggio scientifico offre ampia materia di lavoro non solo al linguista, ma anche allo studioso di
Educazione linguistica SILSIS Scienze Naturali e FIM a.a. 2007-08 Linguaggio scientifico Il tema del linguaggio scientifico offre ampia materia di lavoro non solo al linguista, ma anche allo studioso di
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO Anno scolastico 2010/2011 CURRICULUM DI D ISTITUTO SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Utilizzare criteri e relazioni
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA DI BISUSCHIO Anno scolastico 2010/2011 CURRICULUM DI D ISTITUTO SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Utilizzare criteri e relazioni
PIANO DIDATTICO. Si fa riferimento alla programmazione educativa depositata in segreteria NUCLEI TEMATICI
 PIANO DIDATTICO DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE 4^ COMPETENZE DI CITTADINANZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di
PIANO DIDATTICO DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE 4^ COMPETENZE DI CITTADINANZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di
1) Quale studioso ha ipotizzato l'esistenza di un dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio?
 Capitolo V. Esercizi 1) Quale studioso ha ipotizzato l'esistenza di un dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio? a. Chomsky b. Skinner c. Vygotskij 2) Secondo Piaget l'acquisizione del linguaggio:
Capitolo V. Esercizi 1) Quale studioso ha ipotizzato l'esistenza di un dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio? a. Chomsky b. Skinner c. Vygotskij 2) Secondo Piaget l'acquisizione del linguaggio:
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.)
 Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
Filosofia del linguaggio (i) (3 cr.) Docente: Giuseppe Spolaore Orario: Martedì ore 17.20 aula T4, mercoledì ore 17.20 aula 1.4, giovedì ore 14.00 aula 1.4 (per un totale di circa 10 lezioni). Ricevimento:
LINGUA ITALIANA. Sapere Nuclei fondanti TESTO. Saper fare. Memorizzare. Comprendere. Produrre CODICE OGGETTO CULTURALE LESSICO.
 LINGUA ITALIANA è è Sapere Nuclei fondanti OGGETTO CULTURALE che registra i CAMBIAMENTI. CODICE Utilizzato per la COMUNICAZIONE Ha come unità fondamentale il TESTO Utilizza un LESSICO Saper fare che determinano
LINGUA ITALIANA è è Sapere Nuclei fondanti OGGETTO CULTURALE che registra i CAMBIAMENTI. CODICE Utilizzato per la COMUNICAZIONE Ha come unità fondamentale il TESTO Utilizza un LESSICO Saper fare che determinano
Percorso su LIM da Kant all idealismo
 Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
SCRIVERE TESTI DA TESTI
 SCRIVERE TESTI DA TESTI elementi di riflessione sulla didattica e la valutazione delle abilità di riscrittura di testi in italiano e inglese 15 febbraio 2017 Sofia Di Crisci IPRASE La prima regola per
SCRIVERE TESTI DA TESTI elementi di riflessione sulla didattica e la valutazione delle abilità di riscrittura di testi in italiano e inglese 15 febbraio 2017 Sofia Di Crisci IPRASE La prima regola per
Felice Carugati e Patrizia Selleri. Capitolo 1 La psicologia fra storia e cultura
 PSICOLOGIA DELL EDUCAZIONE Felice Carugati e Patrizia Selleri Capitolo 1 La psicologia fra storia e cultura 1 SCOPO della psicologia del XX sec Ricerca di leggi generali in grado di spiegare gli elementi
PSICOLOGIA DELL EDUCAZIONE Felice Carugati e Patrizia Selleri Capitolo 1 La psicologia fra storia e cultura 1 SCOPO della psicologia del XX sec Ricerca di leggi generali in grado di spiegare gli elementi
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE
 IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE PAROLE Per
Aristotele Dalla dialettica alla filosofia prima
 Aristotele Dalla dialettica alla filosofia prima Che cos è la filosofia? Metafisica I 1 982-983 Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia Protrettico fr. 6
Aristotele Dalla dialettica alla filosofia prima Che cos è la filosofia? Metafisica I 1 982-983 Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia Protrettico fr. 6
INDICE GENERALE Limiti naturali: inferenza e significaione Segni naturali Segni inintenzionali
 INDICE GENERALE O. INTRODUZIONE VERSO UNA LOGICA DELLA CULTURA 0.1. Limiti e fini di una teoria semiotica 0.1.1. Scopo della ricerca 0.1.2. Confini della ricerca O. 1.3. Una teoria della menzogna 0.2.
INDICE GENERALE O. INTRODUZIONE VERSO UNA LOGICA DELLA CULTURA 0.1. Limiti e fini di una teoria semiotica 0.1.1. Scopo della ricerca 0.1.2. Confini della ricerca O. 1.3. Una teoria della menzogna 0.2.
Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva
 Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. MARTINI Castelfranco Veneto (TV) Elementi di Logica
 settembre 008 Elementi di Logica 1. Nozioni preliminari La logica studia come funziona il pensiero e il ragionamento espresso attraverso degli enunciati Il ragionamento è un sistema di enunciati che permette
settembre 008 Elementi di Logica 1. Nozioni preliminari La logica studia come funziona il pensiero e il ragionamento espresso attraverso degli enunciati Il ragionamento è un sistema di enunciati che permette
Dalla grammatica alla riflessione sulla lingua. Didattica della lettura e della scrittura II
 Dalla grammatica alla riflessione sulla lingua Didattica della lettura e della scrittura II Grammatica De Mauro, Il dizionario della lingua italiana 1. Insieme delle convenzioni e delle norme di scrittura,
Dalla grammatica alla riflessione sulla lingua Didattica della lettura e della scrittura II Grammatica De Mauro, Il dizionario della lingua italiana 1. Insieme delle convenzioni e delle norme di scrittura,
Corso di Linguaggi di Programmazione + Laboratorio
 Corso di inguaggi di Programmazione + aboratorio Capitolo 1 - Introduzione Si ringrazia il Dott. Marco de Gemmis per la collaborazione nella predisposizione del materiale didattico Apprendimento di un
Corso di inguaggi di Programmazione + aboratorio Capitolo 1 - Introduzione Si ringrazia il Dott. Marco de Gemmis per la collaborazione nella predisposizione del materiale didattico Apprendimento di un
FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q 10 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALBERTO ANDRONICO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOSOFIA DEL DIRITTO M - Q 10 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ALBERTO ANDRONICO
CURRICOLO di ITALIANO
 CURRICOLO di ITALIANO Classi: I e II della Scuola Secondaria I grado Competenze Abilità Conoscenze Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l interazione comunicativa
CURRICOLO di ITALIANO Classi: I e II della Scuola Secondaria I grado Competenze Abilità Conoscenze Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l interazione comunicativa
Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali Allegato 2.E al Piano Triennale dell Offerta Formativa 2016/19 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA
 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
Come funziona il linguaggio COME FUNZIONA IL LINGUAGGIO
 Come funziona il linguaggio COME FUZIOA IL LIGUAGGIO SITASSI Il cervello di ogni persona contiene un dizionario di parole e dei concetti che esse rappresentano (dizionario mentale) e un insieme di regole
Come funziona il linguaggio COME FUZIOA IL LIGUAGGIO SITASSI Il cervello di ogni persona contiene un dizionario di parole e dei concetti che esse rappresentano (dizionario mentale) e un insieme di regole
LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE Classe LM-39
 TOTALE 0 CFU LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE Classe LM-39 (CDS 05409-1213 ordinamento 2012 - Regolamento 2013 ) I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di
TOTALE 0 CFU LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE Classe LM-39 (CDS 05409-1213 ordinamento 2012 - Regolamento 2013 ) I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di
LABORATORIO DI ERGONOMIA
 Dipartimento di Architettura Corso di Laurea in Disegno Industriale - 2 anno LABORATORIO DI ERGONOMIA prof.ssa Francesca Tosi con: dott.ssa Alessia Brischetto, dott.ssa Irene Bruni, dott. Daniele Busciantella
Dipartimento di Architettura Corso di Laurea in Disegno Industriale - 2 anno LABORATORIO DI ERGONOMIA prof.ssa Francesca Tosi con: dott.ssa Alessia Brischetto, dott.ssa Irene Bruni, dott. Daniele Busciantella
CONOSCENZA ED ESPERIENZA
 CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
Il Concetto Intuitivo di Calcolatore. Esercizio. I Problemi e la loro Soluzione. (esempio)
 Il Concetto Intuitivo di Calcolatore Elementi di Informatica e Programmazione Ingegneria Gestionale Università degli Studi di Brescia Docente: Prof. Alfonso Gerevini Variabile di uscita Classe di domande
Il Concetto Intuitivo di Calcolatore Elementi di Informatica e Programmazione Ingegneria Gestionale Università degli Studi di Brescia Docente: Prof. Alfonso Gerevini Variabile di uscita Classe di domande
Modelli operativi e tecniche didattiche per lo sviluppo delle diverse abilità e competenze nelle varie fasi dell Unità. Viareggio - 20 novembre 2007
 Modelli operativi e tecniche didattiche per lo sviluppo delle diverse abilità e competenze nelle varie fasi dell Unità Viareggio - 20 novembre 2007 COMPETENZE LINGUISTICHE Competenza lessicale Competenza
Modelli operativi e tecniche didattiche per lo sviluppo delle diverse abilità e competenze nelle varie fasi dell Unità Viareggio - 20 novembre 2007 COMPETENZE LINGUISTICHE Competenza lessicale Competenza
Dall educazione alla pedagogia
 Giuseppe Bertagna Dall educazione alla pedagogia Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell educazione Bergamo, settembre 2010 CAPITOLO PRIMO Il problema e il metodo pp. 17-31 Bergamo 28 settembre
Giuseppe Bertagna Dall educazione alla pedagogia Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell educazione Bergamo, settembre 2010 CAPITOLO PRIMO Il problema e il metodo pp. 17-31 Bergamo 28 settembre
Davidson. Verità e significato
 Davidson Verità e significato Teoria del significato Una teoria del significato soddisfacente deve spiegare come i significati degli enunciati dipendono dai significati delle parole Ma come si può costruire
Davidson Verità e significato Teoria del significato Una teoria del significato soddisfacente deve spiegare come i significati degli enunciati dipendono dai significati delle parole Ma come si può costruire
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA
 Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
Le difficoltà di apprendimento e l intervento di aiuto APPRENDIMENTO LETTURA E SCRITTURA COSA SONO LA LETTURA E LA SCRITTURA? Come si colloca la funzione della scrittura all interno dei sistemi di comunicazione?
MODELLO e RAPPRESENTAZIONE
 MODELLO e RAPPRESENTAZIONE I calcolatori elaborano informazione e restituiscono nuova informazione: questa deve essere rappresentata in forma simbolica Esempio : Per poter gestire una biblioteca dobbiamo
MODELLO e RAPPRESENTAZIONE I calcolatori elaborano informazione e restituiscono nuova informazione: questa deve essere rappresentata in forma simbolica Esempio : Per poter gestire una biblioteca dobbiamo
mio indirizzo 1 Sarò lieto di ricevere commenti o segnalazioni di errori presso il
 INTRODUZIONE Purtroppo questo libro è rappresentato molto più dal sottotitolo che dal titolo. Infatti è una semplice trascrizione di miei appunti per vari corsi di logica che ho tenuto in passato all Università
INTRODUZIONE Purtroppo questo libro è rappresentato molto più dal sottotitolo che dal titolo. Infatti è una semplice trascrizione di miei appunti per vari corsi di logica che ho tenuto in passato all Università
Sommario. 1. Approccio logico-filosofico. 2. Approccio linguistico. 3. Pragmatica LEZIONE 7
 Sommario LEZIONE 7 1. Approccio logico-filosofico 2. Approccio linguistico 3. Pragmatica Concezione logico-filosofica referente (significato) significato (senso) segno Nota: fra parentesi la terminologia
Sommario LEZIONE 7 1. Approccio logico-filosofico 2. Approccio linguistico 3. Pragmatica Concezione logico-filosofica referente (significato) significato (senso) segno Nota: fra parentesi la terminologia
I limiti del modello lineare della comunicazione
 I limiti del modello lineare della comunicazione Filosofia del linguaggio 2013-14 Dott.ssa Filomena Diodato Il modello di Jakobson codice canale mittente messaggio destinatario contesto Le funzioni di
I limiti del modello lineare della comunicazione Filosofia del linguaggio 2013-14 Dott.ssa Filomena Diodato Il modello di Jakobson codice canale mittente messaggio destinatario contesto Le funzioni di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE D.M.270/2004 Classe LM-39
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE D.M.270/2004 Classe LM-39 (CDS 05409-1414 ordinamento 2014 - Regolamento 2014 ) Per iscritti
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE D.M.270/2004 Classe LM-39 (CDS 05409-1414 ordinamento 2014 - Regolamento 2014 ) Per iscritti
Johann Gottlieb Fichte
 ADESIONE A KANT Il primo Fichte riteneva che la prospettiva emersa con Kant fosse, in ambito filosofico, insuperabile. -1- Oggetto proprio della Filosofia non è l Essere (quindi l ontologia) ma il sapere
ADESIONE A KANT Il primo Fichte riteneva che la prospettiva emersa con Kant fosse, in ambito filosofico, insuperabile. -1- Oggetto proprio della Filosofia non è l Essere (quindi l ontologia) ma il sapere
L elaborazione del linguaggio naturale
 L elaborazione del linguaggio naturale fondamenti teorici dell intelligenza artificiale: la capacità di elaborare simboli è alla base del comportamento intelligente. L esempio di elaborazione simbolica
L elaborazione del linguaggio naturale fondamenti teorici dell intelligenza artificiale: la capacità di elaborare simboli è alla base del comportamento intelligente. L esempio di elaborazione simbolica
Programmazione annuale a. s
 Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n CISLIANO Tel./Fax
 ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n.8 20080 CISLIANO www.albaciscuole.gov.it Tel./Fax02.9018574 info@albaciscuole.gov.it MAIL miic86900d@istruzione.it PEC: miic86900d@pec.istruzione.it C.F. 90015600159
ICS Erasmo da Rotterdam Via Giovanni XXIII n.8 20080 CISLIANO www.albaciscuole.gov.it Tel./Fax02.9018574 info@albaciscuole.gov.it MAIL miic86900d@istruzione.it PEC: miic86900d@pec.istruzione.it C.F. 90015600159
