ENEA C.R. Casaccia, C.P. 2400, Roma A.D.
|
|
|
- Graziano Pizzi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 16(2), 2003, I DEPOSITI ALLUVIONALI OLOCENICI DI CAMPO IMPERATORE (MASSICCIO DEL GRAN SASSO ABRUZZO) Carlo Giraudi ENEA C.R. Casaccia, C.P. 2400, Roma A.D. RIASSUNTO Il rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio eseguito sui sedimenti e sui terrazzi alluvionali di Campo Imperatore ha permesso di distinguere varie fasi di sedimentazione risalenti all Olocene. La scansione cronologica dell attività alluvionale, ottenuta per mezzo di datazioni radiocarbonio su paleosuoli e sedimenti lacustri, dimostra come il trasporto solido nei corsi d acqua sia avvenuto, seppure con diversa energia e con brevi fasi di interruzione, lungo gran parte dell Olocene. La fase di sedimentazione alluvionale olocenica che forma il primo terrazzo è avvenuta tra ±100 BP ( Cal BP) e un periodo successivo a 7060±70 BP ( Cal BP) e precedente a 5420±80 BP ( Cal BP). La sedimentazione del corpo alluvionale che forma il secondo terrazzo si è verificata tra 7060±70 BP ( Cal BP) e 4070±70 BP ( Cal BP). Le alluvioni che formano il terzo terrazzo si sono deposte in un periodo compreso tra 4070±70 BP ( Cal BP) e un momento successivo a 2130±50 BP ( Cal BP) e precedente a 1410±40 BP ( AD). La sedimentazione delle alluvioni che formano il quarto terrazzo è avvenuta tra 1410±40 BP ( AD) ed un periodo più recente degli anni AD. Il quinto terrazzo è stato formato dall attività alluvionale recentissima. Appare poi evidente la correlazione tra fasi di sedimentazione alluvionale individuate a Campo Imperatore e quelle riconosciute in altre località dell Appennino Centrale e Settentrionale; inoltre vi è una notevole coincidenza cronologica anche con le fasi di espansione del Ghiacciaio del Calderone e di alcuni ghiacciai alpini. ABSTRACT The Campo Imperatore Holocene alluvial sediments (Gran Sasso Massif Central Italy) The detailed geological and geomorphological survey carried out on Campo Imperatore alluvial sediments and terraces enabled some Holocene depositional phases to be recognised. The chronological framework has been obtained through radiocarbon datings on palaeosols and lacustrine sediments and shows that alluvial deposition took place, even if with some interruptions, during most of the Holocene period. The deposition of the alluvial unit forming the first terrace took place between ±100 BP ( Cal BP) and a period more recent than 7060±70 BP ( Cal BP) and older than 5420±80 BP ( Cal BP). The second terrace alluvial sequence has been dated between 7060±70 BP ( Cal BP) and 4070±70 BP ( Cal BP). The deposition of the alluvial sediments forming the third terrace occurred between 4070±70 BP ( Cal BP) and a period following 2130±50 BP ( Cal BP) and preceding 1410±40 BP ( Cal AD). The alluvial sediments forming the fourth terrace were deposited between 1410±40 BP ( Cal AD) and a period following Cal AD. The fifth terrace has been formed by very recent alluvial activity. Thanks to the dating of the sediments one can observe a correlation between alluvial sedimentation at Campo Imperatore and in other Central and Northern Apennine sites, and between the start of the alluvial phases and the advance of the Calderone Glaciers (on the Gran Sasso Massif) and some Alpine glaciers. The Campo Imperatore alluvial sedimentation appears strongly linked to the environmental impact produced by climatic oscillations, which affected both Mediterranean and Alpine areas, also affecting glaciers that cannot be changed by human activity. Even if there is proof of fires that developed during prehistoric times, the data available show that the human impact was not able to produce any instability of the slopes and alluvial sedimentation phases not linked to the climatìc variations. The large, thick alluvial units outcropping at Campo Imperatore seem strongly linked also to the presence of cataclastic rocks on the slope surrounding the northern boundary of the plain; the gullies affecting the cataclasites were inactive only during short periods, when morphological stability prevailed and soils developed. The considerable detail regarding phases of sedimentation and pedogenesis preserved on the deposits (younger than the VI-VII centuries AD) forming the IV terrace seems due to the morphology of the site: the place is very flat and the water in the streams loses its energy, the sediments are mainly thin and between them lie gentle erosion surfaces. The same detail was not found in the older alluvial units lying in different places where the streams flowed with greater energy, the grain size was larger and erosional phases stronger. Parole chiave: Olocene, fasi alluvionali, variazioni climatiche, Gran Sasso, Appennini. Keywords: : Holecene, alluvial phases, climatic variations, Gran Sasso Massif, Apennines. 1. INTRODUZIONE Campo Imperatore è un altopiano, lungo circa 18 km, largo da 1 a 4 km, che occupa il fondo di una conca chiusa tettonico-carsica posta a quote comprese tra 1850 e 1450 m. Il drenaggio superficiale presente sull'altopiano termina negli inghiottitoi presenti nella porzione sud-orientale dell'area. Tuttavia solo una piccola parte della rete di drenaggio appare attiva attualmente: si tratta di corsi d'acqua stagionali che defluiscono quasi esclusivamente nelle porzioni terminali delle valli poste ai margini della piana ove affiora il substrato. Quando l'acqua raggiunge gli apici dei conoidi alluvionali viene infatti assorbita dai sedimenti grossolani. Lo scorrimento di acqua negli alvei presenti sui conoidi avviene generalmente, insieme ad un notevole trasporto solido, in occasione di eventi piovosi eccezionali o nel corso di rapide fasi di scioglimento delle nevi dopo inverni molto
2 198 C. Giraudi nevosi. Tuttavia a giudicare dall'inerbimento della depressione che circonda gli inghiottitoi carsici e dall'assenza di alvei ben identificabili, si può arguire che attualmente l'acqua può arrivare agli inghiottitoi solo in rare occasioni, con bassa energia e senza carico solido. Scopo del presente lavoro è lo studio e la datazione dei sedimenti alluvionali di Campo Imperatore per ottenere informazioni di carattere climatico-ambientale necessarie al completamento della ricostruzione dell'evoluzione paleoclimatica dell' area. I sedimenti alluvionali, rappresentati schematicamente sul Foglio Teramo della Carta Geologica d'italia a scala 1: (Servizio Geologico d'italia, 1963) e in Demangeot (1965) sono stati in parte datati con metodi radiometrici per la prima volta da Frezzotti & Giraudi (1990), cartografati con maggiore dettaglio da Frezzotti & Giraudi (in Ghisetti & Vezzani, 1990) e descritti da Giraudi (1994). Ulteriori datazioni interessanti per l'inquadramento cronologico dei sedimenti alluvionali e fluvioglaciali di Campo Imperatore sono riportati in Giraudi & Frezzotti (1997) ed in Giraudi (1998; 2001) Nel presente lavoro verrà discusso l'inquadramento cronologico di alcuni depositi alluvionali utilizzando dati tratti dalla letteratura e nuove datazioni radiocarbonio. 2. I SEDIMENTI ALLUVIONALI DI CAMPO IMPE- RATORE I sedimenti alluvionali occupano buona parte della porzione centrale ed orientale di Campo Imperatore, e formano alvei di corsi d'acqua stagionali, conoidi alluvionali e varie spianate terrazzate. Gli estesi conoidi alluvionali, in particolare, rappresentano una componente assai evidente del paesaggio dell'altopiano. Essi si trovano quasi esclusivamente al suo margine settentrionale: anche se spesso i conoidi si trovano allo sbocco di bacini idrografici poco estesi, hanno dimensioni rilevanti sicuramente a causa della presenza, sui versanti, di un'ampia fascia di cataclasiti facilmente erodibili. Ghisetti & Vezzani (1986;1990) e Giraudi (1994) hanno evidenziato che le superfici dei conoidi si sono formate in varie fasi: nella porzione centro-orientale di Campo Imperatore si sarebbero formate in cinque fasi, mentre nella porzione occidentale, occupata da un esteso ghiacciaio nel corso dell'ultimo massimo glaciale, si sarebbero sviluppate in quattro fasi. I conoidi sono formati da varie parti incassate una nell'altra, caratterizzate da suoli con diverso grado di sviluppo e, in certi casi, da un diverso sviluppo della copertura vegetale. In base alle datazioni radiometriche riportate da Frezzotti & Giraudi (1990) e Giraudi & Frezzotti (1997) appare evidente che le più antiche superfici dei conoidi presenti nella porzione intermedia ed orientale di Campo Imperatore sono da attribuire all'ultimo Massimo Glaciale e quindi le fasi successive debbono essere avvenute nel Tardiglaciale e nell Olocene. La ricostruzione dell evoluzione morfologica dei conoidi alluvionali e delle fasi di sedimentazione postglaciali è stata resa possibile dal rilevamento geologicogeomorfologico di dettaglio, dal rinvenimento di parecchi affioramenti e dalla datazione di molti campioni di paleosuolo effettuata col metodo del 14 C. Di seguito vengono riportate le descrizioni dei siti e delle successioni alluvionali che hanno permesso di datare le fasi di sedimentazione oloceniche di Campo Imperatore Il conoide di Valle Fornaca Allo sbocco della Valle Fornaca, (2A in Fig. 1) tra i Monti Prena e Camicia, è presente un conoide terrazzato, la superficie del quale si è formata in cinque diverse fasi: il corpo principale del conoide (Ia fase) è costituito (Frezzotti & Giraudi, 1990; Giraudi & Frezzotti, 1997) da alternanze di ghiaie sabbiose e sabbie con intercalazione di suoli (Fig. 2A) datati rispettivamente ±550 BP e ±200 BP; al tetto giacciono sedimenti fluvioglaciali trasportati dall acqua di fusione di un piccolo apparato dell Ultimo Massimo Glaciale presente sul versante occidentale del M. Camicia (Giraudi & Frezzotti, 1997). Nella porzione sommitale della serie compare una fessura parzialmente riempita da carboni e ceneri, formatasi per scivolamento gravitativo di un blocco di sedimenti nel corso di una notevole fase di incisione che ha interessato il conoide. I carboni, datati con il metodo del 14 C (Giraudi,1999), hanno fornito una data di 5720±120 BP ( Cal BP: calibrazione due sigma, come tutte le date successive). I conoidi della II, III, IV e V fase sono incassati rispettivamente di 2-4 m, 12, 14 e 15 m rispetto alla superficie della I fase. La destabilizzazione della parte sommitale della successione sedimentaria deve essere avvenuta mentre era in corso un erosione successiva alla superficie del conoide della II fase. La sedimentazione della IIa fase del conoide è quindi precedente alla data di 5720±120 BP ( Cal BP) mentre la sedimentazione dei conoidi delle fasi successive deve essere più recente Le alluvioni di Fonte della Macina Presso Fonte della Macina (2B in Fig. 1) affiora una serie di sedimenti alluvionali che formano tre distinti terrazzi. Il primo terrazzo è formato (Fig. 2B) da una serie di alluvioni prevalentemente ghiaioso sabbiose, nelle quali si intercalano suoli e livelli di alluvioni sabbiose limose, potenti circa 10 m; il tetto della serie è formato da sedimenti alluvionali, eteropici con i depositi fluvioglaciali che formano il conoide della I fase di Valle Fornaca precedentemente descritto; le alluvioni coprono un paleosuolo datato 21,450±250 BP (Giraudi & Frezzotti, 1997); al di sotto del paleosuolo i sedimenti si presentano con vario grado di cementazione e affiorano in banchi compatti. Il secondo terrazzo, incassato di circa 8-10 m nel precedente, è formato da un deposito alluvionale ghiaioso-sabbioso alla base e sabbioso al tetto; tra le sabbie è intercalato un paleosuolo organico datato 5420±80 BP (BO-253; Cal BP). Il terzo terrazzo, incassato di circa 1 m nel precedente e sospeso di circa 1,5 m sul fondovalle attuale, è costituito prevalentemente da sabbie limose e limi e contiene, intercalato, un paleosuolo poco sviluppato Le alluvioni di Piano dell Ospedale Nella zona di Piano dell Ospedale, ai margini della depressione di Prati di Cretarola ove sono presenti gli
3 I depositi alluvionali olocenici di Fig.1 Carta geologica schematica di Campo Imperatore e delle aree circostanti Legenda: 1- sedimenti quaternari; 2- sedimenti terrigeni cenozoici; 3- rocce carbonatiche meso-cenozoiche; 4- circhi glaciali; 5- morene frontali dell Ultimo Massimo Glaciale; 6- morene stadiali; 7- Ghiacciaio del Calderone; 8- inghiottitoi carsici; 9- spartiacque principali; 10- ubicazioni delle sezioni rappresentate nelle Fig. 2 e 3. Geological sketch map of Campo Imperatore and neighbouring areas. Legend: 1- Quaternary sediments; 2- Cenozoic terrigenous sediments; 3- Meso-Cenozoic carbonate rocks; 4- glacial cirques; 5- Last Glacial Maximum frontal moraine; 6- stadial moraines; 7- Calderone Glacier; 8- ponors (swallow-holes); 9- main divides; 10- site of the stratigraphic section represented in Fig. 2 and 3.
4 200 C. Giraudi Fig. 2 Sezioni stratigrafiche schematiche dei sedimenti alluvionali studiati nella porzione orientale di Campo Imperatore. Legenda Fig. 2A: 1- sedimenti alluvionali attuali e del conoide della V fase; 2- sedimenti alluvionali del conoide della IV fase; 3- sedimenti alluvionali del conoide della III fase; 4- sedimenti alluvionali del conoide della II fase; 5- sedimenti fluvioglaciali, 6- sedimenti alluvionali; 7- paleosuoli. Legenda Fig. 2B: 1- sedimenti alluvionali attuali; 2- alluvioni prevalentemente sabbiose del terrazzo inferiore; 3- alluvioni prevalentemente sabbiose del terrazzo intermedio; 4- alluvioni ghiaiososabbiose del terrazzo intermedio; 5- alluvioni ghiaiose del terrazzo più elevato; 6- alluvioni sabbiose-ghiaiose; 7- alluvioni sabbioso-limose; 8- alluvioni ghiaioso-sabbiose cementate; 9- paleosuoli. Legenda Fig. 2C: 1- suolo attuale e paleosuolo intercalato ai sedimenti alluvionali; 2- alluvioni limose; 3- alluvioni prevalentemente sabbiose; 4- alluvioni sabbiso-ghiaiose. Stratigraphic sketches through the alluvial sediments in eastern Campo Imperatore. Legend Fig. 2A: 1- present and phase V alluvial fan sediments; 2- alluvial fan sediments of phase IV; 3- alluvial fan sediments of phase III; 4- alluvial fan sediments of phase II; 5- fluvioglacial sediments; 6- alluvial sediments; 7- palaeosols. Legend Fig. 2B: 1- presentday alluvial sediments; 2- alluvial sediments, mainly sandy, forming the lower terrace; 3- alluvial sediments, mainly sandy, forming the intermediate terrace; 4- gravelly-sandy alluvial sediments; 5- gravelly-sandy alluvial sediments forming the higher terrace; 6- gravelly-sandy alluvial sediments; 7- silty sandy alluvial sediments; 8- cemented gravelly-sandy alluvial sediments; 9- palaeosols. Legend Fig. 2C: 1- presentday soil and palaeosol interbedded between the alluvial sediments; 2- silty alluvial sediments; 3- sandy alluvial sediments; 4- sandy-gravelly alluvial sediments.
5 I depositi alluvionali olocenici di inghiottitoi carsici, allo sbocco della valle che raccoglie la maggior parte del drenaggio di Campo Imperatore (2C in Fig. 1), vi sono sedimenti alluvionali che formano un terrazzo sospeso di circa due metri sul fondovalle attuale. Tale terrazzo, che corrisponde al più basso di Fonte della Macina, è costituito prevalentemente da sabbie e sabbie limose, che diventano sabbie ghiaiose verso il tetto (Fig.2C). Intercalato nella porzione mediobassa delle sabbie vi è un paleosuolo che è stato datato 1450±50 BP (Beta ; Cal AD) Le alluvioni ed i conoidi alluvionali di Fontari Nella zona occidentale di Campo Imperatore, in zona Fontari (3A in Fig. 1) una serie di piccoli conoidi si sono sviluppati allo sbocco di alcune modeste incisioni che tagliano prevalentemente i depositi del versante meridionale del M. Aquila. Tra i depositi incisi vi sono cordoni di un antico rock glacier (Giraudi & Frezzotti, 1997), coperti da sedimenti lacustri ed alluvionali depostisi nella depressione compresa tra i cordoni frontali del rock glacier e la base del versante. I sedimenti lacustri coprono un paleosuolo (Giraudi, 1998) datato 3440±60 BP ( Cal BP). Alle spalle del rock glacier c è stata quindi sedimentazione alluvionale posteriore a tale data, mentre la fase di incisione di tali sedimenti, che ha dato luogo allo sviluppo dei piccoli conoidi alluvionali posti al piede del versante, appare ancora successiva Il conoide del M. Faeto Il conoide alimentato dalla valle compresa tra il versante settentrionale del M. Faeto ed il M. Brancastello (Fig. 1) ha fornito varie indicazioni utili per ricostruire l evoluzione della sedimentazione alluvionale a Campo Imperatore. Tale conoide, sviluppatosi dopo il ritiro dei ghiacciai sia dal suo bacino di alimentazione che dall apparato morenico di Coppe di Santo Stefano (Giraudi & Frezzotti, 1997), ha invaso la vallecola che, tagliando gli apparati morenici dell Ultimo Massimo Glaciale e delle sue fasi di ritiro, permetteva il drenaggio verso Est delle acque della estrema porzione occidentale di Campo Imperatore (3B in Fig. 1; Fig. 3B). Nelle fasi iniziali, i sedimenti alluvionali hanno prodotto la copertura di un paleosuolo datato ±100 BP ( Cal BP) ed hanno sbarrato la vallecola; allorché il clima diventò più umido, lo sbarramento provocò la formazione di un lago stretto ed allungato ad Ovest del conoide (Giraudi, 1998;2001). I sedimenti lacustri basali sono stati datati 6090±70 BP ( Cal BP), mentre quelli della parte intermedia sono stati datati 5640±60 BP ( Cal BP). In seguito il lago si svuotò a causa dell erosione della soglia e si produsse un incisione nei sedimenti lacustri che venne riempita da altri sedimenti alluvionali. A valle della zona ove avvenne lo sbarramento della valle (Fig. 3b), vi è un secondo corpo alluvionale che copre un paleosuolo sviluppatosi su una superficie di erosione: il paleosuolo è stato datato 4070±70 BP (Beta ; Cal BP). Un terzo corpo alluvionale copre un paleosuolo che si sviluppa su una blanda superficie di erosione presente al tetto delle alluvioni precedenti; il paleosuolo è stato datato 2130±50 BP (Beta ; Cal BP). Nella zona apicale dello stesso conoide (3C in Fig. 1), il deposito alluvionale che forma il terrazzo più antico, corrispondente a quello che copre il paleosuolo datato ±100 BP ( Cal BP), è costituito da ghiaie sabbiose nella parte bassa e da massi e ghiaia in matrice sabbiosa nella parte alta; intercalato ai sedimenti alluvionali è presente un paleosuolo (Giraudi & Frezzotti, 1997), datato 7060±70 BP ( Cal BP). Un secondo deposito alluvionale appare incassato nel primo: è costituito da ghiaie e ghiaietto in abbondante matrice sabbiosa e copre un paleosuolo sviluppatosi sulla superficie di erosione che incide i sedimenti alluvionali più antichi. Il paleosuolo è stato datato 5200±60 BP (BO-285; Cal. BP) Zona a Nord-Ovest del M. San Gregorio di Paganica In una porzione molto piatta di Campo Imperatore (3D in Fig. 1), alle spalle dei depositi morenici, a Nord Ovest del Monte San Gregorio di Paganica, è stata rinvenuta una alternanza di sedimenti alluvionali prevalentemente sabbiosi, con intercalazioni ghiaioso-sabbiose al tetto, e paleosuoli (Fig. 3D): - il primo paleosuolo è datato 1410±40 BP (Cal AD Beta ); - il secondo, che appoggia su una superficie inclinata, è stato coperto in momenti diversi dai sedimenti alluvionali; le datazioni hanno indicato età di 1140±50 BP (Cal AD- Beta ) per la parte topograficamente più bassa della sua area di affioramento, e di 720±50 BP (Cal AD - Beta ) per quella a quota più elevata; vi è inoltre un ulteriore paleosuolo intercalato alle alluvioni che ha fornito una età di 800±50 BP (Cal AD - Beta ); - l ultimo paleosuolo è stato datato 380±40 anni BP (Cal AD - Beta ) ed è coperto dalle alluvioni più grossolane presenti nella sezione. Dopo la sedimentazione delle alluvioni che coprono il paleosuolo più recente, vi è stata una fase erosiva, la deposizione di un piccolo corpo alluvionale e quindi una nuova fase di incisione ancora in corso. Nella stessa zona, ma su un conoide posto poco a Nord-Ovest, un paleosuolo coperto da depositi alluvionali è stato datato 250±40 anni BP (Beta ; Cal AD ) Nel complesso, a Campo Imperatore sono state individuate varie unità alluvionali oloceniche che danno luogo ad una serie di 5 terrazzi sospesi sul fondovalle attuale (Fig. 4) e che trovano riscontro in varie zone appenniniche. Il primo terrazzo alluvionale è costituito da alluvioni prevalentemente ghiaioso sabbiose, successive ad un paleosuolo datato ±100 BP ( Cal BP), e contenenti intercalato un paleosuolo datato 7060±70 BP ( Cal BP). Al Piano Aremogna, presso Roccaraso (Abruzzo), a quote simili a quelle di Campo Imperatore, Frezzotti & Giraudi (1989) segnalano la presenza di un sedimento alluvionale databile tra circa e 7000 anni fa. Il secondo terrazzo alluvionale, incassato nel precedente, è costituito da alluvioni prevalentemente sabbiose o formate da sabbia con ghiaietto, che contengono intercalato un paleosuolo datato rispettivamente 5200±60 BP ( Cal. BP) e 5420±80 BP ( Cal BP).
6 202 C. Giraudi
7 I depositi alluvionali olocenici di Fig. 3 Sezioni geologiche schematiche dei sedimenti alluvionali studiati nella porzione occidentale di Campo Imperatore. Legenda Fig. 3A: 1- sedimenti alluvionali; 2- sedimenti lacustri; 3- accumulo di rock glacier; 4- substrato carbonatico meso-cenozoico; 5- paleosuolo. Legenda Fig. 3B: 1- sedimenti alluvionali sabbioso-limosi; 2- sedimenti alluvionali sabbiso-ghiaiosi; 3- sedimenti alluvionali ghiaiososabbiosi della terza fase del conoide; 4- sedimenti alluvionali ghiaioso-sabbiosi della seconda fase del conoide; 5- sedimenti sabbiosi e limosi lacustri; 6 sedimenti alluvionali ghiaioso-sabbiosi della prima fase del conoide; 7- sedimenti ghiaioso-sabbiosi fluvioglaciali; 8- depositi morenici; 9- paleosuoli. Legenda Fig. 3C; 1- sedimenti dell alveo attuale; 2- sedimenti alluvionali sabbioso-ghiaiosi; 3- ghiaie sabbiose con blocchi; 4- ghiaie sabbiose della prima fase del conoide; 5-substrato carbonatico meso-cenozoico; 6- paleosuoli. Legenda Fig. 3D: 1- suolo attuale e paleosuoli intercalati; 2- sedimenti alluvionali prevalentemente sabbioso-limosi; 3- sedimenti alluvionali sabbiosi; 4- sedimenti alluvionali sabbioso-ghiaiosi. Stratigraphic sketch through the alluvial sediments in western Campo Imperatore. Legend Fig. 3A: 1- alluvial sediments; 2- lacustrine sediments; 3- debris forming the body of the rock glacier; 4- bedrock; 5- palaeosol. Legend Fig. 3B : 1- silty-sandy alluvial sediments; 2- sandy-gravelly alluvial sediments; 3- gravelly-sandy alluvial fan sediments of phase III ; 4- gravelly-sandy alluvial fan sediments of phase II ; 5- sandy-silty lacustrine sediments; 6- - gravelly-sandy alluvial fan sediments of phase I; 7- gravelly-sandy fluvioglacial sediments; 8- till; 9- palaeosols. Legend Fig. 3C: 1- alluvial sediments in presentday stream bed; 2- sandy-gravelly alluvial sediments; 3- sandy gravels with boulders; 4- gravelly sandy alluvial fan sediments of the phase I; 5- bedrock; 6- palaeosols, Legend Fig. 3D: 1- presentday soil and palaeosols interbedded between the alluvial sediments; 2- silty-sandy alluvial sediments; 3- sandy alluvial sediments; 4- sandy-gravelly alluvial sediments. Al Piano Aremogna, presso Roccaraso (Abruzzo), Frezzotti & Giraudi (1989) segnalano la presenza di un paleosuolo datato 5060±150 BP ( Cal BP), intercalato a sedimenti alluvionali. Il terzo terrazzo alluvionale è costituito da alluvioni ghiaioso-sabbiose che coprono un paleosuolo datato 4070±70 BP ( Cal BP) e che inglobano un paleosuolo datato 2130±50 BP ( Cal BP). Sulle sponde del Lago Ballano (Appennino Reggiano, quota 1550 m s.l.m.m.) ricerche in corso hanno evidenziato la presenza di sedimenti alluvionali che coprono torbe datate 4060±60 anni BP ( Cal BP Beta ). Il quarto terrazzo alluvionale appare costituito da un alternanza di depositi prevalentemente fini e di suoli intercalati, datati 1410±40 BP ( AD), 1140±50 BP ( AD); 720±50 BP ( AD), 800±50 BP ( AD) e 380±40 anni BP ( AD). Nella Valle Parma di Budignana, a quota 1530 m s.l.m.m. presso il Lago Scuro, ricerche in corso hanno evidenziato che un sedimento alluvionale contiene un tronco fluitato datato 1310±60 BP ( Cal. AD Beta ) L ultimo terrazzo appare in via di colonizzazione ad opera della vegetazione e, come dimostra lo sviluppo successivo ad eventi deposizionali, erosivi e pedogenetici più recenti dei secoli XV-XVII, il suo modellamento deve essere avvenuto in tempi molto recenti. 3. DISCUSSIONE I depositi alluvionali di Campo Imperatore si sono sedimentati in vari periodi dell Olocene, ma la loro granulometria indica che l energia dei corsi d acqua che li ha depositi era molto diversa. Nel corso della sedimentazione del corpo alluvionale che costituisce il primo terrazzo, avvenuta in un periodo compreso tra ±100 BP ( Cal BP) e 5420±80 BP ( Cal BP) la forte energia dei corsi d acqua evidenzia una situazione di resistasia, e quindi di instabilità dei versanti, anche se attorno a 7060±70 BP ( Cal BP) Fig. 4 Schema dei rapporti stratigrafici tra i sedimenti alluvionali olocenici di Campo Imperatore. Stratigraphic sketch through the Holocene Campo Imperatore alluvial sediments.
8 204 C. Giraudi deve esserci stato un episodio di durata non ben definibile di biostasia, durante il quale, grazie alla stabilità morfologica, si è sviluppato un suolo. Nel corso della sedimentazione del corpo alluvionale che forma il secondo terrazzo, datato tra 7060±70 BP ( Cal BP) e 4070±70 BP ( Cal BP), la granulometria dei sedimenti, piuttosto fine, sembra testimoniare una fase di limitata resistasia; lo sviluppo di suoli datati attorno a 5200±60 BP ( Cal. BP) e 5420±80 BP ( Cal BP) testimoniano il verificarsi di un periodo di biostasia e di stabilità morfologica. Tra la sedimentazione di questo corpo alluvionale ed il successivo, attorno a circa 4070±70 BP ( Cal BP) deve essersi verificata una fase di biostasia che ha prodotto lo sviluppo del suolo di tale età. Nel corso della sedimentazione del corpo alluvionale che forma il terzo terrazzo, costituito da sedimenti piuttosto grossolani, datato tra 4070±70 BP ( Cal BP) e un periodo successivo a 2130±50 BP ( Cal BP) e precedente a 1410±40 BP ( AD), deve essersi verificata una fase di resistasia e di instabilità dei versanti, interrotta da una breve fase di biostasia attorno a 2130±50 BP ( Cal BP), allorché si sviluppò un suolo. La sedimentazione delle alluvioni che formano il quarto terrazzo deve essere avvenuta sotto condizioni ambientali variabili caratterizzate da moderata resistasia, data la granulometria prevalentemente fine dei sedimenti, e da vari periodi di biostasia nel corso dei quali si sviluppavano i suoli. Solo dopo lo sviluppo del suolo datato AD aumentò l energia dei corsi d acqua e quindi si instaurò una fase di resistasia più marcata. Poiché le fasi alluvionali registrate a Campo Imperatore sono state anche riconosciute in altre località dell Appennino Settentrionale e Centrale, a quote simili a quelle dell area oggetto del presente studio, si assume che siano state innescate da variazioni ambientali risentite almeno nell Italia peninsulare. Le fasi alluvionali descritte sono ben correlabili con le espansioni del ghiacciaio del Calderone posto sul versante nord-orientale del Corno Grande (Fig. 1), sul Gran Sasso, segnalate da Giraudi (2000; 2002). Il ghiacciaio si riformò e si espanse dopo lo sviluppo di un suolo datato 3895±65 anni BP ( Cal. BP), un momento molto vicino all inizio della sedimentazione delle alluvioni che formano il terzo terrazzo. Una ulteriore espansione glaciale provocò la copertura di un suolo datato 1450±40 BP (Cal AD); è quindi contemporanea alla copertura di suoli ad opera delle alluvioni basali del complesso di sedimenti che forma il quarto terrazzo. Una nuova espansione glaciale ebbe luogo tra 1450±40 BP (Cal AD) e 670±40 anni BP ( Cal AD), contemporaneamente alla sedimentazione della porzione intermedia dei sedimenti che formano il quarto terrazzo. Il Ghiacciaio del Calderone raggiunse la sua massima espansione tardo-olocenica nel corso di un avanzata successiva a 670±40 anni BP (Cal AD), quindi nel corso della cosiddetta Piccola Età Glaciale, quando si formava la porzione sommitale, più grossolana, dei sedimenti alluvionali del quarto terrazzo di Campo Imperatore. Oltre alle correlazioni con le fasi di avanzata del Ghiacciaio del Calderone, possiamo osservare altri elementi di correlazione tra la sedimentazione alluvionale a Campo Imperatore e le fasi di avanzata glaciale registrate in altre aree. La fase di sedimentazione alluvionale che forma il secondo terrazzo, successiva ai suoli datati attorno a 5000 anni BP (date non calibrate), coincide con l inizio della cosiddetta Neoglaciazione (Orombelli & Ravazzi, 1996). La copertura del paleosuolo, datato AD, ad opera del complesso di sedimenti alluvionali che costituiscono il quarto terrazzo, coincide con una fase di avanzata glaciale registrata sulle Alpi. Infatti le morene del Ghiacciaio della Brenva (M. Bianco) in fase di avanzata hanno coperto un albero datato 1170±75 14 C years BP ( Cal. AD: Orombelli & Porter, 1982), mentre le morene di una fase di avanzata del Ghiacciaio del Lys, sul Massiccio del M. Rosa, coprono un paleosuolo datato 1185±80 14C years BP ( Cal. AD; Strumia, 1997). 4. CONCLUSIONI Il rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio eseguito sui sedimenti e sui terrazzi alluvionali di Campo Imperatore ha permesso di distinguere varie fasi di sedimentazione oloceniche. La scansione cronologica dell attività alluvionale, ottenuta per mezzo di datazioni radiocarbonio su paleosuoli e sedimenti lacustri, dimostra come il trasporto solido nei corsi d acqua sia avvenuto, seppure con diversa energia e con brevi fasi di interruzione, lungo gran parte dell Olocene. Appare poi evidente la correlazione tra fasi di sedimentazione alluvionale a Campo Imperatore e quelle riconosciute in altre località dell Appennino Centrale e Settentrionale, ma anche con le fasi di espansione del Ghiacciaio del Calderone e di alcuni ghiacciai alpini. Le fasi alluvionali di Campo Imperatore sono quindi strettamente legate all impatto sull ambiente prodotto da variazioni climatiche risentite sia in area mediterranea che alpina, evidenziate anche da proxy-data, quali i ghiacciai, che non possono essere influenzati dall intervento dell uomo. Anche se si hanno indizi di incendi preistorici di origine antropica (Giraudi,1999), i dati sembrano dimostrare che l impatto umano non è stato in grado di produrre una destabilizzazione dei versanti e di dare luogo a fasi di sedimentazione alluvionale indipendenti da quelle prodotte dalle variazioni climatiche. La presenza di molti ed estesi corpi sedimentari di origine alluvionale appare strettamente legata alla esistenza di vaste fasce di cataclasiti presso la base del versante che borda la porzione settentrionale di Campo Imperatore; i molti gullies incisi in questa zona si sono stabilizzati solo rare volte, forse in coincidenza con le maggiori fasi di stabilità morfologica, mentre per gran parte dell Olocene l erosione è stata attiva ed ha fornito materiale clastico per il trasporto solido nell alveo dei corsi d acqua. Il notevole dettaglio di fasi di sedimentazione e di pedogenesi registrate nei sedimenti che formano il quar-
9 I depositi alluvionali olocenici di to terrazzo (di età storica) appare sostanzialmente legato al fatto che il sito studiato si trova in un area molto piatta: in tali zone i corsi d acqua perdono energia, la sedimentazione è prevalentemente fine e le superfici di erosione sono assai blande. In alcune aree pianeggianti della porzione occidentale di Campo Imperatore si verificano quindi le condizioni adatte alla preservazione dei sedimenti deposti dalle fasi alluvionali secondarie che, nel loro complesso, hanno formato il quarto terrazzo. Un dettaglio simile non è stato però trovato nei depositi alluvionali più antichi, rilevati in zone ove i corsi d acqua avevano maggiore energia e dove la sedimentazione era più grossolana e le fasi di erosione assai più intense. RINGRAZIAMENTI Il presente lavoro è stato condotto coi contributi finanziari del Ministero per l Ambiente nell ambito dell Accordo di Programma ENEA Ministero dell Ambiente, Progetto 2,4 Variazioni Climatiche, e del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Demangeot J. (1965) Géomorphologie des Abruzzes Adriatiques. Mem. Et Doc., C.N.R.S., 403 pp. Frezzotti M. & Giraudi C. (1989) - Evoluzione geologica tardo-pleistocenica ed olocenica del Piano di Aremogna (Roccaraso - Abruzzo): implicazioni climatiche e tettoniche. Mem. Soc. Geol. It., 42, Frezzotti M. & Giraudi C. (1990) Sedimenti eolici tardopleistocenici ed olocenici nell Appennino Centrale. Mem.Soc.Geol.It., 45, Ghisetti F. & Vezzani L. (1986) Carta geologica del Gran Sasso d Italia (da Vado di Corno a Passo delle Capannelle). S.E.L.C.A., Firenze. Ghisetti F. & Vezzani L. (1990) Carta geologica del Gruppo del M. Siella-M. Camicia-M. Prena- M. Brancastello (Gran Sasso d Italia, Abruzzo). Caratteri stratigrafici e strutturali del settore orientale della catena del Gran Sasso. S.E.L.C.A., Firenze. Giraudi C. (1994) - Elementi di geologia del Quaternario della Piana di Campo Imperatore (Massiccio del Gran Sasso - Italia Centrale). In Atti Tic. Sc. Terra (Serie speciale), 2, Giraudi C. (1998) - I laghi effimeri tardopleistocenici ed olocenici di Campo Imperatore e del Massiccio del Gran Sasso d'italia (Abruzzo - Italia Centrale). Il Quaternario, 11 (2), Giraudi C. (1999) - Incendi di età pleistocenica superiore e olocenica sulle montagne dell'appennino Centrale. Il Quaternario, 12(2), Giraudi C. (2000) - Le oscillazioni oloceniche del ghiacciaio del Calderone, Gran Sasso d'italia (Abruzzo - Italia). Il Quaternario, 13(1/2), Giraudi C. (2001) - The Late Pleistocene and Holocene temporary lakes in the Abruzzo Parks and the Central Apennine. In Visconti G., Beniston M., Iannorelli E. & Barba D. Eds: Global Change and protected areas. Advances in Global Changes Research, 9, Giraudi C. (2002) Le oscillazioni del Ghiacciaio del Calderone (Gran Sasso d Italia, Abruzzo Italia Centrale) e le variazioni climatiche degli ultimi 3000 anni. Il Quaternario, 15(2), Giraudi C. & Frezzotti M. (1997) - Late Pleistocene glacial events in the Central Apennine, Italy. Quaternary Research, 48 (3), Orombelli G. & Porter S.C. (1982) - Late Holocene fluctuations of Brenva Glacier. Geogr. Fis. Dinam. Quat. 5, Orombelli G. & Ravazzi C. (1996) The Late Glacial and Early Holocene chronology and paleoclimate. Il Quaternario, 9(2), Servizio Geologico d Italia (1963) - Carta Geologica d Italia a scala 1: , F. 140, Teramo. II Edizione. Strumia G. (1997) - Oscillazioni glaciali precedenti la piccola età glaciale documentate da un suolo sepolto in una morena del Ghiacciaio del Lys. Il Quaternario, 10(2), Ms. ricevuto il 13 maggio 2003 Testo definitivo ricevuto il 10 giugno 2003 Ms. received: Maj 13, 2003 Final text received: June 10, 2003
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
ENEA C.R. Casaccia, C.P. 2400, Roma A.D.
 Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 15(2), 2002, 149-154 LE OSCILLAZIONI DEL GHIACCIAIO DEL CALDERONE (GRAN SASSO D'ITALIA, ABRUZZO - ITALIA CENTRALE) E LE VARIAZIONI CLIMATICHE DEGLI
Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 15(2), 2002, 149-154 LE OSCILLAZIONI DEL GHIACCIAIO DEL CALDERONE (GRAN SASSO D'ITALIA, ABRUZZO - ITALIA CENTRALE) E LE VARIAZIONI CLIMATICHE DEGLI
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4
 RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
UNIVERSITÀ DI PISA. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
 UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
LE ACQUE DELLA PIANURA ISONTINA VODE SOŠKEGA ALUVIJA INTRODUZIONE AL PROGETTO GEP/ UVODNA BESEDA O PROJEKTU GEP
 EVENTO INFORMATIVO-DIVULGATIVO / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO LE ACQUE DELLA PIANURA ISONTINA VODE SOŠKEGA ALUVIJA INTRODUZIONE AL PROGETTO GEP/ UVODNA BESEDA O PROJEKTU GEP Franco CUCCHI Dipartimento
EVENTO INFORMATIVO-DIVULGATIVO / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO LE ACQUE DELLA PIANURA ISONTINA VODE SOŠKEGA ALUVIJA INTRODUZIONE AL PROGETTO GEP/ UVODNA BESEDA O PROJEKTU GEP Franco CUCCHI Dipartimento
Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana
 Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
LE OSCILLAZIONI DI LIVELLO DEL LAGO DI MEZZANO (VALENTANO - VT): VARIAZIONI CLIMATICHE E INTERVENTI ANTROPICI
 Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 17(2/1), 2004, 221-230 LE OSCILLAZIONI DI LIVELLO DEL LAGO DI MEZZANO (VALENTANO - VT): VARIAZIONI CLIMATICHE E INTERVENTI ANTROPICI Carlo Giraudi
Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 17(2/1), 2004, 221-230 LE OSCILLAZIONI DI LIVELLO DEL LAGO DI MEZZANO (VALENTANO - VT): VARIAZIONI CLIMATICHE E INTERVENTI ANTROPICI Carlo Giraudi
PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO DELLA PIANURA EMILIANO-ROMAGNOLA ALLA SCALA 1:50.000
 Conferenza del Dott. Paolo Severi di Giovedì 18 Marzo 2010 ore 15.00 tenuta presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell Università di Parma PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO
Conferenza del Dott. Paolo Severi di Giovedì 18 Marzo 2010 ore 15.00 tenuta presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell Università di Parma PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO
ENEA, CR Casaccia, C.P. 2400, ROMA A.D.
 Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 15(1), 2002, 45-52 I ROCK GLACIER TARDO-PLEISTOCENICI ED OLOCENI DELL'APPENNINO - ETÀ, DISTRIBUZIONE, SIGNIFICATO PALEOCLIMATICO C. Giraudi ENEA, CR
Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 15(1), 2002, 45-52 I ROCK GLACIER TARDO-PLEISTOCENICI ED OLOCENI DELL'APPENNINO - ETÀ, DISTRIBUZIONE, SIGNIFICATO PALEOCLIMATICO C. Giraudi ENEA, CR
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI
 SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
LE OPERE DI SBARRAMENTO
 LE OPERE DI SBARRAMENTO LE DIGHE Sono opere di sbarramento, di un corso d acqua, che determinano la formazione di un invaso o lago artificiale. L opera può avere diversi scopi: Regolare le portate fluviali
LE OPERE DI SBARRAMENTO LE DIGHE Sono opere di sbarramento, di un corso d acqua, che determinano la formazione di un invaso o lago artificiale. L opera può avere diversi scopi: Regolare le portate fluviali
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
Negli ultimi anni nuovi criteri e metodi per definire i depositi quaternari continentali: Unità Allostratigrafiche e UBSU
 La stratigrafia del Quaternario - 2 Abbiamo visto come per vari motivi le unità della stratigrafia classica, ma anche le unità morfologiche, pedologiche NON siano del tutto adatte al rilevamento del Quaternario,
La stratigrafia del Quaternario - 2 Abbiamo visto come per vari motivi le unità della stratigrafia classica, ma anche le unità morfologiche, pedologiche NON siano del tutto adatte al rilevamento del Quaternario,
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 11 ART. 6 LR N.11/2004 Sig. BONADIMAN TIZIANO Area polifunzionale mista servizi e residenza Zona F per attrezzature e
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 11 ART. 6 LR N.11/2004 Sig. BONADIMAN TIZIANO Area polifunzionale mista servizi e residenza Zona F per attrezzature e
ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE
 ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE FAGLIA ATTIVA E' considerata attiva una faglia originatasi e/o riattivatasi durante il campo di stress agente correntemente nell'area.. Faglia quaternaria, pleistocenica,
ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE FAGLIA ATTIVA E' considerata attiva una faglia originatasi e/o riattivatasi durante il campo di stress agente correntemente nell'area.. Faglia quaternaria, pleistocenica,
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESISTICA E AMBIENTALE AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA)
 AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
COMUNE DI MATELICA. Provincia di Macerata
 DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda.
 La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
di Francesco Galbusera Il paesaggio di Casatenovo origine e trasformazioni
 di Francesco Galbusera Il paesaggio di Casatenovo origine e trasformazioni Percorso e soste Arrivo Lunghezza - 5 km Durata - 2 h Partenza Partenza Frazione Rimoldo Partenza Frazione Rimoldo La Geomorfologia
di Francesco Galbusera Il paesaggio di Casatenovo origine e trasformazioni Percorso e soste Arrivo Lunghezza - 5 km Durata - 2 h Partenza Partenza Frazione Rimoldo Partenza Frazione Rimoldo La Geomorfologia
Francesco Comiti! Facoltà di Scienze e Tecnologie! Libera Università di Bolzano
 Processi erosivi ed evoluzione dei corsi d acqua nel contesto dei cambiamenti climatici Prad am Stilfser Joch - Prato allo Stelvio 19.06.2015 Francesco Comiti Facoltà di Scienze e Tecnologie Libera Università
Processi erosivi ed evoluzione dei corsi d acqua nel contesto dei cambiamenti climatici Prad am Stilfser Joch - Prato allo Stelvio 19.06.2015 Francesco Comiti Facoltà di Scienze e Tecnologie Libera Università
La montagna. Ghiacciai. Clima e vegetazione
 La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
Gli Appennini. Piani di Castelluccio, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Umbria.
 Piani di Castelluccio, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Umbria. Gli Appennini sono un sistema montuoso collegato a nord-ovest alle Alpi e che si estende fino al di là dello Stretto di Messina,
Piani di Castelluccio, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Umbria. Gli Appennini sono un sistema montuoso collegato a nord-ovest alle Alpi e che si estende fino al di là dello Stretto di Messina,
La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana
 La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana L assetto geomorfologico della pianura padana è strettamente connesso al modello genetico della sua formazione. La Pianura Padana costituisce l avanfossa
La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana L assetto geomorfologico della pianura padana è strettamente connesso al modello genetico della sua formazione. La Pianura Padana costituisce l avanfossa
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche:
 Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 10 ART. 6 LR N.11/2004 L&D IMMOBILIARE Srl Centro Servizi per l Automobile con annessa struttura ricettiva autohotel VALUTAZIONE
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 10 ART. 6 LR N.11/2004 L&D IMMOBILIARE Srl Centro Servizi per l Automobile con annessa struttura ricettiva autohotel VALUTAZIONE
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4
 RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9220144 LAGO SAN GIULIANO E TIMMARI Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA
RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9220144 LAGO SAN GIULIANO E TIMMARI Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA
La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con
 La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con la storia geologica del pianeta: quando, 4.600 milioni di anni fa, la superficie terrestre fino allora concentrata in una sola unità strutturale
La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con la storia geologica del pianeta: quando, 4.600 milioni di anni fa, la superficie terrestre fino allora concentrata in una sola unità strutturale
sponda Terrazzo Piana alluvionale Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo barra isola Canale di magra
 Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo sponda Terrazzo Piana alluvionale barra isola Canale di magra Canale di magra: parte dell alveo che risulta totalmente o parzialmente ricoperta di acqua per la maggior
Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo sponda Terrazzo Piana alluvionale barra isola Canale di magra Canale di magra: parte dell alveo che risulta totalmente o parzialmente ricoperta di acqua per la maggior
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 13 ART. 6 LR N.11/2004 FRATELLI DALLA BERNARDINA Srl ZTO DT economico-produttiva turistico-ricettiva VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 13 ART. 6 LR N.11/2004 FRATELLI DALLA BERNARDINA Srl ZTO DT economico-produttiva turistico-ricettiva VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA
 CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA - le forme di erosione e di accumulo La carta geomorfologica di base raffigura in modo analitico: Le informazioni fornite dal documento, considerate sia singolarmente che nei
CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA - le forme di erosione e di accumulo La carta geomorfologica di base raffigura in modo analitico: Le informazioni fornite dal documento, considerate sia singolarmente che nei
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI
 DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
Introduzione...2 Inquadramento geografico...2 Geomorfologia...4 Idrografia...5 Geologia...5 Vincoli...5 Tipologia di interventi...
 Introduzione...2 Inquadramento geografico...2 Geomorfologia...4 Idrografia...5 Geologia...5 Vincoli...5 Tipologia di interventi...6 ALLEGATO 1-Estratto del Foglio 43 della Carta Geologica d Italia alla
Introduzione...2 Inquadramento geografico...2 Geomorfologia...4 Idrografia...5 Geologia...5 Vincoli...5 Tipologia di interventi...6 ALLEGATO 1-Estratto del Foglio 43 della Carta Geologica d Italia alla
Acquiferi alluvionali della pianura padana
 Acquiferi alluvionali della pianura padana Paolo Severi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione Emilia - Romagna La struttura geologica degli acquiferi padani La Pianura Padana è una pianura alluvionale
Acquiferi alluvionali della pianura padana Paolo Severi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione Emilia - Romagna La struttura geologica degli acquiferi padani La Pianura Padana è una pianura alluvionale
3.3 Il bacino del fiume Cavone
 3.3 Il bacino del fiume Cavone 3.3.1 Il territorio Il bacino del fiume Cavone (superficie di 675 kmq) presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, ad eccezione che nella porzione settentrionale
3.3 Il bacino del fiume Cavone 3.3.1 Il territorio Il bacino del fiume Cavone (superficie di 675 kmq) presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, ad eccezione che nella porzione settentrionale
Studio G E O E C O S Dott. Geol. G. MENZIO. Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia. Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN)
 Studio Dott. Geol. G. MENZIO Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN) Tel0175977186-Fax1782737211-Cel.3402572786-mail:geoecos@libero.it Indirizzo di posta
Studio Dott. Geol. G. MENZIO Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN) Tel0175977186-Fax1782737211-Cel.3402572786-mail:geoecos@libero.it Indirizzo di posta
Regione Friuli Venezia Giulia azienda dimostrativa MAURO ZANONE. Localizzazione. azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone
 Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti tra loro diversi per situazione
Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti tra loro diversi per situazione
Giardin Grande. Colle del Castello. Udine
 Giardin Grande Colle del Castello UD Udine TS G E O S I TO Colle di Udine Corrado Venturini C è un Grande Indiziato (secondo la Giuria Popolare) il Colle di Udine 26 m Attila COSA SI DICE luglio 452 d.c.
Giardin Grande Colle del Castello UD Udine TS G E O S I TO Colle di Udine Corrado Venturini C è un Grande Indiziato (secondo la Giuria Popolare) il Colle di Udine 26 m Attila COSA SI DICE luglio 452 d.c.
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio
 UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione:
 CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione: Al fine di chiarire il ruolo della tettonica nell evoluzione sedimentaria dell area di studio, sono stati analizzati i principali caratteri strutturali della successione
CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione: Al fine di chiarire il ruolo della tettonica nell evoluzione sedimentaria dell area di studio, sono stati analizzati i principali caratteri strutturali della successione
COSTRUZIONI CASSARA DI CASSARA GEOM. ANTONINO C.SO TORINO, 55 VIGEVANO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA
 COMUNE DI VIGEVANO Provincia di Pavia COMMITTENTE COSTRUZIONI CASSARA DI CASSARA GEOM. ANTONINO C.SO TORINO, 55 VIGEVANO PROGETTO PL VIA VALLETTA FOGLIANO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott.Geol.
COMUNE DI VIGEVANO Provincia di Pavia COMMITTENTE COSTRUZIONI CASSARA DI CASSARA GEOM. ANTONINO C.SO TORINO, 55 VIGEVANO PROGETTO PL VIA VALLETTA FOGLIANO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott.Geol.
Circa anni fa i ghiacci cominciano a ritirarsi dalla Pianura. La temperatura aumenta, il limite delle nevi persistenti si alza e..
 Circa 18.000-17.000 anni fa i ghiacci cominciano a ritirarsi dalla Pianura. La temperatura aumenta, il limite delle nevi persistenti si alza e..? Adesso, 21 secolo, solamente due piccolissimi ghiacciai
Circa 18.000-17.000 anni fa i ghiacci cominciano a ritirarsi dalla Pianura. La temperatura aumenta, il limite delle nevi persistenti si alza e..? Adesso, 21 secolo, solamente due piccolissimi ghiacciai
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
 EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
EFFETTI DI SITO DELLA PIANA DEL FUCINO attraverso lo studio comparato di dati sismici e geologici. D. Famiani 1, F. Cara 2, G. Di Giulio 2, G. Milana 2,G. Cultrera 2, P. Bordoni 2, G.P. Cavinato 3 1 Dipartimento
COMUNE DI GUASILA. Provincia di CAGLIARI
 Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
LE ROCCE. (seconda parte) Lezioni d'autore. di Simona Mazziotti Tagliani
 LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
 CASADIO & CO. studio tecnico associato Via V.Veneto 1/bis 47100 FORLI Tel: 0543 23923 Email: studio@casadioeco.it P.I. 03480110406 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA Committente: Gruppo Marcegaglia divisione
CASADIO & CO. studio tecnico associato Via V.Veneto 1/bis 47100 FORLI Tel: 0543 23923 Email: studio@casadioeco.it P.I. 03480110406 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA Committente: Gruppo Marcegaglia divisione
I rilievi. Mondadori Education
 I rilievi I rilievi italiani che superano i 600 m di altezza sono suddividi tra le Alpi, che si estendono da ovest a est nella parte settentrionale della penisola, e gli Appennini, che invece la attraversano
I rilievi I rilievi italiani che superano i 600 m di altezza sono suddividi tra le Alpi, che si estendono da ovest a est nella parte settentrionale della penisola, e gli Appennini, che invece la attraversano
Cosa sono le acque continentali?
 Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
Terreno naturale e terreno agrario. rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno
 Terreno naturale e terreno agrario il profilo del terreno rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno In relazione al tipo di profilo che un terreno presenta, possiamo distinguere:
Terreno naturale e terreno agrario il profilo del terreno rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno In relazione al tipo di profilo che un terreno presenta, possiamo distinguere:
Cap. II Origine dei Sedimenti e Trasporto Sedimentario
 Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. II Origine dei Sedimenti e Trasporto Sedimentario I sedimenti clastici si originano per disgregazione di rocce pre-esistenti (EROSIONE). I sedimenti
Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. II Origine dei Sedimenti e Trasporto Sedimentario I sedimenti clastici si originano per disgregazione di rocce pre-esistenti (EROSIONE). I sedimenti
CON-VIVIAMO IL FIUME. Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri. A cura di STEFANO BRIGHENTI
 Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri CON-VIVIAMO IL FIUME A cura di STEFANO BRIGHENTI Filone B- Protezione civile e cultura del rischio naturale Oggi parliamo di fiumi! Ok...ma cosa è un fiume???
Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri CON-VIVIAMO IL FIUME A cura di STEFANO BRIGHENTI Filone B- Protezione civile e cultura del rischio naturale Oggi parliamo di fiumi! Ok...ma cosa è un fiume???
POLO N. 5 BONDENO, SETTEPOLESINI
 TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
Modulo 1: Nozioni di base di Geologia
 Modulo 1: Nozioni di base di Geologia La Terra (Parametri fisici -Origine-Struttura Dinamica) Metodi di datazione assoluta e relativa Il Tempo Geologico e le sue principali suddivisioni La Terra: le principali
Modulo 1: Nozioni di base di Geologia La Terra (Parametri fisici -Origine-Struttura Dinamica) Metodi di datazione assoluta e relativa Il Tempo Geologico e le sue principali suddivisioni La Terra: le principali
Consiglio Nazionale delle Ricerche. RAPPORTO DI EVENTO Fenomeni franosi avvenuti in Val Germanasca (TO) il 16 marzo 2011
 Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA CENTRO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RAPPORTO DI EVENTO
Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA CENTRO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RAPPORTO DI EVENTO
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005)
 SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
Aosta. 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone
 Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
COMUNE DI EMPOLI Provincia di Firenze
 Dr. Geol. Paola Violanti via Osteria Bianca, 43-50057 Ponte a Elsa FI tel e fax: 0571 931212 3479186530 e mail: paolaviolanti@timenet.it cod.fisc.vlnpla53p51d403z part. I.V.A. 04363000482 VARIANTE AL REGOLAMENTO
Dr. Geol. Paola Violanti via Osteria Bianca, 43-50057 Ponte a Elsa FI tel e fax: 0571 931212 3479186530 e mail: paolaviolanti@timenet.it cod.fisc.vlnpla53p51d403z part. I.V.A. 04363000482 VARIANTE AL REGOLAMENTO
La Valle d Aosta. il... (4 476 m). Il capoluogo di regione è...
 La Valle d Aosta La Valle d Aosta confina a nord con la......, a est e a sud con il..., a ovest con la... È una regione completamente...... Le sue cime principali sono: il...... (4 810 m), il...... (4
La Valle d Aosta La Valle d Aosta confina a nord con la......, a est e a sud con il..., a ovest con la... È una regione completamente...... Le sue cime principali sono: il...... (4 810 m), il...... (4
CORSO DI GEOMORFOLOGIA
 CORSO DI GEOMORFOLOGIA ESCURSIONE DIDATTICA A CAMPO IMPERATORE Prof. Sirio Ciccacci INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL AREA DI CAMPO IMPERATORE Situato nell area del Massiccio del Gran Sasso, in provincia dell
CORSO DI GEOMORFOLOGIA ESCURSIONE DIDATTICA A CAMPO IMPERATORE Prof. Sirio Ciccacci INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL AREA DI CAMPO IMPERATORE Situato nell area del Massiccio del Gran Sasso, in provincia dell
Il cambiamento climatico e la risorsa nivo-glaciale del bacino del Po
 Il cambiamento climatico e la risorsa nivo-glaciale del bacino del Po S. Bovo, S. Barbero, R. Pelosini ARPA Piemonte Parma, 16 luglio 2007 IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI COPERTURA
Il cambiamento climatico e la risorsa nivo-glaciale del bacino del Po S. Bovo, S. Barbero, R. Pelosini ARPA Piemonte Parma, 16 luglio 2007 IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI COPERTURA
INDAGINI GEO-ELETTRICHE
 INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
La colata detritica del 7 settembre 2008 nel bacino glaciale della Torre di Castelfranco (Valle Anzasca, Macugnaga)
 La colata detritica del 7 settembre 2008 nel bacino glaciale della Torre di Castelfranco (Valle Anzasca, Macugnaga) RAPPORTO DI EVENTO a cura di Maura Giuliano e Giovanni Mortara Torre di Castelfranco
La colata detritica del 7 settembre 2008 nel bacino glaciale della Torre di Castelfranco (Valle Anzasca, Macugnaga) RAPPORTO DI EVENTO a cura di Maura Giuliano e Giovanni Mortara Torre di Castelfranco
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1
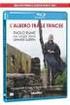 Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
INDICE Paragrafi. Appendici al testo
 INDICE Paragrafi PREMESSA 1 - CARATTERISTICHE DELL INTERVENTO 2 - METODOLOGIA D INDAGINE ED ELABORATI GRAFICI 3 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO E LITOTECNICO 4 - CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
INDICE Paragrafi PREMESSA 1 - CARATTERISTICHE DELL INTERVENTO 2 - METODOLOGIA D INDAGINE ED ELABORATI GRAFICI 3 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO E LITOTECNICO 4 - CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Tunnel AIGUEBELLE - TUNNEL DES HURTIERES (FRANCIA) ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS.
 www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS AIGUEBELLE - TUNNEL DES HURTIERES (FRANCIA) ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS AIGUEBELLE - TUNNEL DES HURTIERES (FRANCIA) PROGETTO: Consolidamento
www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS AIGUEBELLE - TUNNEL DES HURTIERES (FRANCIA) ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS AIGUEBELLE - TUNNEL DES HURTIERES (FRANCIA) PROGETTO: Consolidamento
STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
Regione Toscana Provincia di Arezzo Comune di Sansepolcro
 Regione Toscana Provincia di Arezzo Comune di Sansepolcro RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE GEOLOGICA Progetto V15a Variante all art. 52 delle N.T.A del P.R.G. vigente relativa ad un area ad uso di
Regione Toscana Provincia di Arezzo Comune di Sansepolcro RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE GEOLOGICA Progetto V15a Variante all art. 52 delle N.T.A del P.R.G. vigente relativa ad un area ad uso di
Geografia A2 Classi 3 a, 4 a, 5 a e secondaria Scheda n Sesamo 3 1 gennaio 2011
 Geografia A2 Classi 3 a, 4 a, 5 a e secondaria Scheda n. 1 Nome... Classe... Data... ELEMENTI NATURALI E ANTROPICI Scrivi se gli elementi del paesaggio sono naturali o antropici. È un elemento 1. fiume...
Geografia A2 Classi 3 a, 4 a, 5 a e secondaria Scheda n. 1 Nome... Classe... Data... ELEMENTI NATURALI E ANTROPICI Scrivi se gli elementi del paesaggio sono naturali o antropici. È un elemento 1. fiume...
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
 AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
Modulo 2: Nozioni di base di Geologia
 Modulo 2: Nozioni di base di Geologia Il principio dell attualismo in Geologia la stratigrafia e le sue leggi fondamentali cenni sulla Paleogeografia dell appennino centrale dal Mesozoico ad oggi 1) Principio
Modulo 2: Nozioni di base di Geologia Il principio dell attualismo in Geologia la stratigrafia e le sue leggi fondamentali cenni sulla Paleogeografia dell appennino centrale dal Mesozoico ad oggi 1) Principio
Stratigrafia di sottosuolo dell Oltrepo mantovano e della bassa pianura cremonese
 Luigi Bruno & Alessandro Amorosi Stratigrafia di sottosuolo dell Oltrepo mantovano e della bassa pianura cremonese Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna, Via
Luigi Bruno & Alessandro Amorosi Stratigrafia di sottosuolo dell Oltrepo mantovano e della bassa pianura cremonese Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna, Via
Variazioni volumetriche dei Ghiacciai del Lys e del Ruitor
 Variazioni volumetriche dei Ghiacciai del Lys e del Ruitor Andrea Tamburini & Fabio Villa IMAGEO S.r.l. - Torino Courmayeur, 01 ottobre 2009 Indice Cenni metodologici: Rilievi GPR (Ground Penetrating Radar)
Variazioni volumetriche dei Ghiacciai del Lys e del Ruitor Andrea Tamburini & Fabio Villa IMAGEO S.r.l. - Torino Courmayeur, 01 ottobre 2009 Indice Cenni metodologici: Rilievi GPR (Ground Penetrating Radar)
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
TERREMOTO CENTRO ITALIA Di.Coma.C Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione. Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016
 Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
Esercizio 2 Domi di esfoliazione (Yosemite National Park, California, USA) Domande
 Esercizio 1 La carta mostra delle curve di livello solo in una sua parte. (a) Si definisca la scala della carta: (b) Utilizzando i punti quotati si disegnino le curve di livello principali (di 100 in 100
Esercizio 1 La carta mostra delle curve di livello solo in una sua parte. (a) Si definisca la scala della carta: (b) Utilizzando i punti quotati si disegnino le curve di livello principali (di 100 in 100
4.2. Caratterizzazione geotecnica ai fini delle verifiche di stabilità
 PAG 1 INDICE 1. PREMESSA 2. BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO 3. INDAGINI IN SITO 4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 4.1. Caratterizzazlone geotecnlca di progetto 4.2. Caratterizzazione geotecnica ai fini delle
PAG 1 INDICE 1. PREMESSA 2. BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO 3. INDAGINI IN SITO 4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 4.1. Caratterizzazlone geotecnlca di progetto 4.2. Caratterizzazione geotecnica ai fini delle
GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO DI CARTOGRAFIA
 GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO DI CARTOGRAFIA a cura di S. Furlani A.A. 2016/2017 Programma OBIETTIVI FORMATIVI MORFOLOGIA, CARTOGRAFIA, EVOLUZIONE MORFOLOGICA Composizione dell atmosfera, idrosfera,
GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO DI CARTOGRAFIA a cura di S. Furlani A.A. 2016/2017 Programma OBIETTIVI FORMATIVI MORFOLOGIA, CARTOGRAFIA, EVOLUZIONE MORFOLOGICA Composizione dell atmosfera, idrosfera,
Il terremoto di L Aquila del : alcune osservazioni nella zona di Paganica a quasi quattro mesi dall evento
 Il terremoto di L Aquila del 06.04.2009: alcune osservazioni nella zona di Paganica a quasi quattro mesi dall evento Marco Avanzini Sono qui riportati i risultati di un breve sopralluogo effettuato nei
Il terremoto di L Aquila del 06.04.2009: alcune osservazioni nella zona di Paganica a quasi quattro mesi dall evento Marco Avanzini Sono qui riportati i risultati di un breve sopralluogo effettuato nei
martedì 4 ottobre 2011 Bacini di drenaggio
 Bacini di drenaggio Bacini di drenaggio Bacini di drenaggio = watershed Una parte di territorio definita da spartiacque. Tutta l acqua che si trova sul bacino viene drenata verso il basso verso un fiume
Bacini di drenaggio Bacini di drenaggio Bacini di drenaggio = watershed Una parte di territorio definita da spartiacque. Tutta l acqua che si trova sul bacino viene drenata verso il basso verso un fiume
INQUADRAMENTO GENERALE..1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO..1. Geologia. 1. Geomorflogia..2. Idrogeologia 2. Pericolosità e Fattibilità..
 Sommario INQUADRAMENTO GENERALE..1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO..1 Geologia. 1 Geomorflogia..2 Idrogeologia 2 Pericolosità e Fattibilità.. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 4 Scarpata..4 Nicchia
Sommario INQUADRAMENTO GENERALE..1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO..1 Geologia. 1 Geomorflogia..2 Idrogeologia 2 Pericolosità e Fattibilità.. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 4 Scarpata..4 Nicchia
COMUNE DI GIULIANOVA
 COMUNE DI GIULIANOVA PROVINCIA DI TERAMO OGGETTO: RELAZIONE IDROGEOLOGICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI COMMITTENTE: ITALPLAFER S.R.L. LOCALITA : ZONA INDUSTRIALE COLLERANESCO
COMUNE DI GIULIANOVA PROVINCIA DI TERAMO OGGETTO: RELAZIONE IDROGEOLOGICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI COMMITTENTE: ITALPLAFER S.R.L. LOCALITA : ZONA INDUSTRIALE COLLERANESCO
Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): un estate caldissima annulla i benefici di un inverno nevoso. Ancora un bilancio negativo
 Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): un estate caldissima annulla i benefici di un inverno nevoso. Ancora un bilancio negativo SMI Redazione Nimbus, 8 settembre 2009 I forti e prolungati calori dell estate
Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): un estate caldissima annulla i benefici di un inverno nevoso. Ancora un bilancio negativo SMI Redazione Nimbus, 8 settembre 2009 I forti e prolungati calori dell estate
GEOLOGIA STRATIGRAFICA
 ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
Evoluzione dei litorali sabbiosi in relazione ai cambiamenti climatici nel periodo storico ORTOLANI F. 1, PAGLIUCA S. 2
 Evoluzione dei litorali sabbiosi in relazione ai cambiamenti climatici nel periodo storico ORTOLANI F. 1, PAGLIUCA S. 2 1 Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Università di Napoli Federico
Evoluzione dei litorali sabbiosi in relazione ai cambiamenti climatici nel periodo storico ORTOLANI F. 1, PAGLIUCA S. 2 1 Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Università di Napoli Federico
1. L'EUROPA E L'ITALIA: CONFINI, COSTE, RILIEVI E PIANURE. Pearson Italia
 1. L'EUROPA E L'ITALIA: CONFINI, COSTE, RILIEVI E PIANURE. L'Europa nel mondo L Europa è il quarto continente per dimensioni: solo l Oceania è più piccola. Dal punto di vista geografico è un estensione
1. L'EUROPA E L'ITALIA: CONFINI, COSTE, RILIEVI E PIANURE. L'Europa nel mondo L Europa è il quarto continente per dimensioni: solo l Oceania è più piccola. Dal punto di vista geografico è un estensione
L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando:
 L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando: 1) laghi 2) fiumi 3) falde acquifere LE FALDE ACQUIFERE L'acqua penetra nel terreno
L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando: 1) laghi 2) fiumi 3) falde acquifere LE FALDE ACQUIFERE L'acqua penetra nel terreno
LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE CARTE GEOLOGICHE
 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE CARTE GEOLOGICHE La Carta geologica è una carta tematica che fornisce una rappresentazione bidimensionale dei terreni e delle rocce affioranti in una certa regione e dei
LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE CARTE GEOLOGICHE La Carta geologica è una carta tematica che fornisce una rappresentazione bidimensionale dei terreni e delle rocce affioranti in una certa regione e dei
 RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
IL TORRENTE COSIA: FILO CONDUTTORE DELLA BIODIVERSITA' TRA NATURA E UOMO BANDO CARIPLO - SCUOLA 21, A.S. 2013/14 FASE 2: PROBLEMATIZZAZIONE CLASSE III
 IL TORRENTE COSIA: FILO CONDUTTORE DELLA BIODIVERSITA' TRA NATURA E UOMO BANDO CARIPLO - SCUOLA 21, A.S. 2013/14 FASE 2: PROBLEMATIZZAZIONE CLASSE III UNITA' DI APPRENDIMENTO 1: PROCESSO DI TRASFORMAZIONE
IL TORRENTE COSIA: FILO CONDUTTORE DELLA BIODIVERSITA' TRA NATURA E UOMO BANDO CARIPLO - SCUOLA 21, A.S. 2013/14 FASE 2: PROBLEMATIZZAZIONE CLASSE III UNITA' DI APPRENDIMENTO 1: PROCESSO DI TRASFORMAZIONE
Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo
 Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo F. Pergalani, M. Compagnoni, M.P. Boni Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo F. Pergalani, M. Compagnoni, M.P. Boni Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Analisi suolo e sottosuolo
 Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
Mitigazione del rischio relativo ai dissesti dei corsi d acqua e dei versanti
 Mitigazione del rischio relativo ai dissesti dei corsi d acqua e dei versanti Criteri di approccio sistemico Da R. Rosso 2 Misure Strutturali di Manutenzione Straordinaria OBIETTIVI: riparazione, ricostruzione,
Mitigazione del rischio relativo ai dissesti dei corsi d acqua e dei versanti Criteri di approccio sistemico Da R. Rosso 2 Misure Strutturali di Manutenzione Straordinaria OBIETTIVI: riparazione, ricostruzione,
COMUNE DI AGRA. Provincia di Varese
 COMUNE DI AGRA Provincia di Varese STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T. AI SENSI DELL ART. 57 DELLA L.R. 12/05 REV02 DEL NOVEMBRE 2009 NOTA TECNICA
COMUNE DI AGRA Provincia di Varese STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T. AI SENSI DELL ART. 57 DELLA L.R. 12/05 REV02 DEL NOVEMBRE 2009 NOTA TECNICA
COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. Circolare 7/LAP e N.T.E./99 L.R. 56/77 e s.m.i. NOVARA, marzo 2014
 COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Circolare 7/LAP e N.T.E./99 L.R. 56/77 e s.m.i. STUDIO GEOLOGICO RIVOLTA E GRASSI VIA G. PRATI, 4-28100 NOVARA Tel. e fax: 0321
COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Circolare 7/LAP e N.T.E./99 L.R. 56/77 e s.m.i. STUDIO GEOLOGICO RIVOLTA E GRASSI VIA G. PRATI, 4-28100 NOVARA Tel. e fax: 0321
GUIDA NATURALISTICA La Lomellina, agricoltura e natura come conoscenza III INCONTRO - 23 FEBBRAIO 2013 CORTE GHIOTTA DI VELEZZO LOMELLINA
 GUIDA NATURALISTICA La Lomellina, agricoltura e natura come conoscenza III INCONTRO - 23 FEBBRAIO 2013 CORTE GHIOTTA DI VELEZZO LOMELLINA GEOLOGIA DELLA LOMBARDIA E DELL AREA DELLA LOMELLINA IL SUOLO ED
GUIDA NATURALISTICA La Lomellina, agricoltura e natura come conoscenza III INCONTRO - 23 FEBBRAIO 2013 CORTE GHIOTTA DI VELEZZO LOMELLINA GEOLOGIA DELLA LOMBARDIA E DELL AREA DELLA LOMELLINA IL SUOLO ED
Relazione Geologica di Inquadramento
 Relazione Geologica di Inquadramento Saronno (VA) via Parma Foglio 21 Mappali 140-240-207-214 Committente: via Libertà, 80 - Settimo Milanese (MI) Redatto da: Alessandro Gambini Geologo Specialista Ordine
Relazione Geologica di Inquadramento Saronno (VA) via Parma Foglio 21 Mappali 140-240-207-214 Committente: via Libertà, 80 - Settimo Milanese (MI) Redatto da: Alessandro Gambini Geologo Specialista Ordine
Caratteristiche geomorfologiche
 Fig. 14 - Punto L: Tratto del Rio Fenils poco a valle della zona di testata del bacino. Nell angolo in alto a destra dell immagine è visibile una porzione delle imponenti falde detritiche che ricoprono
Fig. 14 - Punto L: Tratto del Rio Fenils poco a valle della zona di testata del bacino. Nell angolo in alto a destra dell immagine è visibile una porzione delle imponenti falde detritiche che ricoprono
CAPITOLO 7: Ambiente costiero
 CAPITOLO 7: Ambiente costiero 154 7.1: Difesa costiera Presentazione: L' ambiente costiero rappresenta un sistema naturale assai complesso e strettamente connesso alla rete fluviale retrostante che con
CAPITOLO 7: Ambiente costiero 154 7.1: Difesa costiera Presentazione: L' ambiente costiero rappresenta un sistema naturale assai complesso e strettamente connesso alla rete fluviale retrostante che con
Metodologia adottata per la definizione dei corpi idrici sotterranei in regione Lombardia
 Metodologia adottata per la definizione dei corpi idrici sotterranei in regione Lombardia Nell ambito dell aggiornamento sessennale del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, Regione
Metodologia adottata per la definizione dei corpi idrici sotterranei in regione Lombardia Nell ambito dell aggiornamento sessennale del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, Regione
Circolare n. Allegato A. - raccolta dati (A1a) - indagini. - eventuali nuove indagini (A1b) - cartografie di analisi (A1c)
 REPUBBLICA ITALIANA Assessorato Territorio ed Ambiente Circolare n. del Allegato A Elenco degli elaborati cartografici Cartografie Scala - raccolta dati (A1a) - indagini (A) Strumenti Urbanistici Generali
REPUBBLICA ITALIANA Assessorato Territorio ed Ambiente Circolare n. del Allegato A Elenco degli elaborati cartografici Cartografie Scala - raccolta dati (A1a) - indagini (A) Strumenti Urbanistici Generali
