Ī Ĭ Ē Ĕ Ā Ă Ŏ Ō Ŭ Ū. MĂLUS cattivo MĀLUS melo PŌPULUS pioppo PŎPULUS popolo VĔNIT viene VĒNIT venne
|
|
|
- Maddalena Santini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 Il sistema vocalico del latino classico comprendeva dieci fonemi vocalici; ciascuno dei cinque suoni vocalici, infatti, poteva essere distinto per lunghezza o brevità: Ī Ĭ Ē Ĕ Ā Ă Ŏ Ō Ŭ Ū La quantità vocalica incideva sulla posizione dell accento e soprattutto aveva valore fonologico: poteva cioè distinguere il significato delle parole. Alcune coppie minime del latino avevano come fonema distintivo la quantità vocalica: MĂLUS cattivo MĀLUS melo PŌPULUS pioppo PŎPULUS popolo VĔNIT viene VĒNIT venne Con il passare del tempo, tuttavia, nella gran parte dei territori latinizzati, che non conoscevano la quantità vocalica, si affermò la tendenza a realizzare le vocali lunghe con un timbro chiuso e le vocali brevi con un timbro aperto. Nella Romània si affermò così la qualità vocalica, cioè la differenza di timbro, in luogo della quantità. Per il vocalismo tonico, inoltre, si passò da un sistema di dieci vocali a uno di sette. In italiano esiste una differenza di realizzazione tra vocali lunghe e brevi: sono lunghe infatti le vocali toniche in sillaba aperta e non finale (fāto); sono brevi le vocali atone, le toniche in sillaba chiusa (fatto) e le finali. La quantità vocalica però non ha valore fonologico in italiano: fato e fatto, per esempio, sono distinte grazie alla lunghezza e alla brevità consonantica e non a quella vocalica. Nel latino classico esistevano anche tre dittonghi, AU, AE, OE, che potevano trovarsi sia in posizione tonica sia in posizione atona. Nel latino volgare ebbero esiti differenti: AU > Ō solo in parole come CAUDAM e FAUCEM che dalla Ō ebbero un esito in o chiusa: CAUDAM > /'coda/ FAUCEM > /'foce/ In epoca più tarda, nel secolo VIII d.c., il dittongo ebbe un esito in o aperta: AURUM > /'ɔro/ CAUSAM > /'cɔsa/ Il dittongo AE divenne una Ē di timbro aperto e quindi i suoi esiti coincisero con quelli della Ĕ, sviluppando una e aperta: MAESTUM > /'mɛsto/
2 2 Il dittongo OE divenne una Ē di timbro chiuso e quindi sviluppò una e chiusa: POENAM > /'pena/ I suoni vocalici in posizione atona si sono ridotti dalle dieci vocali del latino a cinque. In posizione atona, infatti, si annulla l opposizione tra aperte e chiuse delle vocali e e o. Questi sviluppi riguardano principalmente gli esiti del fiorentino; in altre aree si sono avute trasformazioni diverse. Riguardano inoltre le parole di cosiddetta tradizione popolare (dove pure non mancano eccezioni), mentre le parole di trafila dotta conservano spesso e in parte forme più vicine al latino (disco/desco; angustia/angoscia, ecc.; cfr. i testi sul lessico). Nel fiorentino il vocalismo tonico del latino volgare ha avuto alcuni sviluppi che si sono trasmessi all italiano. Il fenomeno più importante è quello del dittongamento toscano (detto anche dittongamento spontaneo), per cui le vocali e aperta (derivata da Ĕ o dal dittongo AE) e o aperta (derivata da Ŏ) toniche, quando si trovano in sillaba aperta (detta anche sillaba libera) danno luogo ai due dittonghi ascendenti /jɛ/ e /wɔ/: PĔDEM > /'pjɛde/ DĔCEM > /'djɛci/ BŎNUM > /'bwɔno/ FŎCUM > /'fwɔco/ Il dittongamento non si realizza Ø nei cultismi: decimo, rosa; Ø in alcuni proparossitoni (parole sdrucciole): pecora, opera (ma suocera, lievito); Ø in bene, lei, nove (per protonia sintattica ben detto, nove dita). Non si realizza nelle parole con o aperta derivata dal dittongo AU. Il dittongo AU, infatti, si è con molta probabilità chiuso nel secolo VIII, quando ormai il fenomeno del dittongamento si era concluso. Il dittongamento si realizza solo quando la vocale è tonica; accade pertanto che in alcune forme in cui c è spostamento dell accento dalla radice alla desinenza si ha il fenomeno del dittongo mobile: per esempio nelle voci verbali con accento sulla radice (rizotoniche) si può avere il dittongo, che scompare nelle voci con accento sulla desinenza (rizoatone): tiene ma teniamo, puoi ma potete (e posso con sillaba chiusa),
3 3 muovo ma movente, ecc. E anche nei nomi: piede ma pedata Si producono anche diverse eccezioni, per esempio quando le voci verbali si modellano per analogia sulle forme rizotoniche: chiedo e chiedeva Il dittongo mobile si registrava anche negli aggettivi e nei derivati alterati, ma nell italiano moderno è prevalsa, per analogia, l uniformità: buono buonissimo (e non bonissimo), nuovo nuovissimo (e non novissimo). Tra Quattro e Cinquecento, il dittongo si è ridotto dopo consonante occlusiva + r: pruova > prova brieve > breve Dopo suono palatale ha resistito ancora fino a metà Ottocento ma si è progressivamente ridotto: figliuolo > figliolo, giuoco > gioco, spagnuolo > spagnolo, ma ancora oggi abbiamo: aiuola. Il dittongamento toscano è una delle prove della coincidenza dell italiano con i tratti del fiorentino letterario trecentesco. Nelle altre aree dialettali della penisola italiana il dittongo non è uniformemente presente: in alcuni casi questi dittonghi non sono presenti, in altri hanno timbro diverso e si producono in contesti fonetici differenti. Nel fiorentino di uso vivo, tra l altro, il dittongo /wɔ/ ha nuovamente monottongato. L italiano dunque non può che aver derivato questo fenomeno dal fiorentino due- trecentesco. Che l italiano si fondi sul fiorentino letterario del Trecento è provato anche da altri fenomeni come l anafonesi, la chiusura della e protonica in i, il passaggio di ar atono a er e il passaggio del nesso - rj- intervocalico a - j-. L anafonesi consiste nell innalzamento di un grado di chiusura delle vocali e chiusa e o chiusa che passano rispettivamente a i e u quando si trovano in alcuni contesti fonetici.
4 4 Dalla e chiusa si ha i davanti a laterale palatale e a nasale palatale: /e/ + /λ/ > /i/ /e/ + /ɲ/ > /i/ Negli esempi che seguono, secondo lo sviluppo del vocalismo tonico del latino volgare dalla Ĭ breve latina avremmo dovuto avere /e/, ma per il fenomeno dell anafonesi abbiamo esiti diversi: GRAMĬNEAM > gramégna > gramigna CONSĬLIUM > conséglio > consiglio FAMĬLIAM > faméglia > famiglia La e chiusa e la o chiusa si chiudono rispettivamente in /i/ e /u/ davanti a nasale seguita da velare sorda o sonora: /e/ + /n/ + /K/ o /g/ > i /o/ + /n/ + /k/ o /g/ > u VĬNCO > vénco > vinco LĬNGUAM > léngua > lingua FŬNGUM > fóngo > fungo ŬNGULAM > ónghia > unghia La chiusura della e protonica in i consiste nella chiusura in /i/ della /e/ atona che precede l accento: DĔCEMBREM > dicembre MĔLIOREM > migliore SĔNIOREM > signore MĬNOREM > minore Il fenomeno si verifica anche in fonosintassi: DĒ ROMA > di Roma Si ha livellamento tra le forme rizotoniche e rizoatone dei verbi: PĒ(N)SAT > pésa PĒ(N)SABAT > pesàva VĬDET > véde VĬDEBAT > vedéva
5 5 Il passaggio di ar atono a er si realizza in posizione intertonica: MARGARITAM > margherita, postonica: CAMBARUM > gambero, protonica: AMARE HABEO > AMAR(E) *(A)O > amarò > amerò AMARE *EBUI > AMAR(E) * > EI > amarei > amerei La riduzione del nesso - rj- a - j- si verifica in posizione intervocalica: AREA(M) > aja (aria è un esito dotto) CORIU(M) > cuojo NOTARIU(M) > notajo In altre aree della penisola si è avuto in vece l esito contrario: /rj/ > /r/. Il suffisso aro è più tipico delle voci di provenienza meridionale, come notaro, benzinaro, paninaro. Alcune sono arrivate all italiano, come calamaro che ha finito non l opporsi per differenziazione semantica a calamaio. Molte altre sono le coincidenze tra fiorentino e italiano, ma questi cinque tratti hanno avuto esiti diversi nelle diverse aree geografiche della penisola e molti di loro hanno subito ulteriori variazioni nel fiorentino quattro- cinqucentesco.
6 6 CHIUSURA VOCALI TONICHE IN IATO ĔGO > ɛo > io MEUM > mio DEUM > dio TŬAM > toa > tua ma non si produce se la vocale è in iato con i MĔI > mɛi > mjɛi BŎVES > bɔi > bwɔi Latinismi / cultismi restano intatti ANDREAS, DEAM ALTRI FENOMENI DEL VOCALISMO ATONO LABIALIZZAZIONE DELLA VOCALE PROTONICA DĒBERE > dovere DĒMANDARE > domandare *SĬMILIARE > somigliare (e, i vocali aprocheile o, u vocali procheile)
7 7 ASSIMILAZIONE CONSONANTICA REGRESSIVA In un nesso consonantico il secondo dei due elementi assimila l'altro, eliminandone i tratti differenti e trasformando i due suoni diversi in un'unica consonante lunga SEPTE(M) > sette NOCTE(M) > notte SCRIPSI > scrissi DAMNU(M) > danno FIXARE > fissare per [KS] > [ss] ma anche [KS] > [ʃʃ] COXA > coscia LAXARE > lasciare ASSIMILAZIONE CONSONANTICA PROGRESSIVA Nel nesso consonantico è il primo elemento ad assimilare il secondo Non esiste in italiano ma in alcuni dialetti QUANDO > quannɣ PLUMBUM > kiummɣ
8 8 CADUTA DELLE CONSONANTI FINALI Cadono le tre consonanti che più frequentemente si trovavano in posizione finale (- M, - T, - S) LACTE(M) > latte AMABA(T) > amava VALLES > valli La s finale tuttavia ha resistito più a lungo e prima di cadere ha prodotto delle trasformazioni Si è palatalizzata (è passata a vocale palatale) in alcuni monosillabi: VOS > voi NOS > noi Ha palatalizzato la vocale che la precedeva: ANCILLAS > ancelle CAPRAS > capre Si è assimilata alla consonante iniziale della parola seguente producendo raddoppiamento fonosintattico TRES CANES > tre ccani
9 9 RADDOPPIAMENTO FONOSINTATTICO Nel continuum fonico del parlato, talvolta una parola che termina per vocale allunga la consonante della parola che segue. La grafia non registra il fenomeno, tranne che in alcuni casi di parole univerbate, come soprattutto, appena, chicchessia, ecc. Il raddoppiamento si verifica nei seguenti casi: dopo una parola che termini per vocale accentata: comprò tutto; non posso né voglio; andò via; perché tu e non lui; dopo monosillabi forti come re, gru, tre, dì; dopo bisillabi piani come dove, sopra, qualche, come; dopo le forme seguenti: a, da, fra, tra, su, che, chi, se (congiunzione), e, o, ma. Si spiega storicamente come un caso di assimilazione regressiva: TRES CANES > tre ccani AD VENIRE > avvenire TERRA ET MARE > terra e mmare PLUS PANEM > più ppane
10 10 OCCLUSIVA VELARE + VOCALE PALATALE Nel latino classico e ancora fino al V sec. d.c. le velari sorda [k] e sonora [g] avevano una sola resa fonetica davanti a tutte le vocali: COR, CAESAR, CURA, CICERO, CENTUM GALLI, GELUM, GYRUS Nel latino tardo, davanti alle vocali palatali e, i, le occlusive velari si sono palatalizzate, passando ad affricate palatali sorda [ʧ] e sonora [dʒ]: GELUM > gelo CAENAM > cena GYRUM > giro CIBUM > cibo Talvolta, in posizione intervocalica, la velare sonora si è allungata o si è dileguata: LEGIT > legge SAGITTAM > saetta
11 11 J SEMIVOCALICA (IOD) IN POSIZIONE INIZIALE J > /dʒ/ in posizione iniziale: IŬVENE(M) > giovane IUSTU(M) > giusto J > /ddʒ/ in posizione intervocalica: MAIORE(M) > maggiore MAIU(M) > maggio ESITI DELL'OCCLUSIVA BILABIALE SONORA Si conserva in posizione iniziale: BASIU(M) > bacio BALSAMU(M) > balsamo Si spirantizza (passa a fricativa v) in posizione intervocalica: HABERE > avere DEBERE > dovere FABULA(M) > favola Se in posizione intervocalica è seguita da r, si allunga: FABRU(M) > fabbro FEBRE(M) > febbre
12 12 ESITI DELLA LABIOVELARE Le occlusive velari sorda [k] e sonora [g] seguite dalla semivocale [w] producono il suono labiovelare sordo o sonoro (le labbra sono spinte in avanti): quadro, quando, guardia, guanto. In latino la labiovelare sorda si trovava sia in posizione iniziale sia all'interno di parola: QUALIS, AQUAM. La labiovelare sonora poteva trovarsi solo all'interno di parola: ANGUILLAM. Le parole italiane che iniziano con una labiovelare sonora sono di origine germanica (con l'eccezione di guado e guaina): guerra, guida, ecc. La labiovelare sorda del latino (primaria), se seguita dalla vocale A, in posizione iniziale si conserva: QUALE(M) > quale QUANTU(M) > quanto QUANDO > quando In posizione intervocalica si allunga: AQUA(M) > acqua Se è seguita da vocale diversa da A, perde l'elemento labiovelare e passa a occlusiva velare: QUĬD > che QUOMO(DO) + ET > come QUAERERE > chiedere La labiovelare che si è prodotta nel passaggio dal latino volgare all'italiano (secondaria) si conserva sempre, indipendentemente dalla vocale che segue: (EC)CU(M) + ĬSTU(M) > questo (EC)CU(M) + ĬLLU(M) > quello La labiovelare sonora del latino, all'interno della parola, si conserva sempre: lingua, anguilla.
13 13 CONSERVAZIONE O SONORIZZAZIONE DELLE CONSONANTI SORDE IN POSIZIONE INTERVOCALICA Alcune consonanti sorde del latino rimangono inalterate nel passaggio dal latino all'italiano, altre si sonorizzano, dando origine a una doppia serie: CAPUT > capo LUPU(M) > lupo PRATU(M) > prato - RŎTA(M) > ruota AMICU(M) > amico - FŎCU(M) > fuoco ME(N)SE(M) > ['mese] NASU(M) > ['naso] RIPA(M) > riva PAUPERU(M) > povero (con successiva spirantizzazione) STRATA(M) > strada LITU(S) > lido LACU(M) > lago LŎCU(M) > luogo PARADISU(M) > [para'dizo] ECCLESIA(M) > ['kjeza]
14 14 In posizione intervocalica: NESSI DI CONSONANTE + SEMIVOCALE (IOD) allungamento della consonante: SEPIA(M) > seppja SIMIA(M) > scimmja FACIA(T) > faccia (in questo caso la j che seguiva la palatale si è dileguata) RABIA(M) > rabbja REGIA(M) > reggia (in questo caso la j che seguiva la palatale si è dileguata) HABEA(T) > (*abia) > abbja (preceduto dalla chiusura della vocale in iato) Allungamento della consonante seguito da palatalizzazione (con nasale e laterale): VINEA(M) > (*vinja > *vinnja) > vigna FOLIU(M) > (*folljo) > foglio FILIU(M) > (*filljo) > figlio Per la cronologia relativa del fenomeno, in VINEA(M) è evidente che la chiusura della vocale in iato deve essersi prodotta prima che si verificasse il raddoppiamento. Allungamento della consonante seguito da assibilazione (con dentale): PUTEU(M) > (*potjo) > pozzo VĬTIU(M) > vezzo MEDIU(M) > mezzo RADIU(M) > razzo DOPPIO ESITO DI NESSI CONSONANTICI CON IOD DJ > /ddz/ /ddʒ/ MEDIU(M) > mezzo RADIU(M) > razzo RADIU(M) > raggio HODIE > oggi ma in posizione iniziale : DIURNU(M) > giorno
15 15 TJ > /ttz/ /dʒ/ PUTEU(M) > pozzo VITIU(M) > vezzo PRETIU(M) > prezzo PRETIU(M) > pregio STATIONE(M) > stagione (esito dotto stazione) SJ > /ʧ/ /dʒ/ BASIU(M) > bacio CASEU(M) > (*casio) > cacio (preceduta da chiusura in iato) (OC)CASIONE(M) > cagione PE(N)SIONE(M) > pigione In posizione postconsonantica: FORTIA(M) > forza PRANDIU(M) > pranzo HORDEU(M) > orzo NUPTIA(S) > nozze CAPTIARE > cacciare *CUMIN(I)TIARE > cominciare ESITO DI RJ INTERVOCALICO: AREA(M) > aja (aria esito dotto) CORIU(M) > cuojo NOTARIU(M) > notajo
16 16 In posizione iniziale: CLAMAT > kjama FLOREM > fjore blank > bjanco PLACET > pjace In posizione intervocalica: OC(U)LU(M) > okkjo FIB(U)LA(M) > fibbja CAP(U)LU(M) > cappjo NESSI DI CONSONANTE + LATERALE Il raddoppiamento è stato successivo alla formazione della semivocale iod (OCLU > *okjo > okkjo). TL intervocalico per caduta della vocale intertonica passa a - CL- : VET(U)LU(M) > VECLU(M) > vekkjo FIST(U)LARE > fiskjare SL era un nesso sconosciuto in latino; si interpone una velare (SCL) per favorirne la pronuncia: SLAVU(M) > SCLAVU(M) > skjavo I(N)S(U)LA(M) > ISCLA > iskja
17 17 TRAFILA DOTTA (CULTISMI) E TRAFILA POPOLARE È determinata dal mutamento fonetico e non da quello semantico CABALLU(M) > cavallo - trafila popolare ma equino, equestre (dalla base EQUUM) trafila dotta AURU(M) > oro OCULU(M) > occhio ma aureo, oculare, oculista ALLOTROPI Dalla stessa base latina due forme, una dotta e una popolare, con diversificazione semantica ANGŬSTIA(M) > angustia angoscia
18 18
Ī Ĭ Ē Ĕ Ā Ă Ŏ Ō Ŭ Ū. MĂLUS cattivo MĀLUS melo PŌPULUS pioppo PŎPULUS popolo VĔNIT viene VĒNIT venne
 Il sistema vocalico del latino classico comprendeva dieci fonemi vocalici; ciascuno dei cinque suoni vocalici, infatti, poteva essere distinto per lunghezza o brevità: Ī Ĭ Ē Ĕ Ā Ă Ŏ Ō Ŭ Ū La quantità vocalica
Il sistema vocalico del latino classico comprendeva dieci fonemi vocalici; ciascuno dei cinque suoni vocalici, infatti, poteva essere distinto per lunghezza o brevità: Ī Ĭ Ē Ĕ Ā Ă Ŏ Ō Ŭ Ū La quantità vocalica
VOCALISMO ATONO. N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione pdf». Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū
 N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione 07.03.2012.pdf». VOCALISMO ATONO Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū ITALO-ROMANZO (toscano+ area perimediana, ligure, veneto centrale
N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione 07.03.2012.pdf». VOCALISMO ATONO Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū ITALO-ROMANZO (toscano+ area perimediana, ligure, veneto centrale
Consonantismo dal latino all italiano (4)
 Consonantismo dal latino all italiano (4) Sonorizzazione delle sorde intervocal. (o tra voc. e /r/) e di S Nell italiano di oggi in alcuni casi abbiamo la sonora, in altri la sorda: (H)OSPITALE(M) > ospedale
Consonantismo dal latino all italiano (4) Sonorizzazione delle sorde intervocal. (o tra voc. e /r/) e di S Nell italiano di oggi in alcuni casi abbiamo la sonora, in altri la sorda: (H)OSPITALE(M) > ospedale
INDICE. Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12. 1.1. Oggetto di studio 12. 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13
 INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
Dal latino all italiano (1)
 Dal latino all italiano (1) L italiano deriva dal latino è un affermazione solo parzialmente corretta a) deriva continua b) quale latino? 1) variabile diacronica 2) variabile diatopica LATINO (volgare)
Dal latino all italiano (1) L italiano deriva dal latino è un affermazione solo parzialmente corretta a) deriva continua b) quale latino? 1) variabile diacronica 2) variabile diatopica LATINO (volgare)
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA
 STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
4) Con la fine dell Impero romano (476 d.c.) il latino fu sostituito dalle lingue romanze negli atti ufficiali e nel parlato.
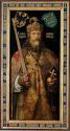 1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE
 INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
L italiano regionale. Lezione del 13 novembre 2014
 L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
LE AREE DELL ITALIA DIALE L TT T A T LE
 LE AREE DELL ITALIA DIALETTALE I dialetti italiani o italoromanzi (secondo G. Battista Pellegrini) sono quelli parlati nei territori in cui la lingua guida [o lingua tetto] è l italiano. Dunque, per esempio,
LE AREE DELL ITALIA DIALETTALE I dialetti italiani o italoromanzi (secondo G. Battista Pellegrini) sono quelli parlati nei territori in cui la lingua guida [o lingua tetto] è l italiano. Dunque, per esempio,
LA FONETICA. Lezione del 2 ottobre 2014
 LA FONETICA Lezione del 2 ottobre 2014 La fonetica è la scienza che studia i suoni del linguaggio Va fatta una distinzione preliminare tra Foni= qualsiasi suono di una lingua. Fonemi (quelli che ci interessano
LA FONETICA Lezione del 2 ottobre 2014 La fonetica è la scienza che studia i suoni del linguaggio Va fatta una distinzione preliminare tra Foni= qualsiasi suono di una lingua. Fonemi (quelli che ci interessano
Il romanesco antico (o di prima fase)
 La parlata romana Il romanesco antico (o di prima fase) Prime testimonianze letterarie Nel Duecento: Storie de Troja et de Roma Miracole de Roma Nel Trecento: Cronica di Anonimo romano (preced. Vita di
La parlata romana Il romanesco antico (o di prima fase) Prime testimonianze letterarie Nel Duecento: Storie de Troja et de Roma Miracole de Roma Nel Trecento: Cronica di Anonimo romano (preced. Vita di
Università degli Studi Guglielmo Marconi
 Alfabeto fonetico Fonetica. Parlato e scritto L alfabeto fonetico Si basa sulla corrispondenza tra grafema e fono: una sola lettera per un solo suono e, viceversa, un solo suono cui corrisponde una sola
Alfabeto fonetico Fonetica. Parlato e scritto L alfabeto fonetico Si basa sulla corrispondenza tra grafema e fono: una sola lettera per un solo suono e, viceversa, un solo suono cui corrisponde una sola
RIEPILOGO GRAMMATICA STORICA PER FREQUENTANTI a.a. 2012/2013
 RIEPILOGO GRAMMATICA STORICA PER FREQUENTANTI a.a. 2012/2013 Manuale di riferimento: Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 2005 Le domande d esame verteranno sugli argomenti
RIEPILOGO GRAMMATICA STORICA PER FREQUENTANTI a.a. 2012/2013 Manuale di riferimento: Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 2005 Le domande d esame verteranno sugli argomenti
Fonetica. Le consonanti
 Fonetica Le consonanti Consonanti Le consonanti sono articolate producendo restringimenti o occlusioni del canale orale L aria che fuoriesce dai polmoni viene modificata dal restringimento del canale che
Fonetica Le consonanti Consonanti Le consonanti sono articolate producendo restringimenti o occlusioni del canale orale L aria che fuoriesce dai polmoni viene modificata dal restringimento del canale che
Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) Giuliano Cianfrocca 2014
 * Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) 01 Concorrenza tra greco e latino L Impero romano, a partire dal I secolo d.c., si presenta come sostanzialmente bilingue, almeno
* Brevi note di filologia romanza (per gli studenti del 1 Liceo Classico) 01 Concorrenza tra greco e latino L Impero romano, a partire dal I secolo d.c., si presenta come sostanzialmente bilingue, almeno
vocali latine esito dialettale
 vocali latine esito dialettale e velari e presentano quattro gradi di apertura. La differenza di apertura e chiusura delle vocali medie appare più evidente attraverso le cosiddette coppie minime, parole
vocali latine esito dialettale e velari e presentano quattro gradi di apertura. La differenza di apertura e chiusura delle vocali medie appare più evidente attraverso le cosiddette coppie minime, parole
II origine e sviluppo delle lingue romanze. Fonetica (cenni)
 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA a.a. 2015-2016 (LM 37) PROF. AGGREGATO BEATRICE FEDI II origine e sviluppo delle lingue romanze. Fonetica (cenni) 1 TRIANGOLO VOCALICO DELL ITALIANO i u e o ε ɔ a 2 VOCALI
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA a.a. 2015-2016 (LM 37) PROF. AGGREGATO BEATRICE FEDI II origine e sviluppo delle lingue romanze. Fonetica (cenni) 1 TRIANGOLO VOCALICO DELL ITALIANO i u e o ε ɔ a 2 VOCALI
La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico
 La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico Presentazioni di Max Pfister e Patrick Sauzet von Michela Russo 1. Auflage La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico
La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico Presentazioni di Max Pfister e Patrick Sauzet von Michela Russo 1. Auflage La metafonia napoletana: evoluzione e funzionamento sincronico
L apparato di fonazione
 L apparato di fonazione Un suono è prodotto dall aria che attraversa i seguenti organi: la gabbia toracica; la laringe; la cavità faringale; la cavità nasale; la cavità orale. L apparato di fonazione A
L apparato di fonazione Un suono è prodotto dall aria che attraversa i seguenti organi: la gabbia toracica; la laringe; la cavità faringale; la cavità nasale; la cavità orale. L apparato di fonazione A
PARTE PRIMA - FONETICA
 Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
4. I suoni linguistici
 1) La fonetica Nel campo della produzione dei suoni è necessario anzitutto distinguere tra: suoni: si tratta di fatti fisici che hanno la capacità di produrre una moltitudine di forme e fenomeni linguistici
1) La fonetica Nel campo della produzione dei suoni è necessario anzitutto distinguere tra: suoni: si tratta di fatti fisici che hanno la capacità di produrre una moltitudine di forme e fenomeni linguistici
Lezione 6 29 ottobre. Mutamenti fonetici
 Lezione 6 29 ottobre Mutamenti fonetici I mutamenti fonetici regolari : gli esiti italiani delle vocali latine Le vocali latine possono essere lunghe o brevi. La norma generale è che le vocali lunghe sono
Lezione 6 29 ottobre Mutamenti fonetici I mutamenti fonetici regolari : gli esiti italiani delle vocali latine Le vocali latine possono essere lunghe o brevi. La norma generale è che le vocali lunghe sono
PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE
 PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE 26. DIURNUS *DJURNU- > GIÓRNO JUORNO di Carlo Iandolo In fiorentino-italiano il monofonema del latino volgare *dj + vocale (eco collaterale del bisillabo classico di + vocale
PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE 26. DIURNUS *DJURNU- > GIÓRNO JUORNO di Carlo Iandolo In fiorentino-italiano il monofonema del latino volgare *dj + vocale (eco collaterale del bisillabo classico di + vocale
BFLR A Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA. edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto
 BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
APPUNTI DI LINGUISTICA GERMANICA a.a
 APPUNTI DI LINGUISTICA GERMANICA a.a. 2016-17 VOCALISMO IN SILLABA TONICA Triangolo vocalico indoeuropeo: vocali brevi vocali lunghe i u ī ū e o ē ō a ā Triangolo vocalico germanico (II-I sec. a.c.): vocali
APPUNTI DI LINGUISTICA GERMANICA a.a. 2016-17 VOCALISMO IN SILLABA TONICA Triangolo vocalico indoeuropeo: vocali brevi vocali lunghe i u ī ū e o ē ō a ā Triangolo vocalico germanico (II-I sec. a.c.): vocali
La fonetica studia le unità di prima o seconda articolazione?
 Proprietà dei codici verbali:andrè Martinet (Saint-Alban-des-Villards, 12 aprile 1908 Châtenay-Malabry, 16 luglio 1999) La fonetica studia le unità di prima o seconda articolazione? Doppia articolazione
Proprietà dei codici verbali:andrè Martinet (Saint-Alban-des-Villards, 12 aprile 1908 Châtenay-Malabry, 16 luglio 1999) La fonetica studia le unità di prima o seconda articolazione? Doppia articolazione
inalterata dall antico al medio inglese. Solo æ > a ags cræft > ingl. med. craft y [u metafonizzata: /y/] > i ags brycge > ingl. med. brigge.
![inalterata dall antico al medio inglese. Solo æ > a ags cræft > ingl. med. craft y [u metafonizzata: /y/] > i ags brycge > ingl. med. brigge. inalterata dall antico al medio inglese. Solo æ > a ags cræft > ingl. med. craft y [u metafonizzata: /y/] > i ags brycge > ingl. med. brigge.](/thumbs/48/24280118.jpg) Great Vowel Shift Cenni essenziali Riepilogo del sistema delle vocali nello sviluppo dell inglese medio La maggior parte delle vocali brevi toniche passa inalterata dall antico al medio inglese. Solo æ
Great Vowel Shift Cenni essenziali Riepilogo del sistema delle vocali nello sviluppo dell inglese medio La maggior parte delle vocali brevi toniche passa inalterata dall antico al medio inglese. Solo æ
13- Metafonia e Mutazione Vocalica Pretonica nella prima coniugazione dei verbi
 A Lenga Turrese La Grammatica 13- Metafonia e Mutazione Vocalica Pretonica nella prima coniugazione dei verbi Salvatore Argenziano METAFONIA 1 e MUTAZIONE VOCALICA, nella coniugazione dei verbi Nel dialetto
A Lenga Turrese La Grammatica 13- Metafonia e Mutazione Vocalica Pretonica nella prima coniugazione dei verbi Salvatore Argenziano METAFONIA 1 e MUTAZIONE VOCALICA, nella coniugazione dei verbi Nel dialetto
1 S t u d i o l e g a l e T e d i o l i v i a F r a t t i n i, M a n t o v a s t u d i o t e d i o l l i b e r o.
 D. L g s. 2 7-0 5-1 9 9 9, n. 1 6 5 S o p p r e s s i o n e d e l l ' A I M A e i s t i t u z i o n e d e l l ' A g e n z i a p e r l e e r o g a z i o n i i n a g r i c o l t u r a ( A G E A ), a n o
D. L g s. 2 7-0 5-1 9 9 9, n. 1 6 5 S o p p r e s s i o n e d e l l ' A I M A e i s t i t u z i o n e d e l l ' A g e n z i a p e r l e e r o g a z i o n i i n a g r i c o l t u r a ( A G E A ), a n o
T R I B U N A L E D I T R E V I S O B A N D O P E R L A C E S S I O N E C O M P E T I T I V A D E L C O M P E N D I O A Z I E N D A L E D E L L E
 1 T R I B U N A L E D I T R E V I S O B A N D O P E R L A C E S S I O N E C O M P E T I T I V A D E L C O M P E N D I O A Z I E N D A L E D E L L E O F F I C I N E M E C C A N I C H E D I P O N Z A N O
1 T R I B U N A L E D I T R E V I S O B A N D O P E R L A C E S S I O N E C O M P E T I T I V A D E L C O M P E N D I O A Z I E N D A L E D E L L E O F F I C I N E M E C C A N I C H E D I P O N Z A N O
C O M U N E D I P O L I C O R O S T A T U T O D E L I B E R A N. 2 3 D E L 2 8 / 0 6 /
 C O M U N E D I P O L I C O R O S T A T U T O D E L I B E R A N. 2 3 D E L 2 8 / 0 6 / 2 0 0 2 A r t. 1 L a C o m u n i t à 1. L o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o d e l C o m u n e è l e s p r e
C O M U N E D I P O L I C O R O S T A T U T O D E L I B E R A N. 2 3 D E L 2 8 / 0 6 / 2 0 0 2 A r t. 1 L a C o m u n i t à 1. L o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o d e l C o m u n e è l e s p r e
Esercizi di fonetica e fonologia (SOLUZIONI IN FONDO)
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di fonetica e fonologia (SOLUZIONI IN FONDO)
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2013 / 2014 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di fonetica e fonologia (SOLUZIONI IN FONDO)
3) Quale di questi nomi propri non contiene un dittongo? a) Paolo b) Pietro c) Mauro d) Chiara
 1) La fonologia: a) studia i suoni in quanto entità concrete fisico-acustiche b) è sinonimo di fonetica c) ha per unità minime i fonemi d) prescinde dalle relazioni tra i suoni in una determinata lingua
1) La fonologia: a) studia i suoni in quanto entità concrete fisico-acustiche b) è sinonimo di fonetica c) ha per unità minime i fonemi d) prescinde dalle relazioni tra i suoni in una determinata lingua
I suoni linguistici. App Generation Writers. I. C. San Francesco. Anguillara Sabazia - RM. Nicola Napolitano. Laboratorio di Scrittura creativa
 Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo I suoni linguistici App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM I fonemi L uomo, utilizzando il suo apparato
Laboratorio di Scrittura creativa Il Testo narrativo I suoni linguistici App Generation Writers I. C. San Francesco Nicola Napolitano Anguillara Sabazia - RM I fonemi L uomo, utilizzando il suo apparato
Dittongamento toscano e metafonesi nelle vocali TONICHE
 Dittongamento toscano e metafonesi nelle vocali TONICHE Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū i e ɛ a ɔ o u Dittongamento toscano (posizione incondizionata) /jɛ/ /wɔ/ Metafonesi a dittongazione (con #-U e con #- I) Metafonesi
Dittongamento toscano e metafonesi nelle vocali TONICHE Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū i e ɛ a ɔ o u Dittongamento toscano (posizione incondizionata) /jɛ/ /wɔ/ Metafonesi a dittongazione (con #-U e con #- I) Metafonesi
I suoni del sanscrito: alfabeto in trascrizione e pronuncia delle parole. Giulio Geymonat website:
 I suoni del sanscrito: alfabeto in trascrizione e pronuncia delle parole Giulio Geymonat website: www.sanscrito.it 1 www.sanscrito.it 2 La trascrizione È possibile rappresentare i suoni del sanscrito (i.e.
I suoni del sanscrito: alfabeto in trascrizione e pronuncia delle parole Giulio Geymonat website: www.sanscrito.it 1 www.sanscrito.it 2 La trascrizione È possibile rappresentare i suoni del sanscrito (i.e.
PRELIMINARI FONETICI (Serianni, pp. 15-26)
 PRELIMINARI FONETICI (Serianni, pp. 15-26) GRAFEMA:la più piccola unità distintiva del sistema di scrittura di una lingua (segno grafico, lettera dell'alfabeto, che rappresenta un fonema) Rappresentazione
PRELIMINARI FONETICI (Serianni, pp. 15-26) GRAFEMA:la più piccola unità distintiva del sistema di scrittura di una lingua (segno grafico, lettera dell'alfabeto, che rappresenta un fonema) Rappresentazione
Esercizi di fonetica e fonologia (SOLUZIONI IN FONDO)
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di fonetica e fonologia (SOLUZIONI IN FONDO)
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) Esercizi di fonetica e fonologia (SOLUZIONI IN FONDO)
Fonologia e ortografia
 Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL CAPITOLO 3
 Linguistica generale, 2e Giovanni Gobber, Moreno Morani Copyright 2014 McGraw Hill Education (Italy) RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL CAPITOLO 3 3.1. Come si distinguono i tre modi di analisi del suono in fonetica?
Linguistica generale, 2e Giovanni Gobber, Moreno Morani Copyright 2014 McGraw Hill Education (Italy) RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL CAPITOLO 3 3.1. Come si distinguono i tre modi di analisi del suono in fonetica?
( 4 ) I l C o n s i g l i o e u r o p e o r i u n i t o s i a T a m p e r e i l 1 5 e 1 6 o t t o b r e h a i n v i t a t o i l C o n s i g l
 R e g o l a m e n t o ( C E ) n. 4 / 2 0 0 9 d e l C o n s i g l i o, d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 0 8, r e l a t i v o a l l a c o m p e t e n z a, a l l a l e g g e a p p l i c a b i l e, a l r i c
R e g o l a m e n t o ( C E ) n. 4 / 2 0 0 9 d e l C o n s i g l i o, d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 0 8, r e l a t i v o a l l a c o m p e t e n z a, a l l a l e g g e a p p l i c a b i l e, a l r i c
RIASSUNTO DI I SUONI DELLE LINGUE I SUONI DELL ITALIANO P. MATURI
 RIASSUNTO DI I SUONI DELLE LINGUE I SUONI DELL ITALIANO P. MATURI INTRODUZIONE 1. LINGUISTICA E SCIENZE FONICHE Le lingue umane sono complessi sistemi di segni, cioé elementi dotati di un significante
RIASSUNTO DI I SUONI DELLE LINGUE I SUONI DELL ITALIANO P. MATURI INTRODUZIONE 1. LINGUISTICA E SCIENZE FONICHE Le lingue umane sono complessi sistemi di segni, cioé elementi dotati di un significante
(L-LIN/01-Glottologia e Linguistica) Linguistica generale 1a. a.a Anna Pompei
 (L-LIN/01-Glottologia e Linguistica) Linguistica generale 1a a.a. 2013-2014 Anna Pompei FONETICA vs. FONOLOGIA Fonetica Disciplina della linguistica che studia gli aspetti fisici inerenti alla produzione
(L-LIN/01-Glottologia e Linguistica) Linguistica generale 1a a.a. 2013-2014 Anna Pompei FONETICA vs. FONOLOGIA Fonetica Disciplina della linguistica che studia gli aspetti fisici inerenti alla produzione
W I L L I A M S H A K E S P E A R E G I U L I O C E S A R E. T r a g e d i a i n 5 a t t i
 W I L L I A M S H A K E S P E A R E G I U L I O C E S A R E T r a g e d i a i n 5 a t t i T r a d u z i o n e e n o t e d i G o f f r e d o R a p o n i T i t o l o o r i g i n a l e : J U L I U S C A E
W I L L I A M S H A K E S P E A R E G I U L I O C E S A R E T r a g e d i a i n 5 a t t i T r a d u z i o n e e n o t e d i G o f f r e d o R a p o n i T i t o l o o r i g i n a l e : J U L I U S C A E
Fonemi, coppie minime. Fonologia. Allofoni. Tratti distintivi
 Fonemi, coppie minime Fonologia Fonemi: segmenti minimi con valore distintivo (distinguono coppie di parole). Coppie minime: parole che differiscono solo per un fonema: mano, nano; sono, sogno /soio/;
Fonemi, coppie minime Fonologia Fonemi: segmenti minimi con valore distintivo (distinguono coppie di parole). Coppie minime: parole che differiscono solo per un fonema: mano, nano; sono, sogno /soio/;
Terza proprietà semiotica fondamentale: la articolatezza del significante
 Terza proprietà semiotica fondamentale: la articolatezza del significante Segni a s.te non articolato e segni a s.te articolato 1. Esempio di codice con segni a s.te non articolato: il codice semaforico
Terza proprietà semiotica fondamentale: la articolatezza del significante Segni a s.te non articolato e segni a s.te articolato 1. Esempio di codice con segni a s.te non articolato: il codice semaforico
La fonetica è la scienza che studia i suoni (o foni) sia nella produzione del parlante sia nella ricezione dell ascoltatore.
 1 FONETICA DELL ITALIANO La fonetica è la scienza che studia i suoni (o foni) sia nella produzione del parlante sia nella ricezione dell ascoltatore. I suoni sono prodotti tramite l apparato fonatorio,
1 FONETICA DELL ITALIANO La fonetica è la scienza che studia i suoni (o foni) sia nella produzione del parlante sia nella ricezione dell ascoltatore. I suoni sono prodotti tramite l apparato fonatorio,
Caratteri principali della fonologia del tedesco antico. Fenomeni di fonetica combinatoria nel vocalismo in sillaba tonica
 Caratteri principali della fonologia del tedesco antico Fenomeni di fonetica combinatoria nel vocalismo in sillaba tonica Si tratta di una serie di sviluppi del vocalismo in sillaba tonica, dovuti sostanzialmente
Caratteri principali della fonologia del tedesco antico Fenomeni di fonetica combinatoria nel vocalismo in sillaba tonica Si tratta di una serie di sviluppi del vocalismo in sillaba tonica, dovuti sostanzialmente
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N. Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato.
 DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
PROGRAMMA DI GRECO. ANNO SCOLASTICO
 GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
Ma come si realizzano i suoni?
 I SUONI E LE LETTERE Ognuno di noi, quando parla, emette dei suoni Parlare significa produrre suoni che formano le parole, cioè la base di ogni messaggio Ma come si realizzano i suoni? È un fenomeno nello
I SUONI E LE LETTERE Ognuno di noi, quando parla, emette dei suoni Parlare significa produrre suoni che formano le parole, cioè la base di ogni messaggio Ma come si realizzano i suoni? È un fenomeno nello
1 S t u d i o l e g a l e T e d i o l i v i a F r a t t i n i, M a n t o v a m a i t e d i o l i. c o m
 C o n v e n z i o n e d e l l A j a 2 5-1 0-1 9 8 0 C o n v e n z i o n e s u g l i a s p e t t i c i v i l i d e l l a s o t t r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i m i n o r i P r e a m b o l
C o n v e n z i o n e d e l l A j a 2 5-1 0-1 9 8 0 C o n v e n z i o n e s u g l i a s p e t t i c i v i l i d e l l a s o t t r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i m i n o r i P r e a m b o l
1 S t u d i o l e g a l e T e d i o l i v i a F r a t t i n i, M a n t o v a m a i t e d i o l i. c o m
 C o n v e n z i o n e E u r o p e a d e l L u s s e m b u r g o, 2 0-0 5-1 9 8 0. C o n v e n z i o n e e u r o p e a s u l r i c o n o s c i m e n t o e l ' e s e c u z i o n e d e l l e d e c i s i o
C o n v e n z i o n e E u r o p e a d e l L u s s e m b u r g o, 2 0-0 5-1 9 8 0. C o n v e n z i o n e e u r o p e a s u l r i c o n o s c i m e n t o e l ' e s e c u z i o n e d e l l e d e c i s i o
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I F O N D A M E N T A L I 3
 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I F O N D A M E N T A L I 3 Introduzione 2 L apparato fonatorio è in grado di produrre una quantità enorme di suoni Ma solo pochi fanno parte
G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio N O Z I O N I F O N D A M E N T A L I 3 Introduzione 2 L apparato fonatorio è in grado di produrre una quantità enorme di suoni Ma solo pochi fanno parte
Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI
 Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI 1.1. Fonetica e fonologia 17 1.1.1. fonetica e fonologia, foni e fonemi 17 1.1.2. La produzione dei suoni 18 1.1.3. Le vocali 20 1.1.4. Le consonanti
Premessa 11 [PARTE PRIMA I LE STRUTTURE DELL'ITALIANO D'OGGI 1.1. Fonetica e fonologia 17 1.1.1. fonetica e fonologia, foni e fonemi 17 1.1.2. La produzione dei suoni 18 1.1.3. Le vocali 20 1.1.4. Le consonanti
Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs.
 Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs. pōpulus pioppo ) Passaggio dal latino alle lingue romanze: distinzioni di
Sistema vocalico del latino: ă vs. ā, ŏ vs. ō, ĕ vs. ē, ĭ vs. ī, ŭ vs. ū (es. mălum il male vs. mālum mela o pŏpulus popolo vs. pōpulus pioppo ) Passaggio dal latino alle lingue romanze: distinzioni di
a. indipendente: se coinvolge una forma in tutte le sue occorrenze. Es. proto-indoeuropeo e, o > sanscrito a p-ie *okto > skt aşţa
 Il mutamento linguistico 1) fonetico a. indipendente: se coinvolge una forma in tutte le sue occorrenze. Es. proto-indoeuropeo e, o > sanscrito a p-ie *okto > skt aşţa b. dipendente: se è condizionato
Il mutamento linguistico 1) fonetico a. indipendente: se coinvolge una forma in tutte le sue occorrenze. Es. proto-indoeuropeo e, o > sanscrito a p-ie *okto > skt aşţa b. dipendente: se è condizionato
C assazione civile, sezione. III, 11 ottobre 2005, n
 C assazione civile, sezione. III, 11 ottobre 2005, n. 19757 P r e s. V i t t o r i a P - R e l. P e r c o n t e L i c a t e s e R - P. M. S c a r d a c c i o n e E V ( C o n f. ) C. c. R. e d a l t r i
C assazione civile, sezione. III, 11 ottobre 2005, n. 19757 P r e s. V i t t o r i a P - R e l. P e r c o n t e L i c a t e s e R - P. M. S c a r d a c c i o n e E V ( C o n f. ) C. c. R. e d a l t r i
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
Taranproject - Occhi di mari
 Taranproject-Occhi di mari Perla d argentu e occhi di mari, di la Calabria tu sì la reggina. La notti nta lu sonnu mi cumpari, cuntentu mi risbigghju ogni matina. Guardandu eu li stiddi i sta nuttata li
Taranproject-Occhi di mari Perla d argentu e occhi di mari, di la Calabria tu sì la reggina. La notti nta lu sonnu mi cumpari, cuntentu mi risbigghju ogni matina. Guardandu eu li stiddi i sta nuttata li
ALFABETO NEOEBRAICO. Dario Giansanti
 ALFABETO NEOEBRAICO LA LINGUA Dario Giansanti È assai strano il destino della lingua ebraica: dopo la Diaspora, gli Ebrei sparsi per il mondo avevano cominciato a utilizzare le parlate locali, servendosi
ALFABETO NEOEBRAICO LA LINGUA Dario Giansanti È assai strano il destino della lingua ebraica: dopo la Diaspora, gli Ebrei sparsi per il mondo avevano cominciato a utilizzare le parlate locali, servendosi
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
7 CAUSE di assenza o riduzione del dittongamento toscano:
 7 CAUSE di assenza o riduzione del dittongamento toscano: 1 La /ɔ/ deriva dalla monottongazione del dittongo AU il dittongamento toscano non si verifica, es. AURUM > /'ɔro/, non * /'wɔro/ (vedi cronologia
7 CAUSE di assenza o riduzione del dittongamento toscano: 1 La /ɔ/ deriva dalla monottongazione del dittongo AU il dittongamento toscano non si verifica, es. AURUM > /'ɔro/, non * /'wɔro/ (vedi cronologia
Transizione dialetti settentrionali-toscani-mediani
 Silvia Capotosto, Grammatica storica italiana LM Transizione dialetti settentrionali-toscani-mediani ( cfr. carta I dialetti della Toscana con aree di transizione) 1) Vocalismo atono finale gallo-italico
Silvia Capotosto, Grammatica storica italiana LM Transizione dialetti settentrionali-toscani-mediani ( cfr. carta I dialetti della Toscana con aree di transizione) 1) Vocalismo atono finale gallo-italico
Il verbo che cos'è. Il verbo è la parte del discorso più importante.
 IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
IL VERBO Il verbo che cos'è Il verbo è la parte del discorso più importante. Esso è il centro di ogni frase. Il verbo "dice" qualcosa sul soggetto e lo fa servendosi anche di altre parti del discorso che
HEGYI ÁGOTA L ITALIANO REGIONALE
 HEGYI ÁGOTA L ITALIANO REGIONALE Un luogo comune sul piano lessicale caratterizza benissimo la situazione linguistica: l italiano non è monolitico; la stessa frutta (verde di fuori e rossa dentro) è chiamata
HEGYI ÁGOTA L ITALIANO REGIONALE Un luogo comune sul piano lessicale caratterizza benissimo la situazione linguistica: l italiano non è monolitico; la stessa frutta (verde di fuori e rossa dentro) è chiamata
NOZIONI DI BASE: FONEMI, TRATTI DISTINTIVI, COPPIE MINIME, ALLOFONI. Fonemi: segmenti minimi con valore distintivo (distinguono coppie di parole).
 FONOLOGIA NOZIONI DI BASE: FONEMI, TRATTI DISTINTIVI, COPPIE MINIME, ALLOFONI. Fonemi: segmenti minimi con valore distintivo (distinguono coppie di parole). Coppie minime: parole che differiscono solo
FONOLOGIA NOZIONI DI BASE: FONEMI, TRATTI DISTINTIVI, COPPIE MINIME, ALLOFONI. Fonemi: segmenti minimi con valore distintivo (distinguono coppie di parole). Coppie minime: parole che differiscono solo
Sistema qualitativo/sistema quantitativo Sistemi del vocalismo tonico romanzo Dittongazione romanza Esiti spontanei ed esiti condizionati
 Sistema qualitativo/sistema quantitativo Sistemi del vocalismo tonico romanzo Dittongazione romanza Esiti spontanei ed esiti condizionati Fono: è un elemento acustico composto da una serie di suoni che
Sistema qualitativo/sistema quantitativo Sistemi del vocalismo tonico romanzo Dittongazione romanza Esiti spontanei ed esiti condizionati Fono: è un elemento acustico composto da una serie di suoni che
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
Francesca Chiusaroli. Linguistica Generale e Applicata 12 cfu
 Francesca Chiusaroli Linguistica Generale e Applicata 12 cfu L-LIN/01 Glottologia e Linguistica chiusaroli@lettere.uniroma2.it Modulo A Programma LE LINGUE E IL LINGUAGGIO: ELEMENTI DI LINGUISTICA GENERALE
Francesca Chiusaroli Linguistica Generale e Applicata 12 cfu L-LIN/01 Glottologia e Linguistica chiusaroli@lettere.uniroma2.it Modulo A Programma LE LINGUE E IL LINGUAGGIO: ELEMENTI DI LINGUISTICA GENERALE
La struttura della sillaba. Sequenze di suoni possibili in italiano. 1
 La struttura della sillaba. Sequenze di suoni possibili in italiano. 1 La sillaba è un unità della lingua maggiore del fonema (cioè si compone o da un fonema o da più fonemi), ma non è un morfema, in quanto
La struttura della sillaba. Sequenze di suoni possibili in italiano. 1 La sillaba è un unità della lingua maggiore del fonema (cioè si compone o da un fonema o da più fonemi), ma non è un morfema, in quanto
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti. Alla scoperta dell italiano
 Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Alla scoperta dell italiano 2003 by G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A. PROGETTO GRAFICO Vincenzo Marineo COPERTINA Federica Giovannini ILLUSTRAZIONI Francesca Speziale
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Alla scoperta dell italiano 2003 by G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A. PROGETTO GRAFICO Vincenzo Marineo COPERTINA Federica Giovannini ILLUSTRAZIONI Francesca Speziale
Classificazioni delle lingue Il cambiamento linguistico
 Classificazioni delle lingue Il cambiamento linguistico Linguistica Generale, parte II a.a. 2006-2007 Tipologica (morfologica; sintattica: OV/VO) Areale (leghe linguistiche) Socio-politica Genealogica
Classificazioni delle lingue Il cambiamento linguistico Linguistica Generale, parte II a.a. 2006-2007 Tipologica (morfologica; sintattica: OV/VO) Areale (leghe linguistiche) Socio-politica Genealogica
Tipologie di repertori plurilingui
 Linguistica Generale (cod. 24169) Modulo 2, a. a. 2016-17 Prof.ssa Federica Guerini Materiali 1 Tipologie di repertori plurilingui (A) Tipologie di repertori plurilingui: A B A A B B Bilinguismo Diglossia
Linguistica Generale (cod. 24169) Modulo 2, a. a. 2016-17 Prof.ssa Federica Guerini Materiali 1 Tipologie di repertori plurilingui (A) Tipologie di repertori plurilingui: A B A A B B Bilinguismo Diglossia
(L-LIN/01-Glottologia e Linguistica) Linguistica generale 1a Strutture del linguaggio. a.a.2009-2010 (M-Z) Anna Pompei
 (L-LIN/01-Glottologia e Linguistica) Linguistica generale 1a Strutture del linguaggio a.a.2009-2010 (M-Z) Anna Pompei FONETICA vs. FONOLOGIA Fonetica Disciplina della linguistica che studia gli aspetti
(L-LIN/01-Glottologia e Linguistica) Linguistica generale 1a Strutture del linguaggio a.a.2009-2010 (M-Z) Anna Pompei FONETICA vs. FONOLOGIA Fonetica Disciplina della linguistica che studia gli aspetti
LE DURATE DEI FONI VOCALICI IN RAPPORTO AL CONTESTO NEL PARLATO DI LOCUTORI PISANI: PRIMI RISULTATI *
 LE DURE DEI FONI VOCALICI IN RAPPOR AL CONTES NEL PARLO DI LOCURI PISANI: PRIMI RISULTI * M. Dell'Aglio - P. M. Bertinetto - M. Agonigi Scuola Normale Superiore, Pisa 1. INTRODUZIONE 1 La presente ricerca
LE DURE DEI FONI VOCALICI IN RAPPOR AL CONTES NEL PARLO DI LOCURI PISANI: PRIMI RISULTI * M. Dell'Aglio - P. M. Bertinetto - M. Agonigi Scuola Normale Superiore, Pisa 1. INTRODUZIONE 1 La presente ricerca
Provincia di Latina. Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale
 Provincia di Latina Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale L E G G E R E G I O N A L E N. 30 DEL 1998 Relazione di Piano C e n t r o L. U. P. T. U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p
Provincia di Latina Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale L E G G E R E G I O N A L E N. 30 DEL 1998 Relazione di Piano C e n t r o L. U. P. T. U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p
Prof.ssa Paola Cotticelli - Linguistica storica - Mutamento fonetico
 2. MUTAMENTO LINGUISTICO 2.1. Mutamento fonetico 2.1.1. Tipologia e processi Per esperienza si osserva che il sistema dei suoni di una lingua e soggetto a mutamenti, questi mutamenti fonetici sono così
2. MUTAMENTO LINGUISTICO 2.1. Mutamento fonetico 2.1.1. Tipologia e processi Per esperienza si osserva che il sistema dei suoni di una lingua e soggetto a mutamenti, questi mutamenti fonetici sono così
4 Fonetica e fonologia
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 4 Fonetica e fonologia [Materiale di riferimento per questa parte: Per fonetica e fonologia in generale: Canepari 1979: 12-34, 40-55,
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 4 Fonetica e fonologia [Materiale di riferimento per questa parte: Per fonetica e fonologia in generale: Canepari 1979: 12-34, 40-55,
4 Fonetica e fonologia
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 4 Fonetica e fonologia [Materiale di riferimento per questa parte: Per fonetica e fonologia in generale: Canepari 1979: 12-34, 40-55, 94-7, 118-23, 193-202
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 4 Fonetica e fonologia [Materiale di riferimento per questa parte: Per fonetica e fonologia in generale: Canepari 1979: 12-34, 40-55, 94-7, 118-23, 193-202
1. I suoni dell italiano (e non solo) 1.1 Vocali. Italiano standard: sistema eptavocalico. [i] alta, anteriore, non arrotondata cani, libro, lingua
![1. I suoni dell italiano (e non solo) 1.1 Vocali. Italiano standard: sistema eptavocalico. [i] alta, anteriore, non arrotondata cani, libro, lingua 1. I suoni dell italiano (e non solo) 1.1 Vocali. Italiano standard: sistema eptavocalico. [i] alta, anteriore, non arrotondata cani, libro, lingua](/thumbs/59/43078644.jpg) Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. I suoni dell italiano (e non solo) 1.1 Vocali
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. I suoni dell italiano (e non solo) 1.1 Vocali
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/ anno
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
1. La fonetica e i suoni delle lingue
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. La fonetica e i suoni delle lingue Lingue verbali:
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. La fonetica e i suoni delle lingue Lingue verbali:
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO. Dottorato di ricerca in Scienze storiche, filologiche e letterarie
 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dottorato di ricerca in Scienze storiche, filologiche e letterarie dell Europa e del Mediterraneo ciclo XXV S.S.D.: L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/12
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dottorato di ricerca in Scienze storiche, filologiche e letterarie dell Europa e del Mediterraneo ciclo XXV S.S.D.: L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/12
Cenni sulla pronuncia dell antico francese
 Cenni sulla pronuncia dell antico francese Questa guida si riferisce alla pronuncia dell antico francese intorno ai secoli XII e XIII, periodo in cui la lingua era in evoluzione e dunque non facilmente
Cenni sulla pronuncia dell antico francese Questa guida si riferisce alla pronuncia dell antico francese intorno ai secoli XII e XIII, periodo in cui la lingua era in evoluzione e dunque non facilmente
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
 BRUNO MIGLIORINI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Sansoni Editore INDICE DEI CAPITOLI 'REMESSA pp. vn-xi BIBLIOGRAFIA pp. xm-xvi - LA LATINITÀ D'ITALIA IN ETÀ IMPERIALE pp. 1-43 1. Da Augusto a Odoacre, p.
BRUNO MIGLIORINI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Sansoni Editore INDICE DEI CAPITOLI 'REMESSA pp. vn-xi BIBLIOGRAFIA pp. xm-xvi - LA LATINITÀ D'ITALIA IN ETÀ IMPERIALE pp. 1-43 1. Da Augusto a Odoacre, p.
Francesca Chiusaroli. Linguistica Generale e Applicata Modulo A. Le lingue e il linguaggio: elementi di linguistica generale. Modulo A Programma
 Francesca Chiusaroli Linguistica Generale e Applicata Modulo A Le lingue e il linguaggio: elementi di linguistica generale Modulo A Programma LE LINGUE E IL LINGUAGGIO: ELEMENTI DI LINGUISTICA GENERALE
Francesca Chiusaroli Linguistica Generale e Applicata Modulo A Le lingue e il linguaggio: elementi di linguistica generale Modulo A Programma LE LINGUE E IL LINGUAGGIO: ELEMENTI DI LINGUISTICA GENERALE
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
AGGETTIVI DI SECONDA CLASSE A DUE E A UNA SOLA USCITA. AGGETTIVI IRREGOLARI AGGETTIVI A DUE USCITE
 ETTII I SECO CLSSE UE E U SOL USCIT. ETTII IRREOLRI ETTII UE USCITE 1 Hanno il tema in preceduta da (Quelli in preceduta da e in preceduta da sono, sempre di seconda classe, ma a 3 uscite; vedi nero e
ETTII I SECO CLSSE UE E U SOL USCIT. ETTII IRREOLRI ETTII UE USCITE 1 Hanno il tema in preceduta da (Quelli in preceduta da e in preceduta da sono, sempre di seconda classe, ma a 3 uscite; vedi nero e
Classificazioni delle lingue Il cambiamento linguistico
 Classificazioni delle lingue Il cambiamento linguistico Linguistica Generale, parte II a.a. 2007-2008 Tipologica (morfologica; sintattica: OV/VO) Areale (leghe linguistiche) Socio-politica (es. Linguasphere)
Classificazioni delle lingue Il cambiamento linguistico Linguistica Generale, parte II a.a. 2007-2008 Tipologica (morfologica; sintattica: OV/VO) Areale (leghe linguistiche) Socio-politica (es. Linguasphere)
Prova di commutazione e la nozione di coppia minima
 FONOLOGIA Definizione di fonema e coppia minima, Regole di Trubekoj e allofoni. Inventario fonematico dell italiano. Teoria dei tratti distintivi Regole fonologiche. FONO vs. FONEMA FONO: suono producibile
FONOLOGIA Definizione di fonema e coppia minima, Regole di Trubekoj e allofoni. Inventario fonematico dell italiano. Teoria dei tratti distintivi Regole fonologiche. FONO vs. FONEMA FONO: suono producibile
1 I suoni del sanscrito
 1 I suoni del sanscrito 1.1 Sanscrito e vedico Il sanscrito, è noto, affonda le sue radici nel vedico, e con esso, volontariamente (cioè per una specifica strategia di rinascita della classe brahmanica
1 I suoni del sanscrito 1.1 Sanscrito e vedico Il sanscrito, è noto, affonda le sue radici nel vedico, e con esso, volontariamente (cioè per una specifica strategia di rinascita della classe brahmanica
Introduzione. L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica
 Introduzione L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica Il mito di Babele (Genesi, 11): la lingua primitiva dell umanità sarebbe stata una sola, l ebraico
Introduzione L idea che le diverse lingue derivino tutte da un unica lingua originaria è molto antica Il mito di Babele (Genesi, 11): la lingua primitiva dell umanità sarebbe stata una sola, l ebraico
2 PAGINA. 1 Il greco lingua flessiva. Radice, tema, desinenza 44 2 La flessione dei nomi. Le declinazioni. I casi e le loro funzioni 47 1 PAGINA
 I AVVERTENZA PAGINA III 0 PAGINA 1 1 PAGINA 15 1 L alfabeto greco 17 2 Spiriti, accenti e altri segni diacritici. I segni d interpunzione 21 3 Le vocali e i dittonghi 25 4 Le consonanti 27 5 L accento
I AVVERTENZA PAGINA III 0 PAGINA 1 1 PAGINA 15 1 L alfabeto greco 17 2 Spiriti, accenti e altri segni diacritici. I segni d interpunzione 21 3 Le vocali e i dittonghi 25 4 Le consonanti 27 5 L accento
Liceo T.L.Caro, Cittadella (PD) 23 gennaio Corso di Formazione Didattica delle Lingue e Linguistica Formale
 Liceo T.L.Caro, Cittadella (PD) 23 gennaio 2012 Corso di Formazione Didattica delle Lingue e Linguistica Formale Renato Oniga Nicoletta Penello Il nuovo paradigma scientifico e didattico della grammatica
Liceo T.L.Caro, Cittadella (PD) 23 gennaio 2012 Corso di Formazione Didattica delle Lingue e Linguistica Formale Renato Oniga Nicoletta Penello Il nuovo paradigma scientifico e didattico della grammatica
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO
 Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
Problemi di Metodologia Statistica
 Questioni Metodologiche Ordine degli interventi: 1. Le basi metodologiche del record linkage Cristina Mazzali Università degli Studi di Milano 2. La scelta degli strumenti di record linkage Soundex Sara
Questioni Metodologiche Ordine degli interventi: 1. Le basi metodologiche del record linkage Cristina Mazzali Università degli Studi di Milano 2. La scelta degli strumenti di record linkage Soundex Sara
