RIEPILOGO GRAMMATICA STORICA PER FREQUENTANTI a.a. 2012/2013
|
|
|
- Eleonora Basso
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RIEPILOGO GRAMMATICA STORICA PER FREQUENTANTI a.a. 2012/2013 Manuale di riferimento: Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 2005 Le domande d esame verteranno sugli argomenti trattati nelle pp e del Serianni e, naturalmente, su tutti gli argomenti che sono stati spiegati nel corso delle esercitazioni, compresi quelli assenti o solamente accennati nel manuale; per questi ultimi vi invito a consultare gli appunti delle lezioni, dove troverete tutte le informazioni necessarie per la preparazione dell'esame. Per agevolare il vostro lavoro fornisco di seguito un prospetto dettagliato delle tematiche affrontate durante il corso, segnalando in rosso gli argomenti trattati a lezione e assenti nel manuale di Serianni, in verde gli argomenti trattati a lezione e accennati nel manuale di Serianni, sul volume di Avolio o sul Marazzini (indico in questo caso le pagine dove potrete trovare ciascun argomento). 1
2 PRELIMINARI DI FONETICA (Serianni, pp ) Grafema, fono, fonema; prova di commutazione; allofoni; varianti libere e varianti combinatorie; differenza tra foni sordi e foni sonori; differenza tra foni vocalici e foni consonantici; definizione di un fono consonantico (luogo di articolazione, modo di articolazione, grado di sonorità, grado di intensità; tavola del consonantismo con principali foni consonantici in trascrizione IPA; definizione di un fono vocalico (anteriore/palatale, centrale, posteriore/velare); trapezio vocalico; distinzione grafica (accento acuto e grave) tra medio-alte o chiuse (/e/, /o/) e medio basse o aperte (/ɛ/, /ɔ/) nel vocalismo tonico; definizione e caratteristiche delle approssimanti /j/ e /w/; definizione e caratteristiche del dittongo; definizione e caratteristiche dello iato; definizione e descrizione strutturale della sillaba (attacco, nucleo, coda); opposizione sillaba libera/aperta vs sillaba implicata/chiusa; sillaba tonica, protonica e postonica. LATINO VOLGARE 1 (Serianni, pp ) Definizione di latino volgare; variabili sociolinguistiche coinvolte nell'evoluzione del latino volgare (diafasica, diastratica, diatopica, diacronica); sostrato e superstrato; fonti per la ricostruzione del latino volgare (comparazione tra le lingue romanze; testimonianze di scrittori che riproducono l'uso popolare o che scrivono testi privati, es. Petronio, Satyricon; Cicerone, Epistolario; iscrizioni di carattere privato, es. scritture esposte di Pompei; testimonianze di grammatici, es. Appendix Probi); LATINO VOLGARE 2 Principali mutamenti morfologici sopraggiunti in diacronia (Serianni, pp e pp ): semplificazione del sistema dei casi; passaggio da ordine libero della frase a ordine SVO; collasso del sistema delle declinazioni (passaggio da 5 a 3) e riorganizzazione del sistema nominale in tre gruppi (I sing. -a, plur. -e; II sing. -o, plur. -i; III sing. -e, plur. -i); semplificazione del sistema dei generi e residui dei neutri plurali in -A e in -ORA; formazione dell'articolo determinativo dal pronome/aggettivo dimostrativo ILLUM + distribuzione dell'articolo nell'italiano antico (norma Gröber, lezione del ); formazione del pronome /aggettivo dimostrativo da ECCUM + ILLUM / ISTUM / TIBI ISTUM (ricordare che in questo caso si ha un nesso labiovelare secondario...); passaggio da futuro sintetico a futuro analitico (costrutto INFINITO + HABEO > INFINITO + * AO); formazione del condizionale (costrutto INFINITO + HEBUI > INFINITO + *EI); sviluppo della desinenza toscana e italiana della I persona plurale del presente indicativo -iamo < congiuntivo -EAMUS (vedi: [a] handout con riepilogo 7 cause di assenza o riduzione del dittongo toscano, nota 2 pagina 3 e [b] appunti esercitazione su testo Chichibio e la gru di Boccaccio); sviluppo delle desinenze dell'imperfetto indicativo di I e III persona singolare e sue variazioni diacroniche (= sviluppo di desinenze con iato -ea, -ia per aplologia; assenza di chiusura della vocale tonica in iato su -ea per evitare l'omofonia con -ia; passaggio da uscita in -a a uscita in -o per analogia con desinenza del presente indicativo. Vedi al riguardo: [a] esercitazione su chiusura delle vocali toniche in iato e [b] handout con riepilogo 7 cause di assenza o riduzione del dittongo toscano, nota 3 pagina 3); 2
3 Principali mutamenti fonetici sopraggiunti in diacronia (Serianni, pp ; sulla sibilante, l'argomento è accennato a p. 42 e ripreso a p. 92, nel commento a è ): caduta di -M finale; caduta di -T finale; riduzione del nesso -NS-; trattamento della sibilante finale -S (tre esiti: vocalizzazione in i; palatalizzazione della vocale precedente; assimilazione alla consonante seguente, quindi caduta + raddoppiamento fonosintattico); passaggio dal sistema vocalico latino al sistema vocalico romanzo comune (perdita dell'opposizione di quantità in favore dell'opposizione di timbro) VOCALISMO 1: SISTEMI VOCALICI Sistema del vocalismo tonico romanzo comune; sistema del vocalismo atono romanzo comune (cfr. anche Serianni, p. 37); altri esiti di vocalismo tonico nell'italoromània (almeno siciliano); altri esiti di vocalismo atono nell'italoromània (almeno meridionale intermedio e meridionale estremo; ricordare che gli esiti del vocalismo atono finale sono il principale tratto distintivo tra dialetti meridionali intermedi e dialetti meridionali estremi all'interno del macrogruppo dei dialetti centro-meridionali ); un caso di toscanizzazione del vocalismo tonico e atono siciliani: la rima siciliana (cfr. anche Marazzini, pp ); come riconoscere un cultismo (assenza fenomeni di vocalismo; assenza fenomeni di consonantismo; principio vocale incerta, vocale aperta - Migliorini); casi di sviluppo popolare e recupero colto di una stessa base latina: gli allotropi (cfr. anche Serianni, pp ) VOCALISMO 2: FENOMENI DI VOCALISMO TONICO (Serianni, p. 35 e pp ) Monottongazioni (OE, AE, AU); dittongamento toscano (definizione, vocali toniche coinvolte, significato di sillaba libera e posizione incondizionata ; distribuzione areale del fenomeno; cronologia del dittongamento toscano in relazione agli esiti di AU; 7 cause di assenza o riduzione del dittongo toscano [la /ɔ/ deriva dalla monottongazione del dittongo AU; latinismi; alcuni proparossitoni; regola del dittongo mobile e sue articolazioni; il dittongo toscano segue un nesso [Consonante+/r/]; il dittongo toscano segue un fono palatale [ʎʎ, ɲɲ, ʃʃ, tʃ, ʤ, j]; /ɛ/ ed /ɔ/ si trovano in iato con una vocale diversa da /i/]; individuazione casistica dittongamento toscano nel passo da Chichibio e la gru di Boccaccio); chiusura delle vocali toniche in iato (fenomeno generale e sue condizioni; qui anche: spiegazione sulla formazione delle desinenze dell'imperfetto indicativo di I e III persona singolare per aplologia e motivazioni dell'assenza di chiusura in iato di /e/ nella desinenza dell'imperfetto indicativo di II coniugazione -ea; sviluppo Ĕ(G)O > io, proposte di Castellani e Meyer Lübke + problematicità insite nel postulare la provenienza di io da dittongo toscano; problematicità insite nel postulare la provenienza di io da dittongo metafonetico (cfr. anche Serianni, pp ); considerando l'assenza di chiusura delle vocali toniche in iato in romanesco, discussione delle proposte presenti a p. 90 del Serianni sulla provenienza del pronome dativo mi a me dall' accusativo MĒ o dal dativo MĬHĬ > MĪ); metafonesi (definizione; vocali toniche coinvolte; condizioni fonetiche che determinano il fenomeno; differenza tra le due tipologie del fenomeno: sabina/ a innalzamento e napoletana/a dittongazione; distribuzione areale del fenomeno (cfr. anche 3
4 Avolio, p. 52); funzioni morfologiche del fenomeno metafonetico: opposizione di genere e opposizione di numero; individuazione forme metafonetiche nel passo dell'epistola napoletana di Boccaccio); anafonesi (definizione; vocali toniche coinvolte; contesti che determinano il fenomeno [attenzione al fatto che per determinare anafonesi su /e/ le consonanti /ʎ/ e /ɲ/ devono derivare da LJ e NJ primari o secondari. Facendo mente locale all'intero consonantismo, ricordare anche quali sono gli altri contesti che generano una /ʎ/ o una /ɲ/ e che però, essendo diversi da LJ e NJ, non danno anafonesi.; al riguardo vedi esercitazione sull'anafonesi]; anafonesi secondaria dovuta ad analogia: [a] anafonesi in assenza di contesti che potrebbero determinarla, per analogia su forme dello stesso paradigma recanti condizioni anafonizzanti, es. IŬNCTUM analogico a IŬNGO; [b] anafonesi su forme rizoatone per analogia con forme rizotoniche dello stesso paradigma, es. IŬNGĔNDU(M) su IŬNGO) VOCALISMO 3: FENOMENI DI VOCALISMO ATONO (Serianni, pp ) Chiusura di /e/ protonica all'interno di parola e in fonosintassi (fenomeno generale; distribuzione areale del fenomeno; casi di assenza del fenomeno: latinismi, semilatinismi, analogia delle forme rizoatone sulle rizotoniche; casi di regresso del fenomeno: rilatinizzazione, dovuta in realtà a dissimilazione, es. felice > filice> felice); chiusura di /e/ postonica non finale solo se derivante da Ĭ [ossia Trattamento di Ĭ postonico non finale]; labializzazione della vocale protonica; -AR- intertonico e postonico (ricordare che il fenomeno è fiorentino, non sistematico negli altri dialetti di Toscana e assente nelle altre varietà italoromanze) FENOMENI GENERALI (Serianni, pp ) Prostesi, epentesi, epitesi (ricordare anche prostesi per concrezione dell'articolo, es. la apa > lapa; epitesi di -no nei verbi; epitesi di -e e di -ne per evitare l'ossitonia); aferesi, sincope e apocope (ricordare anche aferesi per errata discrezione dell'articolo, es. lasagna > la sagna; attenzione nell'individuare se la sincope è della postonica oppure dell'intertonica ); raddoppiamento fonosintattico; aplologia (vedi esercitazione su chiusura vocali toniche in iato e esercitazione , parte con formazione ossitoni per apocope di origine aplologica cittade > città, virtude > virtù etc; vedi anche Serianni, pp e 101); assimilazione progressiva e regressiva; dissimilazione 4
5 CONSONANTISMO (Serianni, pp ) Palatalizzazione delle occlusive: C+ e, i > /ʧ/ ; G+ e, i > /ʤ/ Sonorizzazione delle occlusive Spirantizzazione dell'occlusiva bilabiale sonora intervocalica: -B- > - β- > -v- Nessi di consonante +L: (in linea generale, il fenomeno comune a tutti questi nessi è la palatalizzazione e successivo iotizzamento della laterale, dunque il passaggio -L-> -j-; se si trovano in posizione intervocalica, tutti i nessi in questione subiscono geminazione della consonante iniziale. Ricordare che questi nessi possono essere etimologici oppure formarsi in seguito a sincope della postonica/sincope dell'intertonica, come ad esempio OC(U)LU(M) > OCLU): PL (iniziale: /pj/- ma /kj/- dialetti centro-meridionali; postconsonantico: -/pj/-; intervocalico: -/ppj/-); BL (iniziale e postconsonantico : (-)/bj/-; intervocalico: -/bbj/-) FL (iniziale e postconsonantico : (-)/fj/-; intervocalico: -/ffj/-) CL (iniziale e postconsonantico : (-)/kj/-; intervocalico: -/kkj/-) -TL- > -CL- > -/kj/- (si ha solo in posizione intervocalica e in seguito a sincope della postonica) (-)SL- > (-)SCL-> (-)skj(-) (si ha solo in posizione iniziale e in posizione intervocalica in seguito a sincope della postonica; in posizione iniziale non è indigeno) GL (iniziale >/ɟ/-; intervocalico: -/ɟɟ/-, ma tra fine 1400 e inizio 1500 alcuni -/ɟɟ/- intervocalici vengono passati a -/ʎʎ/- per ipercorrettismo, come reazione fiorentina alla pronuncia di -/ʎʎ/- etimologico che si aveva presso i parlanti del contado) J iniziale e intervocalico: J- + vocale > /ʤ/- (per palatalizzazione) -J- intervocalico > -/dʤ/- (per palatalizzazione + geminazione perché intervocalico) 5
6 Nessi di [consonante+ j]: (ricordare che lo /j/ può essere primario quindi essere presente già nella base latina oppure secondario; in questo caso, lo /j/ si forma per iotizzamento di una /e/ atona < Ĭ, Ĕ in iato, come in HABEA(T) = HABE.AT > abi.a> abja > /'abbja/. Ricordare inoltre che anche in questo caso se i nessi si trovano in posizione intervocalica subiscono geminazione della consonante): (-)VJ- primario e (-)vj- secondario > (-)bj- > (-)bbj- se intervocalico (il nesso VJ primario e secondario subisce betacismo) (-)BJ- primario e (-)bj- secondario = (-)bj - > (-)bbj- se intervocalico -MJ- > -mmj- (solo intervocalico) (-)PJ- primario e (-)pj- secondario [anche proveniente da PL] = pj- (ma kj- nei dialetti centro meridionali) in posizione iniziale > -ppj- se intervocalico (ma nei dialetti centro-meridionali in questa posizione diventa -/tʧ/-, come SAPIO > /'satʧo/) DJ primario e dj secondario: posizione iniziale: DJ-> j-> ʤ- (per palatalizzazione); posizione intervocalica: -DJ-> -jj- > -dʤ- (per palatalizzazione; I secolo d.c., fenomeno condannato dai grammatici) -DJ- > -ddj- >-dʣ- (per assibilazione; II secolo d.c.) posizione postconsonantica: [Consonante] +-DJ- > [Consonante] +-ʣ- (per assibilazione) TJ primario e tj secondario: posizione intervocalica: -TJ-> -tts- (per assibilazione) nesso intervocalico-tj- in prestiti galloromanzi > - ʒ- (Toscana, per spirantizzazione) >-dʤ- (tutte le altre varietà italoromanze + italiano, per palatalizzazione) posizione postconsonantica 2 esiti: [consonante] + -TJ- > [consonante] + -ts- (per assibilazione) > [consonante] + -ʧ- (per palatalizzazione, in alcune forme tarde) -RJ- (intervocalico)> -j- (Toscana); > -r- altrove (di conseguenza, il suffisso -ARIUS diventa -/ajo/ in Toscana, -/aro/ altrove) 6
7 -SJ- intervocalico 2 esiti > -tʃ-, pronunciato però [ʃ] dalla Toscana in giù, es. BASIU(M) > /'batʃo/ pronuncia italiano standard; /'baʃo/ pronuncia toscana, romanesca e dell'italia meridionale > -dʒ-, pronunciato però [ʒ] in Toscana, es. PRE(H)ENSIŌNE(M) > /pri'dʒone/ pronuncia italiano standard; /pri'ʒone/ pronuncia Toscana (il romanesco e i dialetti meridionali seguono la pronuncia standard, ma raddoppiano l'affricata intervocalica: /prid'dʒone/). (-)LJ- >/ʎʎ/ (lo /j/ palatalizza la laterale che lo precede) (-)NJ- primario e secondario > /ɲɲ/ (lo /j/ palatalizza la nasale che lo precede) NESSO LABIOVELARE PRIMARIO sordo e sonoro (cfr. Serianni, p. 65); possibile distinzione etimologica tra che pronome e che congiunzione dichiarativo/causale in italiano (QUID vs QUEM?); distinzione etimologica tra che pronome e che congiunzione dichiarativo/causale nei dialetti meridionali: che pronome vs ca/co congiunzione (e relative basi latine) (cfr. Serianni, p. 91) NESSO LABIOVELARE SECONDARIO e differenza rispetto al nesso labiovelare primario (cfr. Serianni, p. 79); trattamento del nesso labiovelare secondario nei dialetti centromeridionali 7
7 CAUSE di assenza o riduzione del dittongamento toscano:
 7 CAUSE di assenza o riduzione del dittongamento toscano: 1 La /ɔ/ deriva dalla monottongazione del dittongo AU il dittongamento toscano non si verifica, es. AURUM > /'ɔro/, non * /'wɔro/ (vedi cronologia
7 CAUSE di assenza o riduzione del dittongamento toscano: 1 La /ɔ/ deriva dalla monottongazione del dittongo AU il dittongamento toscano non si verifica, es. AURUM > /'ɔro/, non * /'wɔro/ (vedi cronologia
Sociolinguistica a.a. 2005-2006 IV. Regole variabili e Scale implicazionali
 Sociolinguistica a.a. 2005-2006 IV Regole variabili e Scale implicazionali 1 Regole variabili La regola variabile rappresenta il versante descrittivo (punto di vista esterno) della variabilità linguistica
Sociolinguistica a.a. 2005-2006 IV Regole variabili e Scale implicazionali 1 Regole variabili La regola variabile rappresenta il versante descrittivo (punto di vista esterno) della variabilità linguistica
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI, DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI, DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI Sociolinguistica A2 (codice: 37089) Ada Valentini Esercitazione n. 1: fonetica e fonologia L esercitazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI, DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI Sociolinguistica A2 (codice: 37089) Ada Valentini Esercitazione n. 1: fonetica e fonologia L esercitazione
Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri Anno Scolastico 2015/2016. Programmazione didattica annuale FINALITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO
 Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri Anno Scolastico 2015/2016 Classe: I B Docente: Marzia Procopio Materia: Greco Programmazione didattica annuale FINALITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO Lo studio delle lingue
Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri Anno Scolastico 2015/2016 Classe: I B Docente: Marzia Procopio Materia: Greco Programmazione didattica annuale FINALITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO Lo studio delle lingue
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO LUCA SIGNORELLI - CORTONA GRECO BIENNIO
 GRECO BIENNIO Il Liceo Classico promuove lo studio delle lingue classiche per fornire agli studenti validi strumenti di comprensione e riflessione diretta sulla storia e l evoluzione delle civiltà greca
GRECO BIENNIO Il Liceo Classico promuove lo studio delle lingue classiche per fornire agli studenti validi strumenti di comprensione e riflessione diretta sulla storia e l evoluzione delle civiltà greca
1. Fonetica e fonologia. La fonetica studia le caratteristiche fisiche dei suoni linguistici
 Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Fonetica e fonologia La fonetica studia le caratteristiche
Corso di laurea in Scienze dell Educazione A. A. 2011 / 2012 Istituzioni di Linguistica (M-Z) Dr. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. Fonetica e fonologia La fonetica studia le caratteristiche
LATINO (biennio linguistico)
 LATINO (biennio linguistico) OBIETTIVI (CLASSE I) Al termine della classe prima lo studente dovrà essere in possesso delle seguenti: morfologia e sintassi della lingua italiana (recupero e consolidamento
LATINO (biennio linguistico) OBIETTIVI (CLASSE I) Al termine della classe prima lo studente dovrà essere in possesso delle seguenti: morfologia e sintassi della lingua italiana (recupero e consolidamento
Cenni sulla pronuncia dell antico francese
 Cenni sulla pronuncia dell antico francese Questa guida si riferisce alla pronuncia dell antico francese intorno ai secoli XII e XIII, periodo in cui la lingua era in evoluzione e dunque non facilmente
Cenni sulla pronuncia dell antico francese Questa guida si riferisce alla pronuncia dell antico francese intorno ai secoli XII e XIII, periodo in cui la lingua era in evoluzione e dunque non facilmente
La fonologia. (5) esempi di due fonemi dell italiano individuati tramite una coppia minima
 LINGUISTICA GENERALE, Linguistica di base D, a.a 2010/11, Ada Valentini Mat. 4 La fonologia (1) Fonologia: si occupa dei suoni usati sistematicamente nelle l. naturali per comunicare significati, ne studia
LINGUISTICA GENERALE, Linguistica di base D, a.a 2010/11, Ada Valentini Mat. 4 La fonologia (1) Fonologia: si occupa dei suoni usati sistematicamente nelle l. naturali per comunicare significati, ne studia
REGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015)
 Informatica e Programmazione (9 CFU) Ingegneria Meccanica e dei Materiali REGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015) Modalità d esame (note generali) Per superare l esame, lo studente deve sostenere due
Informatica e Programmazione (9 CFU) Ingegneria Meccanica e dei Materiali REGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015) Modalità d esame (note generali) Per superare l esame, lo studente deve sostenere due
LA SCHEDA CONTABILE di Roberto Gabrielli
 LA SCHEDA CONTABILE di Roberto La rilevazione delle imposte sul reddito (Aggiornata al 23.05.2009) Scopo della scheda La scheda si propone di illustrare in modo semplice e sintetico alcune delle più comuni
LA SCHEDA CONTABILE di Roberto La rilevazione delle imposte sul reddito (Aggiornata al 23.05.2009) Scopo della scheda La scheda si propone di illustrare in modo semplice e sintetico alcune delle più comuni
Suono Trascrizione: pos. atona pos. tonica
 118 3. LA LINGUA PIEMONTESE Trascrizione ufficiale (ortografia) Parlando della storia del p. abbiamo già spiegato come si produsse la sua ortografia. Si noterà che affrontiamo la trascrizione dei suoni
118 3. LA LINGUA PIEMONTESE Trascrizione ufficiale (ortografia) Parlando della storia del p. abbiamo già spiegato come si produsse la sua ortografia. Si noterà che affrontiamo la trascrizione dei suoni
Modulo: IV. La salute Livello: Alto
 1. Le strutture mediche Conoscere le strutture mediche presenti sul territorio e le rispettive funzioni Nomi delle diverse strutture mediche e di alcune pratiche mediche di base (ex vaccino, prelievo)
1. Le strutture mediche Conoscere le strutture mediche presenti sul territorio e le rispettive funzioni Nomi delle diverse strutture mediche e di alcune pratiche mediche di base (ex vaccino, prelievo)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Prova scritta di Sociolinguistica A2 (cod. 37089) A. Valentini - 12 gennaio 2005 FILA A Nome e cognome: Matricola: Corso di laurea: Curriculum: Anno di corso Frequentante
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Prova scritta di Sociolinguistica A2 (cod. 37089) A. Valentini - 12 gennaio 2005 FILA A Nome e cognome: Matricola: Corso di laurea: Curriculum: Anno di corso Frequentante
376 Introduzione alla lingua di Roma nel Duecento
 INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
INDICE Introduzione Preliminare» 3 Riferimenti testuali e bibliografici» 4 I. La lingua di Roma nel Duecento» 5 II. La trascrizione dei testi e le abbreviazioni» 7 III. Correzioni alle trascrizioni dei
! Approvato AD Data 01/06/2013
 1 Dipartimento di: Lettere Linguistico: latino 1. COMPETENZE DISCIPLINARI 2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI Anno scolastico: 2014-2015 X Primo biennio Secondo biennio Quinto anno Competenze
1 Dipartimento di: Lettere Linguistico: latino 1. COMPETENZE DISCIPLINARI 2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI Anno scolastico: 2014-2015 X Primo biennio Secondo biennio Quinto anno Competenze
BREVE STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
 BREVE STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Introduzione. Nei film del Neorealismo, spesso gli attori non parlano in italiano standard, ma parlano in dialetto. Cosa sono i dialetti? Come sono nati? 1. Dal latino
BREVE STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Introduzione. Nei film del Neorealismo, spesso gli attori non parlano in italiano standard, ma parlano in dialetto. Cosa sono i dialetti? Come sono nati? 1. Dal latino
La rilevazione delle imposte sul reddito (Aggiornata al 10/10/2010)
 CONTABILITA La rilevazione delle imposte sul reddito (Aggiornata al 10/10/2010) Quadro di sintesi Relativamente alle imposte dirette, l art. 15-bis del D.L. 81/2007 intervenendo sull art. 164 del L utile
CONTABILITA La rilevazione delle imposte sul reddito (Aggiornata al 10/10/2010) Quadro di sintesi Relativamente alle imposte dirette, l art. 15-bis del D.L. 81/2007 intervenendo sull art. 164 del L utile
PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE
 PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE 26. DIURNUS *DJURNU- > GIÓRNO JUORNO di Carlo Iandolo In fiorentino-italiano il monofonema del latino volgare *dj + vocale (eco collaterale del bisillabo classico di + vocale
PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE 26. DIURNUS *DJURNU- > GIÓRNO JUORNO di Carlo Iandolo In fiorentino-italiano il monofonema del latino volgare *dj + vocale (eco collaterale del bisillabo classico di + vocale
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI ITALIANO SECONDO BIENNIO
 SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI ITALIANO SECONDO BIENNIO CLASSI TERZA E QUARTA Competenza 1. Interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura. Al termine del II biennio ( 3^ e 4^ Scuola Primaria)
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI ITALIANO SECONDO BIENNIO CLASSI TERZA E QUARTA Competenza 1. Interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura. Al termine del II biennio ( 3^ e 4^ Scuola Primaria)
INDICE. Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12. 1.1. Oggetto di studio 12. 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13
 INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
4, 5 ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 ASCOLTO E PARLATO Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo pertinente. Interagire nello scambio comunicativo formulando domande e risposte adeguate al contesto. Esprimere il proprio punto
ASCOLTO E PARLATO Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo pertinente. Interagire nello scambio comunicativo formulando domande e risposte adeguate al contesto. Esprimere il proprio punto
4) Con la fine dell Impero romano (476 d.c.) il latino fu sostituito dalle lingue romanze negli atti ufficiali e nel parlato.
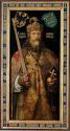 1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
1) La differenza tra documento e monumento sta nel fatto che: a) i documenti sono cartacei, i monumenti lapidei b) il documento è una scrittura non fatta per durare, il monumento sì c) il documento è personale,
È crisi delle piccole botteghe, ma i prezzi restano alti
 Editoriale n. 5 del 16/5/2009 Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno È crisi delle piccole botteghe, ma i prezzi restano alti A commento del Rapporto diffuso da Confesercenti La crisi ha toccato e continua
Editoriale n. 5 del 16/5/2009 Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno È crisi delle piccole botteghe, ma i prezzi restano alti A commento del Rapporto diffuso da Confesercenti La crisi ha toccato e continua
L ITALIANO TRA NOTE E COLORI. L italiano per studenti stranieri neo-arrivati in Italia Fondazione Telecom-Miur.
 L ITALIANO TRA NOTE E COLORI L italiano per studenti stranieri neo-arrivati in Italia Fondazione Telecom-Miur. Obiettivi del Progetto Facilitare l apprendimento della lingua italiana a studenti stranieri
L ITALIANO TRA NOTE E COLORI L italiano per studenti stranieri neo-arrivati in Italia Fondazione Telecom-Miur. Obiettivi del Progetto Facilitare l apprendimento della lingua italiana a studenti stranieri
http://digital.casalini.it/8884535131 ISBN-10: 88-8453-513-1 (online) ISBN-13: 978-88-8453-513-9 (online)
 IV PRIMA UNITÀ Nuovi itinerari alla scoperta del greco antico : le strutture fondamentali della lingua greca : fonetica, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica / Francesco Michelazzo. Firenze : Firenze
IV PRIMA UNITÀ Nuovi itinerari alla scoperta del greco antico : le strutture fondamentali della lingua greca : fonetica, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica / Francesco Michelazzo. Firenze : Firenze
Istituto Comprensivo B.C. Ferrini Anno scolastico 2007-08. Le prove: cosa sono, come si svolgono, cosa accade dopo.
 Istituto Comprensivo B.C. Ferrini Anno scolastico 2007-08 2 Incontro informativo per i Genitori: Le prove: cosa sono, come si svolgono, cosa accade dopo. Progetto di monitoraggio delle capacità di lettoscrittura
Istituto Comprensivo B.C. Ferrini Anno scolastico 2007-08 2 Incontro informativo per i Genitori: Le prove: cosa sono, come si svolgono, cosa accade dopo. Progetto di monitoraggio delle capacità di lettoscrittura
CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA SERVIZI PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI
 02 febbraio 2011 CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA SERVIZI PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ero Gara 702754 - Lotto CIG 0659407FDA Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento
02 febbraio 2011 CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA SERVIZI PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ero Gara 702754 - Lotto CIG 0659407FDA Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento
VOCALISMO ATONO. N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione pdf». Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū
 N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione 07.03.2012.pdf». VOCALISMO ATONO Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū ITALO-ROMANZO (toscano+ area perimediana, ligure, veneto centrale
N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione 07.03.2012.pdf». VOCALISMO ATONO Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū ITALO-ROMANZO (toscano+ area perimediana, ligure, veneto centrale
PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE
 PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE Parte Sesta di Carlo Iandolo Na croce passata Anche le comuni espressioni dialettali è na croce passata, è nu uajo passato riflettono lontane origini latineggianti. Infatti
PILLOLE LINGUISTICHE NAPOLETANE Parte Sesta di Carlo Iandolo Na croce passata Anche le comuni espressioni dialettali è na croce passata, è nu uajo passato riflettono lontane origini latineggianti. Infatti
DSA I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 DSA I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COME INTERVENIRE ALLA LUCE DELLA LEGGE 170/2010 A CURA DEL PROF. Benedetto di Biasio A.S. 2011/2012 LA DISLESSIA è un disturbo strumentale di lettura. Ad esso
DSA I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COME INTERVENIRE ALLA LUCE DELLA LEGGE 170/2010 A CURA DEL PROF. Benedetto di Biasio A.S. 2011/2012 LA DISLESSIA è un disturbo strumentale di lettura. Ad esso
I suoni del sanscrito: alfabeto in trascrizione e pronuncia delle parole. Giulio Geymonat website: www.sanscrito.it
 I suoni del sanscrito: alfabeto in trascrizione e pronuncia delle parole Giulio Geymonat website: www.sanscrito.it i www.sanscrito.it I suoni del sanscrito: trascrizione e pronuncia ii Indice 1 La trascrizione
I suoni del sanscrito: alfabeto in trascrizione e pronuncia delle parole Giulio Geymonat website: www.sanscrito.it i www.sanscrito.it I suoni del sanscrito: trascrizione e pronuncia ii Indice 1 La trascrizione
Statistica. Lezione 6
 Università degli Studi del Piemonte Orientale Corso di Laurea in Infermieristica Corso integrato in Scienze della Prevenzione e dei Servizi sanitari Statistica Lezione 6 a.a 011-01 Dott.ssa Daniela Ferrante
Università degli Studi del Piemonte Orientale Corso di Laurea in Infermieristica Corso integrato in Scienze della Prevenzione e dei Servizi sanitari Statistica Lezione 6 a.a 011-01 Dott.ssa Daniela Ferrante
Metodi di alfabetizzazione
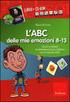 Metodi di alfabetizzazione a cura di Ambra Gasparetto Risorse dei non alfabetizzati Gli immigrati stranieri sono spesso più veloci nell apprendimento degli analfabeti italiani (che se al giorno d oggi
Metodi di alfabetizzazione a cura di Ambra Gasparetto Risorse dei non alfabetizzati Gli immigrati stranieri sono spesso più veloci nell apprendimento degli analfabeti italiani (che se al giorno d oggi
Luca Lorenzetti L italiano contemporaneo, Carocci, 2002
 Luca Lorenzetti L italiano contemporaneo, Carocci, 2002 (schema compilato da Rita Lugaresi: non sostituisce il libro!) 1. L Italia linguistica contemporanea 1.1. le lingue d Italia oggi L italiano è la
Luca Lorenzetti L italiano contemporaneo, Carocci, 2002 (schema compilato da Rita Lugaresi: non sostituisce il libro!) 1. L Italia linguistica contemporanea 1.1. le lingue d Italia oggi L italiano è la
Unità 13. In questura. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A1. In questa unità imparerai:
 Unità 13 In questura In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sul permesso di soggiorno e sulla questura parole relative all ufficio immigrazione della questura l uso dei pronomi
Unità 13 In questura In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sul permesso di soggiorno e sulla questura parole relative all ufficio immigrazione della questura l uso dei pronomi
Contenuti - temi - attività didattiche CLASSE PRIMA
 Corrisponde a un nucleo tematico della disciplina, a un argomento forte della disciplina; caratterizza ASCOLTO Grado scolastico: Scuola Secondaria di 1 grado Comprende brevi dialoghi con un lessico limitato,
Corrisponde a un nucleo tematico della disciplina, a un argomento forte della disciplina; caratterizza ASCOLTO Grado scolastico: Scuola Secondaria di 1 grado Comprende brevi dialoghi con un lessico limitato,
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA PRIMARIA IST. COMP. DON MILANI CERNUSCO S/N -
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA PRIMARIA IST. COMP. DON MILANI CERNUSCO S/N - LINGUA ITALIANA: PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA 1 ASCOLTARE, COMPRENDERE, 1.1 Prendere la parola negli scambi
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA PRIMARIA IST. COMP. DON MILANI CERNUSCO S/N - LINGUA ITALIANA: PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA 1 ASCOLTARE, COMPRENDERE, 1.1 Prendere la parola negli scambi
Analisi della performance temporale della rete
 Analisi della performance temporale della rete In questo documento viene analizzato l andamento nel tempo della performance della rete di promotori. Alcune indicazioni per la lettura di questo documento:
Analisi della performance temporale della rete In questo documento viene analizzato l andamento nel tempo della performance della rete di promotori. Alcune indicazioni per la lettura di questo documento:
1. Distribuzioni campionarie
 Università degli Studi di Basilicata Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale - a.a. 2012/2013 lezioni di statistica del 3 e 6 giugno 2013 - di Massimo Cristallo - 1. Distribuzioni campionarie
Università degli Studi di Basilicata Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale - a.a. 2012/2013 lezioni di statistica del 3 e 6 giugno 2013 - di Massimo Cristallo - 1. Distribuzioni campionarie
ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA. 2 Livello
 ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA 2 Livello UD 30.2 Anno primo Alfabetizzazione italiana II 1 Competenze usare forme linguistiche di base per gestire dialoghi semplici e interagire in situazioni interpersonali
ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA 2 Livello UD 30.2 Anno primo Alfabetizzazione italiana II 1 Competenze usare forme linguistiche di base per gestire dialoghi semplici e interagire in situazioni interpersonali
Risarcimento danno medici corsi specializzazione Facciamo chiarezza. 18/03/2014 Studio Legale Ferrari Paola Ferrari Nicola Di Lernia
 Risarcimento danno medici corsi specializzazione Facciamo chiarezza 18/03/2014 Studio Legale Ferrari Paola Ferrari Nicola Di Lernia SPECIALIZZANDI DALL'1.1.1983 ALL'ANNO ACCADEMICO 1990/91 Prima di far
Risarcimento danno medici corsi specializzazione Facciamo chiarezza 18/03/2014 Studio Legale Ferrari Paola Ferrari Nicola Di Lernia SPECIALIZZANDI DALL'1.1.1983 ALL'ANNO ACCADEMICO 1990/91 Prima di far
Discussione di casi clinici
 Discussione di casi clinici Marcella Ferrari marcella.ferrari@unipv.it Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Laboratorio di Psicologia dell Apprendimento Master in Esperto in Disturbi dell
Discussione di casi clinici Marcella Ferrari marcella.ferrari@unipv.it Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Laboratorio di Psicologia dell Apprendimento Master in Esperto in Disturbi dell
Esercizi del programma (solo su CD-ROM)
 Esercizi Esercizi del programma (solo su CD-ROM) Utilizzo dei comandi Per capire il significato dei termini utilizzati nei video è possibile consultare il glossario.. Passa alla schermata successiva. Ritorna
Esercizi Esercizi del programma (solo su CD-ROM) Utilizzo dei comandi Per capire il significato dei termini utilizzati nei video è possibile consultare il glossario.. Passa alla schermata successiva. Ritorna
Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.
 In un mercato del lavoro competitivo esistono due tipi di lavoratori, quelli con alta produttività L A, che producono per 30 $ l'ora, e quelli con bassa produttività, L B, che producono per 5 $ l'ora.
In un mercato del lavoro competitivo esistono due tipi di lavoratori, quelli con alta produttività L A, che producono per 30 $ l'ora, e quelli con bassa produttività, L B, che producono per 5 $ l'ora.
L armonizzazione dei sistemi contabili
 L armonizzazione dei sistemi contabili Il percorso di avvicinamento della Regione Torino, 20 ottobre 2014 I nuovi principi contabili Definizione di principi contabili Principi contabili Disposizioni tecniche
L armonizzazione dei sistemi contabili Il percorso di avvicinamento della Regione Torino, 20 ottobre 2014 I nuovi principi contabili Definizione di principi contabili Principi contabili Disposizioni tecniche
Programmazione di greco e latino. Primo e secondo anno dell indirizzo internazionale
 Programmazione di greco e latino Primo e secondo anno dell indirizzo internazionale -Premessa Lo studio della lingua e della letteratura greca e latina è, per comune consenso, indispensabile a tutti coloro
Programmazione di greco e latino Primo e secondo anno dell indirizzo internazionale -Premessa Lo studio della lingua e della letteratura greca e latina è, per comune consenso, indispensabile a tutti coloro
13271 - LINGUA INGLESE (a.a. 2013/14-6cfu) Peter Taylor (docente responsabile) David Verzoni, Derick Capaldi (course tutors)
 13271 - LINGUA INGLESE (a.a. 2013/14-6cfu) Peter Taylor (docente responsabile) David Verzoni, Derick Capaldi (course tutors) 1. Il corso si articola in due livelli (Livello intermedio & Livello medio-avanzato):
13271 - LINGUA INGLESE (a.a. 2013/14-6cfu) Peter Taylor (docente responsabile) David Verzoni, Derick Capaldi (course tutors) 1. Il corso si articola in due livelli (Livello intermedio & Livello medio-avanzato):
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof.ssa ANTONELLA PERESSINI A.S. 2015/2016 CLASSE 1 ALL MATERIA: LINGUA LATINA
 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof.ssa ANTONELLA PERESSINI A.S. 2015/2016 CLASSE 1 ALL MATERIA: LINGUA LATINA Modulo n. 1 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL LATINO Collocazione temporale: settembre e ottobre riconoscere
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE prof.ssa ANTONELLA PERESSINI A.S. 2015/2016 CLASSE 1 ALL MATERIA: LINGUA LATINA Modulo n. 1 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL LATINO Collocazione temporale: settembre e ottobre riconoscere
Nato/a a il Cittadino/a. Residente a in Via nr. Stato. Telefono email Pec DICHIARA
 ZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE (ARTT. 5 e ss. DIRETTIVA 2005/36/CE) Al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato,
ZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE (ARTT. 5 e ss. DIRETTIVA 2005/36/CE) Al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato,
NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
 CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE TERZA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto. Processi di controllo da mettere in atto durante l ascolto
CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE TERZA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto. Processi di controllo da mettere in atto durante l ascolto
ASPETTI OPERATIVI TASI. Tabella comuni La tabelle è stata implementata con diversi campi e prospetti utili allo sviluppo calcolo della TASI.
 ASPETTI OPERATIVI TASI Tabella comuni La tabelle è stata implementata con diversi campi e prospetti utili allo sviluppo calcolo della TASI. Data pubblicazione delibera Aliq./Detr. TASI questo campo è fondamentale
ASPETTI OPERATIVI TASI Tabella comuni La tabelle è stata implementata con diversi campi e prospetti utili allo sviluppo calcolo della TASI. Data pubblicazione delibera Aliq./Detr. TASI questo campo è fondamentale
Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti A.A. 2009/2010
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti A.A. 2009/2010 Aprile 2011 Indice Premessa 1. La metodologia adottata. 3 2. Lo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti A.A. 2009/2010 Aprile 2011 Indice Premessa 1. La metodologia adottata. 3 2. Lo
Unità 18. Le certificazioni di italiano L2. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A2 CHIAVI
 Unità 18 Le certificazioni di italiano L2 CHIAVI In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sul test di lingua per stranieri parole relative alle certificazioni di italiano,
Unità 18 Le certificazioni di italiano L2 CHIAVI In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sul test di lingua per stranieri parole relative alle certificazioni di italiano,
Scuola superiore per mediatori linguistici Carlo Bo di Roma FONETICA: LA LINGUA ITALIANA
 Scuola superiore per mediatori linguistici Carlo Bo di Roma FONETICA: LA LINGUA ITALIANA LA SITUAZIONE ITALIANA Molto sinteticam ente si può osservare che la situazione delle parlate con cui ci si esprim
Scuola superiore per mediatori linguistici Carlo Bo di Roma FONETICA: LA LINGUA ITALIANA LA SITUAZIONE ITALIANA Molto sinteticam ente si può osservare che la situazione delle parlate con cui ci si esprim
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE
 DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE (articoli 5 e seguenti della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE) Al
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE (articoli 5 e seguenti della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE) Al
LE PREVISIONI DELLE FAMIGLIE
 LE PREVISIONI DELLE FAMIGLIE Trieste aprile 2013 Riproduzioni e stampe dovranno riportare in modo visibile la fonte e la proprietà dell informazione. Inoltre, su richiesta al Servizio Statistica del Comune
LE PREVISIONI DELLE FAMIGLIE Trieste aprile 2013 Riproduzioni e stampe dovranno riportare in modo visibile la fonte e la proprietà dell informazione. Inoltre, su richiesta al Servizio Statistica del Comune
5 - CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PERLA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
 5 - CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PERLA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) Analisi della situazione Il ruolo del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale è disciplinato dall articolo
5 - CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PERLA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) Analisi della situazione Il ruolo del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale è disciplinato dall articolo
Istituto Comprensivo «G. Marconi», Castelfranco Emilia CURRICOLO VERTICALE DI GRAMMATICA e RIFLESSIONE LINGUISTICA
 Istituto Comprensivo «G. Marconi», Castelfranco Emilia CURRICOLO VERTICALE DI GRAMMATICA e RIFLESSIONE LINGUISTICA INDICE 1 - Prerequisiti in entrata alla Scuola Primaria 2 Scuola Primaria Classe prima
Istituto Comprensivo «G. Marconi», Castelfranco Emilia CURRICOLO VERTICALE DI GRAMMATICA e RIFLESSIONE LINGUISTICA INDICE 1 - Prerequisiti in entrata alla Scuola Primaria 2 Scuola Primaria Classe prima
LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE
 LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE LETTERE AL GINNASIO Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: aver raggiunto una conoscenza adeguata
LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE LETTERE AL GINNASIO Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: aver raggiunto una conoscenza adeguata
CONSIGLIO REGIONALE [DEL PIEMONTE INTERROGAZIONE P 4127"
 Consiglio Regionale P i emont e del O02a320/PG 14/06/2012 CONSIGLIO REGIONALE [DEL PIEMONTE 15:17 14 GIÙ 2012 (101080 08204B INTERROGAZIONE P 4127" ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo
Consiglio Regionale P i emont e del O02a320/PG 14/06/2012 CONSIGLIO REGIONALE [DEL PIEMONTE 15:17 14 GIÙ 2012 (101080 08204B INTERROGAZIONE P 4127" ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo
Le scelte del consumatore in condizione di incertezza (cap.5)
 Le scelte del consumatore in condizione di incertezza (cap.5) Che cos è il rischio? Come possiamo indicare le preferenze del consumatore riguardo al rischio? C è chi acquista assicurazione (non ama il
Le scelte del consumatore in condizione di incertezza (cap.5) Che cos è il rischio? Come possiamo indicare le preferenze del consumatore riguardo al rischio? C è chi acquista assicurazione (non ama il
I libri di testo. Carlo Tarsitani
 I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
Modulo: I. Mi presento Livello: Alto
 1. Mi presento Scrivere i propri dati, parlare di sé, ripasso basi di grammatica e ortografia Saluti, nome, cognome, parlare di sé e della propria personalità basi di ortografia Facsimile carta d identità
1. Mi presento Scrivere i propri dati, parlare di sé, ripasso basi di grammatica e ortografia Saluti, nome, cognome, parlare di sé e della propria personalità basi di ortografia Facsimile carta d identità
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE
 SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE DISCIPLINA AREA ANTROPOLOGICA CLASSI QUINTE LINEE DI COLLEGAMENTO CON IL POF (1)..... PROGETTI.... PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE CLASSE V A-B-C-D DISCIPLINA
SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE DISCIPLINA AREA ANTROPOLOGICA CLASSI QUINTE LINEE DI COLLEGAMENTO CON IL POF (1)..... PROGETTI.... PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE CLASSE V A-B-C-D DISCIPLINA
1. Come si distinguono i tre modi di analisi del suono in fonetica?
 RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL CAPITOLO 3 1. Come si distinguono i tre modi di analisi del suono in fonetica? I modi di analisi del suono sono tre: il percettivo, l'acustico e l'articolatorio. Possiamo ricondurre
RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL CAPITOLO 3 1. Come si distinguono i tre modi di analisi del suono in fonetica? I modi di analisi del suono sono tre: il percettivo, l'acustico e l'articolatorio. Possiamo ricondurre
Facoltà di Lettere efilosofia, Cagliari
 L alfabeto greco L alfabeto greco consta di 24 lettere: 7 vocali e 17 consonanti. Maiuscola Minuscola Nome della lettera Trascrizione latina Pronuncia Α α Alfa a [a] es. amico Β β Beta b [b]es. base Γ
L alfabeto greco L alfabeto greco consta di 24 lettere: 7 vocali e 17 consonanti. Maiuscola Minuscola Nome della lettera Trascrizione latina Pronuncia Α α Alfa a [a] es. amico Β β Beta b [b]es. base Γ
Le regole fonologiche nella fonologia segmentale/lineare
 Le regole fonologiche nella fonologia segmentale/lineare Nella teoria segmentale della fonologia, la rappresentazione consiste in una sequenza lineare di segmenti (consonanti, vocali ed approssimanti)
Le regole fonologiche nella fonologia segmentale/lineare Nella teoria segmentale della fonologia, la rappresentazione consiste in una sequenza lineare di segmenti (consonanti, vocali ed approssimanti)
Griglia di correzione Fascicolo di Italiano Prova Nazionale anno scolastico 2008-2009
 Griglia di correzione Fascicolo di Italiano Prova Nazionale anno scolastico 2008-2009 Il buon nome - Chiavi di risposta e classificazione degli item Item Risposta corretta Ambito di valutazione Processi
Griglia di correzione Fascicolo di Italiano Prova Nazionale anno scolastico 2008-2009 Il buon nome - Chiavi di risposta e classificazione degli item Item Risposta corretta Ambito di valutazione Processi
LE COMPETENZE ESSENZIALI DI SPAGNOLO
 LE ESSENZIALI DI SPAGNOLO classe prima Liceo linguistico comprendere informazioni dirette e concrete su argomenti quotidiani comprendere e seguire istruzioni brevi e semplici comprendere il senso generale
LE ESSENZIALI DI SPAGNOLO classe prima Liceo linguistico comprendere informazioni dirette e concrete su argomenti quotidiani comprendere e seguire istruzioni brevi e semplici comprendere il senso generale
Lingua inglese Domande ricorrenti (e relative risposte) (corsi della Prof. Stefania Maria MACI)
 Lingua inglese Domande ricorrenti (e relative risposte) (corsi della Prof. Stefania Maria MACI) Non potrò frequentare tutte le sue lezioni perché lavoro (oppure si sovrappongono con quelle del corso XY):
Lingua inglese Domande ricorrenti (e relative risposte) (corsi della Prof. Stefania Maria MACI) Non potrò frequentare tutte le sue lezioni perché lavoro (oppure si sovrappongono con quelle del corso XY):
Introduzione alla storia della lingua gaelica
 Introduzione alla storia della lingua gaelica Anna Fattovich EUT Edizioni Università di Trieste ISBN 978-88-8303-316-2 Sommario Introduzione allo studio della lingua gaelica 4 Proto-celtico 9 Stadi della
Introduzione alla storia della lingua gaelica Anna Fattovich EUT Edizioni Università di Trieste ISBN 978-88-8303-316-2 Sommario Introduzione allo studio della lingua gaelica 4 Proto-celtico 9 Stadi della
2 Come consueto in letteratura, si distinguono terminologicamente i casi nei quali
 STUDIO SULL APPRENDIMENTO DEL CONSONANTISMO SPAGNOLO DA PARTE DI ITALOFONI Emanuela Colonna, Barbara Gili Fivela Università degli Studi di Lecce coleman2078@yahoo.it; gili@sns.it 1. SOMMARIO In questo
STUDIO SULL APPRENDIMENTO DEL CONSONANTISMO SPAGNOLO DA PARTE DI ITALOFONI Emanuela Colonna, Barbara Gili Fivela Università degli Studi di Lecce coleman2078@yahoo.it; gili@sns.it 1. SOMMARIO In questo
IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2
 Arcangela Mastromarco IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 Centro COME 2002 Centro COME, Farsi Prossimo Onlus www.centrocome.it 1 Presentazione IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 La declinazione
Arcangela Mastromarco IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 Centro COME 2002 Centro COME, Farsi Prossimo Onlus www.centrocome.it 1 Presentazione IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO L2 La declinazione
CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
 CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DIMENSIONI CRITERI INDICATORI
 Allegato 4 - Manerbio META EDUCATIVA: autonomia in ambito scolastico (classe 4/5 scuola primaria) DIMENSIONI CRITERI INDICATORI GESTIONALE OPERATIVA Uso degli strumenti Conoscere gli strumenti necessari
Allegato 4 - Manerbio META EDUCATIVA: autonomia in ambito scolastico (classe 4/5 scuola primaria) DIMENSIONI CRITERI INDICATORI GESTIONALE OPERATIVA Uso degli strumenti Conoscere gli strumenti necessari
Le risorse finanziarie dei Comuni siciliani tra il 2009 e il 2015. luglio 2015. A cura del Segretario Generale dell AnciSicilia Mario Emanuele Alvano
 Le risorse finanziarie dei Comuni siciliani tra il 2009 e il 2015 luglio 2015 A cura del Segretario Generale dell AnciSicilia Mario Emanuele Alvano INDICE Indice p. 2 Premessa p. 3 Quadro delle risorse
Le risorse finanziarie dei Comuni siciliani tra il 2009 e il 2015 luglio 2015 A cura del Segretario Generale dell AnciSicilia Mario Emanuele Alvano INDICE Indice p. 2 Premessa p. 3 Quadro delle risorse
Università di Friburgo (Svizzera) Facoltà di lettere Dipartimento di lingue e letterature Ambito Italiano
 Università di Friburgo (Svizzera) Facoltà di lettere Dipartimento di lingue e letterature Ambito Italiano Bachelor of Arts Italiano ambito principale (0 crediti ECTS) Piano di studi I. DISPOSIZIONI GENERALI
Università di Friburgo (Svizzera) Facoltà di lettere Dipartimento di lingue e letterature Ambito Italiano Bachelor of Arts Italiano ambito principale (0 crediti ECTS) Piano di studi I. DISPOSIZIONI GENERALI
Teoria e metodologia estimativa
 Teoria e metodologia estimativa Definizioni L estimo è la parte della scienza economica definibile come l insieme dei principi logici e metodologici che regolano e, quindi, consentono la motivata, oggettiva
Teoria e metodologia estimativa Definizioni L estimo è la parte della scienza economica definibile come l insieme dei principi logici e metodologici che regolano e, quindi, consentono la motivata, oggettiva
La valutazione dell opinione degli studenti sulla didattica
 La valutazione dell opinione degli studenti sulla didattica Gli esiti della rilevazione 2012-2013 Anna Maria Milito 26 novembre 2013 La rilevazione dell opinione degli studenti sulla didattica Importanza
La valutazione dell opinione degli studenti sulla didattica Gli esiti della rilevazione 2012-2013 Anna Maria Milito 26 novembre 2013 La rilevazione dell opinione degli studenti sulla didattica Importanza
Contratto Formativo Individuale
 Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico 2010 2011 Contratto Formativo Individuale Classe: 1ª Sez: F Materia: Latino Docente: Annalisa Campanaro Capacità 1.ANALISI DELLA CLASSE: sufficienti
Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico 2010 2011 Contratto Formativo Individuale Classe: 1ª Sez: F Materia: Latino Docente: Annalisa Campanaro Capacità 1.ANALISI DELLA CLASSE: sufficienti
STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.
 Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs
Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs
Istituto Comprensivo di Cologna Veneta Curricolo Scuola Primaria a.s. 2015/2016
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni, di classe o di gruppi) con compagni e insegnanti rispettando
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni, di classe o di gruppi) con compagni e insegnanti rispettando
TELL ME MORE Funzionamento del riconoscimento vocale
 TELL ME MORE Funzionamento del riconoscimento vocale Sommario INFORMAZIONI GENERALI... 3 IL RIQUADRO DEL RICONOSCIMENTO VOCALE... 3 ATTIVITÀ CON RICONOSCIMENTO VOCALE... 3 LE DUE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO...
TELL ME MORE Funzionamento del riconoscimento vocale Sommario INFORMAZIONI GENERALI... 3 IL RIQUADRO DEL RICONOSCIMENTO VOCALE... 3 ATTIVITÀ CON RICONOSCIMENTO VOCALE... 3 LE DUE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO...
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE*
 Liceo Chiabrera Martini Classico-Linguistico-Artistico 17100 Savona Via Caboto, 2 - Tel. 019/821277-8 Fax 019/821277 Cod. fis. 92090320091 Cod. Mecc. SVIS00800D E-mail: classico@liceochiabrera.it www.chiabreramartini.it
Liceo Chiabrera Martini Classico-Linguistico-Artistico 17100 Savona Via Caboto, 2 - Tel. 019/821277-8 Fax 019/821277 Cod. fis. 92090320091 Cod. Mecc. SVIS00800D E-mail: classico@liceochiabrera.it www.chiabreramartini.it
Verdi Cafaro ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Giuseppe Pasquale Verdi Cafaro ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado Sede centrale Via G. Verdi, n. 65-76123 Andria (BT) Telefono 0883 246.239 - Fax 0883-56.45.45
Giuseppe Pasquale Verdi Cafaro ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado Sede centrale Via G. Verdi, n. 65-76123 Andria (BT) Telefono 0883 246.239 - Fax 0883-56.45.45
PIL ANNO PROPEDEUTICO. 1º semestre. Pro Seminario. 95558 Ricerca scientifica 3 ECTS P. Gunter (responsabile) - P.A. Muroni - O.M.
 ANNO PROPEDEUTICO ANNO PROPEDEUTICO 293 1º semestre Pro Seminario 95558 Ricerca scientifica 3 ECTS P. Gunter (responsabile) - P.A. Muroni - O.M. Sarr Obiettivi: Al termine del corso lo studente: Gli studenti
ANNO PROPEDEUTICO ANNO PROPEDEUTICO 293 1º semestre Pro Seminario 95558 Ricerca scientifica 3 ECTS P. Gunter (responsabile) - P.A. Muroni - O.M. Sarr Obiettivi: Al termine del corso lo studente: Gli studenti
lo schema di partenza
 COSTRUZIONE DELLA TESI DI LAUREA lo schema di partenza Inquadrare l argomento Individuare l oggetto della ricerca Argomentare ogni affermazione Documentare correttamente i supporti tecnologici e bibliografici
COSTRUZIONE DELLA TESI DI LAUREA lo schema di partenza Inquadrare l argomento Individuare l oggetto della ricerca Argomentare ogni affermazione Documentare correttamente i supporti tecnologici e bibliografici
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ENRICO TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) CENTRO IDA
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ENRICO TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) CENTRO IDA PROGETTO Assegnazione della quota destinata alle Aree a Forte Processo Immigratorio 1.1 Denominazione progetto Percorso
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ENRICO TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) CENTRO IDA PROGETTO Assegnazione della quota destinata alle Aree a Forte Processo Immigratorio 1.1 Denominazione progetto Percorso
Ferreiro e Teberosky. Ferreiro e Teberosky. Lo sviluppo delle idee sulla scrittura
 Ferreiro e Teberosky Ferreiro e Teberosky Lo sviluppo delle idee sulla scrittura Studiose di orientamento piagetiano Studio sullo sviluppo delle conoscenze Piaget rappresentazione dei fenomeni fisici nel
Ferreiro e Teberosky Ferreiro e Teberosky Lo sviluppo delle idee sulla scrittura Studiose di orientamento piagetiano Studio sullo sviluppo delle conoscenze Piaget rappresentazione dei fenomeni fisici nel
MANUALE ESSE3. Iscrizione alle prove d esame e visione esiti STUDENTI
 MANUALE ESSE3 Iscrizione alle prove d esame e visione esiti STUDENTI 1 INDICE 1. TIPOLOGIE DI PROVE D ESAME IN ESSE3 E OPERAZIONI DEGLI STUDENTI... 3 1.1. Prove d esame in Esse3... 3 1.2. Operazioni richieste
MANUALE ESSE3 Iscrizione alle prove d esame e visione esiti STUDENTI 1 INDICE 1. TIPOLOGIE DI PROVE D ESAME IN ESSE3 E OPERAZIONI DEGLI STUDENTI... 3 1.1. Prove d esame in Esse3... 3 1.2. Operazioni richieste
Anno 1. Definizione di Logica e operazioni logiche
 Anno 1 Definizione di Logica e operazioni logiche 1 Introduzione In questa lezione ci occuperemo di descrivere la definizione di logica matematica e di operazioni logiche. Che cos è la logica matematica?
Anno 1 Definizione di Logica e operazioni logiche 1 Introduzione In questa lezione ci occuperemo di descrivere la definizione di logica matematica e di operazioni logiche. Che cos è la logica matematica?
Corso di laurea in Storia e Civiltà
 Corso di laurea in Storia e Civiltà Piano di studi Percorso Contemporaneo Attività formativa Storia comparata delle società contemporanee 12 Storia della politica ( ); - Storia dell'italia contemporanea
Corso di laurea in Storia e Civiltà Piano di studi Percorso Contemporaneo Attività formativa Storia comparata delle società contemporanee 12 Storia della politica ( ); - Storia dell'italia contemporanea
Test di italiano di livello A2 e Permesso di soggiorno CE
 Unità 16 Test di italiano di livello A2 e Permesso di soggiorno CE In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sul Test di italiano per ottenere il Permesso di soggiorno CE parole
Unità 16 Test di italiano di livello A2 e Permesso di soggiorno CE In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sul Test di italiano per ottenere il Permesso di soggiorno CE parole
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO
 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
Fasi concettualizzazione lingua scritta FASE PRECONVENZIONALE FASI DI CONCETTUALIZZAZIONE LINGUA SCRITTA
 FASI DI CONCETTUALIZZAZIONE LINGUA SCRITTA Per conoscere in quale stadio del processo di apprendimento si trova ogni singolo alunno all'inizio della prima elementare è importante far riferimento alla ricerca
FASI DI CONCETTUALIZZAZIONE LINGUA SCRITTA Per conoscere in quale stadio del processo di apprendimento si trova ogni singolo alunno all'inizio della prima elementare è importante far riferimento alla ricerca
LA DISLESSIA. Lucia Papalia lugr.papalia@libero.it
 LA DISLESSIA Lucia Papalia lugr.papalia@libero.it DISLESSIA È un disturbo di automatizzazione delle procedure di transcodifica dei segni scritti in corrispondenti fonologici che emerge all inizio della
LA DISLESSIA Lucia Papalia lugr.papalia@libero.it DISLESSIA È un disturbo di automatizzazione delle procedure di transcodifica dei segni scritti in corrispondenti fonologici che emerge all inizio della
L età dei vincitori La presenza femminile. L età dei vincitori La presenza femminile. Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
 Premessa Corso-concorso ordinario L età dei vincitori La presenza femminile Corso-concorso riservato L età dei vincitori La presenza femminile Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
Premessa Corso-concorso ordinario L età dei vincitori La presenza femminile Corso-concorso riservato L età dei vincitori La presenza femminile Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
Sintassi della LIS 01. I dati Restrizioni e relazioni d ordine
 Sintassi della LIS 01 I dati Restrizioni e relazioni d ordine Argomento della lezione In questa lezione ci occuperemo della struttura sintattica delle frasi della LIS. Partendo dalle considerazioni che
Sintassi della LIS 01 I dati Restrizioni e relazioni d ordine Argomento della lezione In questa lezione ci occuperemo della struttura sintattica delle frasi della LIS. Partendo dalle considerazioni che
ELEMENTI DI DEMOGRAFIA
 ELEMENTI DI DEMOGRAFIA 2. Caratteristiche strutturali della popolazione Posa Donato k posa@economia.unisalento.it Maggio Sabrina k s.maggio@economia.unisalento.it UNIVERSITÀ DEL SALENTO DIP.TO DI SCIENZE
ELEMENTI DI DEMOGRAFIA 2. Caratteristiche strutturali della popolazione Posa Donato k posa@economia.unisalento.it Maggio Sabrina k s.maggio@economia.unisalento.it UNIVERSITÀ DEL SALENTO DIP.TO DI SCIENZE
