Relazioni Industriali, Contratti a termine e produttività: una prospettiva di politica del lavoro
|
|
|
- Casimiro Tucci
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni Relazioni Industriali, Contratti a termine e produttività: una prospettiva di politica del lavoro Andrea Ricci Conferenza ESPAnet Italia, Torino, settembre 2014
2 OBIETTIVO Il libro Mercato del Lavoro, capitale umano e imprese, rappresenta un tentativo sistematico di mettere in relazione le politiche del mercato del lavoro e il funzionamento del sistema delle imprese italiane ponendo particolare attenzione al tema del capitale umano dei lavoratori e degli imprenditori. In questa prospettiva, le analisi empiriche presentate nel libro sono articolate in una logica di comparazione sia internazionale che nazionale, in senso statico e dinamico, utilizzando dati di impresa e informazioni sui lavoratori, a livello aggregato e microeconomico. Quali sono i risultati principali? Quali implicazioni per la politica economica e sociale? 2
3 Riforme del mercato del lavoro e crescita della produttività: un introduzione Il Analisi di natura comparativa, dinamica e aggregata per misurare gli effetti che le politiche del lavoro e, segnatamente, il processo di deregolamentazione dei norme a tutela del lavoro temporaneo hanno esercitato sulla evoluzione della produttività, dell occupazione e dei salari nei principali paesi europei. Inparticolareleanalisiempirichecondottesudati difonteeurostateocseperilperiodocheva dadalla metà degli anni 90 fino alla vigilia della crisi del 2008 si pongono l obiettivo di verificare se la diminuzione delle norme a tutela del lavoro temporaneo e la conseguente diffusione dei contratti a termine ha causato un significativa riduzione del tasso di crescita settoriale della produttività totale dei fattori nel complesso dell area dell euro 3
4 I dati (1) L esame della relazione che lega le riforme del mercato del lavoro e l evoluzione della produttività dei fattori si sviluppa sulla base di diverse fonti statistiche: i dati EU Klems forniscono le informazioni relative alla performance produttiva, al valore aggiunto e all intensità del capitale nei diversi settori e paesi(van Ark e altri, 2009); gli indici dell Ocse sono usati per misurare le norme a tutela dell'occupazione per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (Eplr) e per quelli con contratti temporanei (Eplt), nonché il grado di regolamentazione del mercato dei prodotti(pmr) in ciascun paese esaminato; i dati Eurostat permettono di ricostruire le serie temporali relative l andamento del tasso di occupazione (a tempo determinato e indeterminato) per ciascun paese e settore, nonché le informazioni relative alla propensione innovativa, identificata dal totale delle spese in R&S, standardizzate rispetto al valore aggiunto settoriale; Il campione di riferimento è costituito da 14 paesi europei e 10 settori di attività. I paesi inclusi nel campione sono: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito. 4
5 Statistiche descrittive(1): dinamica nazionale della Ptf L analisi descrittiva del tasso (medio) annuale di crescita della Ptf nei diversi paesi e settori di attività del nostro campione per il periodo permette di distinguere tre gruppi di paesi sulla base della performance produttive nazionali: Il primo gruppo è identificato da quelle economie che hanno sperimentato un tasso di crescita delle Ptf superiore ad un punto percentuale nel complesso degli anni in esame (Austria, Finlandia e Ungheria); Un secondo gruppo è dato dai paesi con una crescita debole ma positiva (Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Repubblica Ceca, Irlanda e Svezia); Nel terzo gruppo vi sono quelle economie in cui vi è stato un arretramento della dinamica della Ptf(Belgio, Spagna, Danimarca e Italia). 5
6 Statistiche descrittive (3): variazione norme a protezione dell impiego Variazione norme sul lavoro a tempo determinato ( indice Eplt) La riduzione dell indice Eplt ha riguardato un ben definito gruppo di paesi: Svezia (-0.5 ), Olanda (-1.2), Belgio (-2), Germania (-2) e soprattutto Italia (-3.5 punti). Altri paesi hanno sperimentato un lieve incremento indice Eplt (Spagna, Repubblica Ceca, Irlanda, Ungheria). L indice Eplt è rimasto invece sostanzialmente invariato in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia e Regno Unito. Variazione norme sul lavoro a tempo indeterminato(indice Eplr) Le variazioni dell indice Eplr limitate in valore assoluto, sia nei paesi dove vi sono state aumentate le tutele(germania, Francia, Regno Unito) sia in quelli che ne hanno alleggerito le norme a protezione del lavoro a tempo indeterminato (Olanda, Austria, Finlandia, Spagna, Repubblica Ceca) 6
7 Produttività totale dei fattori, (1995=100) 7
8 Il caso dell Italia In Italia è assistito alla riduzione più rilevante delle norme a tutela del lavoro temporaneo: da noi l indicatore Eplt è diminuito di 3,5 punti a fronte di una riduzione di 0,4 punti registrata per la media delle altre economie europee nel corso degli anni Nello stesso periodo di tempo, l Italia ha registrato le peggiori performance per ciò che concerne la dinamica della produttività: la diminuzione cumulata della Ptf è stata di circa 3,7 punti percentuali. Una evidenza in chiaro contrasto con quanto accaduto nell economia europea dove vi è stata una crescita cumulata della Ptf di 7 punti percentuali. Le stime diff in diff razionalizzano questa evidenza dimostrando un ruolo distorsivo giocato dalle riforme del mercato del lavoro nel nostro paese 8
9 Profitti, produttività e uso dei contratti a termine: il ruolo del capitale umano (degli imprenditori) Obiettivo Analizzare in che misura le strategie aziendali basate sulla compressione del costo del lavoro e sulla ricerca della profittabilità(pur in presenza di una scarsa produttività e efficienza dei fattori produttivi) sono in grado di garantire un livello di competitività adeguato per rimanere sul mercato nel medio lungo periodo, soprattutto in presenza di mercati internazionali altamente integrati da un punto di vista reale e finanziario e in periodo di grande cambiamento tecnologico. A tal fine si opera una classificazione delle imprese in quattro tipologie, sulla base di un criterio di classificazione che ordina il modello competitivo da esse adottato in funzione del perseguimento della profittabilità e/o della produttività: le imprese marginaliche presentano indici di redditività e di produttività al di sotto del valore mediano di tali indici riferito al settore di appartenenza. imprese di media qualità (o imprese prevalentemente profittevoli) che presentano indici di bassa produttività e di alta profittabilità, rispetto al valore mediano del settore in cui operano. imprese di buonaqualità (oimprese prevalentemente efficienti) che presentano indici di produttività sopra la mediana e indici di profittabilità al di sotto della mediana. Imprese eccellenti, caratterizzate da indici di produttività e redditività superiori al corrispondente valore mediano 9
10 Ipotesi sul modello competitivo La classificare delle tipologie di imprese in 4 categorie ordinate contiene un ipotesi che le imprese prevalentemente efficientisiano preferibili a quelleprevalentemente profittevoli. Questa ipotesi, a sua volta, può essere giustificata perseguire la redditività, anche a discapito di un organizzazione efficiente dei fattori produttivi, aumenta il rischio di uscire furori dal mercato in un orizzonte di medio-lungo periodo, data la crescente pressione competitiva sui costi di produzione (e su quello del lavoro in particolare) in un economia globalizzata. Al contrario, ci si aspetta che le imprese che presentano una elevata produttività pur in presenza di una scarsa redditività siano favorite dalle tendenze strutturali che indicano nell investimento in innovazione e nell accrescimento del valore produttivo la leva cruciale per sostenere nel medio-lungo periodo la crescente pressione competitiva dei mercati internazionali. L individuazione delle imprese di marginali e quelle eccellenti è chiara, per ragioni opposte. Le imprese di cattiva qualità tendono ad uscire dal mercato, mentre quelle di buona ottima qualità presentano gli indici di performance migliori sotto tutti i punti di vista 10
11 Dati e Statistiche descrittive L'analisi empirica si basa sui dati forniti dalla Rilevazione sulle imprese e sui lavoratori(ril) condotta da Isfolnel 2010 su un campione rappresentativo di oltre operanti nel settore privato non agricolo. I dati Rilrelativi al 2010 raccolgono una ricca serie di informazioni sul livello di istruzione e le caratteristiche demografiche degli imprenditori, sulla la struttura proprietaria e manageriale delle aziende da essi gestite, sulla la composizione della forza lavoro occupata, ecc. Al fine di collegare queste informazioni a indicatori di performance aziendale, un sotto-campione del dataset Rilè stato integrato (usando i codici fiscali) con i dati sui bilanci certificati dell archivio AIDA per le società di capitali La selezione del campione: si considerano solo le imprese con almeno cinque dipendenti; il campione finale su cui viene eseguita l'analisi conta oltre 5000 società di capitali operanti nel settore extra agricolo 11
12 Classificazione delle imprese in 4 tipologie La classificazione di ottiene componendo due indici di perfomance aziendale: un indice di efficienza definito dalla produttività del lavoro (valore aggiunto su numero di addetti, ProdLav) e un indice di profittabilità definito dal reddito operativo sulle vendite (Return on Sales, ROS). Per entrambi gli indicatori ProdLav e Ros sono misurati i corrispondenti valori mediani relativi a ciascun settore di attività produttiva: ogni impresa del campione Ril-AIDA è classificata in ognuna delle quattro tipologie in base alla circostanza che abbia un livello di produttività e di profittabilità, maggiori o minori della mediana del settore in cui opera. La tabella esemplifica la procedura seguita per realizzare tale classificazione: Produttività del lavoro ROS (Reddito operativo/vendite) > mediana <mediana > mediana A (eccellente) C (buona) < mediana B (media) D (marginale) 12
13 Tabella 1 Media Statistiche descrittive Std dev caratteristiche imprenditori istruzione terziaria istruzione secondaria sup istruzione secondaria inf età< <età< età> caratteristiche lavoratori % istruzione terziaria % istruzione secondaria sup % istruzione secondaria inf % formati % contratti a termine % donne caratteristiche imprese proprietà familiare gestione manageriale mercato estero innov prodotto innov processo <n. dipendenti< < n. dipendenti< < n. dipendenti< n. dipendenti> N of osservazioni 5096 Fonte: dati Ril-Aida La dotazione di capitale umano degli imprenditori in Italia è significativamente inferiore al valori medi negli altri paesi europei. L istruzione degli imprenditori influenza la logica di competizione attraverso comportamenti avversi al rischio e soggetti al condizionamento delle preferenza iperboliche (miopia verso il futuro) Ipotesi: imprenditori poco istruiti tendono a sopravvalutare i rendimenti di breve periodo delle proprie scelte, e a sottovalutare i rendimenti di medio lungo periodo derivanti dai progetti di investimento 13
14 Analisi econometrica La classificazione di quattro categorie ordinate di imprese permette di sviluppare un analisi econometrica sulle determinanti della strategia di competizione delle aziende attraverso un modello di regressione Ordered Probit. Formalmente, si indica con Y una variabile indice della performance competitiva che può assumere quattro valori (o categorie) ordinate in senso crescente [0,1,2,3]: Y=0 per quelle imprese in cui sia il Ros che la produttività sono inferiori del loro valore mediano; Y=1 se sono imprese hanno un Ros superiore al suo valore mediano, mentre un produttività del lavoro è inferiore al valore mediano; Y=2 se le imprese presentano un Ros inferiore alla sua media e produttività superiore alla mediana; infine Y=3 per quelle imprese che hanno sia il Ros e la produttività del lavoro superiore rispetto ai loro valori medi. Sesi assumechela variabilelatentey * dipenda da un insiemedi caratteristicheproduttiveedemografichedei lavoratori, degli imprenditori e delle imprese y*=β₀man+β₁work+β₂firm+ε dove il vettore Man include caratteristiche manageriali, il vettore Work rappresenta la composizione della forza lavoro e Firm l insieme di caratteristiche delle imprese. Il termine di errore idiosincratico è tale che ε ~ N (0,1). 14
15 Risultati delle stime Ordered probit Tabella 4: Stima effetti medi marginali "marginali" "media" "buona" "eccellente" dy/dx St. Er dy/dx std er dy/dx st er dy/dx st er caratteristiche imprenditori istruzione terziaria *** ** *** *** istruzione secondaria sup <età< ** ** * ** età> *** *** *** *** caratteristiche lavoratori % istruzione terziaria *** *** *** *** % istruzione second sup *** *** *** *** % formati *** *** *** *** % contratti a termine *** *** *** *** % donne *** *** *** *** caratteristiche imprese proprietà familiare *** *** *** *** gestione manageriale mercato estero *** *** *** *** innov prodotto innov processo *** *** *** *** < n. dipendenti< *** *** *** *** < n. dipendenti< *** *** * *** n. dipendenti> ** * ** * macroregione si si si si settori si si si si N di Oss 5004 Note: Fonte: dati RIL-AIDA; variabili omesse: imprenditori con istruz second inferiore ed età <40 % lavoratori con istruz secondaria inferiore,; n. di dipendenti<15; significatività statistica: *** al 1%, ** al 5%, * al 10% 15
16 Conclusioni Parziali Il livello di istruzione degli imprenditori favorisce la performance delle imprese che puntano sull innovazione produttiva, l accumulazione delle competenze dei lavoratori e, in definitiva, la crescita economica. Una organizzazione inefficiente dei mercati interni del lavoro e delle politiche di gestione delle risorse umane che si concretizza in un uso eccessivo dei contratti a termine, in deboli incentivi ad investire in formazione on-the-job e ad un basso utilizzo di forza lavoro qualificata riduce le potenzialità di performance produttiva delle imprese Assumere che le caratteristiche e i modelli di comportamento degli imprenditori siano un dato esogeno del sistema, è una seria limitazione per le possibilità di intervenire efficacemente sui nodi strutturali del processo produttivo e per le politiche del mercato del lavoro 16
17 Istruzione degli imprenditori e uso dei contratti a tempo determinato Le ricerche nel campo delle scienze sperimentali e dell economia del comportamento supportano l ipotesi che vi siano almeno tre canali attraverso cui il livello di istruzione dei datori di lavoro può costituire un freno alla diffusione dei contratti a tempo determinato. In primo luogo l investimento in istruzione si accompagna all accumulazione di conoscenze e competenze di natura generale che fornisco agli individui/imprenditori la necessaria flessibilità cognitiva e pazienza per operare strategicamente in ambienti economici incerti e altamente competitivi (Lazear, 2002). La presenza di datori di lavoro istruiti riduce quindi la diffusione dei contratti a termine nella misura in cui la flessibilità contrattuale viene utilizzata come strumento per fronteggiare la volatilità della domanda, shocks tecnologici e, più in generale, le incertezze legate all ambiente economico(oreopolous e Salvanes, 2010). In secondo luogo, il percorso scolastico influenza le attitudini individuali verso il rispetto delle norme sociali, la cooperazione e il senso di reciprocità nei luoghi di lavoro. Fehr (2009) ad esempio suggerisce che un comportamento cooperativo e la fiducia può essere un meccanismo per correggere gli esiti inefficienti relativi a contratti di lavoro incompleti legati ad aspetti non osservabili della qualità del capitale umano, delle abilità professionali e dello sforzo produttivo dei lavoratori In terzo luogo il livello di istruzione degli imprenditori è positivamente correlato alla probabilità che essi abbiano una minima consapevolezza delle moderne pratiche manageriale di organizzazione efficiente delle risorse umane. Queste pratiche manageriali richiedono una partecipazione attiva al processo produttivo da parte dei lavoratori, una organizzazione non verticistica dei mercati interni del lavoro ed un continuo investimento nelle competenze professionali dei dipendenti. Si tratta di elementi che di per sé richiedono una certa stabilità dei rapporti di lavoro, relazioni industriali cooperative e, dunque, un ricorso limitato al lavoro temporaneo(bloom, Genakos, Sadun e Van Reenen, 2011). 17
18 Tabella 1 Media Std dev Caratteristiche imprenditori Istruzione terziaria (0/1) Istruzione secondaria sup(0/1) Istruzione secondaria inf. (0/1) <età< <età< età> Caratteristiche lavoratori % contratto a tempo determinato % Istruzione terziaria % Istruzione secondaria sup % Istruzione secondaria inf % formati % donne Caratteristiche impresa Proprietà familiare gest privata gest manageriale gest manageriale esterna Mercato estero Innovazione di prodotto Innovazione processo Contrattazione integrativa salari ln (ROS) N di Oss Dati e Statistiche descrittive L'analisi empirica si basa sui dati della Rilevazione sulle imprese e i lavoratori (Ril) condotta da Isfol nel 2010 su un campione rappresentativo di oltre aziende che operano nel settore privato extra-agricolo. La selezione del campione: società di capitali e società di persone con almeno di cinque dipendenti operanti nel Il campione finale è composto da circa imprese. Fonte: dati Ril 18
19 Analisi econometrica L analisi econometrica della relazione tra livello di istruzione degli imprenditori e la propensione ad assumere con contratto a tempo determinato viene sviluppata a partire dalla seguente equazione di regressione: %FT=α*Employer_educ+β*X+ ρy in cui%ft è la quota di lavoratori a tempo determinato occupati nell impresa i, employer_educ è una variabiledicotomicacheindicalapresenzadiunimprenditoreinpossesso diundiplomadilaurea,x i è un vettore che descrive la composizione della forza lavoro occupata e Y i include un insieme di caratteristiche produttive delle imprese Diverse specificazioni dell equazione (1) sono quindi stimata attraverso un modello di regressione non lineare di tipo Tobit e un approccio di massima verosimiglianza. Al fine di controllare per eventuali distorsioni legati a fenomeni di eterogeneità non osservata si adotta anche un approccio con variabili strumentali 19
20 Risultati delle stime Tobit Tabella 2: Stime effetti marginali medi Caratteristiche imprenditori Istruzione terziaria ** * Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 3 IV dy/dx std er dy/dx std. er dy/dx std er dy/dx st er *** *** *** Istruzione secondaria sup *** *** ** *** <età< *** *** *** *** <età< *** *** *** *** Caratteristiche lavoratori % Istruzione terziaria 0.048*** *** *** % Istruzione secondaria sup ** *** 0.01 % donne *** *** *** % formati *** *** *** Caratteristiche imprese Proprietà familiare Gest privata gest manageriale *** Contrattazione integrativa *** Mercato estero ** ln (ros) *** *** Innov prodotto *** *** Innov processo macroregioni si si si si dimensione si si si si settori si si si si N di Oss Fonte: dati RIL. Note: variabili omesse:imprenditori con istruzione media inferiore ed età >59, Sud, imprese con meno di 15 dipendenti; Signi. statistica: *** 1%, ** 5%, * 10% 20
21 Conclusioni Il capitale umano imprenditoriale è un fattore determinante per operare scelte di gestione del personale che premiano la stabilità delle relazioni di occupazione e l accumulazione di competenze professionale nei luoghi di lavoro. In particolare le stime (standard) degli effetti medi marginali dimostrano che la presenza di imprenditori laureati riduce di circa punti percentuali la proporzione di lavoratori con contatti a tempo determinato nelle aziende da essi gestite Una politica economica che incentivi la creazione di nuova imprenditorialità con elevata dotazione di capitale umano (soprattutto giovanile e femminile) possono contrastare l'effetto negativo dei contratti a tempo determinato sul mercato del lavoro. 21
22 Istruzione imprenditori e contrattazione integrativa : Equità, strategia o altro? La probabilità di adottare uno schema di contrattazione integrativa sui salari (PRP) è funzione di una serie di variabili che misurano le caratteristiche demografiche imprenditori, quelle occupazionali lavoratori e produttive delle imprese. Si utilizzano i microdati della RIL 2010 per stimare la seguente equazione: (1) %PRP i =α educ_grad i +δ W i +χ F i +ε i L equazione (1) èstimata con modelli di regressione lineare (OLS e 2SLS- IV) per facilitare l interpretazione dei coefficienti (Angrist and Pischke, 2009) La Tabella 1 riporta le stime OLS e IV della probabilità di adottare uno schema PRP; la Tabella 2 mostra le stime IV distinguendo differenti forme di PRP: di team, individuale, di stablimento
23 Tabella 1: stime OLS IV con LPM; dep var: PRP imprenditori ols IV First stage robust coef st er coef st er coef st er Istruzione terziaria (0/1) *** *** Istruzione secondaria (0/1) *** *** *** <età< ** *** età> ** *** *** Lavoratori % istruzione terziaria *** *** % istruzione secondaria *** *** *** % formati *** *** % contratti a termine *** *** *** % donne *** *** Imprese controlli yes yes yes Quota di laureati *** Distretto industriale *** costante *** Uncentered R N of Obs Source: RIL-ISFOL data. Note: omitted variable employer with elementary education and age <40 %, workers with elementary education, South; n. of employees<15; statistical significance *** at 1%, ** at 5%, * at 10%
24 Tabella 2: stime 2SLS-IV : Second stage individuale Team Stablimento coef st er coef st er coef st er Imprenditori Istr terziaria (0/1) *** * Istr secondaria (0/1) ** <età< ** * età> *** ** lavoratori % terziaria * % secondaria ** * % formati *** *** *** % contratti a termine ** ** *** % donne *** *** Imprese controlli yes yes yes N of Obs Source: RIL-ISFOL data. Note: omitted variable employer with elementary education and age <40 %, workers with elementary,south; n. of employees<15; statistical significance *** at 1%, ** at 5%, * at 10%
25 Conclusioni di Politica Economica 1. Politica del credito 2. Politica industriale e dell innovazione 3. Politica del mercato del lavoro 4. Politica di coesione sociale 25
Mercato del lavoro, capitale umano e imprese: una prospettiva di politica del lavoro
 Seminario Isfol Mercato del lavoro, capitale umano e imprese: una prospettiva di politica del lavoro Andrea Ricci Auditorium ISFOL, 25 giugno 2014, Roma OBIETTIVO Il libro Mercato del Lavoro, capitale
Seminario Isfol Mercato del lavoro, capitale umano e imprese: una prospettiva di politica del lavoro Andrea Ricci Auditorium ISFOL, 25 giugno 2014, Roma OBIETTIVO Il libro Mercato del Lavoro, capitale
Etica, Impresa e Competitività: L esperienza di Cucinelli
 INAPP, 19 Aprile 2017 Etica, Impresa e Competitività: L esperienza di Cucinelli Andrea Ricci PRESENTAZIONE Formazione, innovazione e competitività: il ruolo dell etica nelle strategie aziendali Crisi economica
INAPP, 19 Aprile 2017 Etica, Impresa e Competitività: L esperienza di Cucinelli Andrea Ricci PRESENTAZIONE Formazione, innovazione e competitività: il ruolo dell etica nelle strategie aziendali Crisi economica
Elena PODRECCA DINAMIC EFFECTS OF LABOR MARKET REFORMS ON PRODUCTIVITY. A SURVEY.
 Elena PODRECCA DINAMIC EFFECTS OF LABOR MARKET REFORMS ON PRODUCTIVITY. A SURVEY. Concetti di flessibilità del lavoro ESTERNA: FLESSIBILITA SALARIALE INTERNA: FLESSIBILITA FUNZIONALE FLESSIBILITA NUMERICA
Elena PODRECCA DINAMIC EFFECTS OF LABOR MARKET REFORMS ON PRODUCTIVITY. A SURVEY. Concetti di flessibilità del lavoro ESTERNA: FLESSIBILITA SALARIALE INTERNA: FLESSIBILITA FUNZIONALE FLESSIBILITA NUMERICA
Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA. II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio
 Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio I recenti dati di contabilità nazionale confermano un passaggio difficile per l economia
Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio I recenti dati di contabilità nazionale confermano un passaggio difficile per l economia
Guido Corbetta. Irene Dagnino. Mario Minoja. Giovanni Valentini
 Il settore farmaceutico in Italia: Posizionamento e fattori di crescita Guido Corbetta Irene Dagnino Mario Minoja Giovanni Valentini Centro di Ricerca Imprenditorialità e Imprenditori (EntER) Università
Il settore farmaceutico in Italia: Posizionamento e fattori di crescita Guido Corbetta Irene Dagnino Mario Minoja Giovanni Valentini Centro di Ricerca Imprenditorialità e Imprenditori (EntER) Università
Nuove energie per l economia italiana
 Women Value Company 2017 Nuove energie per l economia italiana Gregorio De Felice Milano, 4 maggio 2017 Italia in ripresa, ma ancora in ritardo nel confronto internazionale 1 Crescita cumulata del PIL
Women Value Company 2017 Nuove energie per l economia italiana Gregorio De Felice Milano, 4 maggio 2017 Italia in ripresa, ma ancora in ritardo nel confronto internazionale 1 Crescita cumulata del PIL
PREZZI, INFLAZIONE E CRISI ECONOMICA
 PREZZI, INFLAZIONE E CRISI ECONOMICA Luigi Campiglio Università Cattolica del S. Cuore Milano, 23 gennaio 2012 Convegno CNCU-Regioni Servizi pubblici e partecipazione civica L Italia è un paese costoso
PREZZI, INFLAZIONE E CRISI ECONOMICA Luigi Campiglio Università Cattolica del S. Cuore Milano, 23 gennaio 2012 Convegno CNCU-Regioni Servizi pubblici e partecipazione civica L Italia è un paese costoso
Dinamiche, occupabilità, servizi
 Roma, 16 ottobre 2012 Il Mercato del lavoro negli anni della crisi Dinamiche, occupabilità, servizi Mario Mezzanzanica 1 Alcuni dati in sintesi Occupabilità : un problema di concezione Sistema di servizi
Roma, 16 ottobre 2012 Il Mercato del lavoro negli anni della crisi Dinamiche, occupabilità, servizi Mario Mezzanzanica 1 Alcuni dati in sintesi Occupabilità : un problema di concezione Sistema di servizi
Credito ai Consumatori in Europa a fine 2012
 Credito ai Consumatori in Europa a fine 2012 Introduzione Crédit Agricole Consumer Finance ha pubblicato, per il sesto anno consecutivo, la propria ricerca annuale sul mercato del credito ai consumatori
Credito ai Consumatori in Europa a fine 2012 Introduzione Crédit Agricole Consumer Finance ha pubblicato, per il sesto anno consecutivo, la propria ricerca annuale sul mercato del credito ai consumatori
L agricoltura italiana a confronto con gli altri principali paesi agricoli dell UE
 L agricoltura italiana a confronto con gli altri principali paesi agricoli dell UE Confrontando i paesi dell Unione Europea per i principali indicatori statistici dell agricoltura, si vede (ultimi rilevamenti
L agricoltura italiana a confronto con gli altri principali paesi agricoli dell UE Confrontando i paesi dell Unione Europea per i principali indicatori statistici dell agricoltura, si vede (ultimi rilevamenti
Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 SERVIZI ALLE IMPRESE Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore dei servizi alle imprese; come misura dell attività
SERVIZI ALLE IMPRESE Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore dei servizi alle imprese; come misura dell attività
Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 INDUSTRIA DEL LEGNO Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il valore aggiunto prodotto dall industria del legno rappresenta lo 0.3 per cento del Pil italiano. Il settore è
INDUSTRIA DEL LEGNO Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il valore aggiunto prodotto dall industria del legno rappresenta lo 0.3 per cento del Pil italiano. Il settore è
Le imprese toscane al 9 Censimento Istat dell industria e dei servizi Temi di approfondimento
 Settore Sistema Informativo di Supporto alle Decisioni. Ufficio Regionale di Statistica Le imprese toscane al 9 Censimento Istat dell industria e dei servizi Temi di approfondimento SINTESI La seguente
Settore Sistema Informativo di Supporto alle Decisioni. Ufficio Regionale di Statistica Le imprese toscane al 9 Censimento Istat dell industria e dei servizi Temi di approfondimento SINTESI La seguente
LA SPESA PER L ISTRUZIONE
 CONTENUTO DELLA LEZIONE LA SPESA PER L ISTRUZIONE Natura del servizio Ragioni dell intervento pubblico nella spesa per istruzione Modelli di organizzazione del servizio L istruzione in Italia L istruzione
CONTENUTO DELLA LEZIONE LA SPESA PER L ISTRUZIONE Natura del servizio Ragioni dell intervento pubblico nella spesa per istruzione Modelli di organizzazione del servizio L istruzione in Italia L istruzione
Le previsioni macroeconomiche dell UNICE - Autunno
 Rapporti e Sintesi rilascia delle sintesi relative ai temi presidiati dal Centro Studi nella sua attività di monitoraggio dell andamento economico Le previsioni macroeconomiche dell UNICE - Autunno 2005
Rapporti e Sintesi rilascia delle sintesi relative ai temi presidiati dal Centro Studi nella sua attività di monitoraggio dell andamento economico Le previsioni macroeconomiche dell UNICE - Autunno 2005
Crisi e ripresa dell economia, resilienza del sistema delle imprese e nuove informazioni statistiche a supporto delle policy
 Crisi e ripresa dell economia, resilienza del sistema delle imprese e nuove informazioni statistiche a supporto delle policy Roberto Monducci Istat Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le
Crisi e ripresa dell economia, resilienza del sistema delle imprese e nuove informazioni statistiche a supporto delle policy Roberto Monducci Istat Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le
Newsletter ARIFL - IO LAVORO
 Newsletter ARIFL - IO LAVORO Numero 8 Settimana 8 Gennaio - 14 Gennaio 2010 Stime provvisorie sui tassi di occupazione, disoccupazione e inattività in Italia e sui tassi di disoccupazione nei Paesi dell
Newsletter ARIFL - IO LAVORO Numero 8 Settimana 8 Gennaio - 14 Gennaio 2010 Stime provvisorie sui tassi di occupazione, disoccupazione e inattività in Italia e sui tassi di disoccupazione nei Paesi dell
Produttività e riallocazione delle risorse in Italia e in Lombardia: anni
 BANCA D ITALIA E U R O S I S T E M A Produttività e riallocazione delle risorse in Italia e in Lombardia: anni 2005-2013 Corrado Abbate (Istat), Andrea Linarello (BdI) e Andrea Petrella (BdI) MILeS2016,
BANCA D ITALIA E U R O S I S T E M A Produttività e riallocazione delle risorse in Italia e in Lombardia: anni 2005-2013 Corrado Abbate (Istat), Andrea Linarello (BdI) e Andrea Petrella (BdI) MILeS2016,
Capitolo 3. Occupazione e disoccupazione
 Capitolo 3. Occupazione e disoccupazione Le rilevazioni sul mercato del lavoro hanno cadenza trimestrale e riguardano le consistenze degli occupati e dei disoccupati. I dati annuali sono medie di quelli
Capitolo 3. Occupazione e disoccupazione Le rilevazioni sul mercato del lavoro hanno cadenza trimestrale e riguardano le consistenze degli occupati e dei disoccupati. I dati annuali sono medie di quelli
ANALISI - FORMAZIONE - STRATEGIE - NETWORKING
 ANALISI - FORMAZIONE - STRATEGIE - NETWORKING Rapporto annuale e congiuntura Struttura e performance Due leve per la crescita Rapporto annuale e congiuntura L economia mondiale nel 2015 e le previsioni
ANALISI - FORMAZIONE - STRATEGIE - NETWORKING Rapporto annuale e congiuntura Struttura e performance Due leve per la crescita Rapporto annuale e congiuntura L economia mondiale nel 2015 e le previsioni
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano
 Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI
 24 febbraio 2016 RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI Edizione 2016 Il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, giunto alla quarta edizione, fornisce un quadro informativo dettagliato
24 febbraio 2016 RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI Edizione 2016 Il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, giunto alla quarta edizione, fornisce un quadro informativo dettagliato
AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO:
 PAOLA GAZZOLA, UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA SIMONE NOVELLO, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO: PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA CONDOTTA NEL 2008 La ricerca condotta nel 2008 sulle
PAOLA GAZZOLA, UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA SIMONE NOVELLO, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO: PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA CONDOTTA NEL 2008 La ricerca condotta nel 2008 sulle
Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 GOMMA E MATERIE PLASTICHE Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore della gomma e della plastica; come misura dell
GOMMA E MATERIE PLASTICHE Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore della gomma e della plastica; come misura dell
In Italia la percentuale di persone con un lavoro regolare è in media del 60%, con un evidente gradiente nord-sud [figura 1].
![In Italia la percentuale di persone con un lavoro regolare è in media del 60%, con un evidente gradiente nord-sud [figura 1]. In Italia la percentuale di persone con un lavoro regolare è in media del 60%, con un evidente gradiente nord-sud [figura 1].](/thumbs/41/22484166.jpg) Il lavoro Il lavoro e il tempo libero dovrebbero essere una fonte di salute per le persone. Il modo in cui la società organizza il lavoro dovrebbe contribuire a creare una società sana. La promozione della
Il lavoro Il lavoro e il tempo libero dovrebbero essere una fonte di salute per le persone. Il modo in cui la società organizza il lavoro dovrebbe contribuire a creare una società sana. La promozione della
Struttura delle aziende agricole / Novembre 2015
 206/2015-26 Novembre 2015 Struttura delle aziende agricole 2013 Mentre la superficie agricola utilizzata è rimasta invariata, più di 1 azienda agricola su 4 è scomparsa tra il 2003 e il 2013 nell UE. Quasi
206/2015-26 Novembre 2015 Struttura delle aziende agricole 2013 Mentre la superficie agricola utilizzata è rimasta invariata, più di 1 azienda agricola su 4 è scomparsa tra il 2003 e il 2013 nell UE. Quasi
INVESTIMENTI E FINANZA IN ITALIA SFIDE E OPPORTUNITÀ. Investimenti, innovazione e produttività. Matteo Bugamelli Banca d Italia
 INVESTIMENTI E FINANZA IN ITALIA SFIDE E OPPORTUNITÀ Investimenti, innovazione e produttività Matteo Bugamelli Banca d Italia Presentazione del rapporto BEI Investment and Investment Finance in Europe
INVESTIMENTI E FINANZA IN ITALIA SFIDE E OPPORTUNITÀ Investimenti, innovazione e produttività Matteo Bugamelli Banca d Italia Presentazione del rapporto BEI Investment and Investment Finance in Europe
Partecipazione femminile al mercato del lavoro in Abruzzo: caratteri e dinamiche
 PARTECIPAZIONE FEMMINILE al MERCATO del LAVORO in ABRUZZO Partecipazione femminile al mercato del lavoro in Abruzzo: caratteri e dinamiche Marcella Mulino Francesca Tironi Facoltà di Economia Università
PARTECIPAZIONE FEMMINILE al MERCATO del LAVORO in ABRUZZO Partecipazione femminile al mercato del lavoro in Abruzzo: caratteri e dinamiche Marcella Mulino Francesca Tironi Facoltà di Economia Università
ECONOMIA E AGRICOLTURA
 Itaconta2007 8 3-07-2007 4:5 Pagina 3 ECONOMIA E AGRICOLTURA Prodotto Interno Lordo Andamento del PIL (mio euro), dal 2000 al 2006.475.40.500.000.255.848.200.000 900.000 600.000 300.000 0 2000 200 2002
Itaconta2007 8 3-07-2007 4:5 Pagina 3 ECONOMIA E AGRICOLTURA Prodotto Interno Lordo Andamento del PIL (mio euro), dal 2000 al 2006.475.40.500.000.255.848.200.000 900.000 600.000 300.000 0 2000 200 2002
Comportamenti inerziali o scelte consapevoli? Primi risultati della ricerca CeRP sulle banche dati Cometa e Fonchim
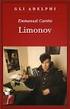 Comportamenti inerziali o scelte consapevoli? Primi risultati della ricerca CeRP sulle banche dati Cometa e Fonchim Elsa Fornero Università di Torino e CeRP Federica Teppa CeRP Workshop CeRP L operatività
Comportamenti inerziali o scelte consapevoli? Primi risultati della ricerca CeRP sulle banche dati Cometa e Fonchim Elsa Fornero Università di Torino e CeRP Federica Teppa CeRP Workshop CeRP L operatività
I DATI STRUTTURALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO
 I DATI STRUTTURALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO IMPRESE E OCCUPATI: UNA PANORAMICA SUL DECENNIO 2001-2011 Il 9 Censimento generale dell industria e dei servizi ha registrato 4.425.950 imprese attive
I DATI STRUTTURALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO IMPRESE E OCCUPATI: UNA PANORAMICA SUL DECENNIO 2001-2011 Il 9 Censimento generale dell industria e dei servizi ha registrato 4.425.950 imprese attive
Consolidamento e sostegno alla crescita
 Consolidamento e sostegno alla crescita Marzo 2016 IRELAND GREECE SLOVENIA CYPRUS In riferimento ad alcune analisi apparse sui media a proposito delle dimensioni delle misure di aggiustamento fiscale messe
Consolidamento e sostegno alla crescita Marzo 2016 IRELAND GREECE SLOVENIA CYPRUS In riferimento ad alcune analisi apparse sui media a proposito delle dimensioni delle misure di aggiustamento fiscale messe
Premessa. Entrate tributarie
 2 Premessa Le informazioni diffuse con i Bollettini mensili sulle entrate tributarie di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna, pubblicati sui portali web istituzionali dalle Amministrazioni
2 Premessa Le informazioni diffuse con i Bollettini mensili sulle entrate tributarie di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna, pubblicati sui portali web istituzionali dalle Amministrazioni
CRUSCOTTO DI INDICATORI STATISTICI
 CRUSCOTTO DI INDICATORI STATISTICI REPORT CON DATI STRUTTURALI ANNO 2015 STESSO INSIEME DI BILANCI NEI 3 ANNI Elaborazioni a: Settembre 2016 Indice delle tavole Dati strutturali a periodicità annuale di
CRUSCOTTO DI INDICATORI STATISTICI REPORT CON DATI STRUTTURALI ANNO 2015 STESSO INSIEME DI BILANCI NEI 3 ANNI Elaborazioni a: Settembre 2016 Indice delle tavole Dati strutturali a periodicità annuale di
La disoccupazione (soprattutto giovanile) in Italia: le modalità dell istruzione corresponsabili del fenomeno?
 La disoccupazione (soprattutto giovanile) in Italia: le modalità dell istruzione corresponsabili del fenomeno? Emilio Reyneri Università di Milano Bicocca Éupolis Lombardia 11 dicembre 2014 1 La disoccupazione
La disoccupazione (soprattutto giovanile) in Italia: le modalità dell istruzione corresponsabili del fenomeno? Emilio Reyneri Università di Milano Bicocca Éupolis Lombardia 11 dicembre 2014 1 La disoccupazione
Asset Camera. Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma
 Asset Camera Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma Indagine congiunturale sulle aspettative di Roma e Provincia Terzo quadrimestre 2013 L indagine congiunturale ha come obiettivo quello di raccogliere
Asset Camera Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma Indagine congiunturale sulle aspettative di Roma e Provincia Terzo quadrimestre 2013 L indagine congiunturale ha come obiettivo quello di raccogliere
Campobasso - 10 giugno Presentazione del Rapporto. L economia del Molise
 Campobasso - 10 giugno 2014 - Presentazione del Rapporto L economia del Molise Prodotto interno lordo Nel 2013 l economia molisana si è ancora contratta. Le stime di Prometeia indicano una riduzione del
Campobasso - 10 giugno 2014 - Presentazione del Rapporto L economia del Molise Prodotto interno lordo Nel 2013 l economia molisana si è ancora contratta. Le stime di Prometeia indicano una riduzione del
Come rilanciare l economia puntando su giovani e donne. Fatima Spinelli (Univ. Parthenope di Napoli, corso di laurea di I livello)
 PROPOSTE DI POLICY PER UNA AZIENDA ITALIA PIU ROSA ED UNDER 35. Come rilanciare l economia puntando su giovani e donne Fatima Spinelli (Univ. Parthenope di Napoli, corso di laurea di I livello) GIOVANI
PROPOSTE DI POLICY PER UNA AZIENDA ITALIA PIU ROSA ED UNDER 35. Come rilanciare l economia puntando su giovani e donne Fatima Spinelli (Univ. Parthenope di Napoli, corso di laurea di I livello) GIOVANI
Modelli di impresa e Corporate Governance Parte prima 3.3 I caratteri strutturali delle imprese italiane e la loro evoluzione
 Parte prima 3.3 I caratteri strutturali delle italiane e la loro evoluzione 3.3.1 Numerosità, dimensioni e composizione settoriale 3.3.2 Le italiane nel quadro europeo 3.3.3 Primi dati sulla crisi: natalità
Parte prima 3.3 I caratteri strutturali delle italiane e la loro evoluzione 3.3.1 Numerosità, dimensioni e composizione settoriale 3.3.2 Le italiane nel quadro europeo 3.3.3 Primi dati sulla crisi: natalità
Economia e lavoro in Francia, Germania, Italia e Spagna: scenari macro
 Economia e lavoro in Francia, Germania, Italia e Spagna: scenari macro di Francesca Fazio Questa analisi mostra l andamento di alcuni indicatori macroeconomici in Francia, Germania, Italia e Spagna dal
Economia e lavoro in Francia, Germania, Italia e Spagna: scenari macro di Francesca Fazio Questa analisi mostra l andamento di alcuni indicatori macroeconomici in Francia, Germania, Italia e Spagna dal
Presentazione Annuario Istat-Ice 2016
 Presentazione Annuario Istat-Ice 2016 Commercio estero ed attività internazionali delle imprese Giorgio Alleva Presidente dell Istituto Nazionale di Statistica Outline Le principali novità dell Annuario
Presentazione Annuario Istat-Ice 2016 Commercio estero ed attività internazionali delle imprese Giorgio Alleva Presidente dell Istituto Nazionale di Statistica Outline Le principali novità dell Annuario
CRUSCOTTO DI INDICATORI STATISTICI ANCONA
 CRUSCOTTO DI INDICATORI STATISTICI REPORT CON DATI STRUTTURALI ANNO 2014 STESSO INSIEME DI BILANCI NEI 3 ANNI Elaborazioni a: Marzo 2016 Indice delle tavole Dati strutturali a periodicità annuale di imprese
CRUSCOTTO DI INDICATORI STATISTICI REPORT CON DATI STRUTTURALI ANNO 2014 STESSO INSIEME DI BILANCI NEI 3 ANNI Elaborazioni a: Marzo 2016 Indice delle tavole Dati strutturali a periodicità annuale di imprese
CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA
 CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROCESSO
CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA VOLUME DI MERCATO LANCIO CRESCITA MATURITA OBSOLESCENZA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROCESSO
Il sistema della subfornitura artigiana per il settore dei mezzi di trasporto terrestre in Toscana
 Laboratorio di Economia dell Innovazione Keith Pavitt Il sistema della subfornitura artigiana per il settore dei mezzi di trasporto terrestre in Toscana Regione Toscana Sala Pegaso P.zza del Duomo, 10
Laboratorio di Economia dell Innovazione Keith Pavitt Il sistema della subfornitura artigiana per il settore dei mezzi di trasporto terrestre in Toscana Regione Toscana Sala Pegaso P.zza del Duomo, 10
Il Benessere Equo Sostenibile nella provincia di Ravenna anno 2015
 Il Benessere Equo Sostenibile nella provincia di Ravenna anno 2015 Servizio Statistica Roberta Cuffiani 3 dicembre 2015 Il Bes delle province Anno 2015 82 indicatori per 11 dimensioni per 25 province aderenti,
Il Benessere Equo Sostenibile nella provincia di Ravenna anno 2015 Servizio Statistica Roberta Cuffiani 3 dicembre 2015 Il Bes delle province Anno 2015 82 indicatori per 11 dimensioni per 25 province aderenti,
Notiziario su prospettive e congiuntura dell economia italiana
 Ufficio di supporto agli organi collegiali Notiziario su prospettive e congiuntura dell economia italiana L Italia in confronto con i paesi dell OCSE Ufficio di supporto agli organi collegiali Notiziario
Ufficio di supporto agli organi collegiali Notiziario su prospettive e congiuntura dell economia italiana L Italia in confronto con i paesi dell OCSE Ufficio di supporto agli organi collegiali Notiziario
NUOVO CONTINENTE: UN SUPPORTO ALL ITALIA DIGITALE. La situazione attuale: infrastrutture, alfabetizzazione digitale, e-commerce
 NUOVO CONTINENTE: UN SUPPORTO ALL ITALIA DIGITALE La situazione attuale: infrastrutture, alfabetizzazione digitale, e-commerce LE INFRASTRUTTURE DIGITALI UNA DOTAZIONE DIFFUSA, MA CON ALCUNI LIMITI TERRITORIALI
NUOVO CONTINENTE: UN SUPPORTO ALL ITALIA DIGITALE La situazione attuale: infrastrutture, alfabetizzazione digitale, e-commerce LE INFRASTRUTTURE DIGITALI UNA DOTAZIONE DIFFUSA, MA CON ALCUNI LIMITI TERRITORIALI
Tito Boeri. Università degli Studi di Milano La Statale. Milano, 5 dicembre 2016
 Al posto giusto Tito Boeri Università degli Studi di Milano La Statale Milano, 5 dicembre 2016 La grande inefficienza allocativa OECD 2015 Da criticità a opportunità Problema allocativo: abbiamo le persone
Al posto giusto Tito Boeri Università degli Studi di Milano La Statale Milano, 5 dicembre 2016 La grande inefficienza allocativa OECD 2015 Da criticità a opportunità Problema allocativo: abbiamo le persone
Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 GOMMA E MATERIE PLASTICHE Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il valore aggiunto prodotto dalla fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche rappresenta lo 0.6
GOMMA E MATERIE PLASTICHE Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il valore aggiunto prodotto dalla fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche rappresenta lo 0.6
Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 AGRICOLTURA Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore dell agricoltura; come misura dell attività si utilizza il
AGRICOLTURA Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore dell agricoltura; come misura dell attività si utilizza il
LAVORO, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE
 LAVORO, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE DEFINIZIONI: OCCUPATI, DISOCCUPATI, INATTIVI Ogni adulto in età lavorativa viene collocato in una delle seguenti categorie: OCCUPATI: chi ha più di 15 anni e nella settimana
LAVORO, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE DEFINIZIONI: OCCUPATI, DISOCCUPATI, INATTIVI Ogni adulto in età lavorativa viene collocato in una delle seguenti categorie: OCCUPATI: chi ha più di 15 anni e nella settimana
Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 AGRICOLTURA Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il peso del settore dell agricoltura si è ridotto rispetto a qualche decennio fa, ma in alcuni territori rappresenta ancora
AGRICOLTURA Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il peso del settore dell agricoltura si è ridotto rispetto a qualche decennio fa, ma in alcuni territori rappresenta ancora
LA STRATEGIA DI LISBONA E I MODELLI SOCIALI EUROPEI DI SOSTENIBILITA
 9 CONVEGNO INTERNAZIONALE IN RICORDO DI MARCO BIAGI Modena, 17-18-19 marzo 2011 EUROPA 2020: PROSPETTIVE COMPARATE E AZIONE TRANSNAZIONALE Exit strategies per i mercati del lavoro, le relazioni industriali
9 CONVEGNO INTERNAZIONALE IN RICORDO DI MARCO BIAGI Modena, 17-18-19 marzo 2011 EUROPA 2020: PROSPETTIVE COMPARATE E AZIONE TRANSNAZIONALE Exit strategies per i mercati del lavoro, le relazioni industriali
Le prospettive di lavoro
 Le prospettive di lavoro per chi prosegue gli studi Quanti sono i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro Cresce la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, cioè la quota di quanti lavorano
Le prospettive di lavoro per chi prosegue gli studi Quanti sono i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro Cresce la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, cioè la quota di quanti lavorano
Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 ALBERGHI E RISTORANTI Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore del commercio; come misura dell attività si utilizza
ALBERGHI E RISTORANTI Le previsioni al 2015: valore aggiunto, produttività ed occupazione Nel primo grafico viene rappresentata la crescita del settore del commercio; come misura dell attività si utilizza
STOVIGLIERIA. 9a edizione
 STOVIGLIERIA 9a edizione 49 INTRODUZIONE Confindustria Ceramica ha realizzato l'ottava indagine statistica per il settore della porcellana e ceramica da tavola, allo scopo di monitorare i principali dati
STOVIGLIERIA 9a edizione 49 INTRODUZIONE Confindustria Ceramica ha realizzato l'ottava indagine statistica per il settore della porcellana e ceramica da tavola, allo scopo di monitorare i principali dati
La fiscalità e la spesa pubblica: un confronto internazionale
 La fiscalità e la spesa pubblica: un confronto internazionale 1. L analisi dei livelli di prelievo fiscale nei principali Paesi costituisce uno degli elementi maggiormente significativi al fine di valutare
La fiscalità e la spesa pubblica: un confronto internazionale 1. L analisi dei livelli di prelievo fiscale nei principali Paesi costituisce uno degli elementi maggiormente significativi al fine di valutare
L evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL in Italia e nei maggiori paesi
 L evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL in Italia e nei maggiori paesi Negli ultimi ventuno anni in Italia il rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto di 15,7 punti, d a 116,9 a fine
L evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL in Italia e nei maggiori paesi Negli ultimi ventuno anni in Italia il rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto di 15,7 punti, d a 116,9 a fine
Il voto alle donne: fattori e implicazioni Un analisi economica di lungo periodo Graziella Bertocchi Dipartimento di Economia Marco Biagi e RECent
 Il voto alle donne: fattori e implicazioni Un analisi economica di lungo periodo Graziella Bertocchi Dipartimento di Economia Marco Biagi e RECent Il 2 Giugno 1946: 70 Anniversario della nascita della
Il voto alle donne: fattori e implicazioni Un analisi economica di lungo periodo Graziella Bertocchi Dipartimento di Economia Marco Biagi e RECent Il 2 Giugno 1946: 70 Anniversario della nascita della
I MIGLIORI E I PEGGIORI
 NOTE STAMPA UN TERMOMETRO MISURA LA FEBBRE ALLA FINANZA LOCALE IN EMILIA ROMAGNA CNA PRESENTA UNO STUDIO SULL EFFICIENZA FINANZIARIA DEI COMUNI DELLA REGIONE BOLOGNA 7 MAGGIO 2013 Il Termometro fornisce
NOTE STAMPA UN TERMOMETRO MISURA LA FEBBRE ALLA FINANZA LOCALE IN EMILIA ROMAGNA CNA PRESENTA UNO STUDIO SULL EFFICIENZA FINANZIARIA DEI COMUNI DELLA REGIONE BOLOGNA 7 MAGGIO 2013 Il Termometro fornisce
Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 TRASPORTI E COMUNICAZIONI Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il comparto dei servizi di trasporto e comunicazioni, producendo circa l 8.4 per cento del Pil italiano, rappresenta
TRASPORTI E COMUNICAZIONI Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il comparto dei servizi di trasporto e comunicazioni, producendo circa l 8.4 per cento del Pil italiano, rappresenta
Alessandro Scopelliti.
 Alessandro Scopelliti alessandro.scopelliti@unirc.it Il tasso di crescita ed il tasso di disoccupazione negli USA dal 1970 ad oggi Nel grafico precedente sono state riportate le variazioni del Pil e della
Alessandro Scopelliti alessandro.scopelliti@unirc.it Il tasso di crescita ed il tasso di disoccupazione negli USA dal 1970 ad oggi Nel grafico precedente sono state riportate le variazioni del Pil e della
L evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL in Italia e nei maggiori paesi
 L evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL in Italia e nei maggiori paesi Negli ultimi ventuno anni in Italia il rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto di 15,7 punti, da 116,9 a fine 1995
L evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL in Italia e nei maggiori paesi Negli ultimi ventuno anni in Italia il rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto di 15,7 punti, da 116,9 a fine 1995
Obiettivo della ricerca e oggetto di analisi
 Analisi dei comportamenti imprenditoriali ed organizzativi delle imprese del comparto del materiale rotabile nella realtà produttiva pistoiese e definizione di di politiche di di intervento a sostegno
Analisi dei comportamenti imprenditoriali ed organizzativi delle imprese del comparto del materiale rotabile nella realtà produttiva pistoiese e definizione di di politiche di di intervento a sostegno
Occupati e disoccupati in FVG nel 2015
 15 marzo #lavoro Rassegna stampa TG3 RAI FVG 10mar2016 Messaggero Veneto 11mar2016 Il Piccolo 11mar2016 Il Gazzettino 11mar2016 Occupati e disoccupati in FVG nel 2015 In Friuli Venezia Giulia nell ultimo
15 marzo #lavoro Rassegna stampa TG3 RAI FVG 10mar2016 Messaggero Veneto 11mar2016 Il Piccolo 11mar2016 Il Gazzettino 11mar2016 Occupati e disoccupati in FVG nel 2015 In Friuli Venezia Giulia nell ultimo
Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Centro Studi CNA LAVORO. OSSERVATORIO LAVORO Luglio-Agosto 2017
 LAVORO Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Centro Studi CNA OSSERVATORIO LAVORO Luglio-Agosto 2017 27 SETTEMBRE 2017 NEI MESI ESTIVI TIENE L OCCUPAZIONE NELLE MICRO
LAVORO Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Centro Studi CNA OSSERVATORIO LAVORO Luglio-Agosto 2017 27 SETTEMBRE 2017 NEI MESI ESTIVI TIENE L OCCUPAZIONE NELLE MICRO
ALMALAUREAAUREA E L OCCUPABILITL OCCUPABILITÀ DEI
 BOLOGNA PROCESS OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI E SVILUPPO ECONOMICO-CULTURALE DEI TERRITORI IL CONSORZIO ALMALAUREAAUREA E L OCCUPABILITL CCUPABILITÀ DEI LAUREATI Angelo di Francia Consorzio Interuniversitario
BOLOGNA PROCESS OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI E SVILUPPO ECONOMICO-CULTURALE DEI TERRITORI IL CONSORZIO ALMALAUREAAUREA E L OCCUPABILITL CCUPABILITÀ DEI LAUREATI Angelo di Francia Consorzio Interuniversitario
Economia e gestione delle imprese
 Prof. Antonio Renzi Economia e gestione delle imprese Parte nona Dinamica evolutiva dell impresa: ricavi, contribuzione e profitto 1 Argomenti 1. Il profitto nelle teorie economiche (cenni) 2. Il profitto
Prof. Antonio Renzi Economia e gestione delle imprese Parte nona Dinamica evolutiva dell impresa: ricavi, contribuzione e profitto 1 Argomenti 1. Il profitto nelle teorie economiche (cenni) 2. Il profitto
RAPPORTO IMPRESAINGENERE
 ! RAPPORTO IMPRESAINGENERE La crisi non ha fermato le donne: 35mila imprese femminili in più tra 2010 e 2015 Anche a Trieste il trend è positivo Sono 1 milione e 312mila, danno lavoro a 3 milioni di persone
! RAPPORTO IMPRESAINGENERE La crisi non ha fermato le donne: 35mila imprese femminili in più tra 2010 e 2015 Anche a Trieste il trend è positivo Sono 1 milione e 312mila, danno lavoro a 3 milioni di persone
Il sistema finanziario cap.10
 10-5-2017 Il sistema finanziario cap.10 Svolge la funzione di trasferire risorse finanziarie ai soggetti che ne dispongono a quelli che le impiegano Strumenti finanziari principali (par. 10.2.1) Strumenti
10-5-2017 Il sistema finanziario cap.10 Svolge la funzione di trasferire risorse finanziarie ai soggetti che ne dispongono a quelli che le impiegano Strumenti finanziari principali (par. 10.2.1) Strumenti
IL SISTEMA VITIVINICOLO COOPERATIVO
 Note e commenti n 30 Aprile 2015 Ufficio Studi AGCI Area Studi Confcooperative Centro Studi Legacoop IL SISTEMA VITIVINICOLO COOPERATIVO 1 L analisi relativa ai Numeri dell Alleanza delle Cooperative Italiane
Note e commenti n 30 Aprile 2015 Ufficio Studi AGCI Area Studi Confcooperative Centro Studi Legacoop IL SISTEMA VITIVINICOLO COOPERATIVO 1 L analisi relativa ai Numeri dell Alleanza delle Cooperative Italiane
L abbandono dell attività agricola condiziona l intera economia delle aree rurali
 L abbandono dell attività agricola condiziona l intera economia delle aree rurali Come evidenzia la figura 1, l invecchiamento e lo spopolamento sono fenomeni che interessano soprattutto i Paesi dell Europa
L abbandono dell attività agricola condiziona l intera economia delle aree rurali Come evidenzia la figura 1, l invecchiamento e lo spopolamento sono fenomeni che interessano soprattutto i Paesi dell Europa
STATISTICHE IN BREVE. Archivio Statistico delle Imprese Attive (Asia) Anni La struttura delle imprese e dell occupazione
 STATISTICHE IN BREVE Archivio Statistico delle Imprese Attive (Asia) Anni 2007-2010 La struttura delle imprese e dell occupazione Nel 2010, secondo l ATECO 2007, le imprese attive nell industria e nei
STATISTICHE IN BREVE Archivio Statistico delle Imprese Attive (Asia) Anni 2007-2010 La struttura delle imprese e dell occupazione Nel 2010, secondo l ATECO 2007, le imprese attive nell industria e nei
DATI ISTAT SULLA FORZA LAVORO
 DATI ISTAT SULLA FORZA LAVORO La nuova indagine sulle forze di lavoro condotta dall Istat presenta profonde innovazioni rispetto a quella precedente, al punto che la nuova modalità di rilevazione ha creato
DATI ISTAT SULLA FORZA LAVORO La nuova indagine sulle forze di lavoro condotta dall Istat presenta profonde innovazioni rispetto a quella precedente, al punto che la nuova modalità di rilevazione ha creato
Il capitale territoriale nelle regioni europee: un modello di crescita
 Il capitale territoriale nelle regioni europee: un modello di crescita Cristina Brasili Presidente Associazione egios e Docente dell Università di Bologna VI Workshop Unicredit-egios Le regioni italiane:
Il capitale territoriale nelle regioni europee: un modello di crescita Cristina Brasili Presidente Associazione egios e Docente dell Università di Bologna VI Workshop Unicredit-egios Le regioni italiane:
Economia del Lavoro 2010
 Economia del Lavoro 2010 Capitolo 7-3 La distribuzione del salario - La struttura del salario: i fatti base 1 La distribuzione del salario La struttura del salario: i fatti base Fig. 7-4: Negli US, la
Economia del Lavoro 2010 Capitolo 7-3 La distribuzione del salario - La struttura del salario: i fatti base 1 La distribuzione del salario La struttura del salario: i fatti base Fig. 7-4: Negli US, la
Osservatorio Isnet sulle Imprese Sociali in Italia. IX edizione. Luglio 2015
 Osservatorio Isnet sulle Imprese Sociali in Italia IX edizione Luglio 2015 1. Introduzione L Associazione ISNET dialoga con una rete di oltre 1.000 imprese sociali in tutta Italia, con l obiettivo di favorire
Osservatorio Isnet sulle Imprese Sociali in Italia IX edizione Luglio 2015 1. Introduzione L Associazione ISNET dialoga con una rete di oltre 1.000 imprese sociali in tutta Italia, con l obiettivo di favorire
Cristiana Minguzzi ABI - Settore Dinamiche Salariali
 BANCARIA N. 7-8 / 2007 Cristiana Minguzzi ABI - Settore Dinamiche Salariali L impatto della demografia sulle politiche delle risorse umane nel settore bancario: un approccio statistico nell evoluzione
BANCARIA N. 7-8 / 2007 Cristiana Minguzzi ABI - Settore Dinamiche Salariali L impatto della demografia sulle politiche delle risorse umane nel settore bancario: un approccio statistico nell evoluzione
BANCHE: I CLIENTI ITALIANI SONO I PIU TARTASSATI D EUROPA
 BANCHE: I CLIENTI ITALIANI SONO I PIU TARTASSATI D EUROPA Nel 2015 l incidenza percentuale delle commissioni nette sui ricavi delle banche italiane (pari al 36,5 per cento) è stata la più elevata d Europa.
BANCHE: I CLIENTI ITALIANI SONO I PIU TARTASSATI D EUROPA Nel 2015 l incidenza percentuale delle commissioni nette sui ricavi delle banche italiane (pari al 36,5 per cento) è stata la più elevata d Europa.
Blanchard, Macroeconom ia Una prospettiva europea, I l Mulino Crescita: i fatti principali
 Capitolo XI. Crescita: i fatti principali 1. Come si misura il tenore di vita Ci spostiamo dallo studio delle determinanti della produzione nel breve e nel medio periodo, quando dominano le fluttuazioni,
Capitolo XI. Crescita: i fatti principali 1. Come si misura il tenore di vita Ci spostiamo dallo studio delle determinanti della produzione nel breve e nel medio periodo, quando dominano le fluttuazioni,
La dispersione regionale dell'occupazione e della disoccupazione nell'unione Europea
 La dispersione regionale dell'occupazione e della disoccupazione nell'unione Europea I Paesi dell Unione Europea (UE) sono molto diversi fra di loro e mostrano dinamiche differenziate interne a livello
La dispersione regionale dell'occupazione e della disoccupazione nell'unione Europea I Paesi dell Unione Europea (UE) sono molto diversi fra di loro e mostrano dinamiche differenziate interne a livello
I caratteri strutturali del sistema Paese Italia
 I caratteri strutturali del sistema Paese Italia a cura di Ugo Lassini Vicenza, 02 aprile 2008 Agenda Il sistema delle imprese italiane: Caratteri strutturali Numerosità, dimensioni e composizione settoriale
I caratteri strutturali del sistema Paese Italia a cura di Ugo Lassini Vicenza, 02 aprile 2008 Agenda Il sistema delle imprese italiane: Caratteri strutturali Numerosità, dimensioni e composizione settoriale
Il mercato del lavoro in Europa
 Il mercato del lavoro in Europa Il diritto di essere piccoli Milano, 6 maggio 2014 Silvia Spattini @SilviaSpattini silvia.spattini@adapt.it Tassi di occupazione 2013 Tasso occupazione totale Tasso occupazione
Il mercato del lavoro in Europa Il diritto di essere piccoli Milano, 6 maggio 2014 Silvia Spattini @SilviaSpattini silvia.spattini@adapt.it Tassi di occupazione 2013 Tasso occupazione totale Tasso occupazione
Osservatorio & Ricerca
 Osservatorio & Ricerca IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 Sintesi Grafica Maggio 2017 IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 LE PREVISIONI Se per i Paesi dell area euro
Osservatorio & Ricerca IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 Sintesi Grafica Maggio 2017 IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 LE PREVISIONI Se per i Paesi dell area euro
Argomenti. Prof. A. Renzi Economia e Gestione delle Imprese Ricavi, contribuzione e profitto
 Prof. Antonio enzi Economia e gestione delle imprese Dinamica evolutiva dell impresa: ricavi, contribuzione e profitto 1 Argomenti 1. Il profitto nelle teorie economiche (cenni) 2. Il profitto e le sue
Prof. Antonio enzi Economia e gestione delle imprese Dinamica evolutiva dell impresa: ricavi, contribuzione e profitto 1 Argomenti 1. Il profitto nelle teorie economiche (cenni) 2. Il profitto e le sue
Il riposizionamento competitivo delle imprese internazionalizzate: nuove evidenze a supporto delle policy
 Il riposizionamento competitivo delle imprese internazionalizzate: nuove evidenze a supporto delle policy Presidente Istat Presentazione Annuario Istat-Ice 2017 Milano, 13 luglio 2017 OUTLINE Operatori
Il riposizionamento competitivo delle imprese internazionalizzate: nuove evidenze a supporto delle policy Presidente Istat Presentazione Annuario Istat-Ice 2017 Milano, 13 luglio 2017 OUTLINE Operatori
Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione
 ALBERGHI E RISTORANTI Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il settore degli alberghi e dei pubblici esercizi rappresenta una quota non trascurabile dell economia italiana:
ALBERGHI E RISTORANTI Le previsioni al 2016: valore aggiunto, produttività ed occupazione Il settore degli alberghi e dei pubblici esercizi rappresenta una quota non trascurabile dell economia italiana:
Best practice e limiti da superare per il rilancio delle imprese M3: Prima evidenza dall indagine Benchmark
 Best practice e limiti da superare per il rilancio delle imprese M3: Prima evidenza dall indagine Benchmark Carlo Altomonte Università Bocconi & Bruegel 9 giugno 2015 Outline L indagine Il campione I risultati
Best practice e limiti da superare per il rilancio delle imprese M3: Prima evidenza dall indagine Benchmark Carlo Altomonte Università Bocconi & Bruegel 9 giugno 2015 Outline L indagine Il campione I risultati
REDDITO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE E PROFITTI DELLE SOCIETÀ
 8 gennaio 2016 III trimestre 2015 REDDITO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE E PROFITTI DELLE SOCIETÀ Nel terzo trimestre del 2015 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in valori correnti è aumentato
8 gennaio 2016 III trimestre 2015 REDDITO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE E PROFITTI DELLE SOCIETÀ Nel terzo trimestre del 2015 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in valori correnti è aumentato
IL LAVORO A TERMINE IN ITALIA E NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI
 IL LAVORO A TERMINE IN ITALIA E NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI P.tta Gasparotto, 8-35131 Padova Tel. 049 8046411 Fax 049 8046444 www.datagiovani.it info@datagiovani.it IL LAVORO A TERMINE IN ITALIA E NEI
IL LAVORO A TERMINE IN ITALIA E NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI P.tta Gasparotto, 8-35131 Padova Tel. 049 8046411 Fax 049 8046444 www.datagiovani.it info@datagiovani.it IL LAVORO A TERMINE IN ITALIA E NEI
Economia del Lavoro 2010
 Economia del Lavoro 2010 Capitolo 6-1 Il capitale umano - Introduzione -L istruzione nel mercato del lavoro: alcuni fatti stilizzati 1 Introduzione Ognuno di noi porta nel mercato del lavoro abilità innate
Economia del Lavoro 2010 Capitolo 6-1 Il capitale umano - Introduzione -L istruzione nel mercato del lavoro: alcuni fatti stilizzati 1 Introduzione Ognuno di noi porta nel mercato del lavoro abilità innate
Laureati in agraria conduttori di aziende agricole
 Laureati in agraria conduttori di aziende agricole Negli ultimi cinque anni, è cresciuta da circa il 2% dei sei anni precedenti ad oltre il 3%, la quota di studenti immatricolati ai corsi di laurea nelle
Laureati in agraria conduttori di aziende agricole Negli ultimi cinque anni, è cresciuta da circa il 2% dei sei anni precedenti ad oltre il 3%, la quota di studenti immatricolati ai corsi di laurea nelle
il mercato del lavoro
 il mercato del lavoro giulio.zanella@unibo.it 20 aprile 2017 domande per oggi cos e il mercato del lavoro? come funziona il mercato del lavoro? perché lo chiamiamo mercato? il lavoro non e una merce (preambolo
il mercato del lavoro giulio.zanella@unibo.it 20 aprile 2017 domande per oggi cos e il mercato del lavoro? come funziona il mercato del lavoro? perché lo chiamiamo mercato? il lavoro non e una merce (preambolo
Le conseguenze della crisi per le famiglie e le imprese
 Le conseguenze della crisi per le famiglie e le imprese Di Monica Montella, Franco Mostacci In assenza di una politica fiscale comune, e privi di sovranità sulla loro politica monetaria e del cambio, gli
Le conseguenze della crisi per le famiglie e le imprese Di Monica Montella, Franco Mostacci In assenza di una politica fiscale comune, e privi di sovranità sulla loro politica monetaria e del cambio, gli
PRIMA PARTE: POLITICHE MACROECONOMICHE
 PRIMA PARTE: POLITICHE MACROECONOMICHE 1 In questa parte del corso: Utilizzeremo i modelli del corso di Economia politica (macroeconomia) e ne analizzeremo in maggiore profondità le implicazioni di politica
PRIMA PARTE: POLITICHE MACROECONOMICHE 1 In questa parte del corso: Utilizzeremo i modelli del corso di Economia politica (macroeconomia) e ne analizzeremo in maggiore profondità le implicazioni di politica
IL MEZZOGIORNO DIMENTICATO LE REGIONI MERIDIONALI PRIME PER RISCHIO POVERTA IN EUROPA
 CENTRO STUDI IL MEZZOGIORNO DIMENTICATO LE REGIONI MERIDIONALI PRIME PER RISCHIO POVERTA IN EUROPA Nota CNA N. 11/DICEMBRE 2014 CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
CENTRO STUDI IL MEZZOGIORNO DIMENTICATO LE REGIONI MERIDIONALI PRIME PER RISCHIO POVERTA IN EUROPA Nota CNA N. 11/DICEMBRE 2014 CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
Rapporto Economia Provinciale Analisi per Cluster
 Rapporto Economia Provinciale 2009 271 Analisi per Cluster Analisi per Cluster 273 Cluster Per trarre qualche informazione dall andamento degli indicatori economici che ormai da sette anni vengono monitorati,
Rapporto Economia Provinciale 2009 271 Analisi per Cluster Analisi per Cluster 273 Cluster Per trarre qualche informazione dall andamento degli indicatori economici che ormai da sette anni vengono monitorati,
Le riforme per la crescita: la giustizia civile
 Le riforme per la crescita: la giustizia civile Silvia Giacomelli Banca d Italia -Servizio Studi SSE Associazione Dirigenti Giustizia 17 Convegno nazionale Brescia, 15 giugno 2013 Contenuto 1 Crescita
Le riforme per la crescita: la giustizia civile Silvia Giacomelli Banca d Italia -Servizio Studi SSE Associazione Dirigenti Giustizia 17 Convegno nazionale Brescia, 15 giugno 2013 Contenuto 1 Crescita
LA FORMAZIONE DUALE IN TOSCANA: ESPERIENZE, IDEE, CONFRONTI
 LA FORMAZIONE DUALE IN TOSCANA: ESPERIENZE, IDEE, CONFRONTI La formazione per lo sviluppo della Toscana Nicola Sciclone Palazzo Vecchio - Sala di San Lorenzo, Firenze - 13 novembre 2014 Il contesto Il
LA FORMAZIONE DUALE IN TOSCANA: ESPERIENZE, IDEE, CONFRONTI La formazione per lo sviluppo della Toscana Nicola Sciclone Palazzo Vecchio - Sala di San Lorenzo, Firenze - 13 novembre 2014 Il contesto Il
Il Capitale Umano. Adam Smith, 1776
 Il Capitale Umano L acquisizione di queste capacità mantenendo chi le acquisisce durante la sua educazione, studio o apprendistato, comporta sempre una spesa reale che è un capitale fisso e investito,
Il Capitale Umano L acquisizione di queste capacità mantenendo chi le acquisisce durante la sua educazione, studio o apprendistato, comporta sempre una spesa reale che è un capitale fisso e investito,
