Esperienze di studio della qualità biologica di corsi d acqua italiani mediante l uso delle diatomee
|
|
|
- Albana Lupo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Biologia Ambientale, 19 (1): Atti del Seminario: Classificazione ecologica delle acque interne. Applicabilità della Direttiva 2000/60/CE. Trento, febbraio G.N. Baldaccini e G. Sansoni (eds.). Ed. APAT, APPA Trento, CISBA. Trento, Esperienze di studio della qualità biologica di corsi d acqua italiani mediante l uso delle diatomee Maurizio Battegazzore 1*, Stefano Fenoglio 2, Luana Gallo 3, Lucio Lucadamo 3, Angelo Morisi 1 1 A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento di Cuneo, via D Azeglio 4, I Cuneo. 2 Di.S.A.V., Università del Piemonte Orientale, C.so Borsalino 54, I Alessandria 3 Università della Calabria, Dip.di Ecologia, v.ponte P. Bucci 4B, I Arcavacata di Rende (CS) * Referente per la corrispondenza (fax ; m.battegazzore@arpa.piemonte.it) Riassunto Il presente studio è stato condotto nel Novembre 2000 su 6 corsi d acqua del Parco Nazionale del Pollino per valutarne la qualità sulla base delle comunità di Diatomee bentoniche. Sono stati identificati 67 taxa, sulla base dei quali è stato calcolato il valore dell indice di polluzione/eutrofizzazione EPI-D. Coi dati tassonomici, assieme a quelli di 5 variabili chimico-fisiche, è stata effettuata l analisi delle corrispondenze (CORANA). Questi risultati, insieme a quelli dell indice NNS che valuta il disturbo fisico, hanno permesso di distinguere le stazioni del versante tirrenico (risultate di qualità migliore) da quelle lucane. Inoltre, sono state esaminate due situazioni particolari: la stazione sul Fiume Sarmento con una proporzione bassa di taxa mobili e la stazione sul Fiume Peschiera con valori relativamente elevati degli indici NNS ed EPI-D. Come cause sono state ipotizzate rispettivamente i fattori idrologici e l ombreggiatura. Un secondo studio, condotto nel 2001 su 6 corsi d acqua sorgivi nella Valle Pesio, ha permesso, attraverso gli indici citati e l analisi TWINSPAN di mettere in evidenza una qualità complessivamente elevata, ma anche gli effetti di alcune attività antropiche. Complessivamente, gli indici diatomici hanno mostrato di essere applicabili in diversi ambienti di acqua corrente, in aree geografiche lontane caratterizzate da climi e altitudini differenti. Le Diatomee bentoniche rivestono un particolare interesse ai fini della Direttiva 2000/60/UE: si possono utilizzare per il monitoraggio qualitativo delle acque correnti anche laddove altri metodi, compresi quelli attualmente più utilizzati, sono difficili o impossibili da applicare. PAROLE CHIAVE: Diatomee / Indici biotici / Direttiva 2000/60/CE Experiences in quality evaluation of italian watercourses based on diatoms The benthic Diatom communities in 6 rivers in the Pollino National Park were sampled in November taxa were identified and values of EPI-D eutrophication/pollution index and NNS, an index based on the proportion of motile diatom species for the evaluation of the degree of physical disturbance, were calculated. The stations on the Argentino and Abatemarco rivers (Tyrrhenian basins) showed higher quality than those situated within the Ionian basins. Correspondence analysis (CORANA) performed on taxonomic and chemicalphysical data discriminated the Tyrrhenian stations from the Ionian ones. The station on the Sarmento R. showed the lowest NNS value, and the one on the Peschiera R. showed a high value for both NNS and EPI-D. We hypothesize hydrological factors and shading of the stream bed, respectively, as explanations. The second study was undertaken on 6 spring environments in the upper Pesio Valley, NW Italy. 98 taxa were identified in the samples taken in spring, summer and autumn of EPI-D values were always in the first quality class. The NNS index and TWINSPAN classification indicated a slight degree of impact, in two springs, presumably due to a combination of pasture and recreational activities. The 2 indices proved to be appropriate for the evaluation of the quality of a variety of watercourses, in geographically separate areas and situated in a wide range of different altitudes and climatic conditions. Both indices can be used in environments where other standardized methods (including currently adopted ones) can prove difficult to use. KEY WORDS: Diatoms / Biotic Indices / 2000/60/CE Directive INTRODUZIONE Le Diatomee sono generalmente ritenute un gruppo tassonomico particolarmente idoneo per valutare non solo la qualità biologica delle acque, ma anche altri aspetti dell ecologia degli ambienti delle acque correnti, compresi quelli dove altre componenti, quali quella ittica o quella macrobentonica, risultano assenti o difficilmente campionabili. Infatti, ogni taxon delle Diatomee si colloca entro una gamma di risposte possibili ai
2 110 BATTEGAZZORE et al. - Diatomee e qualità dei corsi d acqua: due studi italiani METODI Il primo studio è stato effettuato in 7 stazioni, 4 delle quali sono situate sul versante Ionico (fiumi Sarmento, Sinni, Peschiera e Frida) e 3 su quello Tirrenico (fiumi Argentino ed Abatemarco) nel Parco Nazionale del Pollino (Fig. 1), in un unica campagna di campionafattori ambientali o entro un gradiente di fattori biologici. A tali caratteristiche delle Diatomee (la tolleranza ai fattori ambientali e le caratteristiche biologiche) è stato dato il nome di attributes o attributi (VAN DAM et al., 1994). Gli attributi meglio conosciuti sono l umidità, la salinità, il ph, l esigenza rispetto all azoto organico, il grado di ossigenazione, quello di trofia, la sensibilità all inquinamento e la mobilità (o risposta al disturbo fisico). A molte specie di Diatomee è stato attribuito un valore corrispondente alla loro collocazione nel gradiente del singolo attributo. L attributo della sensibilità all inquinamento assume una grande importanza alla luce dell attuazione della Direttiva 2000/60/CE che prevede l ampliamento della gamma di organismi e di metodi da utilizzare nel monitoraggio dei corsi d acqua. Un altro attributo importante è quello della mobilità, che può fornire informazioni sul grado di disturbo fisico di un ecosistema acquatico ed è quindi complementare a quello citato precedentemente. Lo studio delle Diatomee è ancora molto poco sviluppato nel nostro Paese, nonostante la DIR 2000/60/ CE preveda metodi basati sul perifiton nel monitorag- gio routinario dei corsi d acqua; due studi condotti in alcuni corsi d acqua nell area del Parco Nazionale del Pollino (Calabria e Lucania) e a valle di alcune sorgenti sul versante piemontese delle Alpi Liguri, costituiscono l oggetto del presente lavoro, finalizzato a valutare l utilizzabilità dei metodi basati sulle Diatomee in aree geografiche e condizioni ambientali differenti. Parte dei risultati dei due lavori citati, compresi gli elenchi floristici completi di tutti i campioni, è riportata rispettivamente in BATTEGAZZORE et al. (2004a, 2004b). Con il presente articolo si intende invece verificare l adeguatezza dei metodi basati sulle Diatomee in tipologie di corsi d acqua italiani molto diverse dal punto di vista geografico, climatico, geologico, dell altitudine e dei fattori ambientali, in vista di un loro uso ai sensi della normativa comunitaria. Fig. 1. Area di studio nel territorio del Parco Nazionale del Pollino con l indicazione delle stazioni campionate nel 2000.
3 BATTEGAZZORE et al. - Diatomee e qualità dei corsi d acqua: due studi italiani 111 Fig. 2. Area di studio dei corsi d acqua sorgentizi dell Alta Valle Pesio, con indicazione delle principali attività antropiche (gias ossìa edifici adibiti alla pastorizia, aree di pascolo, rifugi, sorgenti captate). Le stazioni, indicate coi numerie da 1 a 6, corrispondono alle sigle da Pe1 a Pe6 riportate in altre parti di questo lavoro. menti condotta nel Novembre Su ognuno dei fiumi era collocata una stazione di campionamento, mentre sul fiume Abatemarco ne sono state individuate due. Nel secondo studio sono stati condotti 3 campionamenti (Maggio, Agosto e Ottobre 2001) in 6 stazioni situate a valle di altrettante sorgenti nella parte superiore del bacino del T. Pesio (nel Parco regionale Alta Valle Pesio e Tanaro in Prov. di Cuneo, Piemonte Fig.2). Nella tabella I vengono riportati alcuni dati che caratterizzano le stazioni di campionamento. Oltre alle differenze climatiche e geografiche, le stazioni della Valle Pesio sono ubicate in una fascia altitudinale più alta rispetto alle stazioni del Pollino. Dal punto di vista geologico, le stazioni del Pollino sono tutte situate in aree a substrato sedimentario, caratterizzate da rocce carbonatiche calcareo-dolomitiche. I substrati delle stazioni della Valle Pesio possono invece essere distinti in base alla prevalenza di rocce carbonatiche (stazioni Pe1 e Pe2 nel Vallone del Marguareis) oppure di rocce silicee (stazioni dalla Pe3 alla Pe6 nel Vallone di Sestrera). Tutte le sorgenti sono in qualche misura interessate da vicino dalle attività estive di pascolo, come si può notare nella Fig. 2, dove sono indicate anche le ubicazioni dei gias, aree di sosta del bestiame con edifici tipici utilizzati dai pastori; le sorgenti Pe3 e Pe4 sono altresì molto prossime ad un rifugio molto frequentato dagli escursionisti. Le sorgenti Pe3 e Pe6 sono anche utilizzate per l approvigionamento idrico, la prima a servizio del rifugio, la seconda di un gias. Le Diatomee sono state campionate spazzolando 5 sassi per una superficie complessiva di circa 200 cm 2 e conservate in formalina. In laboratorio, sono stati preparati vetrini permanenti centrifugando i campioni per 3 volte a 1500 giri al minuto, calcinando un aliquota a 550 C per 1h e fissandola con il mezzo ottico
4 112 BATTEGAZZORE et al. - Diatomee e qualità dei corsi d acqua: due studi italiani Naphrax. L identificazione tassonomica è stata realizzata utilizzando un microscopio Leica DMLS dotato di camera lucida, con l ausilio delle guide di KRAM- MER e LANGE-BERTALOT ( ). DELL UOMO (1996, 1999, 2004) e DELL UOMO et al. (1999) hanno elaborato per l Italia l EPI-D, un indice di inquinamento dei corsi d acqua basato sulle diatomee: EPI D = n = 1 n = 1 a r i dove i è il valore indicatore del -esimo taxon (variabile da 0,0 a 4,0) ed r è il valore di affidabilità come indicatore (valori possibili 1, 3 o 5). L abbondanza a invece è stata stimata sulla base di una scala di numeri interi da 1 (pochi individui) a 5 (specie dominante). L indice è strutturato in modo che i valori possano essere compresi in un intervallo fra 0,0 e 4,0. Allo scopo di permettere l uniformazione delle scale degli indici diatomici a livello europeo, esiste uno schema di trasformazione dei valori delle Classi dalla scala 0-4 alla scala 1-20 (Tab. II). Tenuto conto delle osservazioni di HILL et al. (2001) che hanno rilevato come le specie appartenenti ai generi Navicula, Nitzschia e Surirella siano caratterizzate da un grado elevato di mobilità, e di quelle di BAHLS (1993) che ha proposto di stimare il grado di disturbo fisico dovuto ai fenomeni di sedimentazione e risospensione con la percentuale di specie mobili in un campione, viene qui utilizzato l indice NNS (BATTE- GAZZORE et al., 2004a): S NNS = Navicula + S S Nitzschia Tot. a r + S Surirella *100 dove S è il numero di taxa appartenenti rispettivamente ai generi Navicula, Nitzschia e Surirella. Sono state effettuate analisi chimico-fisiche secondo le metodiche APHA (1998). In particolare, nelle stazioni del Pollino sono stati rilevati i parametri temperatura, ph, conducibilità, durezza e ossigeno disciolto (O.D.). Nelle stazioni delle sorgenti del Pesio, nel corso del campionamento dell Ottobre 2001 sono stati rilevati temperatura, ph, conducibilità, durezza, Ca, Mg, ammoniaca, nitrati, nitriti, fosforo reattivo solubile (SRP), cloruri e solfati. Per quanto riguarda le analisi statistiche, sui dati delle comunità di Diatomee (considerando i 32 taxa più comuni) e sui 5 parametri chimico-fisici rilevati nello studio sul Pollino è stata effettuata l analisi delle corrispondenze CORANA utilizzando il software Systat (WILKINSON, 1992). Per le sorgenti del T. Pesio è stata effettuata la classificazione dei campioni di Diatomee mediante il programma TWINSPAN (HILL, 1979). RISULTATI E DISCUSSIONE Nel lavoro sul Pollino sono stati identificati complessivamente 98 taxa. Alcune specie relativamente tolleranti l inquinamento quali Navicula cryptotenella, N. viridula e Diatoma vulgaris erano relativamente comuni nelle stazioni S1, Sa1, F1 e P1. Nelle stazioni tirreniche, i taxa indicatori di ambienti ben ossigenati e puliti Diatoma mesodon, D. hyemalis e Cymbella delicatula erano ben rappresentati. Nella Tab. III vengono riportati i valori dell EPI-D Tab. I. Alcuni elementi di caratterizzazione delle stazioni di campionamento nei due studi. Aree di studio Staz. Altitudine Bacino [m s.l.m.] Pollino Ar1 180 Argentino A1 475 Abatemarco A2 359 Abatemarco F1 775 Frida P1 629 Peschiera Sa1 158 Sarmènto S1 458 Sìnni Alta Valle Pesio Pe Vallone del Marguareis Pe Vallone del Marguareis Pe Vallone di Sestrera Pe Vallone di Sestrera Pe Vallone di Sestrera Pe Vallone di Sestrera Tab. II. Classi di Qualità in base ai possibili valori dell EPI-D in scala 0-4 e 1-20 (DELL UOMO, 2004). Classe EPI-D EPI-D Giudizio Colore Qualità (scala 0-4) (scala 1-20) I > 0,0 < 1, Ottima Blu II > 1,0 < 1, Buona Verde III > 1,7 < 2, Mediocre Giallo IV > 2,3 < 3,0 6 9 Cattiva Arancione V > 2,5 < 3,0 1-6 Pessima Rosso Tab. III. Valori degli indici EPI-D (0-4) e dell indice NNS rilevati nel Nov in tutti i campioni del Pollino. Stazioni tirreniche Stazioni ioniche Indici Ar1 A1 A2 F1 P1 Sa1 S1 EPI-D 0,63 0,62 0,93 1,28 1,68 1,06 1,69 NNS 26,1 23,8 25,0 18,8 36,4 10,0 41,2
5 BATTEGAZZORE et al. - Diatomee e qualità dei corsi d acqua: due studi italiani 113 (scala 0-4) e dell indice NNS per tutti i campioni. Le stazioni tirreniche rientrano nella prima Classe di Qualità dell EPI-D, mentre quelle ioniche sono nella seconda Classe. I valori dell indice NNS presentano un quadro più diversificato. Infatti, mentre alcune stazioni dei bacini ionici (S1 e P1) presentano percentuali relativamente elevate di taxa mobili, e quindi una indicazione di disturbo fisico piuttosto significativo, altre (F1 e, soprattutto, Sa1) presentano valori addirittura più bassi di quelli delle stazioni tirreniche. Per quest ultima stazione, situata nel tratto potamale del T. Sarmento, si può ipotizzare un effetto del regime idrologico caratterizzato dal frequente alternarsi di forti piene e magre molto spinte, che ostacola la colonizzazione stabile delle Diatomee mobili, come riportato da STEVENSON (1996). Anche i valori di NNS e di EPI-D della stazione P1, situata nel bosco Magnano, caratterizzata da acque peraltro di qualità chimico-fisica piuttosto buona (Tab. IV e Fig. 3), potrebbero essere impropriamente influenzati proprio dal fatto che si tratta dell unica stazione situata in un tratto fortemente ombreggiato, selettivo per molti taxa. I dati chimico-fisici per le stazioni sono riportati nella tabella IV. Si può osservare come nelle stazioni del versante tirrenico i valori di conducibilità fossero più bassi rispetto a quelli dei bacini ionici. L ossigeno disciolto non è mai risultato inferiore agli 8,0 mg L -1, mentre il ph era sempre compreso fra 8,1 e 8,3, con l eccezione della stazione Sa1, risultata leggermente meno basica. Nella figura 3 viene presentato il diagramma di ordinazione dell analisi CORANA per i campioni e le CORANA - stazioni (7) e parametri (5) asse 2 (7%) --- asse 1 (92%) Fig. 3. Grafico dei primi 2 assi dell Analisi delle Corrispondenze realizzata con il programma Systat (WILKINSON, 1992). La variabilità complessiva dei dati spiegata dall ordinazione è del 99%. Il primo asse corrisponde da sin. a dx. ad un gradiente decrescente di conducibilità e temperatura e crescente degli altri parametri (O.D., ph e durezza), mentre le stazioni si dispongono lungo tale gradiente da quelle ioniche Sa1, S1, F1 e P1 fino a quelle tirreniche Ar1, A1 e A2. Tab. IV. Valori delle 5 variabili ambientali rilevate nello studio dei corsi d acqua del Pollino. Stazione Temperatura ph Conducibilità Durezza O.D. [ C] [μs cm -1 ] [mg L -1 CaCO 3 ] [mg L -1 ] S1 25,1 8, ,4 9,1 Sa1 27,3 7, ,7 11,4 P1 18,5 8, ,9 8,7 F1 23,7 8, ,2 8,1 A2 11,3 8, ,8 10,4 A1 10,4 8, ,2 10,7 Ar1 13,5 8, ,0 9,8
6 114 BATTEGAZZORE et al. - Diatomee e qualità dei corsi d acqua: due studi italiani variabili ambientali, dal quale si può osservare come il primo asse spieghi il 92% della variabilità complessiva dei dati mentre il secondo asse ne spieghi il 7%. È piuttosto evidente il gradiente da sinistra verso destra dalle stazioni tirreniche, maggiormente correlate alla conducibilità e alla temperatura, fino a quelle ioniche, positivamente correlate a ossigeno disciolto, durezza e ph. Nel lavoro sulle sorgenti del Pesio sono stati determinati complessivamente 67 taxa, dei quali i più comuni erano Achnanthes lanceolata (Brebisson) Grunow ssp. lanceolata var. lanceolata, Achnanthes minutissima Kützing, Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing e Meridion circulare (Greville) Agardh. Nella stazione Pe1 Achnanthes biasolettiana Grunow era molto abbondante, mentree Tabellaria flocculosa Roth (Kützing) lo era nel campione di Agosto della sorgente Pe5. Nella tabella V si possono osservare i valori degli indici EPI-D ed NNS nelle 3 date. Si può osservare come i valori dell EPI-D siano quasi sempre entro la prima Classe di Qualità; tuttavia, alcune considerazioni meritano di essere fatte. La stazione Pe5 in Agosto ha mostrato un minimo davvero ragguardevole, indicando una qualità eccezionalmente buona. Per contro, i valori dell EPI-D di Ottobre sono scesi alla seconda Classe nelle sorgenti Pe3 e Pe4. Queste due stazioni sono anche quelle con i valori più alti dell indice NNS, sia ad Ottobre che come valore medio su tutte le date. Pertanto, è ipotizzabile una fonte di disturbo fisico che potrebbe consistere nell effetto combinato di attività turistiche collegate al vicino rifugio e attività di pascolo. Le captazioni presenti nelle sorgenti 3 e 6 non sembrano invece produrre effetti negativi sulla qualità così come rilevata dai due indici. Nella tabella VI vengono riportati i valori dei rilevamenti chimico-fisici effettuati nel corso del campionamento di Ottobre nelle stazioni in Valle Pesio. Come si può notare, i valori dei solfati sono nettamente più elevati nella stazione Pe1 rispetto alle altre; ciò può essere spiegato dalla presenza di gesso nel substrato geologico di quell area del Vallone del Marguareis. Il substrato spiega anche le differenze fra sorgenti in termini di Ca e di Mg: le stazioni Pe1 e Pe2 risultano le più carbonatiche, mentre la Pe5 e la Pe6, trovandosi in aree a substrato siliceo (SAPPA e PIOVA- NO, 1947), presentano valori nettamente più bassi. Fra i sali nutrienti, solo i nitrati erano rilevabili, mentre i cloruri erano presenti a concentrazioni piuttosto ridotte. Nella figura 4 si può osservare il dendrogramma dell analisi TWINSPAN sui 18 campioni di Diatomee. Dopo 5 divisioni, i 3 campioni della sorgente Pe1 erano ancora raggruppati insieme. Lo stesso dicasi per le stazioni Pe2 e Pe6. Queste 3 sorgenti sono quindi risultate quelle con comunità di Diatomee che hanno subito meno cambiamenti nella composizione tassonomica nel corso dei campionamenti. Il campione di Agosto della stazione Pe5 è quello che più si distingue Tab. V. Valori singoli e medi degli indici EPI-D (0-4) ed NNS nelle stazioni della Valle Pesio. Stazione Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 EPI-D Mag 0,77 0,68 0,76 0,80 0,70 0,68 EPI-D Ago 0,80 0,84 0,77 0,75 0,22 0,97 EPI-D Ott 0,81 0,84 1,16 1,13 0,73 0,63 EPI-D medio 0,79 0,79 0,90 0,89 0,55 0,76 NNS Mag 22,2 6,3 13,3 21,4 0,0 18,9 NNS Ago 15,4 13,3 16,7 19,0 6,3 12,5 NNS Ott 12,5 13,6 40,0 37,5 25,0 21,4 NNS medio 16,7 11,1 23,3 26,0 10,4 17,6 Tab. VI. Valori delle variabili ambientali rilevate nel corso del campionamento dell Ottobre 2001 nelle stazioni della Valle Pesio. Temp. Cond. Durezza ph Ca Mg Ca+Mg NH 4 P (SRP) N-NO 3 N-NO 2 Cl SO 4 Stazione ( C) (μs/cm) ( F) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Pe1 6,4 176 <1 8,0 37,0 6,0 43,0 n.r. n.r. 0,68 n.r. 0,0 22,6 Pe2 2,3 104 <1 8,0 19,6 4,9 24,5 n.r. n.r. 1,27 n.r. 1,6 3,7 Pe3 3,7 72 <1 7,9 17,9 0,4 18,3 n.r. n.r. 0,85 n.r. 1,4 2,8 Pe4 6,3 84 <1 7,6 21,0 0,1 21,1 n.r. n.r. 0,45 n.r. 3,5 2,5 Pe5 5,1 21 <1 7,4 5,7 0,1 5,8 n.r. n.r. 1,36 n.r. 3,9 4,0 Pe6 6,0 42 <1 7,4 8,4 0,5 8,9 n.r. n.r. 1,58 n.r. 1,9 3,9
7 BATTEGAZZORE et al. - Diatomee e qualità dei corsi d acqua: due studi italiani 115 Pe5ago Pe2mag Pe2ago Pe2ott Pe1mag Pe1ago Pe1ott Pe3ago Pe4mag Pe3mag Pe5mag Pe5ott Pe3ott Pe4ago Pe4ott Pe6mag Pe6ago Pe6ott Fig. 4. Dendrogramma di classificazione dei 18 campioni di Diatomee del 2001 nell Alta Valle Pesio con analisi effettuata col programma TWINSPAN (HILL, 1979) fermata dopo 5 divisioni. Si può osservare come la comunità nella stazione Pe5 di Agosto sia risultata la meno simile rispetto a tutte le altre. I campioni stagionali della stazioni Pe1 (ma anche quelli delle stazioni Pe2 e Pe6) sono risultati sempre più simili tra di loro che con gli altri campioni. Invece, le comunità della sorgente Pe4 e - ancora di più - della Pe3, sono risultati piuttosto dissimili tra loro nel corso dei campionamenti, anche a causa delle variazioni della qualità delle acque e di fattori di disturbo fisico. dagli altri (presumibilmente a causa della prevalenza di taxa indicatori di una qualità particolarmente elevata, in accordo con quanto scritto sopra). Le altre stazioni che hanno evidenziato scostamenti nella composizione nel corso dei 3 campionamenti sono la Pe 4 e, soprattutto, la Pe3, per la quale i 3 campioni hanno mostrato di essere sempre più simili a campioni di altre stazioni che tra di loro. In definitiva, ciò conferma quanto già emerso con gli indici diatomici, cioè che le sorgenti 3 e 4 sono da ritenersi quelle che subiscono i peggioramenti di qualità relativamente più grandi nel corso dei campionamenti. Tra le cause di tale sia pur modesto grado di alterazione che è stato riscontrato, possono essere ipotizzate la combinazione delle attività di pascolo e di quelle ricreative legate alla presenza del rifugio, con una prevalenza di queste ultime. Sembrano da escludere, invece, effetti significativi dovuti alle captazioni idriche delle sorgenti 3 e 6 (di modesta entità e realizzate con tecniche poco impattanti). CONCLUSIONI Nel quadro della Direttiva 2000/60/UE, il presente lavoro conferma che le comunità di Diatomee possono essere un importante complemento dei metodi più collaudati per la classificazione ecologica dei corsi d acqua: a) per il loro diverso intervallo di risposta ai fattori di inquinamento, b) per l ampia varietà di habitat colonizzabili, c) per la significativa estensione geografica, climatica e altitudinale degli ambienti acquatici nei quali si trovano comunità di Diatomee ben strutturate e d) per la loro risposta misurabile anche rispetto a fattori di disturbo di tipo fisico. Le comunità di Diatomee sembrano rispondere anche a piccole variazioni dei fattori ambientali; tuttavia, nel confronto fra campioni, occorre prestare attenzione ai fattori diversi dall inquinamento che selezionano i taxa di Diatomee, come la luminosità, l idrologia e la tipologia di substrato geologico. Il grado di standardizzazione dei protocolli applicativi dei metodi basati sugli indici diatomici potrebbe e dovrebbe essere migliorato per ridurre questi problemi. Infine, con poche eccezioni, in Italia la preparazione tassonomica necessaria per il riconoscimento delle Diatomee a livello di specie è attualmente carente sia nelle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale che nelle Università; andrebbe pertanto attuato un grande sforzo di formazione in questa direzione. BIBLIOGRAFIA APHA, American Public Health Association, Standard methods for the examination of water and wastewater, 22 nd Ed., Washington DC. BAHLS L.L. (1993). Periphyton bioassessment methods for Montana streams. Water Quality Bureau, Dept. Of Health and Environmental Sciences, Helena, Montana. BATTEGAZZORE M., MORISI A., GALLINO B., FENOGLIO S., 2004 a. Environmental quality evaluation of alpine springs in NW Italy using benthic Diatoms. Diatom Research Diatom Research, 19 (2): BATTEGAZZORE M., GALLO L., LUCADAMO L., MORISI A., 2004b. Quality of the main watercourses in the Pollino National Park
8 116 BATTEGAZZORE et al. - Diatomee e qualità dei corsi d acqua: due studi italiani (Apennine Mts., S Italy) on the basis of the Diatom benthic communities. Atti XVI Convegno del Gruppo per l Ecologia di Base G. Gadio Il fiume e il suo bacino Pavia, maggio Studi Trentini di Sc. Nat. - Acta Biologica, 80: DELL UOMO A., Assessment of water quality of an Apennine river as a pilot study for diatom-based monitoring of Italian watercourses. In: Whtitton BA & Rott E (eds), Use of algae for monitoring rivers II, Institut für Botanik, Universität Innsbruck: DELL UOMO A., Use of algae for monitoring rivers in Italy: current situation and perspectives. In: Prygiel J., Whitton B.A., Bukowska J. (eds), Use of algae for monitoring rivers III, Agence de l Eau Artois-Picardie, Douai (France): DELL UOMO A., PENSIRI A., CORRADETTI D., Diatomeés épilithiques du fleuve Esino (Italie centrale) et leur utilisation pour l evaluation de la qualité biologique de l eau. Cryptogamie, Algologie, 20: DELL UOMO A., Indice Diatomico di Eutrofizzazione/Polluzione (EPI-D) nel monitoraggio delle acque correnti. Linee Guida. APAT, Roma. HILL M.O., TWINSPAN. A FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of individuals and attributes. Microcomputer Power, New York. HILL B.H., STEVENSON R.J., PAN Y., HERLIHY A.T., KAUFMANN P.R., JOHNSON C.B., Comparison of correlations between environmental characteristics and stream diatom assemblages characterized at genus and species levels. J.N.Am.Benthol.Soc. 20 (2): KRAMMER K., LANGE-BERTALOT H., Bacillariophyceae (1-5). In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. and Mollenhauer D., Susswasserflora von Mitteleuropa. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin. SAPPA F., PIOVANO G., La valle Pesio e la sua vegetazione (Alpi Marittime). Lavori di Botanica, Istituto Botanico dell Università di Torino, VIII: STEVENSON, R.J., An introduction to algal ecology in freshwater benthic habitats. In: Algal Ecology, R.J. Stevenson, M.L. Bothwell & R.L. Lowe (Ed.), Academic Press: VAN DAM H., MERTENS A., SINKELDAM J., A coded checklist and ecological indicator values of freshwater Diatoms from the Netherlands. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 28 (1): WILKINSON L., Systat 8.0. SPSS Ed. Chicago.
LE DIATOMEE BENTONICHE FLUVIALI ESPERIENZE APPLICATIVE DI ARPAV
 LE DIATOMEE BENTONICHE FLUVIALI ESPERIENZE APPLICATIVE DI ARPAV Federica Giacomazzi - Silvia Menegon ARPAV- Dipartimento Regionale Laboratori (con la collaborazione di Ermanno Bertuzzi ARPAV Dipartimento
LE DIATOMEE BENTONICHE FLUVIALI ESPERIENZE APPLICATIVE DI ARPAV Federica Giacomazzi - Silvia Menegon ARPAV- Dipartimento Regionale Laboratori (con la collaborazione di Ermanno Bertuzzi ARPAV Dipartimento
OLTRE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE VERSO LO STATO ECOLOGICO DEI FIUMI. Claudia Orlandi ARPA FVG
 OLTRE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE VERSO LO STATO ECOLOGICO DEI FIUMI Claudia Orlandi ARPA FVG 27 GENNAIO 2011 RIPENSARE L IDROELETTRICO Energia rinnovabile o energia da rinnovare?, 8 giugno 2013 WATER FRAME
OLTRE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE VERSO LO STATO ECOLOGICO DEI FIUMI Claudia Orlandi ARPA FVG 27 GENNAIO 2011 RIPENSARE L IDROELETTRICO Energia rinnovabile o energia da rinnovare?, 8 giugno 2013 WATER FRAME
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. DAI DATI DEL MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLA RETE ARPA PIEMONTE
 IL SISTEMA VITI-VINICOLO REGIONALE - 24 marzo 24 Dott.ssa Maria Rita Cesare Arpa Piemonte Dipartimento di Torino AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. DAI DATI DEL MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLA RETE ARPA PIEMONTE
IL SISTEMA VITI-VINICOLO REGIONALE - 24 marzo 24 Dott.ssa Maria Rita Cesare Arpa Piemonte Dipartimento di Torino AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. DAI DATI DEL MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLA RETE ARPA PIEMONTE
I fiumi. La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia
 I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Inquadramento ittiofaunistico
 Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
Dicembre 2014 CARATTERIZZAZIONE DELL ITTIOFAUNA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI SU UN OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TOSSIET (BACINO
Lo stato ecologico degli ambienti fluviali
 Abteilung 29 - Umweltagentur Amt 29.9 Biologisches Labor Ripartizione 29 Agenzia per l ambiente Ufficio 29.9 Laboratorio biologico Lo stato ecologico degli ambienti fluviali Diatomee Birgit Lösch & Renate
Abteilung 29 - Umweltagentur Amt 29.9 Biologisches Labor Ripartizione 29 Agenzia per l ambiente Ufficio 29.9 Laboratorio biologico Lo stato ecologico degli ambienti fluviali Diatomee Birgit Lösch & Renate
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI
 IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Progetto di restauro del complesso monumentale della Fontana del Nettuno
 Progetto di restauro del complesso monumentale della Fontana del Nettuno Qualità delle acque. Stato attuale di funzionamento della fontana monumentale: scenario primaverile. Relazione a cura di: Prof.
Progetto di restauro del complesso monumentale della Fontana del Nettuno Qualità delle acque. Stato attuale di funzionamento della fontana monumentale: scenario primaverile. Relazione a cura di: Prof.
DICAM DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA AMBIENTALE E DEI MATERIALI
 COLLABORAZIONE SCIENTIFICA COMUNE DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO Attività n. 3 QUALITA DELLE ACQUE Indice: SECONDA RELAZIONE Stato
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA COMUNE DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO Attività n. 3 QUALITA DELLE ACQUE Indice: SECONDA RELAZIONE Stato
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/2010.
 Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Wew32q4e2. Monitoraggio Diga del Pertusillo
 Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Wew32q4e2 Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MAGGIO 2011 L attività di monitoraggio dell A.R.P.A.B. della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Tesero. Il primo gruppo di sorgenti si trova alla testata della Val dei Cavai, ed emerge per contatto da depositi detritici:
 Tesero Figura 1 : stralcio di mappe di parti del Comune di Tesero con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti
Tesero Figura 1 : stralcio di mappe di parti del Comune di Tesero con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti
Totale campionati
 2.3.2. Carichi chimici Gli apporti al Lago Maggiore dei principali nutrienti algali dai tributari e in uscita attraverso il Ticino emissario sono stati misurati nel corso del 2007 con le stesse metodologie
2.3.2. Carichi chimici Gli apporti al Lago Maggiore dei principali nutrienti algali dai tributari e in uscita attraverso il Ticino emissario sono stati misurati nel corso del 2007 con le stesse metodologie
9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA
 9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA Pagina 83 9.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Ventena confina in sinistra idrografica con il bacino del Conca ed in destra con i bacini del Foglia e del Tavollo. Il bacino
9 IL BACINO DEL TORRENTE VENTENA Pagina 83 9.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Ventena confina in sinistra idrografica con il bacino del Conca ed in destra con i bacini del Foglia e del Tavollo. Il bacino
MONITORAGGIO R.N.O. MARINELLO
 MONITORAGGIO R.N.O. MARINELLO Febbraio Dicembre 2016 La riserva naturale orientata Laghetti di Marinello, istituita nel 1998 e affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina (ora Città Metropolitana
MONITORAGGIO R.N.O. MARINELLO Febbraio Dicembre 2016 La riserva naturale orientata Laghetti di Marinello, istituita nel 1998 e affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina (ora Città Metropolitana
Rovereto. Servizio Geologico 1
 Rovereto Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile sono riportate
Rovereto Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile sono riportate
Monitoraggio Diga del Pertusillo
 We Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MARZO 2011 L attività dell A.R.P.A.B. di monitoraggio della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
We Monitoraggio Diga del Pertusillo Campionamento relativo al mese MARZO 2011 L attività dell A.R.P.A.B. di monitoraggio della qualità delle acque dell invaso del Pertusillo, prosegue con i campionamenti
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
Riva del Garda. Servizio Geologico 1
 Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile sono riportate con
Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile sono riportate con
Diga di Saretto Comune di Acceglio. La gestione di un invaso. ENEL Produzione ing. Barettini San Damiano Macra 18 ottobre 2014
 Diga di Saretto Comune di Acceglio La gestione di un invaso ENEL Produzione ing. Barettini San Damiano Macra 18 ottobre 2014 Asta del T. Maira Produzione idroelettrica Profilo idraulico Asta del T. Maira
Diga di Saretto Comune di Acceglio La gestione di un invaso ENEL Produzione ing. Barettini San Damiano Macra 18 ottobre 2014 Asta del T. Maira Produzione idroelettrica Profilo idraulico Asta del T. Maira
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia
 Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA
 LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA CONFIGURAZIONE DELLA RETE Il sistema di controllo della qualità dell aria in Valle d Aosta è finalizzato al monitoraggio della qualità dell aria dell intero
LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA CONFIGURAZIONE DELLA RETE Il sistema di controllo della qualità dell aria in Valle d Aosta è finalizzato al monitoraggio della qualità dell aria dell intero
PROGETTO GLORIA : LA VEGETAZIONE DI ALTA QUOTA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
 PROGETTO GLORIA : LA VEGETAZIONE DI ALTA QUOTA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI Gli ecosistemi montani rappresentano l unica unità biogeografica terrestre distribuita su tutto
PROGETTO GLORIA : LA VEGETAZIONE DI ALTA QUOTA PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI Gli ecosistemi montani rappresentano l unica unità biogeografica terrestre distribuita su tutto
6 METODOLOGIA qualità chimico-fisica
 6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI D ACQUA E STRUMENTO DI MONITORAGGIO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
 2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
13 dicembre Descrizione dell attività didattica
 13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO SINTESI DELL ELABORATO DI TESI VALUTAZIONE DEI TREND DEI NITRATI IN CAMPANIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO SINTESI DELL ELABORATO DI TESI VALUTAZIONE DEI TREND DEI NITRATI IN CAMPANIA
Utilizzeremo un kit analitico per valutare la qualità dell acqua potabile delle nostre case, scuole e fontanelle cittadine.
 Acqua in brocca Ciao! Io sono LABBY e vi farò da guida per l analisi dell acqua del vostro rubinetto! Utilizzeremo un kit analitico per valutare la qualità dell acqua potabile delle nostre case, scuole
Acqua in brocca Ciao! Io sono LABBY e vi farò da guida per l analisi dell acqua del vostro rubinetto! Utilizzeremo un kit analitico per valutare la qualità dell acqua potabile delle nostre case, scuole
L'implementazione della Water Framework Directive e il contributo delle ricerche a lungo termine nei siti lacustri della rete LTER-Italia.
 L'implementazione della Water Framework Directive e il contributo delle ricerche a lungo termine nei siti lacustri della rete LTER-Italia. G. Morabito & A. Marchetto CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
L'implementazione della Water Framework Directive e il contributo delle ricerche a lungo termine nei siti lacustri della rete LTER-Italia. G. Morabito & A. Marchetto CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA Facoltà si scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze Ambientali Curriculum EcoGeFCo
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA Facoltà si scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze Ambientali Curriculum EcoGeFCo MONITORAGGIO DEI COMPOSTI DELL AZOTO E DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA Facoltà si scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze Ambientali Curriculum EcoGeFCo MONITORAGGIO DEI COMPOSTI DELL AZOTO E DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI
ALLEGATO 5 MODELLI DI MESCOLAMENTO
 ALLEGATO 5 MODELLI DI MESCOLAMENTO Di seguito è riportata la discussione sintetica relativa alle variazioni di composizione chimica rilevate nei canali. Mese per mese sono presi in considerazione i campioni
ALLEGATO 5 MODELLI DI MESCOLAMENTO Di seguito è riportata la discussione sintetica relativa alle variazioni di composizione chimica rilevate nei canali. Mese per mese sono presi in considerazione i campioni
L importanza della zona iporreica e dell idromorfologia nella ritenzione dei nutrienti: esperienze condotte nel torrente Curone (LC)
 Presentazione preparata con il contributo Europeo LIFE+ 2008 Programme (European Commission) L importanza della zona iporreica e dell idromorfologia nella ritenzione dei nutrienti: esperienze condotte
Presentazione preparata con il contributo Europeo LIFE+ 2008 Programme (European Commission) L importanza della zona iporreica e dell idromorfologia nella ritenzione dei nutrienti: esperienze condotte
Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2)
 Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2) In particolare i valori di piezometria sono risultati più bassi rispetto a quelli del
Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2) In particolare i valori di piezometria sono risultati più bassi rispetto a quelli del
Indagine nazionale sugli aspetti qualitativi dell'acqua condottata. 2 Relazione biennale.
 Indagine nazionale sugli aspetti qualitativi dell'acqua condottata. 2 Relazione biennale. Dr.ssa Anna Maria Manzieri Arpa Sezione Provinciale di Modena P.I. Franca Bottazzi Arpa Sezione Provinciale di
Indagine nazionale sugli aspetti qualitativi dell'acqua condottata. 2 Relazione biennale. Dr.ssa Anna Maria Manzieri Arpa Sezione Provinciale di Modena P.I. Franca Bottazzi Arpa Sezione Provinciale di
Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia
 CORPO IDRICO: TME4 CATEGORIA acque di transizione TIPOLOGIA AT17 CORPO IDRICO TME4 DENOMINAZIONE AREA Secca Man di Spiesà SUPERFICIE AREA (km 2 ) 4,63 NUMERO DI STAZIONI 3 Codice stazione X(GB) Y(GB) TME401
CORPO IDRICO: TME4 CATEGORIA acque di transizione TIPOLOGIA AT17 CORPO IDRICO TME4 DENOMINAZIONE AREA Secca Man di Spiesà SUPERFICIE AREA (km 2 ) 4,63 NUMERO DI STAZIONI 3 Codice stazione X(GB) Y(GB) TME401
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
BLAND-ALTMAN PLOT. + X 2i 2 la differenza ( d ) tra le due misure per ognuno degli n campioni; d i. X i. = X 1i. X 2i
 BLAND-ALTMAN PLOT Il metodo di J. M. Bland e D. G. Altman è finalizzato alla verifica se due tecniche di misura sono comparabili. Resta da comprendere cosa si intenda con il termine metodi comparabili
BLAND-ALTMAN PLOT Il metodo di J. M. Bland e D. G. Altman è finalizzato alla verifica se due tecniche di misura sono comparabili. Resta da comprendere cosa si intenda con il termine metodi comparabili
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci
 Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche.
 corpo idrico sotterraneo: Piana di Catania b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche. Caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche L acquifero principale è costituito sia dalle alluvioni
corpo idrico sotterraneo: Piana di Catania b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche. Caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche L acquifero principale è costituito sia dalle alluvioni
CORPI IDRICI: STATO E OBIETTIVI. II Forum di informazione pubblica Milano, 17 settembre 2009
 Progetto di Piano Elaborato ai sensi dell art. 13 della Direttiva 2000/60 CE e dell art. 117 del D.Lgs. 152/06 e dell art. 1, comma 3 bis della L.13/09 CORPI IDRICI: STATO E OBIETTIVI II Forum di informazione
Progetto di Piano Elaborato ai sensi dell art. 13 della Direttiva 2000/60 CE e dell art. 117 del D.Lgs. 152/06 e dell art. 1, comma 3 bis della L.13/09 CORPI IDRICI: STATO E OBIETTIVI II Forum di informazione
I RISULTATI WQI 1) BOD
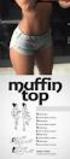 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
ARPA Sezione di Rimini
 ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
ARPA Sezione di Rimini Melo Rio Melo 211 B Ponte Via Venezia Riccione Bacino idrografico Corso d acqua Codice Tipo Localizzazione Pagina 76 Pagina 77 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori Anche per
3.4 Livello di funzionalità ecologica (IFF), Giugno 2000
 3.4 Livello di funzionalità ecologica (IFF), Giugno 2000 L ecosistema fluviale dell alto Sangro (S1-S2) denota un livello di funzionalità fluviale giudicabile buono ottimo, che diviene ottimo all altezza
3.4 Livello di funzionalità ecologica (IFF), Giugno 2000 L ecosistema fluviale dell alto Sangro (S1-S2) denota un livello di funzionalità fluviale giudicabile buono ottimo, che diviene ottimo all altezza
Giornata celebrativa per il ventennale del Programma LIFE Università degli Studi di Brescia 25 maggio 2012
 Premesse, obiettivi e struttura generale del progetto INHABIT: importanza dell habitat nella definizione dello stato ecologico in fiumi e laghi del Sud Europa Giornata celebrativa per il ventennale del
Premesse, obiettivi e struttura generale del progetto INHABIT: importanza dell habitat nella definizione dello stato ecologico in fiumi e laghi del Sud Europa Giornata celebrativa per il ventennale del
ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA
 1 / 20 ST-001 ALLEGATO I ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA 2 / 20 ST-001 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE Gli impianti di trattamento e di compressione gas della Concessione Stoccaggio
1 / 20 ST-001 ALLEGATO I ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA 2 / 20 ST-001 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE Gli impianti di trattamento e di compressione gas della Concessione Stoccaggio
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CISANO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 17/11/2016 120 mg/l - Ammoniaca (NH4) 17/11/2016 0,093 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 17/11/2016 0 µg/l 0-10 Calcio
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CISANO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 17/11/2016 120 mg/l - Ammoniaca (NH4) 17/11/2016 0,093 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 17/11/2016 0 µg/l 0-10 Calcio
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
Denno e Campodenno. Servizio Geologico 1
 Denno e Campodenno Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile
Denno e Campodenno Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile
AAVV, (1998), Water quality criteria in enviromental management Commission of the European Communities.
 BIBLIOGRAFIA AAVV, (1998), Water quality criteria in enviromental management Commission of the European Communities. AAVV, (2001), Manuale di riqualificazione fluviale C.I.R.F. AAVV, (2002), Applicazione
BIBLIOGRAFIA AAVV, (1998), Water quality criteria in enviromental management Commission of the European Communities. AAVV, (2001), Manuale di riqualificazione fluviale C.I.R.F. AAVV, (2002), Applicazione
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo
 PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE COSTE PUGLIESI
 UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE COSTE PUGLIESI a cura di Nicola Ungaro, Annamaria Pastorelli, Enrico Barbone Unità Operativa Semplice Biologia Mare e Coste I rifiuti spiaggiati e
UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE COSTE PUGLIESI a cura di Nicola Ungaro, Annamaria Pastorelli, Enrico Barbone Unità Operativa Semplice Biologia Mare e Coste I rifiuti spiaggiati e
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CASTELLETTO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 31/10/2016 384 mg/l - Ammoniaca (NH4) 31/10/2016 0,11 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 31/10/2016 0 µg/l 0-10
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 5 DISTRETTO CASTELLETTO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 31/10/2016 384 mg/l - Ammoniaca (NH4) 31/10/2016 0,11 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 31/10/2016 0 µg/l 0-10
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENTRO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 22/06/2017 141,6 mg/l - Ammoniaca (NH4) 22/06/2017 0,147 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 22/06/2017 0,27
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENTRO Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 22/06/2017 141,6 mg/l - Ammoniaca (NH4) 22/06/2017 0,147 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 22/06/2017 0,27
I LIVELLI DEL LAGO DI GARDA NEGLI ANNI
 DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO GARDA NEGLI ANNI 2009-10 ARPAV Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Alberto Luchetta Servizio Idrologico Regionale Giacomo Renzo
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO GARDA NEGLI ANNI 2009-10 ARPAV Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Alberto Luchetta Servizio Idrologico Regionale Giacomo Renzo
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENT Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 23/12/2016 148,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 23/12/2016 0,1275 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 23/12/2016 0,8125
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 9 DISTRETTO DESENZANO CENT Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 23/12/2016 148,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 23/12/2016 0,1275 mg/l 0-0,5 Arsenico (As) 23/12/2016 0,8125
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E.
 Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
Zaupa S.! "# Boggero A. Rossaro B. Bettinetti R. Buscarinu P. Sesia E. Il progetto finanziato per l implementazione della Direttiva 2000/60/CE ha lo scopo di definire lo stato ecologico e il potenziale
Bologna, 11 dicembre Clara Bravi, Regione Lombardia - Pietro Genoni, ARPA Lombardia
 1 Il progetto di gestione - obiettivi Pianificazione ed attuazione delle operazioni di gestione del materiale sedimentato nell invaso (svaso, sfangamento, spurgo). Assicurare il mantenimento e ripristino
1 Il progetto di gestione - obiettivi Pianificazione ed attuazione delle operazioni di gestione del materiale sedimentato nell invaso (svaso, sfangamento, spurgo). Assicurare il mantenimento e ripristino
S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l.
 REPORT AMBIENTALE ANNO 2015 METRI CUBI TRATTATI DALL IMPIANTO SEB Si evidenzia un lieve incremento dei mc ritirati c/to terzi e una diminuzione dei reflui della conceria MIB rispetto all anno precedente.
REPORT AMBIENTALE ANNO 2015 METRI CUBI TRATTATI DALL IMPIANTO SEB Si evidenzia un lieve incremento dei mc ritirati c/to terzi e una diminuzione dei reflui della conceria MIB rispetto all anno precedente.
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Relatore: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, Classe n 35. Corso di Laurea Magistrale
Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Relatore: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, Classe n 35. Corso di Laurea Magistrale
MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO
 MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO Gennaio Dicembre 2016 Monitoraggio Laguna di Capo Peloro La Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro, istituita con Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
MONITORAGGIO R.N.O. CAPO PELORO Gennaio Dicembre 2016 Monitoraggio Laguna di Capo Peloro La Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro, istituita con Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena
 STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento di Torino Sede di Torino Struttura Semplice Attività di produzione Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione Cunicolo esplorativo La Maddalena MONITORAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI
 SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SERVIZIO OSSERVATORIO ACQUE MARINE E LAGUNARI Copertura: regionale Periodicità: annuale www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 7
 Qualità dell'acqua Pagina 1 di 7 DISTRETTO CECINA Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 04/01/2017 152,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 04/01/2017 0,0935 mg/l 0-0,5 Calcio (Ca) 04/01/2017 56,35 mg/l - Cloro
Qualità dell'acqua Pagina 1 di 7 DISTRETTO CECINA Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3) 04/01/2017 152,5 mg/l - Ammoniaca (NH4) 04/01/2017 0,0935 mg/l 0-0,5 Calcio (Ca) 04/01/2017 56,35 mg/l - Cloro
Incontro di consultazione pubblica Venezia, 6 luglio 2017
 Inquadramento norma-vo europeo: le linee guida europee sull ecological flow Il conceao di deflusso ecologico in Europa A Blueprint to safeguard Europe s water resources, 2012 (Piano per la salvaguardia
Inquadramento norma-vo europeo: le linee guida europee sull ecological flow Il conceao di deflusso ecologico in Europa A Blueprint to safeguard Europe s water resources, 2012 (Piano per la salvaguardia
LA QUALITA DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI DELLA REGIONE UMBRIA. Valutazione della conformità Anni
 LA QUALITA DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI DELLA REGIONE UMBRIA Valutazione della conformità Anni 2011-2013 Aprile 2014 Redazione Coordinamento Visto Alessandra Cingolani Alessandra
LA QUALITA DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI DELLA REGIONE UMBRIA Valutazione della conformità Anni 2011-2013 Aprile 2014 Redazione Coordinamento Visto Alessandra Cingolani Alessandra
Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali
 Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali Daniele Nizzoli, Rossano Bolpagni, Marco Bartoli, Pierluigi Viaroli Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi
Caratterizzazione ecologica e utilizzo dei laghi di cava nelle aree golenali Daniele Nizzoli, Rossano Bolpagni, Marco Bartoli, Pierluigi Viaroli Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi
Imer. - Solani alta (1882), che sgorga a quota 1020 m, con una portata media di 1.4 l/s.
 Imer Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile sono riportate
Imer Figura 1 : mappa con l ubicazione delle sorgenti selezionate ed analizzate (in rosso) con il codice che le caratterizza univocamente; per le sole sorgenti utilizzate a scopo potabile sono riportate
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA
 servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
Modellistica numerica avanzata a supporto dell idroecologia Scenari di impatto sulla qualità delle acque
 Modellistica numerica avanzata a supporto dell idroecologia Scenari di impatto sulla qualità delle acque Luca Dutto - Hydrodata S.p.A. Mauro Porcelli - Ente Parco Nazionale del Circeo Torino, 14-15 Ottobre
Modellistica numerica avanzata a supporto dell idroecologia Scenari di impatto sulla qualità delle acque Luca Dutto - Hydrodata S.p.A. Mauro Porcelli - Ente Parco Nazionale del Circeo Torino, 14-15 Ottobre
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
Indice. Approccio concettuale. Procedura operativa
 Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) A1Z ,5 5,6
 Rio Cavelonte Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) A1Z5010000 13,5 5,6 Tabella 1: Punteggio, livello, giudizio IFF reale e relativ o Descrizione tratto IFF reale IFF relativo Codice Data
Rio Cavelonte Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) A1Z5010000 13,5 5,6 Tabella 1: Punteggio, livello, giudizio IFF reale e relativ o Descrizione tratto IFF reale IFF relativo Codice Data
PROGETTO LIFE 13 ENV/IT/ RINASCE Attività di monitoraggio chimico-fisico delle acque superficiali
 Consorzio di Bonifica dell'emilia Centrale PROGETTO LIFE 13 ENV/IT/000169 RINASCE Attività di monitoraggio chimico-fisico delle acque superficiali CAMPAGNA MONITORAGGIO ANTE OPERAM Dati GENNAIO-OTTOBRE
Consorzio di Bonifica dell'emilia Centrale PROGETTO LIFE 13 ENV/IT/000169 RINASCE Attività di monitoraggio chimico-fisico delle acque superficiali CAMPAGNA MONITORAGGIO ANTE OPERAM Dati GENNAIO-OTTOBRE
L Italia sismica Dati socio-demografici e strutturali dei comuni del centro Italia
 L Italia sismica Dati socio-demografici e strutturali dei comuni del centro Italia Chiara Caramia n. matricola 100254 Eleonora Romagnoli n. matricola 97679 Federica Rossi n. matricola 100573 Sofia Solera
L Italia sismica Dati socio-demografici e strutturali dei comuni del centro Italia Chiara Caramia n. matricola 100254 Eleonora Romagnoli n. matricola 97679 Federica Rossi n. matricola 100573 Sofia Solera
Indagini biologiche e morfologiche sul torrente Gesso
 Indagini biologiche e morfologiche sul torrente Gesso L.Gautero, M.Battegazzore, G.Cavallera, A.Gaggino, E.Gastaldi, L.Giordano, I.Mattone, G.Moletta, P.Molineri Progetto 2010-2012: Monitoraggio e studio
Indagini biologiche e morfologiche sul torrente Gesso L.Gautero, M.Battegazzore, G.Cavallera, A.Gaggino, E.Gastaldi, L.Giordano, I.Mattone, G.Moletta, P.Molineri Progetto 2010-2012: Monitoraggio e studio
Recenti sviluppi nella classificazione ecologica dei laghi tramite i macroinvertebrati
 Recenti sviluppi nella classificazione ecologica dei laghi tramite i macroinvertebrati Boggero Angela CNR ISE a.boggero@ise.cnr.it http://www.ise.cnr.it/ AQUAE VENEZIA 2015 Research as a tool for freshwater
Recenti sviluppi nella classificazione ecologica dei laghi tramite i macroinvertebrati Boggero Angela CNR ISE a.boggero@ise.cnr.it http://www.ise.cnr.it/ AQUAE VENEZIA 2015 Research as a tool for freshwater
FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI E FACOLTA DI AGRARIA. Corso di Laurea Interfacoltà In. Scienze Ambientali
 UNIVERSITA DI PISA FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI E FACOLTA DI AGRARIA Corso di Laurea Interfacoltà In Scienze Ambientali TESI DI LAUREA IN FORMA ELETTRONICA (http//etd.adm.unipi.it/etd-db/etd-search/search)
UNIVERSITA DI PISA FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI E FACOLTA DI AGRARIA Corso di Laurea Interfacoltà In Scienze Ambientali TESI DI LAUREA IN FORMA ELETTRONICA (http//etd.adm.unipi.it/etd-db/etd-search/search)
Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime idrologico (IARI)
 Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
Direttiva 2000/60/CE: Struttura delle reti e dei programmi di monitoraggio sui corsi d acqua Indici di classificazione dello stato di qualità Elementi idromorfologici: indice di alterazione del regime
Indagine ambientale Villa Lagarina Scuola P. Lodron Maggio - Luglio 2010
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente Settore Informazione e monitoraggi U.O. per le Attività di monitoraggio ambientale Rete provinciale di controllo della qualità
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente Settore Informazione e monitoraggi U.O. per le Attività di monitoraggio ambientale Rete provinciale di controllo della qualità
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Un nuovo indice per valutare la qualità ecologica dei laghi attraverso gli invertebrati bentonici: validazione con i risultati del Progetto INHABIT
 Un nuovo indice per valutare la qualità ecologica dei laghi attraverso gli invertebrati bentonici: validazione con i risultati del Progetto INHABIT Zaupa Silvia & Boggero Angela CNR-ISE a.boggero@ise.cnr.it
Un nuovo indice per valutare la qualità ecologica dei laghi attraverso gli invertebrati bentonici: validazione con i risultati del Progetto INHABIT Zaupa Silvia & Boggero Angela CNR-ISE a.boggero@ise.cnr.it
Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente.
 Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Febbraio 2015 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Febbraio 2015 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
Rete di monitoraggio della qualità dell aria della Provincia di Rimini Report 2012
 Rete di monitoraggio della qualità dell aria della Provincia di Rimini Report 2012 NOx - Via Flaminia Valori orari NOx - Parco Marecchia Valori orari 500 500 Valore limite media annuale Media annuale Valore
Rete di monitoraggio della qualità dell aria della Provincia di Rimini Report 2012 NOx - Via Flaminia Valori orari NOx - Parco Marecchia Valori orari 500 500 Valore limite media annuale Media annuale Valore
Estate 2012. Settimana 13-19 agosto 2012. 11 bollettino
 Estate 2012 Monitoraggio tramite centraline sul fiume Arno Settimana 13-19 agosto 2012 11 bollettino INDICE SOGLIE di attenzione e di allarme per ossigeno e temperatura...2 Stazione di BUONRIPOSO...3 Stazione
Estate 2012 Monitoraggio tramite centraline sul fiume Arno Settimana 13-19 agosto 2012 11 bollettino INDICE SOGLIE di attenzione e di allarme per ossigeno e temperatura...2 Stazione di BUONRIPOSO...3 Stazione
Analisi delle caratteristiche delle acque superficiali nel bacino del fiume Adige: corpi idrici superficiali e condizioni di riferimento
 Analisi delle caratteristiche delle acque superficiali nel bacino del fiume Adige: corpi idrici superficiali e condizioni di riferimento TRENTO Museo tridentino di scienze naturali 17 gennaio 2007 dott.
Analisi delle caratteristiche delle acque superficiali nel bacino del fiume Adige: corpi idrici superficiali e condizioni di riferimento TRENTO Museo tridentino di scienze naturali 17 gennaio 2007 dott.
06. CONOIDE DEL PARMA-BAGANZA
 06. CONOIDE DEL PARMA-BAGANZA Le conoidi del Parma e del Baganza sono state individuate come conoidi alluvionali maggiori. I principali centri abitati che vi insistono sono Parma, Monticelli Terme, Sala
06. CONOIDE DEL PARMA-BAGANZA Le conoidi del Parma e del Baganza sono state individuate come conoidi alluvionali maggiori. I principali centri abitati che vi insistono sono Parma, Monticelli Terme, Sala
IBE del principale fiume calabrese negli ultimi 15 anni: tendenze emerse e riflessioni
 Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 83 (007): 19-133 ISSN 039-054 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 007 IBE del principale fiume calabrese negli ultimi 15 anni: tendenze emerse e riflessioni
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 83 (007): 19-133 ISSN 039-054 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 007 IBE del principale fiume calabrese negli ultimi 15 anni: tendenze emerse e riflessioni
Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Ufficio Idrografico e Mareografico - Area D2/2S/09. Roma, 20 aprile 2007
 REGIONE LAZIO Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Ufficio Idrografico e Mareografico - Area D2/2S/09 Roma, 20 aprile 2007 OGGETTO: Relazione idrologica. Evento del
REGIONE LAZIO Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Ufficio Idrografico e Mareografico - Area D2/2S/09 Roma, 20 aprile 2007 OGGETTO: Relazione idrologica. Evento del
ACQUE SUPERFICIALI PROGETTO BALNEABILITA F. TREBBIA HIDROSOURCE 2005
 CODICE: 15_HS_B DATI BACINO Nome bacino: TREBBIA Nome corso d acqua: F. TREBBIA Sup. bacino (km 2 ): 1085 Lungh. corso d acqua (km): 119.98 Ordine corso d acqua: 2 DATI STAZIONE Provincia: PIACENZA Comune:
CODICE: 15_HS_B DATI BACINO Nome bacino: TREBBIA Nome corso d acqua: F. TREBBIA Sup. bacino (km 2 ): 1085 Lungh. corso d acqua (km): 119.98 Ordine corso d acqua: 2 DATI STAZIONE Provincia: PIACENZA Comune:
Fiume Lete (Campania)
 Fiume Lete (Campania) Fiume appenninico della Campania, affluente di sinistra del Volturno; 20 km. Nasce nel massiccio calcareo del Matese e al termine del suo corso superiore, presso il centro di Letino
Fiume Lete (Campania) Fiume appenninico della Campania, affluente di sinistra del Volturno; 20 km. Nasce nel massiccio calcareo del Matese e al termine del suo corso superiore, presso il centro di Letino
Analisi chimiche. Confronto di alcuni parametri chimici dell acqua del Lambro alla sorgente e alla foce
 Analisi chimiche Confronto di alcuni parametri chimici dell acqua del Lambro alla sorgente e alla foce 1 Scuola media Anna Frank Graffignana (Lo) Ecolab a.s.2008/2009 Tipologia di analisi Abbiamo analizzato
Analisi chimiche Confronto di alcuni parametri chimici dell acqua del Lambro alla sorgente e alla foce 1 Scuola media Anna Frank Graffignana (Lo) Ecolab a.s.2008/2009 Tipologia di analisi Abbiamo analizzato
Fiume Aniene (Lazio) Confluenza nel fiume Tevere. Sorgente del fiume Aniene. Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente
 Fiume Aniene (Lazio) Fiume dell'italia centrale, affluente di sinistra del Tevere; 100 km circa. Nato dal versante meridionale del monte Tarino, nei Simbruini (subappennino laziale), scorre in direzione
Fiume Aniene (Lazio) Fiume dell'italia centrale, affluente di sinistra del Tevere; 100 km circa. Nato dal versante meridionale del monte Tarino, nei Simbruini (subappennino laziale), scorre in direzione
Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente.
 Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Agosto 2014 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Agosto 2014 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
GEOCHIMICA DELLE ACQUE
 Alpi Latine Identificazione delle Risorse HYdriques Sotterranee GEOCHIMICA DELLE ACQUE Relatore: Fabrizio Bianco Adriano Fiorucci Torino, Centro Incontri Regione Piemonte 03 febbraio 205 Valle Corsaglia:
Alpi Latine Identificazione delle Risorse HYdriques Sotterranee GEOCHIMICA DELLE ACQUE Relatore: Fabrizio Bianco Adriano Fiorucci Torino, Centro Incontri Regione Piemonte 03 febbraio 205 Valle Corsaglia:
