ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2009 A T T I
|
|
|
- Costanzo Fontana
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa: Centro Grafi co S.r.l. - Tel cofoggia.it
2 ARMANDO GRAVINA * Osser vazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio * Collaboratore Cattedra di Paletnologia. Università di Roma La Sapienza Fin dal VII millennio gruppi del primo neolitico antico dall Egeo hanno risalito la costa orientale dell Adriatico da quella albanese a quella dalmata da cui, attraverso il ponte naturale formato dalle isole di Lagosta, Cazza, Pelagosa e Pianosa, sono giunti nelle isole Tremiti a Prato don Michele e sulla costa settentrionale garganica, facile accesso alla piana del Tavoliere. Altri gruppi hanno raggiunto Coppa Nevigata, probabilmente seguendo le correnti sotto costa, che dalla foce del Fortore lambiscono Vieste e ripiegano verso il golfo di Manfredonia dopo aver doppiato il Promontorio. Soprattutto con la fase evoluta del neolitico a ceramica impressa la neolitizzazione del bacino centro-meridionale dell Adriatico sembra un fatto compiuto. I motivi decorativi della produzione vascolare, caratterizzati da complessi schemi sintattici ampiamente attestati in una vasta area che va dai villaggi di Guadone e Lama Marangia, nella Puglia settentrionale, a Rendina in Basilicata, a Obre I in Bosnia (BENAC ), a Cakran (KORKUTI, ANDREA 1972) in Albania, a Smilcic (Batovic 1963) e a Skarim Samograd (BATOVIC 1975) in Dalmazia, testimoniano l esistenza di una koiné culturale che interessa le due sponde dell Adriatico e che è caratterizzata da una forte uniformità, quale non si registrerà in nessun altro periodo della preistoria. Tale uniformità si riscontra anche nelle strutture dei villaggi (BATOVIC 1963; 1966, pp. 44 sgg.). È questo il periodo in cui la Daunia presenta la più intensa occupazione preistorica. Con la successiva fase della ceramica bicromica il territorio presenta una frequentazione ridotta di circa il 70-80% rispetto a quella della ceramica impressa.
3 66 Armando Gravina Probabilmente si è in presenza di una crisi demografica attestata dalla contrazione non solo del numero degli insediamenti, ma anche delle aree di frequentazione. Ad una presenza a larghe maglie della bicromica nel Tavoliere e sui primi rilievi collinari del Preappennino Dauno fa riscontro una emarginazione di alcune aree, come quella della valle del Fortore e del Gargano. Nella prima, a fronte dei 18 siti abitati (a cui sono da aggiungere altri 7 che appaiono di semplice frequentazione) nella fase a ceramica impressa, fa riscontro un abbandono totale (fig.1:d), se si fa eccezione per qualche labile indizio di figulina a fasce rosse in tre località (Piani di Lauria, Settimo di Grotte e forse Tronco Sud) che costeggiano il segmento finale del Fortore (GRAVINA 2005). Una analoga situazione si registra anche nel Promontorio, lungo la fascia perigarganica (l area interna finora non ha restituito dati di questo periodo sia per mancanza di ricerca sia per la quasi totale non visibilità delle emergenze archeologiche dovuta al pluristratificato manto forestale talvolta vecchio di secoli) e soprattutto sulla costa settentrionale, dove ad una frequentazine ricca di 20 località del neolitico antico (che annovera alcuni siti particolarmente significativi, come la miniera per l estrazione della selce di Difensola, cfr. Galiberti 2005) si contrappone un panorama insediativo quasi del tutto deserto, se si escludono le isole Tremiti, con ceramiche bicromiche individuate solo a Vieste (figg.1:e; 8:1), ed in modo piuttosto evanescente a Coppa Cardone e a Macchia di Mare (GRAVINA 2005). Meno drastico è lo spopolamento dei primi rilievi meridionali garganici da relazionarsi più all immediato contatto con la pianura e con la sponda sinistra del Candelaro che alla contiguità dei rilievi montani. Delle 8 località dislocate sulle sponde del tratto terminale del Candelaro, 6 sono poste all aperto e una è nella grotta Scaloria-Occhiopinto (fig.1:c); l ottava, la grotta del Brigante (GRAVINA 1994), è la sola ubicata a quota m 400 nella Valle dell Inferno. Si deve precisare che queste ultime sono distribuite nel settore orientale della pedegarganica, facente parte di un quadro più ampio che abbraccia un territorio compreso fra Foggia, località Ciccalento (GRAVINA 1999) e Manfredonia, settore in cui una posizione centrale è tenuta proprio da Passo di Corvo, che evidentemente faceva sentire più intensamente la propria influenza entro un raggio che verso il Promontorio lambiva il versante meridionale, nel Tavoliere si slargava ad Est verso il Carapelle in direzione dell Ofanto, e ad Ovest si allungava fin nei pressi di San Severo-Lucera, raggiungendo solo in qualche caso il basso Fortore con una documentazione, come si è detto, molto rara e non univoca (fig.1:b). Il ridotto quadro insediamentale della bicromica suggerisce, insieme alla già accennata probabile crisi demografica, anche una diminuita e limitata capacità di espansione territoriale dei gruppi a ceramica tipo Passo di Corvo, che da una parte sembrano avere significativi contatti con le comunità abruzzesi di Catignano (fig.3), le cui ceramiche trovano sicuri confronti con la produzione fittile di Passo di Corvo classico ma soprattutto di Scaloria Bassa (TOZZI, ZAMAGNI 2003), dall altra parte non mostrano avere interesse a mantenere i rapporti con l opposta sponda adriatica, i
4 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 67 quali in questo periodo sembrano attutirsi notevolmente e quasi annullarsi se confrontati con quanto è stato registrato nel periodo precedente. Queste emergenze configurano un nuovo assetto della società neolitica interadriatica, seguito ad una probabile crisi i cui prodromi sono da ricercarsi forse a livello delle prime ceramiche di impasto dipinte stile Lagnano da Piede e Mass. La Quercia, la cui diffusione territoriale appare più limitata di quelle bicromiche, o nella fase di transizione fra le dipinte di impasto e quelle figuline; crisi il cui quadro al momento non ci è sufficientemente chiaro nei suoi lineamenti essenziali, anche se si possono intravederne le conseguenze nel prospettato quadro insediamentale e nell insorgere di più poli di propulsione individuabili nell area interadriatica. La bicromica tipo Passo di Corvo è documentata raramente sull opposta sponda adriatica, dove ceramiche che richiamano questo stile si rinvengono solo in qualche sito dell Albania e della Dalmazia, come nella grotta Gudnja (BATOVIC 1975, p.153) mentre, ad eccezione di qualche suggestione riscontrabile in alcuni frammenti pubblicati dal Quagliati (QUAGLIATI 1936, fig.51;52;54), non si è registrata fino ad oggi in Daunia alcuna documentazione della nascente cultura di Danilo della quale, tra l altro, pur sussistendo problemi di inquadramento cronologico da meglio definire, si deve porre l inizio con ogni probabilità in un momento maturo del percorso evolutivo della figulina e/o nella fase della tricromica tipo Scaloria Bassa del Tavoliere, come si vedrà in seguito. A Danilo si sviluppa autonomamente una sintassi decorativa prevalentemente in tricromia, che si distingue in modo notevole da quella di Grotta Scaloria-Catignano. A differenza delle tricromiche daune di Passo di Corvo-Grotta Scaloria, in cui predominano larghe fasce rosse, che formano in genere motivi angolari e curvilinei, nella cultura di Danilo la bicromica-tricromica è costituita da sottili fasce rosse o brune generalmente multiple, che formano zig-zag e motivi geometrici, come losanghe e triangoli (fig.5), a cui si accompagna non in modo diffuso il motivo a spirale (fig.5:13) che avrà successivi sviluppi nella ceramica dipinta di Kamnic in Albania (probabilmente contemporanea del nostro Serra d Alto), dove sono stati evidenziati gli influssi del Dimini classico della Tessaglia (PRENDI, ALIU 1971, Tavv. VI-VIII,IX,X). Gli schemi esornativi essenzialmente lineari e rettilinei finora non sono mai stati attestati in Daunia, ma trovano confronti soprattutto in Abruzzo nella produzione ceramica dipinta in tricromia della cultura di Ripoli dove, al di là della fila di puntini marginata da due lineole caratteristica della ceramica ripolina, fra gli elementi comuni alle due aree si rinvengono i triangoli campiti a reticolo e le fasce di linee disposte a zig-zag (fig.6). Tali attestazioni indiziano l esistenza di veri e propri scambi e la circolazione dei modelli decorativi fra le due sponde abruzzese e dalmata, da cui, è importante sottolineare, sembra essere esclusa la Daunia. In Daunia, in un panorama ricco di siti di insediamento e/o di frequentazione dislocati quasi sempre in zone pianeggianti, in un momento maturo della
5 68 Armando Gravina bicromica si colloca la comparsa della ceramica tricromica che appare in 15 località, 14 sulla penisola ed una a Cala Tramontana nelle isole Tremiti (PALMA DI CESNOLA 1967), e che nella parte bassa di Grotta Scaloria ha trovato una sua definizione tecnico-stilistica ed è caratterizzata da una particolare tecnica a negativo (fig.10:1-5,11) (TINÈ, ISETTI 1982). Il quadro della loro distribuzione geografica sembra mettere in risalto l estremo diradarsi della frequentazione del Tavoliere e sembra segnare il tracollo del sistema degli insediamenti della ceramica bicromica-ticromica della Daunia. Le località con attestazione della tricromica sono territorialmente così suddivise: una a Vieste (fig.8:1-12,14,15), nessuna sul Fortore, 6 sul versante meridionale del Gargano, negli stessi siti in cui è stata rilevata la bicromica come a Ciccalento (GRAVINA 1999), e 7 in pieno Tavoliere, dove appaiono incentrate in una piccola area ai margini di un estesa palude a Sud di San Severo, come a Coppa Pocci (GRAVINA 1990), ed in un comprensorio che si estende tra Foggia, Grotta Scaloria e la foce del Candelaro (fig.2). Per tutti questi siti, ad eccezione di Passo di Corvo, di Grotta Scaloria ed in parte di Vieste e di Ciccalento, si tratta di evidenze di superficie spesso relative ad un solo frammento in ben otto località e di due o tre frammenti nelle altre località, frustoli pervenuti in non buone condizioni di conservazione (GRAVINA 1984). La tricromica, nella Daunia, sia per i modi di acquisizione della documentazione, legata ad attività di recupero, sia per la mancanza di scavi (se si fa eccezione per Grotta Scaloria e per Passo di Corvo), presenta aspetti non ancora adeguatamente approfonditi. I più significativi sono: la accennata esiguità numerica della documentazione; la sua costante contestualità con la bicromica ed il suo collocarsi nei livelli superiori di quest ultima; la mancanza di stratigrafie con livelli di sola tricromica; la sua diffusione documentata non in modo uniforme sul territorio, ma circoscritta ad aree ben definite in un più ampio sistema insediativo, quale è quello caratterizzato dalla figulina bicromica. Tale dato topografico non attesta la benché minima modifica del precedente sistema di insediamenti in cui la tricromica sembra essersi inserita come un semplice aspetto collaterale in un complesso socio-culturale ben strutturato; modifica che appare evidente con l avvento del Serra d Alto al termine di un periodo di transizione e che assumerà dimensioni macroscopiche col pieno affermarsi del Diana (fig.1:a), quando il territorio sarà occupato in tutte le sue parti con un indice complessivo di frequentazione superiore quasi al 50% di quello accertato per il Serra d Alto (GRAVINA 1984). La tricromica, pertanto, per le sue presenze sporadiche concentrate in luoghi di culto, come Grotta Scaloria, o in siti dove più vivace era l attività di scambio, come a Vieste e a Cala Tramontana nelle isole Tremiti, o nei territori strettamente collegati con la via d acqua del Candelaro, e alla sua probabile laguna terminale, come a Ciccalento, o infine in località particolarmente favorevoli alla pratica di attività produttive per la presenza di vaste aree paludose, come a Coppa Pocci, appare una
6 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 69 classe ceramica utilizzata in contesti sacrali o in connessione con rituali praticati forse per propiziare le stesse attività di scambio o la fecondità della terra; destinazione, questa, che ha forse determinato la sua limitata diffusione territoriale e la selezione dei suoi elementi formali attinenti sia alle morfologie vascolari sia alle decorazioni dipinte. In sintesi, per quanto finora si conosce, la tricromica non sembra rappresentare una fase culturale a sé stante nel Tavoliere, con uno spessore temporale frapposto tra Passo di Corvo e Serra d Alto, ma piuttosto essa appare come una classe ceramica, affermatasi nelle fasi finali della bicromica, con destinazione ad usi particolari a cui vanno riferiti determinati aspetti della religiosità e della vita sociale delle comunità del neolitico medio (GRAVINA 1984; 1987; MOSCOLONI 1992; CASSANO 1993) nel momento della crisi risolutiva della civiltà di Passo di Corvo e/o di transizione a quella del Serra d Alto. In Daunia la tricromica è rappresentata da quella stile Scaloria Bassa e da quella stile Scaloria Alta. La prima presenta nella grotta eponima una assoluta unitarietà stilistica dei materiali ceramici impiegati nel culto (TINÈ, ISETTI 1982) e una limitatissima diffusione nel territorio; frammenti assimilabili allo stesso stile sono stati rinvenuti solo a Ciccalento (Gravina 1999, figg.6:1,2; 23:9,13) e a Vieste (fig.8:3). La ceramica della Scaloria Alta, che in alcuni suoi schemi decorativi risente degli influssi culturali di altre aree culturali anche transadriatiche, è più largamente documentata. Fra i siti in cui è stata riscontrata si possono evidenziare Coppa Pocci (fig.16), Ciccalento (GRAVINA 1999, fig.6:11,13,14), Cala Tramontana (fig.7:8,11-13), S. Lorenzo, e Santa Tecchia (CASSANO, MANFREDINI 1983, fig.77:1), Mass. Li Gatti- Oliveto Masselli (GRAVINA 1984) e Vieste (fig.8:7-12,14,15). In associazione alla tricromica stile Scaloria Alta è attestato un apprezzabile numero di presenze, riconducibili allo stile Ripoli-Cassano Ionio, rilevate a Cala Tramontana nello strato II (fig.7.1), nella stessa Grotta Scaloria Alta (fig.10:5,6,10,12), a Ciccalento (GRAVINA 1999, figg.6:3,5,7,8; 23,10,11,12), a Vieste (fig.8:12), e a Coppa Pallante (GRAVINA 1983, fig.18:6). Questa emergenza, oltre ad indiziare rapporti del territorio in esame con aree extradaune, potrebbe individuare un altro importante dato, quale è quello della mancanza di un polo stilistico-culturale ben definito a cui la tricromica della Daunia possa riferirsi in contrasto con quella compatta e unitaria sintassi di schemi stilistici riscontrabili nella piena fioritura di Passo di Corvo, i cui moduli esornativi si ritrovano in parte sulla tricromica della Scaloria Bassa. Le molte analogie esistenti fra la tricromica di Ripoli e di Danilo hanno fatto ipotizzare che quella di Danilo, per la sua ricchezza di forme e di motivi decorativi, abbia esercitato influssi su Ripoli piuttosto che subirli (BATOVIC 1975). Comunque la presenza a Ripoli di alcuni vasi provenienti probabilmente dalla sfera di Danilo (CREMONESI 1965) testimoniano l esistenza di contatti fra l Abruzzo e la Dalmazia
7 70 Armando Gravina nell ambito di una koinè culturale di matrice medio-orientale (KOROSEC ), da cui, come si è detto, è esclusa la Daunia. La forza di irradiazione del polo dalmataabruzzese è documentata dalla presenza degli elementi decorativi molto simili a quelli caratteristici di Danilo fin sulla costa tirrenica, a Capri (fig.4), nella Grotta delle Felci (RELLINI 1923, Tav. I:1,3), dove hanno connotato lo stile di Capri e nello strato inferiore dell acropoli di Lipari, in cui sono contestuali a ceramiche stile Ripoli (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1958, pp.27,28). * * * Sull opposta sponda adriatica in un momento avanzato e/o finale della tricromica di Danilo compare la ceramica scura decorata con schemi meandrospiralici incisi e intagliati, che sostituisce quella chiara dipinta (S. TINÈ 1983, p.178). Il nuovo tipo ceramico, che presenta una grande ricchezza di partiti decorativi, dall area balcanica, dove è attestato in straordinaria quantità, si è diffuso verso l Italia meridionale, fino a Lipari, dove sull acropoli è stata documentata esclusivamente negli strati che precedono la ceramica dipinta dello stile Serra d Alto e non mai associata con essa (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1956, pp.24-25, fig.16). Una analisi della sua sintassi decorativa evidenzia la ripetizione con la tecnica dell incisione e dell intaglio di molti motivi presenti sulla ceramica dipinta in tricromia. Si rinvengono i gruppi di fasce sottili formanti angoli (fig.17:1); le fasce di triangoli penduli campiti alternativamente da segmenti obliqui (fig.17:2); i triangoli penduli campiti da reticolo (fig.17:3); le file verticali di losanghe semplici o delimitate da bande a zig-zag campite da segmenti o da cerchielli incisi (fig.17:4); i gruppi di fasce sottili a zig-zag (fig.17:5); i motivi di losanghe a reticolo (fig.17:6); le fasce di linee oblique che formano motivi geometrici, angolari o campiscono forme triangolari; i motivi spiraliformi molto più diffusi in confronto della ceramica dipinta (fig.17:7), che talvolta occupano tutta o gran parte della superficie del vaso quasi che il figulo avesse un horror vacui (fig.18:1); i motivi a fasci di linee formanti ampi meandri spezzati o nella loro forma semplificata ad uncino costituito da bande semplici campite da piccoli segmenti e delimitate da linee incise (fig.17:8). In Abruzzo la presenza di ceramica scura incisa tipo Danilo è molto limitata. Cremonesi a Ripoli constatava che questo tipo ceramico era poco rappresentato e ne ipotizzava la sua importazione da aree esterne (CREMONESI 1965, p.129, fig.12:25); per altro fra la ceramica graffita poneva in evidenza un motivo a cerchi concentrici, un unicum in area abruzzese (CREMONESI 1965, p.129, figg.12:23; 16:12), che però trova confronti puntuali non solo oltre Adriatico, ma anche a Vieste (fig.8:18), e forse in un momento tardo a Cala Scizzo nel barese (GENIOLA 1979, figg.194; 197) (fig.18:7).
8 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 71 In Daunia si deve notare che con la comparsa della ceramica d impasto incisa di tipo Danilo l area garganica entra in un più ampio contesto di scambi interadriatici che al tempo delle più antiche ceramiche tricromiche, come si è accennato, erano limitati solamente fra le due opposte sponde dalmata e abruzzese. Il cointeressamento del Promontorio ai rapporti interadriatici è da collocarsi sicuramente nella fase della Scaloria Alta. Una documentazione incontrovertibile in questo senso ci è fornita dal materiale di Vieste, che ha restituito frammenti di probabili tazze o ollette con alto collo verticale in ceramica figulina decorate da ampie spirali in tricromia stile Scaloria Alta, sopradipinte a fasci di linee incise formanti ampi meandri spezzati (figg.8:4-6; 19:1), motivo tipico della ceramica scura di Danilo (cfr. fig.17.8 in alto a sinistra). Inoltre motivi identici a quelli incisi su ceramica scura di oltre Adriatico sono riprodotti in tricromia sulle due superfici di frammenti di alti colli verticali di tazze o ollette in ceramica figulina, il cui uso in pratiche cerimoniali appare evidente (figg.19:3; 8:8,9). Non manca il meandro spezzato nella forma semplice ad uncino, che appare inciso su frammenti di vasi, pure essi in ceramica figulina acroma o con residui lembi sbiaditi di colore rosso, sia a Vieste (figg.8:17; 19:1) sia a Grotta Scaloria (fig.10:13). Le ceramiche di accompagno sono tutte riferibili alla tricromica stile Scaloria Alta (figg.8:2,7,10,11,14,15; 19:2). Alla luce della documentazione di Vieste, che attesta la contestualità e la contemporaneità sia delle due tecniche dell incisione e della dipintura in tricromia sia dei due stili di Danilo e di Scaloria Alta, tenendo conto inoltre che non vi è traccia di ceramica dipinta di Danilo nell ambito delle ceramiche della Scaloria Alta, si può ritenere valida l opinione di S. Tinè (TINÈ 1983, p.178) secondo cui la ceramica scura incisa ed intagliata di Danilo è successiva alla tricromica, non essendo mai stato trovato alcun elemento che faccia pensare ad una loro contestualità; ne consegue che la fioritura della tricromica dalmata si deve porre verosimilmente nel periodo della Scaloria Bassa, se non proprio in una fase non antica di Passo di Corvo. Del resto indizi di una possibile arcaicità della ceramica ripolina, contemporanea di quella dipinta di Danilo, si rinvengono a Cala Tramontana. Qui il vasellame tipo Ripoli è localizzato alla base del deposito nel livello III Superiore, mentre la ceramica tipo Scaloria Alta è stata rinvenuta in parte nello strato III Superiore, ma soprattutto nel II strato, dove è risultata più abbondante e dove è associata alla ceramica di impasto incisa che trova puntuale riscontro nell area dalmata (PALMA DI CESNOLA 1967, pp.18 sgg.) da cui quasi certamente proviene. A tale proposito si possono confrontare i motivi angolari (fig.18:2); le fasce di triangoli penduli campiti in vario modo (fig.18:3); i triangoli campiti da segmenti o marginati da fasce (fig. 18:4); i motivi a losanga (fig.18:5); le fasce di segmenti obliqui parallele o formanti angoli e il meandro spezzato nella sua forma semplice ad uncino (fig. 18:8).
9 72 Armando Gravina A differenza della ceramica figulina dipinta di Danilo, quella di impasto incisa e intagliata segna il momento di massima espansione sul territorio peninsulare con presenze, come si è accennato, nello strato inferiore dell acropoli di Lipari, di frammenti d impasto con motivi incisi meandrospiralici identici a quelli di oltre Adriatico contestualmente a ceramica dipinta marginata in nero (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1956, p.25, fig.12), pervenuti nell isola probabilmente per scambi ed approvvigionamento dell ossidiana che da questa fase e per tutta quella successiva del Serra d Alto avrà un ampia diffusione, così come è stato accertato nelle isole Tremiti e a S. Matteo di Chiantinelle alla foce del Fortore (da qui in avanti il sito sarà indicato solo col toponimo di Chiantinelle ), che ha restituito oltre un migliaio di piccoli strumenti ed alcuni chili di schegge. Lungo la costa occidentale adriatica le ceramiche scure incise e intagliate di tipo Danilo, già evidenziate fra i materiali di Ripoli (fig. 18,2,3,4,6,7) e di Cala Tramontana (fig.18:2-8), si rinvengono in Daunia a Grotta Scaloria, (figg.10:14;18:8), a Chiantinelle (figg.11:2,4,5; 18:7) e a Vieste (fig. 8:13, 16, 18, 19). * * * Se a Danilo, nella fase precedente, i vecchi motivi meandrospiralici dipinti in tricromia sono stati riprodotti su ceramica di impasto (fig. 20), a Vieste questi ultimi si ritrovano frequentemente su ceramica dipinta della successiva fase del Serra d Alto (fig.9). Nella sequenza del materiale viestano (figg.8; 9) si percepisce un continuum di forme vascolari, di partiti decorativi ubicati sulla pancia-spalla di tazze o di ollette e di elementi della sintassi decorativa che va dalla tricromica stile Scaloria Alta alla ceramica tipica di un Serra d Alto arcaico puro non inquinato, per quanto si conosce fino ad oggi, da elementi recenziori, quali le anse e le prese baroccheggianti. In tale sequenza il trait d union o il momento di transizione fra le due fasi è costituito dalle decorazioni delle ceramiche d impasto, che documentano inequivocabilmente gli influssi della cultura di Danilo, la quale rappresenta il sottofondo remoto dello sviluppo degli schemi decorativi del Serra d Alto di Vieste. Questi richiamano gli aspetti tipici più antichi dell area apulo-materana (fig.9) che, fra l altro, si rinvengono raramente anche nei territori extradauni, dove i singoli schemi usati differiscono da quelli del centro garganico che più direttamente si riferiscono a quelli del mondo dalmata. A Vieste, oltre al consueto schema esornativo del meandro spezzato nella forma semplice dell uncino che appare su un ansa a nastro e sul corpo di vasi di dimensioni piccolo-medie in ceramica scura (figg.8:13,16,19; 18:8), si può avvertire una innovazione presente in un cartoccio stilizzato sulla sommità di un ansa di un boccale di impasto con i caratteristici motivi incisi di Danilo (figg.8:13; 18:8). Tale elemento plastico, contestuale alle incisioni, potrebbe essere considerato
10 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 73 ancora una volta un trait d union fra il mondo culturale balcanico ed i numerosi riscontri di questo particolare esornativo che si rinvengono su ceramica figulina in un momento evoluto del Serra d Alto a Pian Devoto (GRAVINA 1985, fig.4:2), presso San Severo in pieno Tavoliere, a Ciccalento (GRAVINA 1999, fig. 7:1), a Cala Scizzo nella Puglia centrale (FEDELE 1984, fig.5) e nel fondo Chico (LO PORTO 1989, figg.122;124). * * * Il cartoccio stilizzato di Vieste prelude a quella grande fioritura del Serra d Alto maturo e finale sviluppatosi a Chiantinelle (figg. 12; 13; 14:1-3). Esso è caratterizzato dal tremolo sottile marginato, dalle protomi zoomorfe poste all apice di anse a largo nastro (fig. 13:10-12), elementi che trovano puntuale riscontro a Serra d Alto (LO PORTO 1989), da una grande varietà di decorazioni plastiche, di cui quella del frammento della fig. 13:6 è comparabile con una identica del fondo Chico (LO PORTO 1989, fig.110) e dalle anse e prese a cartoccio ad avvolgimenti semplici e multipli. Impressionante è la varietà di queste ultime che presentano motivi decorativi che vanno dalle composizioni plastiche complesse delle figg. 12:1,4; 13:1,2,4,6,8,9, in cui predomina l intaglio, a quelli spiraliformi incisi riquadrati da figure geometriche excise, evidenti sulle facce laterali di anse e prese o sull intera superficie soprattutto nei frammenti delle figg.12:1-4; 13:1-3,5,7,8; 14:1,2 nei quali le suggestioni delle decorazioni dell area dalmata sono più che convincenti. Tali suggestioni perdureranno fin nell ultima fase del neolitico, quando due file di spirali semplici marginate si rinvengono incise su una tazza in ceramica scura con ansa a rocchetto insellato (fig.14:6) inquadrabile nel Diana (GRAVINA, GENIOLA 1975, Tavv.8:13; 10:12). Gli elementi caratteristici di questa cultura si trovano affermati già nel Serra d Alto avanzato con la presenza di rocchetti in ceramica figulina su ciotole decorate a tremolo sottile marginato (fig.14:4,5), in stretta consonanza con quanto è stato intravisto a Cala Tramontana e documentato a Lipari, dove la ceramica stile Serra d Alto è indiziata nelle stratigrafie dell acropoli e della contrada Diana. Gli influssi di oltre mare della tecnica dell incisione e dell intaglio e dei moduli decorativi meandrospiralici, persistenti a Chiantinelle, acquistano una ulteriore valenza per la significativa presenza di due statuine frammentarie della dea madre (GRAVINA 2008), le quali rinviano, più degli altri elementi evidenziati nella produzione vascolare, alla sfera di Danilo e al mondo balcanico-egeo, nella cui plastica idolica trovano riscontri puntuali (fig.16:1,2). A Chiantinelle i due elementi caratteristici del Serra d Alto e del Diana sono presenti contestualmente in strati datati con cronologia calibrata intorno alla metà del V millennio a. C. (TUNZI, SANSEVERINO 2007). Ma una frequentazione forse precedente a quella di Serra d Alto, e probabilmente saltuaria, di gruppi che intrattenevano
11 74 Armando Gravina rapporti con gli ambienti ripolini e dalmati, può essere indiziata dalla presenza nel sito di ceramiche figuline dipinte e di impasto incise con motivi decorativi propri di Ripoli (fig.11:1,3) e di Danilo (fig.11:2,4,5). Nel complesso il Serra d Alto di Chiantinelle, pur conservando una forte connotazione che si richiama ad una matrice transadriatica, è inquadrabile nella più ampia koinè medio finale apula-materana di questo orizzonte culturale ed appare diffuso in molti siti della Daunia, fra cui si possono ricordare Mass. Mischitelli (CASSANO, MANFREDINI 1983, fig.15:11), Ciccalento (GRAVINA 1999, fig.7:5), Coppa Pocci (GRAVINA 1990, fig.6:8), Mass. Candelaro (CASSANO, MANFREDINI 2004, fig.6:58; Tav.X:2), Mass. Istituto di Sangro (GRAVINA 1986, fig.19), Pian Devoto (GRAVINA 1985), C. Chiarappa (GRAVINA, RONCHITELLI ), Coppa Pallante (GRAVINA 1983), Coppa Nevigata (PUGLISI 1955, p.26, fig.2:4), Oliveto Masselli (GRAVINA 1984), Fontana Rosa Oliveto (CASSANO, MANFREDINI 1983), Cala Tramontana, Cala degli Inglesi (ZORZI 1958). In Daunia tracce di più antichi contatti, sicuramente sporadici per la loro rarità, con la costa orientale adriatica sono stati rinvenuti ad Anzano di Puglia e a Mass. Candelaro. Nel primo sito, nella Daunia interna subappennica a confine con la Campania (GRAVINA 2001), è stato rinvenuto un piede di ryton con una decorazione a motivi rettangolari finemente incisi e campiti da una fitta e lieve punteggiatura incisa (fig.16:15), sicuramente confrontabile con quelli della cultura di Danilo (KOROSEC , Tavv.XVI-XXI) o della più antica cultura albanese di Cakran (KORKUTI, AN- DREA 1972), considerati centri di fabbricazione di questi vasi di culto zoomorfi muniti di quattro piedi. A tale tipologia vascolare caratteristica di un momento antico del neolitico medio o forse di una fase precedente dell area egeo-adriatica orientale possono essere riferiti anche i tre animaletti fittili quadrupedi di Masseria Candelaro (CASSANO, MAN- FREDINI 2004, figg. 12.6; 12.7) e l esemplare di Lagnano da Piede (MALLORY , fig.34:2), per i quali sussistono problemi di raccordi cronologici. * * * A conclusione, si possono fare alcune sintetiche considerazioni. I rapporti fra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel corso del neolitico medio, che si distende lungo il V millennio a. C. ed in parte in quello precedente, presentano aspetti abbastanza ben delineati nel loro insieme. Essi, per mancanza di un soddisfacente numero di datazioni e di puntuali riscontri stratigrafici, hanno il loro principale riferimento definitorio nelle decorazioni e nelle morfologie vascolari la cui articolazione, pur non potendo essere assunta a fondamento della scansione cronologica dei vari periodi, rimane fino ad oggi uno degli elementi disponibili e più attendibili
12 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 75 su cui fondare un quadro di insieme. D altronde il risultato non può essere del tutto banale e aleatorio se si tiene conto che i partiti decorativi, soprattutto quelli delle ceramiche dipinte, hanno una linea di sviluppo continuativa che presenta una base, se pur minima, di affidabilità. La forte omogeneità che ha caratterizzato le due sponde dell Adriatico nel periodo della ceramica impressa si è dissolta con l affermarsi delle ceramiche bicromiche di Passo di Corvo, che con la loro diffusione soprattutto in ambito regionale sembrano non essere molto attestate in altre aree peninsulari, ad eccezione di quelle di Catignano. L avvento delle ceramiche tricromiche segna forse il momento di crisi più acuto del mondo neolitico interadriatico, caratterizzato nella penisola dalla molteplicità di stili della Scaloria Bassa-Catignano, di Ripoli-Cassano Ionio-Capri e di quello più recente di Scaloria Alta, mentre sull opposta sponda adriatica si afferma la ceramica dipinta di Danilo. La tricromica della Scaloria Bassa si rinviene raramente fuori della grotta eponima e trova riscontri, talvolta non strettamente puntuali, nell area abruzzese di Catignano. La ceramica dipinta di Danilo mostra una maggiore capacità di espansione, tanto da presentare connessioni con la tricromica di Capri e con quella di Ripoli. Quest ultima elabora a sua volta moduli decorativi suoi propri che interagiscono con quelli di Danilo. Con la tricromica della Scaloria Alta, che è attestata in modo alquanto diffuso nel Tavoliere, la Daunia tende ad aprirsi ai contatti con l esterno. I rapporti più significativi, ancora una volta, vengono intrattenuti con le comunità abruzzesi ripoline, che, si può supporre, sembrano averne avuta l esclusiva fino all arrivo nel Promontorio della ceramica d impasto incisa di Danilo. I caratteristici schemi esornativi di Ripoli, e non pure quelli della tricromica di Danilo, si rinvengono insieme a materiale della Scaloria Alta a Cala Tramontana, nella stessa grotta Scaloria Alta, a Ciccalento, a Vieste e a Chiantinelle (Nel successivo periodo di Serra d Alto si avvertono ancora i riverberi di questa cultura nei motivi tipici di Ripoli presenti a Coppa Pallante, cfr. Gravina 1983, fig.18:5,6; a Fontana Rosa Oliveto, cfr. Cassano, Manfredini 1983, fig. 40:3; a Mass. Istituto di Sangro, cfr. Gravina 1986, fig.1:3). Tali contatti non pare abbiano avuto carattere di reciprocità e gli influssi sembrano aver viaggiato a senso unico, in quanto non si sono rinvenuti elementi di stile Scaloria Alta nel sito abruzzese né nell area dalmata quando la Daunia, forse tramite Ripoli o per rapporti diretti, contemporaneamente o in un momento successivo ai contatti con l area abruzzese sembra aprirsi alla sfera della cultura di Danilo già pervenuta nella sua fase a ceramica di impasto incisa ed intagliata che ne segna nello stesso tempo la massima capacità di espansione e l inizio del declino(fig. 20). Il mondo culturale dauno in questo periodo, in cui è attestata la frequentazione della Scaloria Alta, appare essenzialmente ricettivo, mentre le ceramiche d impasto decorate di stile Danilo si diffondono su una vasta area della penisola da Ripoli a
13 76 Armando Gravina Lipari, e soprattutto nella Daunia garganica, a Cala Tramontana, Grotta Scaloria, Vieste e Chiantinelle. In questo momento i citati siti garganici sembrano far parte di una rete di scambi commerciali e di un vasto circuito di relazioni interadriatiche con ruolo non propriamente di propulsione culturale, ma con funzionalità logistica periferica. Grotta Scaloria, che nella parte bassa si era connotata essenzialmente per la sua funzione di luogo di culto (TINÉ, ISETTI 1982), fenomeno del tutto nuovo nel panorama del neolitico medio della Daunia, nella parte alta appare come luogo di frequentazione a scopo sepolcrale ed abitativo (ELSTER ET ALII, 2007), caratteristica questa non marginale nella topografia abitativa della zona per una comunità che intratteneva rapporti con Ripoli, Danilo e sicuramente con Cala Tramontana, Vieste e forse anche con Chiantinelle (quest ultima in un suo supposto momento antico). Rapporti documentati dalla presenza alle Tremiti e a Vieste delle ceramiche dipinte, ma soprattutto delle attestazioni in tutti i siti menzionati delle ceramiche incise. Cala Tramontana, che è stata sede di insediamento di gruppi a ceramica bicromica, tricromica e Serra d Alto, sembra assolvere nelle fasi di transizione tra Passo di Corvo e Serra d Alto al ruolo di centro di incontro, di mediazione e di diffusione marittima di correnti culturali dalle due opposte sponde; i non pochi elementi che risentono dell influsso delle varie culture si suppone siano giunti nell isola attraverso consistenti correnti di scambi connessi alla navigazione. Le più antiche ceramiche rinvenute alla base del deposito sono quelle dipinte nello stile di Ripoli, che segnano la fase più antica dell insediamento e i più antichi rapporti con aree extra-daunie, a cui forse si devono associare quelli con la Scaloria Alta, che potrebbero essere di poco successivi. Un ruolo analogo a quello di Cala Tramontana è svolto sulla terraferma da Vieste, che è posta su uno sperone roccioso provvisto di buoni punti di approdo sull estrema punta orientale del Gargano settentrionale, da cui sono visibili ad occhio nudo, nelle giornate limpide, Pianosa e Pelagosa. La sua posizione geografica doveva apparire altamente strategica per i traffici marittimi dell epoca. Pur sembrando isolata in un interland del tutto deserto, secondo i dati finora conosciuti, con ogni probabilità fungeva da punto di riferimento di eccezionale importanza logistica sia per le comunità di terraferma sia per quelle di oltremare. A Vieste infatti convergono gli influssi culturali più vari, da quelli più antichi di Passo di Corvo e di Scaloria Bassa, in cui trovano puntuali confronti il fiasco delle figg. 8:3 e un frammento in tricromia con la tecnica in negativo, a quelli più recenti della Scaloria Alta e di tradizione Ripoli-Cassano Ionio e dalmata decorata ad incisione (GRAVINA 1988). Di quest ultima se ne recepiscono la tecnica e gli schemi che non solo vengono ripetuti in chiave tricromica stile Scaloria Alta, ma si rinvengono sullo stesso vaso sopradipinti con motivi spiraliformi in tricromia tipici della Scaloria Alta, fornendo la più evidente documentazione della contemporaneità e della contestualità delle due tecniche dell incisione e della dipintura in tricromia e dei due schemi
14 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 77 esornativi del meandro spezzato e della decorazione spiraliforme rispettivamente tipici di Danilo e di Scaloria Alta (fig. 8:4,5,6). La sintesi degli elementi di varie culture operata dalla comunità viestana molto probabilmente la porta ad assumere col tempo una sorta di centralità nell area dauna-abruzzese-dalmata, evidenziata dalla ricezione e dalla elaborazione dei prodromi della nuova civiltà di Serra d Alto, che si possono cogliere nel frammento di boccale con ansa sormontata da un cartoccio stilizzato tipo Serra d Alto e nei frammenti in ceramica chiara decorati nello stile Serra d Alto meandrospiralico, che viene ritenuto caratteristico di un momento antico della fase e che nella essenzialità delle sue linee non si rinviene né nell area ripolina né in quella dalmata e solo raramente fuori dalla Daunia nella penisola. Questo ultimo aspetto della ceramica dipinta, i cui elementi della sintassi decorativa trovano fondamento nella cultura di Danilo tramite i più recenti schemi della Scaloria Alta, sembra chiudere il periodo di crisi del neolitico medio della Daunia perdurato dall avvento delle tricromiche della Scaloria Bassa fino agli albori del Serra d Alto, per un periodo in cui il neolitico dauno sembra essere stato tributario delle culture abruzzese e dalmata. Nell ambito delle nuove civiltà si avverte una netta cesura fra la sua espressione antica di Vieste e quella medio-finale. La prima sembra un episodio concluso, forse perché il centro garganico con il Promontorio perde la sua valenza logistica col venir meno dei contatti con le aree dalmata e abruzzese. La seconda si afferma soprattutto nel Tavoliere, dove sorgono quasi contemporaneamente ex novo abitati all aperto, come Masseria Istituto Di Sangro, C. Chiarappa e Chiantinelle. Mass. Istituto Di Sangro è posto ai margini della palude a sud di San Severo e sembra il più importante ed esteso dei villaggi localizzati intorno alla stessa palude, come Coppa Pocci, Oliveto Masselli, Pian Devoto e Coppa Pallante, dove l area occupata dalla comunità di Serra d Alto è nettamente distinta da quella che è stata sede degli insediamenti precedenti, ripetendo una situazione che è stata verificata anche a Chiantinelle. L abitato di C. Chiarappa, di piccole dimensioni, è ubicato nei pressi della vecchia foce del Fortore e fa da pendent al vicino megavillaggio di Chiantinelle. Questo, per la sua posizione topografica, che appare ideale per controllare sia il tratto terminale del corso d acqua attraverso cui si può risalire fino al confine con la Campania sia il vicino guado che permetteva un facile accesso alla piana di Lesina e quindi al Tavoliere, sembra il punto di riferimento per i traffici e per le attività di scambio di materie prime, quali l ossidiana liparota e gli strumenti di selce garganica presenti in grande abbondanza (gli scarti di lavorazione fanno ipotizzare l esistenza di un officina in loco). Nel Serra d Alto maturo e finale si configura un nuovo modello di rapporto con l ecosistema ed una diversa organizzazione sociale, che vengono indiziati dal nuovo
15 78 Armando Gravina impianto insediativo accertato nella Daunia (GRAVINA 1984) e costituito da piccoli abitati, per due terzi inedito rispetto a quello delle ceramiche bicromiche-tricromiche. Significativo è il caso riscontrabile a San Domino nelle isole Tremiti, dove la nuova comunità si insedia nel nuovo sito di Cala degli Inglesi. Vengono occupati i luoghi caratterizzati da zone umide, da affioramento delle falde freatiche superficiali o da terreni leggeri per la coltivazione o da abbondanza di acque di superficie, elemento importante per la pratica della pastorizia il cui incremento è stato documentato nella Puglia centrale con la tendenziale prevalenza degli ovini-caprini sui bovini (GENIOLA 1979). La maggiore esigenza di mobilità e le diversificate forme di attività produttive forse rendono meno vincolanti le scelte del terreno su cui impiantare l insediamento e meno complesse le strutture dei villaggi. Molti punti chiave dei percorsi viari preistorici vengono utilizzati o riattivati. Vistose innovazioni si registrano nel mondo culturale e ideologico; fra le più importanti sono da ricordare il venir meno dell uso e del significato dei fossati e la presenza di statuine della dea madre a Chiantinelle (GRAVINA 2008), le quali, pur indiziando un adesione ad una sfera spirituale comunitaria, si differenziano notevolmente dalle consimili espressioni idoliche dell area apulo-materana (GENIOLA, TUNZI 1980; STRIC- COLI 1988), ed evidenziano in modo marcato ascendenze egeo-balcaniche. È una nuova situazione storica quella che si afferma col Serra d Alto mediofinale, che presenta da un lato una precoce interconnessione con la sfera culturale del Diana e dall altro ambiti distinti sul piano territoriale, nel più ampio crogiuolo delle civiltà di Serra d Alto. L area apulo-materana se da una parte acquista una fisionomia sua propria e diventa un centro di propulsione culturale i cui influssi pervengono nelle regioni viciniori (sull acropoli di Lipari è considerata una importazione da centri stilisticamente più avanzati, cfr. BERNABÒ BREA, CAVALIER, 1956, p. 25) e transmarine (si pensi al vaso Serra d Alto, probabilmente di provenienza pugliese, ad Obre II, cfr. BENAC 1975, Tav. 41, fig. 3,5), dall altra presenta nella Daunia centro-settentrionale un aspetto locale in cui Chiantinelle assume una certa centralità in un panorama di abitati all aperto, peculiarità che non si riscontra diffusamente in altre zone dove il Serra d Alto è documentato prevalentemente in grotta. BIBLIOGRAFIA BATOVIC S. 1963, Neolitsko nalaziste Smilcic, Zadar. BATOVIC S. 1966, Starij neolit u Dalmaciji, BATOVIC S. 1975, Le relazioni tra la Daunia e la sponda orientale dell Adriatico, in Atti del Coll. Int. di Preistoria e Protostoria della Daunia, Foggia 1973, Firenze, pp
16 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 79 BENAC A , Obre I, in Galsnik Zemaljskoy muzeja, Bibl. Antologija, N.S., XXVII, Serajevo. BENAC A. 1973, Obre II, A neolithic settlement of Butmir group at Gornje Polje, in W.M.B.H.L., A Serajevo. BERNABÒ BREA L. 1962, Il Neolitico e la prima civiltà dei Metalli nell Italia meridionale, in Atti del I Convegno di studi sulla Magna Grecia. BERNABÒ BREA L., CAVALIER L. 1956, Civiltà preistoriche delle isole Eolie e del Territorio di Milazzo, in BPI, LXI, CASSANO S. M. 1993, La facies Serra d Alto: intensificazione delle attività produttive e aspetti del rituale, in Origini XVII, pp CASSANO S. M., MANFREDINI A. 1983, Studi sul Neolitico del Tavoliere della Puglia. Indagine territoriale su un area campione, BAR. Int.S. 160, Oxford. CASSANO S. M., MANFREDINI A. 2004, Masseria Candelaro. Vita quotidiana e mondo ideologico in una comunità neolitica del Tavoliere, Claudio Grenzi Ed., Foggia. CREMONESI G. 1965, Il villaggio di Ripoli alla luce dei recenti scavi, in RSP., XX,1, pp ELSTER E. S., ISETTI E., TRAVERSO A. 2008, Nuove evidenze di studio dal sito di Grotta Scaloria (Fg), in A. Gravina (a cura di), Atti 28 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, San Severo 2007, San Severo, pp GALIBERTI A. 2005, a cura di, Difensola, una miniera di selce di 7000 anni fa, Siena. GENIOLA A. 1979, Il Neolitico nella Puglia settentrionale e centrale, in La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Electa Ed., Milano, pp GENIOLA A, TUNZI A. M. 1980, Espressioni cultuali e d arte nella Grotta di Cala Scizzo, in RSP., XXXV, 1-2, pp GRAVINA A. 1983, Le comunità neolitiche di Coppa Pallante, in Atti 5 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, I, San Severo, pp , Tavv. I-XXII. GRAVINA A. 1984, Caratteri del Neolitico medio-finale nella Daunia centro-settentrionale, in Atti 6 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, San Severo, pp 22-41, Tavv. VIII-XX. GRAVINA A. 1985, Pian Devoto un insediamento neolitico nella Daunia, in Atti 7 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, I, San Severo 1985, pp GRAVINA A. 1986, Masseria Istituto di Sangro. Un insediamento del Neolitico mediofinale nella Daunia, in Atti 8 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, I, San Severo, pp GRAVINA A. 1987, Alcuni aspetti del Neolitico medio-finale nella Daunia centro-settentrionale. Elementi di topografia, in Atti XXXVI della Riun. Sc. dell IIPP, pp GRAVINA A. 1988, Vieste: la frequentazione neolitica medio-finale ed eneolitica, in A. Gravina (a cura di), Atti 10 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, I, San Severo, pp GRAVINA A. 1990, Coppa Pocci. La frequentazione del Neolitico antico e medio in Atti 12 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, I, San Severo, pp , Tavv. XVI-XXIII.
17 80 Armando Gravina GRAVINA A. 1994, Il complesso preistorico della Valle dell Inferno presso San Giovanni Rotondo, in A. Gravina (a cura di), Atti 15 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, I, San Severo, pp GRAVINA A. 1999, Località Ciccalento fra preistoria e storia, in Bollettino della Biblioteca del Santuario di San Matteo (San Marco in Lamis, Foggia), 2, Malagrinò Ed., Bari, pp GRAVINA A. 2000, Nuovi dati sulla frequentazione del territorio di Anzano di Puglia (Foggia), in A. Gravina (a cura di), Atti 21 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, I, San Severo, pp GRAVINA. A. 2005, Il popolamento neolitico nella Daunia costiera, garganica e nella valle del Fortore, RSP, LV, pp GRAVINA. A. 2008, Due statuine fittili da S. Matteo-Chiantinelle (Serracapriola, Foggia), in BPI, v. 97, nuova serie XV, Roma, pp GRAVINA A., GENIOLA A. 1978, Insediamento neolitico di C.no S. Matteo-Chiantinelle (Serracapriola-FG), in La Capitanata, a. XIV, n.16, II, 1976, Foggia, pp GRAVINA A., RONCHITELLI A.M , Il villaggio neolitico di C.no Chiarappa (Serracapriola-Fg), in La Capitanata, a.xxi-xxii, I, Foggia, pp KORKUTI M., ANDREA Zh.1972, Fouilles dans l agglomeration néolithique de Cakran (Fieri), in Studia Albanica, IX, I, N.S. XXVII, Serajevo. KOROSEK J , Neolitska naseobina u Danilu bitinju, Zagreb. KOROSEC J. 1964, Danilo in danilaska Kultura, Lubiana. MALLORY J. P , (a cura di), Lagnano da Piede I An early neolithic village in the Tavoliere, in Origini XIII, pp PALMA DI CESNOLA A. 1967, Il Neolitico medio e superiore a S. Domino (Arcipelago delle Tremiti), in RSP, XXII, pp PRENDI F., ALIU S. 1971, Vendbamini neolitik ne fshatin Kamnik Rzethit Kolonjes, in Iliria, Tirana, pp PUGLISI S. M. 1955, Industria microlitica nei livelli a ceramica impressa di Coppa Nevigata, in RSP, X, 1-4, Firenze. QUAGLIATI Q. 1936, La Puglia Preistorica, Trani. RELLINI U. 1923, La Grotta delle felci a Capri, in Monum. Antichi dei Lincei, XXIX, STRICCOLI R. 1988, Le culture preistoriche di Grotta Pacelli (Castellana Grotte- Bari), Schena Ed., Fasano. TINÈ S. 1983, Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, Genova. TINÈ, S. ISETTI E. 1982, Culto neolitico delle acque e recenti scavi nella Grotta Scaloria, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, Manfredonia. TOZZI C., ZAMAGNI B. 2003, Gli scavi nel villaggio neolitico di Catignano, Firenze. TUNZI A. M., SANSEVERINO R. 2007, Nota preliminare sull insediamento neolitico di C.no S. Matteo-Chiantinelle (Serracapriola Fg), in A. Gravina (a cura di), Atti 28 Conv. Naz. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, San Severo, pp ZORZI F. 1958, Tremiti, in RSP, XIII, Firenze.
18 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 81 Fig. 1 Variazione del popolamento della Daunia da Passo di Corvo al Diana. Fig. 2 Daunia: siti con ceramica bicromica-tricromica.
19 82 Armando Gravina Fig. 3 Catignano: ceramiche dipinte (da Tozzi, Zamagni 2003). Fig. 4 Grotta delle Felci: ceramiche dipinte (da Rellini 1923). Fig. 5 Danilo: ceramiche dipinte (da Korosec 1924).
20 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 83 Fig. 6 Ripoli: ceramiche dipinte (da Cremonesi 1965). Fig. 7 Cala Tramontana: ceramiche (da Palma di Cesnola 1967).
21 84 Armando Gravina Fig. 8 Vieste: ceramiche tricromiche ed incise.
22 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 85 Fig. 9 Vieste: ceramiche del Serra d Alto.
23 86 Armando Gravina Fig. 10 Grotta Scaloria Bassa 1-4; Grotta Scaloria Alta 6-14 (da Tiné, Isetti 1982). Fig. 11 C.no San Matteo-Chiantinelle: ceramiche dipinte in bicromia ed incise.
24 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 87 Fig. 12 C.no San Matteo-Chiantinelle: ceramiche del Serra d Alto.
25 88 Armando Gravina Fig. 13 C.no San Matteo-Chiantinelle: ceramiche del Serra d Alto.
26 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 89 Fig. 14 C.no San Matteo-Chiantinelle: ceramiche del Serra d Alto e del Diana.
27 90 Armando Gravina Fig. 15 Fig. 16 Fig. 15 C.no San Matteo-Chiantinelle: Dea Madre (1-2); Anzano di Puglia: piede di ryton (3) (da Gravina 2000). Fig. 16 Coppa Pocci: ceramiche tricromiche (1-5) (da Gravina 1990).
28 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 91 Fig. 17 Danilo: schemi decorativi dipinti su ceramica figulina ed incisi su ceramica d impasto (da Korosec ).
29 92 Armando Gravina Fig. 18 Confronti fra schemi decorativi di Danilo, Ripoli, Cala Tramontana, Vieste, Grotta Scaloria, Chiantinelle, Cala Scizzo.
30 Osservazioni sui rapporti tra la Daunia, l Abruzzo e l opposta sponda adriatica nel V millennio 93 Fig. 19 Confronti fra schemi decorativi di Danilo, Vieste, Grotta Scaloria Alta, Chiantinelle, Ripoli, Cala Tramontana.
31 94 Armando Gravina Fig. 20 Cultura di Danilo. Motivi decorativi incisi su ceramica d impasto che imitano dipinti in tricromia, diffusi fuori dell area di Danilo (da Korasec ).
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO CONVEGNO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2017 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale
NOTA SUL VILLAGGIO NEOLITICO SCOPERTO AL CENTRO DI FOGGIA
 NOTA SUL VILLAGGIO NEOLITICO SCOPERTO AL CENTRO DI FOGGIA Nel settembre 1977, durante i lavori di scavo per l impianto di un tratto della nuova rete fognante, sono venute in luce, nel centro di Foggia,
NOTA SUL VILLAGGIO NEOLITICO SCOPERTO AL CENTRO DI FOGGIA Nel settembre 1977, durante i lavori di scavo per l impianto di un tratto della nuova rete fognante, sono venute in luce, nel centro di Foggia,
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2009 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972)
 Luciano Salzani 111 SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972) Luciano Salzani Nell autunno del 1971 i lavori di una cava di sabbia intaccavano l ultimo sperone di una collina
Luciano Salzani 111 SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972) Luciano Salzani Nell autunno del 1971 i lavori di una cava di sabbia intaccavano l ultimo sperone di una collina
GROTTA TRAPPEDO E GROTTA DEI MIRACOLI CENNI SULLA FREQUENTAZIONE PREISTORICA IN TERRITORIO DI RIGNANO GARGANICO (FG)
 GROTTA TRAPPEDO E GROTTA DEI MIRACOLI CENNI SULLA FREQUENTAZIONE PREISTORICA IN TERRITORIO DI RIGNANO GARGANICO (FG) GROTTA TRAPPEDO Si apre in territorio di Rignano Garganico (Foggia), circa un chilometro
GROTTA TRAPPEDO E GROTTA DEI MIRACOLI CENNI SULLA FREQUENTAZIONE PREISTORICA IN TERRITORIO DI RIGNANO GARGANICO (FG) GROTTA TRAPPEDO Si apre in territorio di Rignano Garganico (Foggia), circa un chilometro
LA PUGLIA LA PUGLIA È LA REGIONE PIÙ A EST DELLA PENISOLA E PER LA SUA POSIZIONE È ANCHE DETTA TACCO D'ITALIA
 LA PUGLIA LA PUGLIA È LA REGIONE PIÙ A EST DELLA PENISOLA E PER LA SUA POSIZIONE È ANCHE DETTA TACCO D'ITALIA I CONFINI E LE PROVINCE La regione confina a nord-ovest con il Molise, a ovest con la Campania,
LA PUGLIA LA PUGLIA È LA REGIONE PIÙ A EST DELLA PENISOLA E PER LA SUA POSIZIONE È ANCHE DETTA TACCO D'ITALIA I CONFINI E LE PROVINCE La regione confina a nord-ovest con il Molise, a ovest con la Campania,
Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1
 ARIMNESTOS Ricerche di Protostoria Mediterranea 1/2018, pp. 147-155 Patrizia von Eles* Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1 Gli anelli in osso sono relativamente numerosi a Verucchio
ARIMNESTOS Ricerche di Protostoria Mediterranea 1/2018, pp. 147-155 Patrizia von Eles* Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1 Gli anelli in osso sono relativamente numerosi a Verucchio
Tipologia delle Forme vascolari. Claudio Giardino
 Tipologia delle Forme vascolari Claudio Giardino CATEGORIA Categorie sistematiche (spada, pugnale, ascia, brocca, urna) CLASSE (spada a lingua da presa, ascia ad alette, brocca, urna a collo) FORMA (spada
Tipologia delle Forme vascolari Claudio Giardino CATEGORIA Categorie sistematiche (spada, pugnale, ascia, brocca, urna) CLASSE (spada a lingua da presa, ascia ad alette, brocca, urna a collo) FORMA (spada
III. I VETRI. BAUMGARTNER, KRUEGER 1988, p
 III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 1998 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 1998 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Grandi e medie imprese toscane e gruppi d impresa
 Grandi e medie imprese toscane e gruppi d impresa Firenze, 16 maggio 2012 Unioncamere Toscana - Ufficio Studi Riccardo Perugi Massimo Pazzarelli (elaborazioni) 1) I gruppi d impresa in Toscana: una visione
Grandi e medie imprese toscane e gruppi d impresa Firenze, 16 maggio 2012 Unioncamere Toscana - Ufficio Studi Riccardo Perugi Massimo Pazzarelli (elaborazioni) 1) I gruppi d impresa in Toscana: una visione
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
La Valle d Aosta. il... (4 476 m). Il capoluogo di regione è...
 La Valle d Aosta La Valle d Aosta confina a nord con la......, a est e a sud con il..., a ovest con la... È una regione completamente...... Le sue cime principali sono: il...... (4 810 m), il...... (4
La Valle d Aosta La Valle d Aosta confina a nord con la......, a est e a sud con il..., a ovest con la... È una regione completamente...... Le sue cime principali sono: il...... (4 810 m), il...... (4
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
Tarquinia, complesso monumentale : ceramica depurata acroma e a bande
 XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
ASPETTI DEL NEOLITICO MATURO SUL VERSANTE ADRIATICO MERIDIONALE DELL ITALIA. Alfredo Geniola*, Rocco Sanseverino*
 ASPETTI DEL NEOLITICO MATURO SUL VERSANTE ADRIATICO MERIDIONALE DELL ITALIA Alfredo Geniola*, Rocco Sanseverino* Riassunto: In questo lavoro l indagine riguarda la diffusione di alcuni materiali nel IV
ASPETTI DEL NEOLITICO MATURO SUL VERSANTE ADRIATICO MERIDIONALE DELL ITALIA Alfredo Geniola*, Rocco Sanseverino* Riassunto: In questo lavoro l indagine riguarda la diffusione di alcuni materiali nel IV
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche
 Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA NOVEMBRE Con il patrocinio:
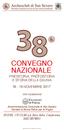 CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
I PRINCIPALI INDICATORI DI
 I PRINCIPALI INDICATORI DI FABBISOGNO PER MUNICIPIO A ROMA CAPITALE Anno 2016 Indice Fabbisogno di servizi sociali... 4 I campi d indagine... 4 Gli asili nido... 4 Famiglie e minori... 5 Anziani... 6 Disagio
I PRINCIPALI INDICATORI DI FABBISOGNO PER MUNICIPIO A ROMA CAPITALE Anno 2016 Indice Fabbisogno di servizi sociali... 4 I campi d indagine... 4 Gli asili nido... 4 Famiglie e minori... 5 Anziani... 6 Disagio
ARCHEOLOGIA CLASSICA AA 2017/2018. Allegato 2. Prof. Roberto PERNA
 ARCHEOLOGIA CLASSICA AA 2017/2018 Allegato 2 Prof. Roberto PERNA Pollentia-Urbs Salvia : localizzazione topografica Tardoantico 19 siti Medioevo 81 siti Paleolitico - mesolitico 25 siti Non id. 106 siti
ARCHEOLOGIA CLASSICA AA 2017/2018 Allegato 2 Prof. Roberto PERNA Pollentia-Urbs Salvia : localizzazione topografica Tardoantico 19 siti Medioevo 81 siti Paleolitico - mesolitico 25 siti Non id. 106 siti
Arcipelaghi e isole d Italia
 L Isola di Vulcano, in primo piano, nelle Eolie. La penisola italiana è circondata, oltre che dalla Sicilia e dalla Sardegna, che sono le isole più grandi del Mediterraneo, anche da numerosi arcipelaghi
L Isola di Vulcano, in primo piano, nelle Eolie. La penisola italiana è circondata, oltre che dalla Sicilia e dalla Sardegna, che sono le isole più grandi del Mediterraneo, anche da numerosi arcipelaghi
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
DanielaCocchiGenick PREISTORIA. ContieneCD-ROM. QuiEdit
 DanielaCocchiGenick PREISTORIA ContieneCD-ROM QuiEdit Copyright by Qui Edit di S.D.S. s.n.c. Via S. Francesco, 7 37129 Verona, Italy www.quiedit.it e-mail: informazioni@quiedit.it Edizione I Anno 2009
DanielaCocchiGenick PREISTORIA ContieneCD-ROM QuiEdit Copyright by Qui Edit di S.D.S. s.n.c. Via S. Francesco, 7 37129 Verona, Italy www.quiedit.it e-mail: informazioni@quiedit.it Edizione I Anno 2009
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO CONVEGNO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2017 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale sulla Preistoria,
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale sulla Preistoria,
Regione PUGLIA - Note storiche
 Regione PUGLIA - Note storiche Terremoto del 1627. Mappa con la descrizione dei danni secondo una scala macrosismica a quattro gradi riportata in legenda. [in ENEA (1992), Terremoti in Italia dal 62 a.d.
Regione PUGLIA - Note storiche Terremoto del 1627. Mappa con la descrizione dei danni secondo una scala macrosismica a quattro gradi riportata in legenda. [in ENEA (1992), Terremoti in Italia dal 62 a.d.
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012
 Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Le pianure. Mondadori Education
 Le pianure La pianura italiana più vasta e fertile è la Pianura Padana, che si estende da ovest verso est ai piedi delle Alpi. È una pianura di origine alluvionale, cioè si è formata in seguito al deposito
Le pianure La pianura italiana più vasta e fertile è la Pianura Padana, che si estende da ovest verso est ai piedi delle Alpi. È una pianura di origine alluvionale, cioè si è formata in seguito al deposito
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda.
 La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
Focus Provinciale Il mercato immobiliare residenziale
 Il mercato immobiliare residenziale periodo di riferimento: 1 semestre 2017 a cura della Ufficio Provinciale Territorio di (Poliseno Maria Giuseppina - referente OMI) Direzione Centrale Osservatorio Mercato
Il mercato immobiliare residenziale periodo di riferimento: 1 semestre 2017 a cura della Ufficio Provinciale Territorio di (Poliseno Maria Giuseppina - referente OMI) Direzione Centrale Osservatorio Mercato
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE Il territorio comunale di Montebello Jonico ha una estensione di 55,67 Kmq ed è posizionato al margine meridionale dello spazio geografico che da secoli viene denominato con
INQUADRAMENTO TERRITORIALE Il territorio comunale di Montebello Jonico ha una estensione di 55,67 Kmq ed è posizionato al margine meridionale dello spazio geografico che da secoli viene denominato con
1. INTRODUZIONE Antonio Martinelli
 1. INTRODUZIONE Antonio Martinelli In questa breve introduzione si illustra l'organizzazione ed i tenuti del volume mettendo in evidenza alcune osservazioni di carattere generale emergenti dalla lettura
1. INTRODUZIONE Antonio Martinelli In questa breve introduzione si illustra l'organizzazione ed i tenuti del volume mettendo in evidenza alcune osservazioni di carattere generale emergenti dalla lettura
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO. 36 sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2015 A T T I. a cura di Armando Gravina
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 36 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 15-16 novembre 2015 A T T I a cura di San Severo 2016 Il 36 Convegno Nazionale sulla Preistoria,
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 36 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 15-16 novembre 2015 A T T I a cura di San Severo 2016 Il 36 Convegno Nazionale sulla Preistoria,
Una nuova interpretazione della fossa del vasaio di Turona,
 Una nuova interpretazione della fossa del vasaio di Turona, «En contrebas de la colline de la Cività un grand nombre de fragments de vases d impasto et de bucchero apparurent dans ce qui devait être une
Una nuova interpretazione della fossa del vasaio di Turona, «En contrebas de la colline de la Cività un grand nombre de fragments de vases d impasto et de bucchero apparurent dans ce qui devait être une
Il Neolitico 3. PROFILI DELLE PRODUZIONI CERAMICHE IN ITALIA NELL ANTICHITÀ LA PREISTORIA
 3. PROFILI DELLE PRODUZIONI CERAMICHE IN ITALIA NELL ANTICHITÀ LA PREISTORIA Il Neolitico Nicoletta Volante La produzione della ceramica preistorica La trattazione della ceramica preistorica copre un arco
3. PROFILI DELLE PRODUZIONI CERAMICHE IN ITALIA NELL ANTICHITÀ LA PREISTORIA Il Neolitico Nicoletta Volante La produzione della ceramica preistorica La trattazione della ceramica preistorica copre un arco
MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011
 MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011 N 2-2014/15 Ottobre 2014 Il campione di aziende La fase agricola pag.2 La commercializzazione pag.5
MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011 N 2-2014/15 Ottobre 2014 Il campione di aziende La fase agricola pag.2 La commercializzazione pag.5
L economia del Lazio nel 2009
 L economia del Lazio nel 2009 Evidenza dai conti regionali Istat pubblicati il 28 settembre 2010 Servizio Analisi e Finanza Sviluppo Lazio L economia del Lazio nel 2009 1. Premessa Il 28 settembre, l Istat
L economia del Lazio nel 2009 Evidenza dai conti regionali Istat pubblicati il 28 settembre 2010 Servizio Analisi e Finanza Sviluppo Lazio L economia del Lazio nel 2009 1. Premessa Il 28 settembre, l Istat
SANTA MARIA NAVARRESE SCHEDA AMBITO N. 22 SUPRAMONTE DI BAUNEI E DORGALI SCHEDA AMBITO N. 23 OGLIASTRA
 SANTA MARIA NAVARRESE SCHEDA AMBITO N. 22 SUPRAMONTE DI BAUNEI E DORGALI SCHEDA AMBITO N. 23 OGLIASTRA Il Comune di Baunei ricade all interno di due ambiti di paesaggio del PPR, quello del Supramonte di
SANTA MARIA NAVARRESE SCHEDA AMBITO N. 22 SUPRAMONTE DI BAUNEI E DORGALI SCHEDA AMBITO N. 23 OGLIASTRA Il Comune di Baunei ricade all interno di due ambiti di paesaggio del PPR, quello del Supramonte di
Relazione di compatibilità Idraulica Art.10 L.R. 23 Novembre COMPRENSORIO VALLE CUPA 5.1 VERIFICA PRELIMINARE E VERIFICA SEMPLIFICATA Il Compr
 Relazione di compatibilità Idraulica Art.10 L.R. 23 Novembre 2011 5. COMPRENSORIO VALLE CUPA 5.1 VERIFICA PRELIMINARE E VERIFICA SEMPLIFICATA Il Comprensorio di Valle Cupa è sito a NW del centro abitato
Relazione di compatibilità Idraulica Art.10 L.R. 23 Novembre 2011 5. COMPRENSORIO VALLE CUPA 5.1 VERIFICA PRELIMINARE E VERIFICA SEMPLIFICATA Il Comprensorio di Valle Cupa è sito a NW del centro abitato
Sandrino Luigi MARRA. Le ceramiche del Castello di Gioia Sannitica (Ce)
 Sandrino Luigi MARRA Le ceramiche del Castello di Gioia Sannitica (Ce) Le ceramiche del castello di Gioia Sannitica sono il frutto di un salvataggio effettuato tra il 2004 ed il 2005 durante i lavori di
Sandrino Luigi MARRA Le ceramiche del Castello di Gioia Sannitica (Ce) Le ceramiche del castello di Gioia Sannitica sono il frutto di un salvataggio effettuato tra il 2004 ed il 2005 durante i lavori di
1. CONTENUTI DEL PROGETTO
 Volume I - RELAZIONE GENERALE 1.1 Ambito territoriale Il progetto, nella sua formulazione iniziale, riguardava 5 regioni del Sud dell Italia: Molise, Campania,, e la orientale comprendente 67 della provincia
Volume I - RELAZIONE GENERALE 1.1 Ambito territoriale Il progetto, nella sua formulazione iniziale, riguardava 5 regioni del Sud dell Italia: Molise, Campania,, e la orientale comprendente 67 della provincia
1. L'EUROPA E L'ITALIA: CONFINI, COSTE, RILIEVI E PIANURE. Pearson Italia
 1. L'EUROPA E L'ITALIA: CONFINI, COSTE, RILIEVI E PIANURE. L'Europa nel mondo L Europa è il quarto continente per dimensioni: solo l Oceania è più piccola. Dal punto di vista geografico è un estensione
1. L'EUROPA E L'ITALIA: CONFINI, COSTE, RILIEVI E PIANURE. L'Europa nel mondo L Europa è il quarto continente per dimensioni: solo l Oceania è più piccola. Dal punto di vista geografico è un estensione
La frontiera di Lucania
 Comune di Rionero PIT Vulture Alto Bradano - The Vultur Archaeological Project La frontiera di Lucania Un area di interazione culturale nell epocaepoca pre-romana romana e di stabilità nell età romana.
Comune di Rionero PIT Vulture Alto Bradano - The Vultur Archaeological Project La frontiera di Lucania Un area di interazione culturale nell epocaepoca pre-romana romana e di stabilità nell età romana.
COMUNE DI LUNANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGIONE MARCHE
 COMUNE DI LUNANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGIONE MARCHE PROGETTO PER L APERTURA DI UNA CAVA DI CONGLOMERATO IN LOCALITÀ LUPAIOLO BASSO, COMUNE DI LUNANO. POLO ESTRATTIVO FCOB014-22B, PEAE PROV. DI
COMUNE DI LUNANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGIONE MARCHE PROGETTO PER L APERTURA DI UNA CAVA DI CONGLOMERATO IN LOCALITÀ LUPAIOLO BASSO, COMUNE DI LUNANO. POLO ESTRATTIVO FCOB014-22B, PEAE PROV. DI
2 - LA STRUTTURA SOCIO ECONOMICA
 2 - LA STRUTTURA SOCIO ECONOMICA 1 2 2.1 Indicatori demografici 2.1.1 Densità della popolazione residente al 2009 2.1.2 Variazione della popolazione residente 2001-2009 n. residenti 2.1.3 Variazione della
2 - LA STRUTTURA SOCIO ECONOMICA 1 2 2.1 Indicatori demografici 2.1.1 Densità della popolazione residente al 2009 2.1.2 Variazione della popolazione residente 2001-2009 n. residenti 2.1.3 Variazione della
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica. Relazione sul rischio archeologico Lavori eseguiti dalla
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica. Relazione sul rischio archeologico Lavori eseguiti dalla
Cascina Concoreggia - complesso
 Cascina Concoreggia - complesso Lodi (LO) Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/lo470-00045/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/lo470-00045/
Cascina Concoreggia - complesso Lodi (LO) Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/lo470-00045/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/lo470-00045/
PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ATMOSFERA. Analisi campo vento stazioni a 10 m (ARPAV Centro Meteorologico di Teolo)
 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ATMOSFERA Analisi campo vento stazioni a 10 m (ARPAV Centro Meteorologico di Teolo) STAZIONI ARPAV-CMT CON ANEMOMETRO A 10 m Il Centro Meteorologico di Teolo
PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ATMOSFERA Analisi campo vento stazioni a 10 m (ARPAV Centro Meteorologico di Teolo) STAZIONI ARPAV-CMT CON ANEMOMETRO A 10 m Il Centro Meteorologico di Teolo
Restauro del castello di Piombino 3 dicembre 2008
 Restauro del castello di Piombino 3 dicembre 2008 G. Stradano L assedio di Piombino (seconda metà XVI secolo) Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento P. Galle (su disegno di G. Stradano) L assedio
Restauro del castello di Piombino 3 dicembre 2008 G. Stradano L assedio di Piombino (seconda metà XVI secolo) Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento P. Galle (su disegno di G. Stradano) L assedio
Albo IP: analisi dei flussi
 Federazione nazionale Collegi Ipasvi Via Agostino Depretis 70 Tel. 06 46200101 00184 Roma Fax 06 46200131 Albo IP: analisi dei flussi Rapporto 2007 Marzo 2008 1. Presentazione Dal 2007, dopo due anni di
Federazione nazionale Collegi Ipasvi Via Agostino Depretis 70 Tel. 06 46200101 00184 Roma Fax 06 46200131 Albo IP: analisi dei flussi Rapporto 2007 Marzo 2008 1. Presentazione Dal 2007, dopo due anni di
DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI ABITAZIONI: L ANDAMENTO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE
 DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI ABITAZIONI: L ANDAMENTO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE ESTRATTO DALL OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DICEMBRE 2011 ABITAZIONI: L ANDAMENTO
DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI ABITAZIONI: L ANDAMENTO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE ESTRATTO DALL OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DICEMBRE 2011 ABITAZIONI: L ANDAMENTO
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia
 Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
6 LA MOBILITÀ PER AMBITI TERRITORIALI
 6 LA MOBILITÀ PER AMBITI TERRITORIALI La mobilità nella Provincia di Bergamo, che ammonta a circa 520.000 spostamenti giornalieri, risente delle caratteristiche di un assetto territoriale fortemente sbilanciato
6 LA MOBILITÀ PER AMBITI TERRITORIALI La mobilità nella Provincia di Bergamo, che ammonta a circa 520.000 spostamenti giornalieri, risente delle caratteristiche di un assetto territoriale fortemente sbilanciato
APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici. Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste
 APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste CAPITOLO 3 IL CLIMA ONDOSO A LARGO DELLE COSTE ITALIANE
APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste CAPITOLO 3 IL CLIMA ONDOSO A LARGO DELLE COSTE ITALIANE
4 PRINCIPALI DATI STATISTICI 4.1 DEMOGRAFIA E DENSITÀ SUPERFICIE E DENSITÀ ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 5
 4 PRINCIPALI DATI STATISTICI 4.1 DEMOGRAFIA E DENSITÀ 4.1.1 SUPERFICIE E DENSITÀ L insieme delle tre province occidentali si estende su una superficie territoriale di circa 8500 Kmq con 1,8 milioni di
4 PRINCIPALI DATI STATISTICI 4.1 DEMOGRAFIA E DENSITÀ 4.1.1 SUPERFICIE E DENSITÀ L insieme delle tre province occidentali si estende su una superficie territoriale di circa 8500 Kmq con 1,8 milioni di
39. IL LAVORO NELL ACCOGLIENZA TURISTICA
 39. IL LAVORO NELL ACCOGLIENZA TURISTICA Il turismo costituisce per l economia italiana un importante bacino occupazionale, tanto più in quanto negli ultimi anni l offerta turistica del Paese è andata
39. IL LAVORO NELL ACCOGLIENZA TURISTICA Il turismo costituisce per l economia italiana un importante bacino occupazionale, tanto più in quanto negli ultimi anni l offerta turistica del Paese è andata
Acquarossa: tramonto.
 La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
INDICATORI DI FABBISOGNO
 Ragioneria Generale I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario U.O. Statistica INDICATORI DI FABBISOGNO Valutazione delle condizioni esterne nei municipi Indice Asili nido...
Ragioneria Generale I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario U.O. Statistica INDICATORI DI FABBISOGNO Valutazione delle condizioni esterne nei municipi Indice Asili nido...
Marta BOTTOS. Materiali di età medievale e moderna
 Marta BOTTOS Materiali di età medievale e moderna Non sono molte le attestazioni di ceramiche postclassiche provenienti dall area in oggetto di studio. L analisi dei pochi reperti recuperati nell area
Marta BOTTOS Materiali di età medievale e moderna Non sono molte le attestazioni di ceramiche postclassiche provenienti dall area in oggetto di studio. L analisi dei pochi reperti recuperati nell area
Maggio Il Clima in Piemonte. Arpa Piemonte Sistemi Previsionali
 Il Clima in Piemonte Maggio 2014 In Piemonte il mese di Maggio 2014 è stato caratterizzato da temperature nella norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000. Nella serie storica
Il Clima in Piemonte Maggio 2014 In Piemonte il mese di Maggio 2014 è stato caratterizzato da temperature nella norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000. Nella serie storica
Villa Braila. Lodi (LO)
 Villa Braila Lodi (LO) Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/lo480-00010/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/lo480-00010/
Villa Braila Lodi (LO) Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/lo480-00010/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/lo480-00010/
10-11 novembre 2012 REPORT METEOROLOGICO. Per info:
 REPORT METEOROLOGICO 10-11 novembre 2012 Per info: previsori@lamma.rete.toscana.it Consorzio LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale 1 Evento meteorologico 10-11 novembre 2012 Una
REPORT METEOROLOGICO 10-11 novembre 2012 Per info: previsori@lamma.rete.toscana.it Consorzio LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale 1 Evento meteorologico 10-11 novembre 2012 Una
PUBBLICAZIONI ISTITUTO PER LA STORIA E L ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA ATTI DEI CONVEGNI DI STUDI SULLA MAGNA GRECIA. anno titolo euro 60,00
 PUBBLICAZIONI ISTITUTO PER LA STORIA E L ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA ATTI DEI CONVEGNI DI STUDI SULLA MAGNA GRECIA anno titolo euro I 1961 Greci e Italici in Magna Grecia Vol. 1, pp. 315. 60,00 II 1962
PUBBLICAZIONI ISTITUTO PER LA STORIA E L ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA ATTI DEI CONVEGNI DI STUDI SULLA MAGNA GRECIA anno titolo euro I 1961 Greci e Italici in Magna Grecia Vol. 1, pp. 315. 60,00 II 1962
Distretto Idrografico dell Appennino Meridionale Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicat
 PIANO DI GESTIONE ACQUE (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09, D.L. 194/09) ALLEGATO 1 alla Delibera di Comitato Istituzionale del 24 febbraio 2010 Elaborati di Piano Febbraio 2010
PIANO DI GESTIONE ACQUE (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09, D.L. 194/09) ALLEGATO 1 alla Delibera di Comitato Istituzionale del 24 febbraio 2010 Elaborati di Piano Febbraio 2010
G. NONINI, G. TASCA - Rinvenimenti di superficie... Quaderni Friulani di Archeologia V/1995
 G. NONINI, G. TASCA - Rinvenimenti di superficie... Quaderni Friulani di Archeologia V/1995 Figura 1. Buttrio (UD) - Localizzazione del rinvenimento. 44 Quaderni Friulani di Archeologia V/1995 RINVENIMENTI
G. NONINI, G. TASCA - Rinvenimenti di superficie... Quaderni Friulani di Archeologia V/1995 Figura 1. Buttrio (UD) - Localizzazione del rinvenimento. 44 Quaderni Friulani di Archeologia V/1995 RINVENIMENTI
OGGETTO : RECUPERO, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CASALE MONFERRATO - 5/8 LOTTO DI LAVORI
 MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano
 Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
COMUNE DI TURI SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
 COMUNE DI TURI SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALLA DISPONIBILITÀ DI AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELL HINTERLAND DEL COMUNE DI TURI BANDO DI GARA PER L
COMUNE DI TURI SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALLA DISPONIBILITÀ DI AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELL HINTERLAND DEL COMUNE DI TURI BANDO DI GARA PER L
Andamento dei prezzi e delle compravendite nelle principali città italiane
 Andamento dei prezzi e delle compravendite nelle principali città italiane La ricerca è stata confrontata in base ai dati forniti dal numero di compravendite concluse nell anno 2009, precisamente dall
Andamento dei prezzi e delle compravendite nelle principali città italiane La ricerca è stata confrontata in base ai dati forniti dal numero di compravendite concluse nell anno 2009, precisamente dall
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Documento digitalizzato dallo Staff di UnissResearch
 Depalmas, Anna; Melis, Maria Grazia; Tanda, Giuseppa (2000) Gli Orizzonti Campaniforme e Bonnanaro nella necropoli di Lochele-Sedilo (OR). n: L'ipogeismo nel Mediterraneo: origini, sviluppo, quadri culturali:
Depalmas, Anna; Melis, Maria Grazia; Tanda, Giuseppa (2000) Gli Orizzonti Campaniforme e Bonnanaro nella necropoli di Lochele-Sedilo (OR). n: L'ipogeismo nel Mediterraneo: origini, sviluppo, quadri culturali:
I flussi commerciali con l estero III Trimestre 2015
 I dati relativi ai flussi commerciali della provincia di Reggio Calabria segnalano, per il terzo trimestre 2015, un ulteriore peggioramento della bilancia commerciale, tracciando un andamento al ribasso
I dati relativi ai flussi commerciali della provincia di Reggio Calabria segnalano, per il terzo trimestre 2015, un ulteriore peggioramento della bilancia commerciale, tracciando un andamento al ribasso
L OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
 L OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Estratto dall Osservatorio Congiunturale sull Industria delle Costruzioni Luglio a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi ESTRATTO DALL'OSSERVATORIO
L OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Estratto dall Osservatorio Congiunturale sull Industria delle Costruzioni Luglio a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi ESTRATTO DALL'OSSERVATORIO
Tarquinia, complesso monumentale : ceramica depurata etrusco-geometrica
 XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Tra importazione e produzione locale: lineamenti teoretici e applicazioni pratiche per l individuazione di modelli culturali...
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CORSO Claudio Negrelli
 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CORSO 2014-2015 Claudio Negrelli La ceramologia: una disciplina a sé stante? Lo studio del materiale ceramico medievale e post-medievale La ceramologia in generale come studio tipologico,
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CORSO 2014-2015 Claudio Negrelli La ceramologia: una disciplina a sé stante? Lo studio del materiale ceramico medievale e post-medievale La ceramologia in generale come studio tipologico,
STIMA PRELIMINARE DEL PIL E DELL OCCUPAZIONE TERRITORIALE ANNO Pil 2018: corre il Nord-est, ma frena il Sud
 26 GIUGNO 2019 ANNO 2018 Pil 2018: corre il Nord-est, ma frena il Sud Nel 2018 la crescita del Prodotto interno lordo è ben superiore alla media nazionale nel Nord-est (+1,4%), con una dinamica particolarmente
26 GIUGNO 2019 ANNO 2018 Pil 2018: corre il Nord-est, ma frena il Sud Nel 2018 la crescita del Prodotto interno lordo è ben superiore alla media nazionale nel Nord-est (+1,4%), con una dinamica particolarmente
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011
 MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011 N 3-2013/14 Gennaio 2014 Il campione di aziende La fase agricola pag.2 La commercializzazione pag.5
MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011 N 3-2013/14 Gennaio 2014 Il campione di aziende La fase agricola pag.2 La commercializzazione pag.5
MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011
 2013-14 MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011 Giugno 2014 Il campione di aziende La fase agricola pag.2 La commercializzazione pag.5 Per
2013-14 MONITORAGGIO DEL MERCATO E DELL OFFERTA DISPONIBILE NEL SETTORE DELL OLIO DI OLIVA REG. (UE) 1220/2011 Giugno 2014 Il campione di aziende La fase agricola pag.2 La commercializzazione pag.5 Per
Le mappe della fragilità nei comuni della Città metropolitana di Bologna
 Le mappe della fragilità nei comuni della Città metropolitana di Bologna L elaborazione delle mappe della fragilità nei Comuni della Città metropolitana riprende l esperienza e la metodologia di mappatura
Le mappe della fragilità nei comuni della Città metropolitana di Bologna L elaborazione delle mappe della fragilità nei Comuni della Città metropolitana riprende l esperienza e la metodologia di mappatura
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO. 36 sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2015 A T T I. a cura di Armando Gravina
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 36 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 15-16 novembre 2015 A T T I a cura di Armando Gravina San Severo 2016 Il 36 Convegno Nazionale
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 36 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 15-16 novembre 2015 A T T I a cura di Armando Gravina San Severo 2016 Il 36 Convegno Nazionale
REPORT 1 I FASE. Flussi veicolari di scambio con il territorio extraurbano Campagna di rilevamenti (fascia oraria 07:00-21:00)
 n veicoli totali REPORT 1 I FASE ANALISI DEI RILIEVI DEI FLUSSI DI TRAFFICO La campagna di indagini sui flussi di traffico finalizzata ad individuare la mobilità sistematica complessiva dei residenti in
n veicoli totali REPORT 1 I FASE ANALISI DEI RILIEVI DEI FLUSSI DI TRAFFICO La campagna di indagini sui flussi di traffico finalizzata ad individuare la mobilità sistematica complessiva dei residenti in
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
costituito dai seguenti comuni: Casnigo, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Vertova. La superficie territoriale del sub-ambito è di 51,71 km 2.
 costituito dai seguenti comuni: Casnigo, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Vertova. La superficie territoriale del sub-ambito è di 51,71 km 2. Figura 9 suddivisione della provincia di Bergamo in 24
costituito dai seguenti comuni: Casnigo, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Vertova. La superficie territoriale del sub-ambito è di 51,71 km 2. Figura 9 suddivisione della provincia di Bergamo in 24
POLO N. 5 BONDENO, SETTEPOLESINI
 TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
Lavoro News # 10 Bollettino trimestrale sul mercato del lavoro
 Agenzia per il lavoro e l istruzione Osservatorio sul MdL Lavoro News # 10 Bollettino trimestrale sul mercato del lavoro I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2014 ISTAT Indagine Continua sulle Forze di Lavoro
Agenzia per il lavoro e l istruzione Osservatorio sul MdL Lavoro News # 10 Bollettino trimestrale sul mercato del lavoro I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2014 ISTAT Indagine Continua sulle Forze di Lavoro
COMUNE DI CHIEVE Provincia di Cremona
 COMUNE DI CHIEVE Provincia di Cremona COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione dell art. 57, comma 1, della L.R.
COMUNE DI CHIEVE Provincia di Cremona COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione dell art. 57, comma 1, della L.R.
Fig 1. Situazione meteo da satellite delle ore 10 UTC del Elaborazione grafica di Lorenzo Catania.
 Dopo un lungo periodo caratterizzato da situazioni meteorologiche di stampo autunnale, dall inizio della seconda decade di febbraio il quadro sinottico è cambiato drasticamente in favore di situazioni
Dopo un lungo periodo caratterizzato da situazioni meteorologiche di stampo autunnale, dall inizio della seconda decade di febbraio il quadro sinottico è cambiato drasticamente in favore di situazioni
RICERCA TOPOGRAFICA SUL SISTEMA INSEDIATIVO DEL NEOLITICO ANTICO IN UNA MICRO AREA DELLA DAUNIA SETTENTRIONALE
 Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 94 (1987) pagg. 203 210, figg. 2 A. GRAVINA RICERCA TOPOGRAFICA SUL SISTEMA INSEDIATIVO DEL NEOLITICO ANTICO IN UNA MICRO AREA DELLA DAUNIA SETTENTRIONALE Riassunto
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 94 (1987) pagg. 203 210, figg. 2 A. GRAVINA RICERCA TOPOGRAFICA SUL SISTEMA INSEDIATIVO DEL NEOLITICO ANTICO IN UNA MICRO AREA DELLA DAUNIA SETTENTRIONALE Riassunto
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2011 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ARMANDO GRAVINA* Il
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ARMANDO GRAVINA* Il
CONVEGNO NAZIONALE. Archeoclub di San Severo PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011
 Archeoclub di San Severo Movimento di opinione al servizio dei beni culturali ed ambientali CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011 Col patrocinio dell Amministrazione
Archeoclub di San Severo Movimento di opinione al servizio dei beni culturali ed ambientali CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011 Col patrocinio dell Amministrazione
