Roma non aveva un esercito, Roma era un esercito Talcott Parsons elenarovelli 1
|
|
|
- Beatrice Carboni
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Roma non aveva un esercito, Roma era un esercito Talcott Parsons elenarovelli 1
2 L esercito e la flotta elenarovelli 2 Percorso tematico e lessicale
3 L esercito (exercitus, -i i ; copiae, -arum) Ascolta il testo elenarovelli 3
4 La storia Durante la monarchia l esercito è formato dai membri delle gentes (grandi famiglie) e dai loro clienti Su tali aristocratici il re esercitava autorità limitata Gli scontri si risolvevano in duelli individuali elenarovelli 4
5 V IV secolo a. C. Con l inserimento nell esercito dei PLEBEI si forma la LEGIONE, modellata sulla falange oplitica greca. note elenarovelli 5
6 Formata dai cittadini tra i 17 e i 45 anni, che si equipaggiavano a proprie spese: i ricchi militavano nella cavalleria e nella fanteria pesante; i poveri nella fanteria leggera, dall armamento meno costoso. La leva era organizzata in base a 5 classi censitarie (istituite da Servio Tullio): I più ricchi della 1^ classe costituivano le 18 centurie (1800 uomini) della cavalleria ma con cavalli a carico dello Stato I membri delle prime 3 classi costituivano le 60 centurie (6000 uomini) della fanteria pesante Le ultime due classi formavano 25 centurie (2500 uomini) di fanteria leggera. La 2^ e la 5^ classe fornivano anche 5 centurie di carpentieri (fabri) e suonatori di strumenti a fiato (bucinatores, tubicines). I cittadini tra i 45 e i 60 restavano a disposizione per la leva. Quelli con un reddito inferiore agli assi erano riuniti in un'unica classe e venivano esentati dal servizio militare. Composizione delle legioni serviane elenarovelli 6
7 L'ordinamento della legione serviana aveva per base la decuria e la centuria, mentre la cavalleria era divisa in turme (tre decurie), per un totale di 300 cavalieri. La formazione era di 3000 uomini su sei righe di profondità e 500 file di fronte, che si muoveva all'unisono contro il nemico, preceduta dai veliti. elenarovelli 7
8 La fanteria leggera (expediti, -orum) Nello schieramento di battaglia (acies, -ei) il primo contatto con il nemico era affidato alla fanteria leggera, costituita da Vèliti (velites, -um) > armati di giavellotto (pilum, -i) e spada corta a doppio taglio per il corpo a corpo (gladius, -ii) che provocavano il nemico con rapide incursioni e si ritiravano Arcieri (sagittarii, -orum) > armati di arcus, -i per il lancio di frecce (sagittae, -arum) in legno con punta in ferro spesso avvelenata Frombolieri (funditores, -um) > i più abili erano Balearici e con la fionda scagliavano sassi di una libbra (mezzo chilo circa) o glandae, -arum (grosse biglie di piombo)
9 La cavalleria (equitatus( equitatus, us) L unità della cavalleria è l ala, -ae, divisa in squadroni di 32 cavalieri ciascuno (turma, -ae). In Gallia la cavalleria di Cesare è in gran parte di Galli alleati e varia continuamente di numero. elenarovelli 9
10 Ai veliti erano affiancati i cavalieri (equites) Armati di spada e lancia, agivano sulle ali dello schieramento (cornu, -us) e, grazie alla loro mobilità, accorrevano dove la necessità lo richiedeva. elenarovelli 10
11 Un'ulteriore suddivisione fra juniores e seniores intervenne probabilmente solo più tardi: i primi formavano l'esercito di linea mentre i secondi, uomini tra i 45 ed i 60 anni, costituivano i reparti dell'esercito di riserva. Questo tipo di formazione aveva indubbi vantaggi: era un complesso monolitico difficilmente arrestabile, una volta in movimento, ma anche evidenti difetti: mancava di flessibilità e di manovrabilità e in seguito come formazione tattica fu abbandonata. elenarovelli 11
12 Nacque allora il manipolo per avere reparti più manovrabili e capaci di agire con più elasticità. I 10 manipoli degli hastati si ponevano in prima linea, quindi seguivano 10 manipoli di principes e altrettanti manipoli di triarii: Manipolo di hastati e principes = 120 uomini manipolo di triarii = 60 uomini la cavalleria rimaneva divisa in decurie e turme. La fanteria leggera, i velites, non era inquadrata in unità organiche ma poteva combattere sia autonomamente sia frammista ai reparti di fanteria pesante. In pratica la legione manipolare era formata da 1 centuria = 10 manipoli hastati = 1200 hastati 1 centuria = 10 manipoli principes = 1200 principes 1 centuria = 10 manipoli triarii = 600 triarii 1200 velites 1 decuria = 10 turmae equites = 300 equites note elenarovelli 12
13 Ufficiali della legione manipolare Il supremo potere militare (imperium militiae) era detenuto da consoli, pretori dittatore, quest'ultimo con un comandante in seconda, il magister equitum.
14 Fra gli ufficiali la legione annoverava 6 tribuni militum 1 di rango senatorio, detto laticlavius, dall'ampia striscia di porpora (clavus) che orlava la sua tunica 5 di rango equestre, detti angusticlavi. Essi in coppia comandavano la legione per due mesi, tenendo il comando un giorno o un mese per uno. legati: ufficiali aggiunti, nominati dal Senato in seguito alle proposte del comandante. elenarovelli 14
15 60 centuriones: comandanti delle centurie, nominati dai tribuni e provenienti dalle truppe, erano ufficiali subalterni (duces minores). Ogni manipolo ne contava due: il centurione che comandava la centuria di destra, centurio prior, che comandava tutto il manipolo e quindi aveva ai suoi ordini il centurione della centuria di sinistra, centurio posterior. Gli hastati erano agli ordini di 10 centuriones priores e 10 centuriones posteriores, e così i principes ed i triarii. Il grado più elevato fra i centuriones priores era tenuto dal centurione del primo manipolo dei triarii, detto primus pilus. 60 optiones: comandanti in seconda della centuria. 30 decuriones: in ogni turma di 30 cavalieri c'erano 3 decurioni, al comando del più anziano. 12 praefecti alae: alti ufficiali romani, 6 per ciascuna delle due alae, a cui erano aggregati i contingenti degli alleati, inquadrati in cohortes di fanteria e in turmae di cavalleria. elenarovelli 15
16 manipulus elenarovelli 16
17 La legione era scaglionata su tre linee di fanteria pesante (peditatus, -us) Esse entravano in battaglia una dopo l altra: 1. I più giovani muniti di asta (hastati)* 2. I meglio addestrati e armati (principes) 3. I veterani, utilizzati solo in caso di bisogno (triarii). * dapprima armati di asta lunga = hasta, la sostituirono poi col pilum = giavellotto leggero con punta in ferro.
18 Schieramento Dal retro elenarovelli 18
19 Durante la battaglia, i veliti, disposti in modo casuale davanti alla Legione, attaccavano con armi da lancio (B) e lasciavano poi il posto alla fanteria pesante. Toccava per primi agli hastati affrontare l'urto corpo a corpo con l'esercito avversario(c). Se il nemico opponeva resistenza oppure la pressione era troppo forte, i manipoli dei principes avanzavano (D) disponendosi negli intervalli tra le file degli astati, formando cosi' una linea continua. Se la lotta continuava con esito incerto, avanzavano in ultimo i triarii, più forti e sperimentati (E). Fasi della battaglia elenarovelli 19
20 La forza di un'unità legionaria era di circa 4200 fanti e 300 cavalieri, ma poteva essere incrementata fino a raggiungere le 6000 unità. Con legioni così composte Roma conquistò l'italia. Il loro numero usuale era di 2 (ciascuna agli ordini di un console). Dalle 2 dell'esercito consolare si passò a 4 legioni (2 per console) nella guerra sannitica. Solo nella II guerra punica contro Annibale il numero di legioni salì eccezionalmente a 27. elenarovelli 20
21 PRIMA L esercito non era permanente e veniva mobilitato solo in caso di guerra, poi congedato. IN SEGUITO ALL ESPANSIONE DI ROMA L esercito divenne stabile, con soldati di professione, in parte dislocato ai confini. Nel I sec. a.c. il console Caio Mario riformò l'ordinamento delle Legioni, abolendo il vecchio sistema di reclutamento in base al censo e arruolando tutti i cittadini romani volontari (anche italici) con le qualità fisiche necessarie. Da questo momento l'esercito divenne un mestiere. Le Legioni furono rinforzate e disposte su due file, formate da 10 coorti schierate a scacchiera e composte ciascuna di 600 uomini (formata dall unione di 3 manipoli, uno di hastati, uno di principes, uno di triarii, portati ciascuno a 200 uomini), per un totale di Sparivano inoltre i veliti, sostituiti dalle truppe ausiliarie. note elenarovelli 21
22 Auxilia, -orum Truppe fornite dagli alleati delle province e ripartite in cohortes o turmae di cavalleria, indicate in genere con il nome della popolazione d origine. Al congedo, gli ausiliari ottenevano la cittadinanza romana. note elenarovelli 22
23 Costituzione della legione di Mario (in 10 coorti) comprende fino a 6000 fanti e 300 cavalieri COORTE (cohors, -ortis = decima parte della legione, divisa in tre manipoli) MANIPOLO (manipulus, -i = terza parte di una coorte, composto da due centurie) CENTURIA (centuria, ae = cento soldati) DECURIA (decuria, ae = gruppo di dieci cavalieri) elenarovelli 23
24 Schieramento delle coorti La legione coortale di Mario si schierava su due linee di coorti, a scacchiera. Cesare portò le coorti su tre linee (quattro in prima linea e tre in seconda e terza linea queste ultime utilizzate anche come riserve -) elenarovelli 24
25 Con Cesare la legione oscilla da 3000 a 6000 uomini, raccolti con leve o volontari, con una ferma militare che può giungere a 20 anni. All inizio della campagna Cesare ha 5 legioni, alla fine 10. Dai tempi di Mario, il legionario non è più il cittadino che difende in armi la patria, ma una figura professionale regolarmente stipendiata; con Cesare lo stipendium, -ii (escludendo i premi concessi dal comandante o le quote del bottino di guerra) si aggirava sui 500 sesterzi annui, pari a 125 denari d argento (1 denario = 4 sesterzi). Il costo annuo per il mantenimento di una legione ammontava, solo per gli stipendia, a circa denari, cioè oltre tre milioni di sesterzi, cifra assai considerevole. elenarovelli 25
26 Come è formata la legione di Cesare? E composta di 10 coorti, ciascuna suddivisa in 3 manipoli, ognuno dei quali formato da 2 centurie, comandate da altrettanti centurioni. Ogni legione ha 60 ufficiali di truppa con il grado di centurione, 6 per coorte (il grado più basso è quello di centurione della II centuria del III manipolo della X coorte; il più alto quello di centurione della I centuria del I manipolo della I coorte > primipilus). A capo della legione, al posto dei tribuni militari nominati con regolari elezioni popolari, nella campagna di Gallia Cesare pone dei legati (=delegati) nominati da lui che gli rispondono direttamente. elenarovelli 26
27 Legione imperiale note Con Ottaviano Augusto la legione aumenta i suoi effettivi fino a soldati, di cui 120 cavalieri. E divisa in 10 coorti, costituite da 3 manipoli oppure 6 centurie. La prima coorte ha 5 centurie anziché 6, ma con il doppio di soldati per centuria. La centuria viene ridotta a 80 uomini invece dei 100 dell'epoca repubblicana. Gli ufficiali della legione imperiale sono, partendo dal basso: 59 centurioni, di cui il più alto in grado era chiamato primipilaris; 1 tribuno al comando della cavalleria, il sexmenstris, in carica 6 mesi; 5 tribuni augusticlavii, di ordine equestre, ciascuno al comando di 2 coorti; 1 prefetto del campo; 1 tribuno laticlavio dell'aristocrazia senatoria; 1 legato di legione a cui era affidato il comando della legione: nel caso di più legioni in una stessa provincia vi era un legato d'armata che comandava i legati di legione. elenarovelli 27
28 Legione tardoimperiale Col passare degli anni i legionari da italici diventano sempre più provinciali e anche gli ufficiali vengono dai territori d'oltralpe; con Settimio Severo i legionari possono sposarsi; con Gallieno i cavalieri da 120 per legione passano a 750 e la legione non è comandata da Legati di rango senatorio ma da Prefetti di rango equestre. Dopo la riforma di Costantino I, l'esercito romano si divide in Domestici, Scholae, Vexillationes, Auxilia, Legiones (legioni): questi ultimi tre corpi si distinguono in Palatina e Comitatensis. La consistenza delle legioni si riduce a 1500 uomini, indebolendone così l'organismo. La legione diventa un unità come tante senza più l'importanza di un tempo. elenarovelli 28
29 Esercito in marcia (agmen, -minis) con truppe schierate in quadrato (agmen quadratum) elenarovelli 29
30 FORMAZIONI PRINCIPALI (di epoca imperiale) Agmen, -minis (colonna, o quadrato): era la principale formazione delle centurie, e quella con la quale si schieravano in battaglia; generalmente il quadratum o agmine era composto da 5 file ravvicinate di uomini composte da due contuberne ciascuna in tal modo risultava facile allargare e restringere i ranghi oppure aprirli per il passaggio di altre truppe facendo "scivolare" gli uomini delle colonne dispari dietro agli uomini di quelle pari. Finis, -is (riga):era uno schieramento formato da poche linee di soldati, di solito usato dagli ausiliari della cavalleria, e talvolta dai legionari durante l'attacco. elenarovelli 30
31 Testudo, -inis Formazione d attacco in cui i soldati univano gli scudi sopra la testa, simili a un guscio di tartaruga, formando un tetto per ripararsi dai proiettili. note elenarovelli 31
32 Moenia, -ium Formazione a muro di scudi, così chiamata perché è in effetti una "parete umana, era utilizzata per contrastare attacchi con la cavalleria e con i carri. Si formava facendo abbassare i legionari della prima fila, con i pila inclinati in avanti e posati con la parte posteriore a terra, e facendo avvicinare quelli della seconda fila a quelli della prima con gli scudi alzati e i pila inclinati in avanti. elenarovelli 32
33 Cuneum, -i Il cuneo è una formazione d'attacco impiegata dai legionari o dalla cavalleria per sfondare e oltrepassare uno schieramento avversario. Consisteva nel fare disporre i soldati o gli equites in modo da realizzare una figura triangolare, che si scagliava con la punta rivolta verso i nemici come se fosse un tutt'uno. La particolarità di questo schieramento non stava tanto nella capacità di combattimento, quanto nella forza d'urto impressa da quest' ultima verso l' unità nemica. elenarovelli 33
34 Orbiter Usato nel caso in cui alcuni milites si ritrovassero isolati dalle altre truppe e circondati dai nemici. In tal caso si formava un cerchio con i legionari posti nella prima fila, e gli altri soldati, se presenti, al centro. Questa formazione permetteva una facile difesa, quasi si fosse dietro alle mura di una fortezza umana, e permetteva di attendere il soccorso delle altre truppe che, con l'efficiente sistema di comunicazioni, non avrebbero tardato ad arrivare. elenarovelli 34
35 Legio, -onis elenarovelli 35
36 Le legioni più importanti VI Victrix XX Valeria Victrix II Augusta XXX Ulpia I Minerva XXII Primigenia VIII Augusta III Italica II Italica X Gemina XIV Gemina I e II Adiutrix IV Flavia e VII Macedonica Claudia VMacedonica XIII Gemini I Italica XI Claudia XV Apollinaris XII Fulminata IParthia II Parthia IV Italica IV Scythia XVI Flavia Firma III Gallica XFretensis VI Ferrata III Cyrenaica II Traiana III Augusta VII Gemina elenarovelli 36 note
37 Insegna della legione (aquila, -ae) E un aquila d oro portata dall alfiere della I centuria della I coorte, che ha sulle spalle una pelle d orso (aquilifer, -i) elenarovelli 37
38 elenarovelli 38
39 NOME DELLE LEGIONI E SIMBOLI Ogni legione era contraddistinta da un numero, un nome e un simbolo zoomorfo. Es.: XXX Legio Ulpia Traiana Victrix, dove XXX è il numero dell'unità, Ulpia Traiana è il nome, Victrix è un attributo dato dall'imperatore. La legione prendeva il nome o dall'imperatore che l'aveva istituita, oppure dal luogo nel quale prestava servizio. Il numero la distingueva da altre legioni con lo stesso nome. Il simbolo zoomorfo, riportato sul vessillo, era un animale dello zodiaco. 39
40 Le insegne della legione più importanti sono Aquila e vexillum, venerati dai soldati L'Aquila, donata dal Senato o dall'imperatore quando la legione veniva costituita, era formata da un'asta di legno, con in cima l'aquila Imperiale dorata, su cui venivano poi affisse le phalerae= riconoscimenti al valore militare della Legione. Il vexillum era composto da un drappo rosso e quadrato fissato ad una traversa elegato ad una picca. Sul drappo erano ricamati in oro nome, numero dell'unità e simbolo zoomorfo. Ogni coorte era numerata da uno a dieci e talvolta aveva anche un nome; i manipoli erano numerati da uno a tre per ogni coorte; le centurie erano distinte dal numero uno o due e dal nome del centurione. Un soldato doveva quindi ricordarsi queste informazione per cercare il suo posto, per esempio: Legio IV Italica, III cohortis Mediolana, I Manipolus, Caenturia secunda. Inoltre le coorti e i manipoli avevano un vessillo detto signum. 40
41 Vexillum, -i Affidato a un vexillarius, è lo stendardo, o bandiera, utilizzato anche per segnalazioni (insieme ad altre bandiere minori). elenarovelli 41
42 Signum, -i Portato dal signifer, era l insegna della coorte o del manipolo, a forma di animale o di mano. Indicava il cammino da seguire nella marcia o in battaglia. elenarovelli 42
43 Insegne elenarovelli 43
44 Segnali sonori I soldati dovevano obbedire alla voce dei loro superiori, ma anche agli squilli di tromba, che indicavano la sveglia e il cambio della guardia, ma servivano soprattutto per la tattica. In battaglia venivano utilizzati tre strumenti: La tromba diritta (tuba, -ae) destinata a tutti gli uomini, ai quali dava il segnale dell'assalto o quello della ritirata, come pure della partenza dal campo; Il corno (cornu, -us) cioè una tuba ricurva e rinforzata da una barra metallica, che in battaglia suonava per i portatori di signa. La tromba corta e leggermente arcuata (bucina, -ae). Normalmente, trombe e corni suonavano insieme per avvertire che si doveva avanzare verso il nemico, ma ogni istante della battaglia era segnalato e cadenzato da particolari squilli, che organizzavano gli spostamenti e i movimenti sul campo delle truppe e l'avvicendarsi dei manipoli, lo spostamento della cavalleria, l'attacco dei veliti o dell'artiglieria ecc. cornicifer elenarovelli 44
45 Comandanti (dux, ducis) e soldati (miles, militis) Il comando (imperium militiae) era affidato a un console (consul, -is), oppure al dittatore (dictator, -oris), affiancato dal comandante della cavalleria (magister, -i equitum o praefectus, -i equitum); In età imperiale sarà il principe ad avere il comando supremo, esercitato per mezzo di delegati, i legati Augusti, di rango e grado diverso in base all'importanza del dislocamento della legione. Ascolta il testo Ascolta il testo Ascolta il testo elenarovelli 45
46 Il dux poteva essere anche un alto magistrato (pretore, propretore, proconsole ) con poteri propri di un comandante in capo (cum imperio). Il dux veniva proclamato dai soldati imperator a seguito di una vittoria decisiva. elenarovelli 46
47 Alti ufficiali erano i sei tribuni militari (tribunus, -i militum) e i luogotenenti (legatus, -i), che potevano sostituire il dux nel comando. elenarovelli 47
48 centurione A capo delle centurie stavano 60 centurioni (centurio, -onis), scelti dai tribuni; quello di grado più alto comandava la I centuria del I manipolo della I coorte (primipilus, -i). Di provata abilità, vivevano a contatto con i soldati di cui curavano l addestramento. Sottufficiali assistenti dei centurioni e addetti alle attrezzature e alle munizioni necessarie alla centuria erano gli optiones A capo delle decurie stavano 30 decurioni (decurio, -onis); Dieci ufficiali erano preposti a ciascuna delle due alae dell esercito schierato (praefectus, -i alae) elenarovelli 48
49 Altri ufficiali Praefectus equitum = comandante della cavalleria; Praefectus fabrum = comandante dei genieri (fabri); Praefectus sociorum = ufficiale delle truppe alleate elenarovelli 49
50 vi erano poi I trombettieri (bucinator, -oris, tibicen, - inis) I suonatori di corno (cornicen, cornicinis o cornicifer) I portatori delle insegne della coorte o del manipolo (signifer, -i) Il portatore del vexillum = insegna della cavalleria (vexillarius, -ii) I portabagagli (calones, -um), addetti al trasporto delle salmerie (impedimenta, - orum) L amministratore della cassa dell esercito (quaestor, -oris) Le spie (speculator, -oris) Le sentinelle (vigiliae, -arum; excubiae, - arum; excubitor, -oris) Bucina, ae= tromba per il segnale d attacco e per il cambio delle sentinelle di notte; Classicum, -i = squillo di tromba; Tuba, -ae = tromba della fanteria; Lituus, -i = tromba ricurva della cavalleria
51 La disciplina Era assai rigida e imposta con pene severe, come la decapitazione. In caso di colpa collettiva si ricorreva alla decimazione, giustiziando un soldato ogni dieci, estratto a sorte dal gruppo colpevole. elenarovelli 51
52 Tutti i soldati venivano addestrati in modo omogeneo elenarovelli 52
53 Le decorazioni Si aggiungevano alla distribuzione tra i soldati del bottino di guerra. L armilla (= bracciale) e la torquis, -is (= collana) venivano donate ai soldati come ricompense minori. La corona era un premio al valore. Poteva essere Corona triumphalis (d oro), con cui si incoronava il generale vittorioso nel trionfo; Corona obsidionalis, donata al generale liberatore da coloro che venivano liberati dall assedio; Corona muralis (d oro), assegnata al soldato che per primo aveva scalato le mura della città attaccata; Corona civica, data al cittadino romano salvatore di un altro civis in battaglia; Corona castrensis, donata dal comandante a chi per primo entrava combattendo nell accampamento nemico; Corona vallaris (d oro con fregi a forma di palizzata), conferita a chi per primo superava il vallo di un accampamento nemico; Corona navalis o rostrata, donata a chi in battaglia navale balzava per primo sulla nave nemica. elenarovelli 53
54 Bracciali e fibbie elenarovelli 54
55 Il trionfo (triumphus, -i) Il comandante celebrava la vittoria con il trionfo, solenne parata (= pompa, ae) dell esercito lungo le vie di Roma, sotto gli archi di trionfo, fino al tempio di Giove sul Campidoglio. Il comandante vittorioso, oltre alla corona triumphalis, indossava la toga picta (toga ricamata d oro) e la tunica palmata (tunica ornata di palme). Tali elementi, insieme al carro trionfale, alla ghirlanda di alloro e allo scettro d avorio costituivano gli ornamenti del trionfo (triumphalia, - orum). elenarovelli 55
56 Il corteo esponeva una rappresentanza dei prigionieri catturati e le spoglie opìme (spolia, -orum opima), tolte al comandante nemico abbattuto in duello. Il senato decretava al generale vittorioso un solenne rendimento di grazie (supplicatio, -onis) Una forma di trionfo meno solenne era l ovazione (ovatio, -onis), durante la quale si sacrificavano pecore (oves)
57 elenarovelli 57
58 Figure della legione elenarovelli 58
59 elenarovelli 59
60 Il legionario E un fante pesantemente armato, addestrato a marciare per ore, carico di bagaglio, su qualunque terreno, a combattere in linea e nel corpo a corpo, nonché a realizzare lavori di carpenteria, falegnameria ed edilizia che andavano dalla fortificazione dell accampamento, alla costruzione di ponti, alla posa in opera di strade. note elenarovelli 60
61 Legionario della Repubblica
62 elenarovelli 62
63 Legionario dell Impero
64 Stipendi e liquidazione Dai 500 sesterzi annui di epoca cesariana il legionario passa ad uno stipendio pari a 900 sesterzi in epoca imperiale. con sesterzi si poteva acquistare uno Jugero di terra da vigneto (jugero = mq) Quando il legionario raggiungeva il termine della carriera riceveva una liquidazione consistente in una centuria di terra (misura agraria pari a 200 jugeri = mq.) elenarovelli 64
65 L equipaggiamentobase del legionario Ocreae In bronzo
66 Caligae, -arum Sandali di cuoio con borchie di metallo nella suola elenarovelli 66
67 Calzature militari semichiuse (Museo di Leiden) elenarovelli 67
68 Sarcina, -ae = bagaglio personale elenarovelli 68
69 Il mantello Sagum, -i = mantello militare Paludamentum, -i = mantello da generale, bianco o purpureo, indossato in battaglia
70 Le armi difensive (arma, -orum) elenarovelli 70
71 Parma, -ae I primi scudi latini furono rotondi = parma (su modello di quelli etruschi e greci), poi sostituiti da quelli ovali e rettangolari. Nel tardo Impero si tornò allo scudo tondo, più adatto alle reclute barbare, portate a tecniche individuali molto più che a studiate manovre collettive. Clypeus (scudo rotondo o ovale, convesso) Gli scudi ovali, di dimensioni maggiori,vennero adottati dopo i contatti con i Galli. Furono sempre preferiti dalla cavalleria. Scudi della cavalleria Scudi della fanteria ausiliaria
72 Scutum, -i Scudo rettangolare, convesso, in legno, rivestito di pelle di bue, orlato di ferro, rafforzato al centro da una spina, - ae verticale lignea e da una piastra metallica (umbo, -onis) che serviva a deviare le frecce. Fu adottato dopo la riforma di Mario e mantenuto per tutta la storia di Roma. Altezza m elenarovelli 72
73 L altezza dello scutum era quella di un uomo fino alle spalle; grazie ad esso il legionario poteva spingere sul nemico per attaccare al di sotto. I materiali, non rigidi, erano abbastanza resistenti da sopportare gli urti. Scudi delle Legioni (dai bassorilievi della Colonna Traiana) elenarovelli 73
74 Galea, -ae Elmo in cuoio o in pelle, con due fasce laterali (bucculae, -arum) di cuoio e scaglie di bronzo, legate sotto il mento, utili alla protezione delle guance. Cassis, -is Elmo con paraguance interamente di metallo, quello degli ufficiali con pennacchio (crista, -ae o iuba, -ae) elenarovelli 74
75 elenarovelli 75
76 Tipi di elmo elenarovelli 76
77 Armatura o corazza in cuoio e piastre di metallo, per la protezione di spalle e torace Lorica, -ae - Pettorale con phalerae, -arum Phalerae = borchie metalliche usate come decorazioni militari
78 Lorica hamata Protezione in maglia di ferro lunga fino alla coscia; al di sotto veniva indossata una tunica, - ae di lino o lana elenarovelli 78
79 Feminalia o bracae pantaloni aderenti in spesso cuoio di vitello,indossati sotto la tunica; proteggono dal freddo e dalle lacerazioni dovute alla tecnica di accosciata nel combattimento in cui il legionario striscia con le ginocchia e alla frizione contro il suolo o parti di legno nei lavori di fortificazione e assalto elenarovelli 79
80 Armi da offesa (tela, -orum) elenarovelli 80
81 ARMI DA LANCIO E DA PUNTA Hasta, -ae Asta di legno da fianco impossibile da lanciare -, con punta in ferro (cuspis) a doppio taglio; dopo la riforma di Mario venne sostituita dal pilum. elenarovelli 81
82 Pilum, -i Arma da lancio di circa 2 metri, il cosiddetto giavellotto, di origine sannitica, in legno ma con puntale in ferro dolce a sezione quadrata. Aveva una gittata di 25m.; poteva arrivare a 60 m. se scagliato mediante una striscia di cuoio (amentum, -i). Pesava circa 2 Kg e in genere superava i due metri di lunghezza. Il lancio in corsa dei pila precedeva il corpo a corpo con lo scopo di scompaginare le file del nemico, provocando il più alto numero possibile di perdite All impatto la punta si piegava rendendone impossibile il riutilizzo da parte del nemico. Poteva trapassare uno scudo e anche l uomo che vi si riparava dietro; era difficile svellerlo (gli Elvezi dovettero abbandonare gli scudi colpiti dai soldati di Cesare).
83 Lancea Era una lancia da fianco che rimpiazzò il pilum nel III sec. d.c. Verutum Giavellotto di ferro, sottile e leggero, in dotazione ai veliti. Iaculum Giavellotto corto con punta tricuspidata Tragula Lancia molto lunga, impiegata dai cavalieri elenarovelli 83
84 Plumbatae o mattiobarbuli Proiettili in piombo in dotazione ai veliti, da scagliare con le fionde (fundae, -arum)oppure a mano; era costoso produrli, ma incrementarono la capacità offensiva della fanteria.
85 Sagittae, -arum Punte di frecce dal museo di Xanten elenarovelli 85
86 ARMI DA PUGNO E DA TAGLIO Gladius, -ii Spada corta (70 cm.) a doppio taglio, su modello delle spade dei Celti Hispanici. Secondo Polibio fu introdotto durante la II Guerra Punica. Era studiato per un attacco di punta: nel corpo a corpo si doveva respingere il nemico con lo scutum, sollevarlo inginocchiandosi e colpire l arteria femorale, lasciando il nemico caduto da finire alle file seguenti. elenarovelli 86
87 Il gladio veniva portato in un fodero di legno appeso al balteus o al cingulus L ensis, -is era una spada più lunga e sottile, a doppio taglio elenarovelli 87
88 Balteus, -i Bandoliera in cuoio con placche metalliche a cui appendere il gladio (va dal lato sinistro del collo al fianco destro per i soldati al fianco sinistro per gli ufficiali - che non portavano lo scudo) Compare solo in epoca imperiale, abbinato al focale, una sciarpa destinata a evitare le lacerazioni della cinghia sul collo nelle azioni di trattenimento. elenarovelli 88
89 Cingulus, i Cintura alla vita per appendere il gladio in età repubblicana elenarovelli 89
90 Pugio, -onis A partire dal II secolo a.c. i legionari portavano al fianco destro il pugio, una piccola daga. Dopo Augusto il suo utilizzo andò scemando. elenarovelli 90
91 Spatha, -ae A doppio taglio, larga e piatta, arma della cavalleria Essendo più lunga ( cm.) permetteva di colpire di fendente, unico colpo possibile a cavallo. In epoca classica era di ferro e facilmente si piegava nelle collisioni con altre lame o scudi, perciò si usava per colpire il bersaglio ma non per parare (funzione dello scutum) elenarovelli 91
92 Dolabra, -ae Incrocio fra ascia e piccone. Non un arma, ma uno strumento che veniva utilizzato per la costruzione degli accampamenti. Ricorda le pale pieghevoli in dotazione agli eserciti odierni Permette di tagliare o smussare i pali, scavare il suolo, divellere massi elenarovelli 92
93 Poliorcetica ( =arte dell assedio) I Romani si servivano di MACCHINE DA GUERRA (dette tormenta, -orum, dal verbo torqueo, ēre = torcere, perché la spinta di lancio era ottenuta mediante la torsione di corde ) Servivano a espugnare con un attacco (oppugnatio) e a respingere le sortite (eruptiones) degli assediati.
94 MACCHINE DA OFFESA Macchine da lancio Macchinario atto a scagliare pietre, palle di piombo, grossi dardi con tiri quasi orizzontali elenarovelli 94
95 Ballista, -ae Balestra che lanciava pietre o giavellotti con traiettoria molto curva. Deriva dal greco ballizein = lanciare, da cui ballare elenarovelli 95
96 Ballista (particolari) elenarovelli 96
97 Varianti arcuballista, -ae scorpio onis (leggero, facilmente trasportabile e adatto a campagne di rapidi spostamenti. Ha due bracci articolati messi in tensione dagli avvolgimenti di cordame intrecciato, ottenuto con crine di cavallo o capelli di donna) Carroballista (macchina da artiglieria pesante su carro, di altissima potenza e precisione, che sfrutta la torsione di fasciami di crine di cavallo per ottenere il caricamento dei colpi. Può sparare sassi o dardi acuminati) elenarovelli 97
98 Onager/onagrus Catapulta leggera e agevolmente trasportabile, a forma di fionda per scagliare grosse pietre (simile all asino selvatico che scalcia e lancia dietro di sé sassi, cfr. Ammiano Marcellino, 23,4,4) Variante: carroballista, -ae elenarovelli 98
99 Onagro
100 Aries, -tis Trave larga e grossa che in punta ha una testa di ariete in ferro; veniva sospesa mediante catene a un impalcatura e fatta oscillare in modo da colpire o sfondare le porte o le mura della città assediata; In epoca arcaica l ariete era portato a mano dai soldati, poi fu inserito nelle macchine lignee a ruote, costituendo la testudo arietaria elenarovelli 100
101 Le ricostruzioni a sinistra mostrano due diversi modi di servirsi dell ariete (Roma, Museo della Civiltà Romana) elenarovelli 101
102 Turris, -is Le torri, a più piani, contenevano soldati e macchine d assedio Potevano essere mobili, scorrevoli su rulli (turris ambulatoria): da esse si potevano osservare i movimenti dei nemici e si lanciavano ponteggi in legno su cui far passare i soldati sulle mura della città assediata. Ricoperta di ferro è detta eliopoli elenarovelli 102
103 Altre macchine da guerra Falarica, -ae : proiettile lanciato di solito dalle torri da assedio. Era di due tipi: uno scagliato a mano (Livio, 34,14,1) uno maggiore, avvolto di stoppa, pece o altri materiali infiammabili, lanciato da una catapulta; Terebra, -ae : trivella per forare le mura; Tolleno, -onis : macchina con funzioni analoghe a quelle delle moderne gru, consistente in un altalena che aveva a un estremità un cassone entro cui si piazzavano i soldati, che venivano sollevati fin sopra le mura della città assediata, per esservi poi calati all interno. elenarovelli 103
104 MACCHINE DA DIFESA Vinea, -ae (LETT. PERGOLATO) baracca in legno con tetto inclinato, mobile, riparata sui lati da graticci di vimini e ricoperta di pelli fresche e coperte bagnate per evitare che potesse essere incendiata; al suo interno i soldati manovravano al coperto arieti e altre macchine da guerra. Testudo, -inis Galleria su ruote, ricoperta di pelli fresche non conciate Musculus, -i (LETT. TOPOLINO) Macchina montata su ruote, una sorta di gabbia coperta usata per avvicinarsi alle mura della città assediata riparandosi dal lancio di pietre o proiettili elenarovelli 104
105 Pluteus, -ei Paravento di legno ricoperto di pelli che proteggeva dai proiettili i soldati assedianti. elenarovelli 105
106
107 FORTIFICAZIONI elenarovelli 107
108 Castra, - orum elenarovelli 108
109 Opere di difesa intorno all accampamento o alle fortificazioni 1. Un fossato (fovea, -ae) largo 5 m. e profondo 3 m.; 2. Un terrapieno formato con terreno di riporto (agger, -eris); 3. Una palizzata (vallum, -i), di 4 m. in Cesare (B.G.7,72,5), che poteva essere provvista di Parapetti (loricae, -arum) Merli (pinnae, -arum) Tronchi con rami sporgenti (cervi, -orum) Torri e fortini (castella, -orum) elenarovelli 109
110 elenarovelli 110
111 Fortificazione a doppio anello posta da Cesare intorno ad Alesia elenarovelli 111
112 Cervi
113 Castella, vallum con pinnae, agger con cervi, fovea, cervi
114 elenarovelli 114
115 Fossa tranello a imbuto contenente un palo grosso come una coscia, appuntito e bruciato all estremità (lilium) che sporgeva dal suolo 4 dita e vi era conficcato per un piede (m.0,296), mimetizzato con vimini e frasche.
116 Tranelli Per evitare sortite da parte degli assediati, gli assedianti difendevano le loro fortificazioni con pali aguzzi (cippi, -orum) fosse-tranello (lilia, -orum) pioli con uncini di ferro conficcati nel terreno (stimuli, -orum) > cfr. Cesare, B.G., 7,73 elenarovelli 116
117 entriamo nell accampamento elenarovelli 117
118 Si doveva scegliere il luogo, tracciare la pianta, di forma quadrata (secondo lo storico greco Polibio, 6, 27 36; III sec. A.C) o rettangolare ( secondo Igino, Le fortificazioni dell accampamento, 32 44, III sec. D. C.), ripulire il terreno da ogni ostacolo (castra metari). elenarovelli 118
119 Se serviva per una sola notte il campo era detto castra, se per più giorni castra stativa, distinto in aestiva (con tende) e hiberna (con baracche di legno o costruzioni in muratura). elenarovelli 119
120 Per l accampamento era preferibile un suolo in pendenza, che favoriva l'evacuazione delle acque, l'aerazione, e rendeva più agevole l'uscita di fronte a eventuali assalitori. Doveva esserci acqua in quantità sufficiente per sostenere un assedio. Era necessario che la posizione fosse difendibile: per esempio, che non fosse dominata da un'altura da dove il nemico poteva facilmente lanciare giavellotti, frecce e pietre sulla guarnigione. Una volta che il terreno era stato spianato, un agrimensore, a partire dal centro del campo, usando uno strumento chiamato groma, -ae, disegnava la dislocazione delle vie e del muro (sembra si chiamasse groma anche il punto centrale del campo). elenarovelli 120
121 elenarovelli 121
122 Tracciati i perimetri e le vie principali, si scavava il fossato (fossa), con sezione a V. elenarovelli 122
123 elenarovelli 123
124 La terra di riporto veniva depositata verso l'interno e spianata, in maniera da creare un terrapieno, una specie di camminamento di ronda sopraelevato di circa 2 metri (agger), al di sopra del quale veniva costruita una palizzata di legno (vallum) o, più raramente, un muretto di terriccio, o di pietra, che poteva essere dotato di torri o bastioni (castella) sostenenti pezzi di artiglieria come scorpioni, catapulte e baliste. 124
125 elenarovelli 125
126 Internamente alla palizzata veniva lasciato uno spazio vuoto (intervallum) destinato a raccogliere frecce e giavellotti che eventualmente superavano il muro di cinta; questa zona aveva anche lo scopo di accelerare gli spostamenti all'interno della fortezza. Accuratamente rinforzati erano poi i quattro accessi del campo, poiché costituivano altrettanti punti deboli del muro. Venivano adottate due soluzioni: un piccolo ostacolo in parallelo col grande recinto e collocato sull'asse del passaggio (titulum) in maniera da infrangere lo slancio di un assalto; il muro veniva prolungato verso l'interno e verso l'esterno con due quarti di cerchio ("piccola chiave" o clauicula). elenarovelli 126
127 Strade e porte L accampamento era suddiviso in quattro settori da due arterie principali che si incrociavano ortogonalmente sfociando in quattro porte: Il decumanus maximus ( detto via decumana e, nel tratto finale, via praetoria) andava dalla porta decumana, sul lato posteriore, alla porta praetoria, aperta sul lato prospiciente il nemico; Il cardus maximus univa la porta principalis dextera alla porta principalis sinistra, aperte sui fianchi. Parallela al cardus maximus, sul retro, la via quintana (detta così perché attraversava gli attendamenti dei soldati disposti parallelamente lungo le vie perpendicolari alla via principalis, all altezza della quinta coorte) elenarovelli 127
128 Sulla via praetoria era situato il praetorium (= quartier generale del comandante, in origine praetor). Molto vicino si trovava l'auguratorium, dove venivano presi gli auspici. In prossimità era installata una tribuna (tribunal), da dove il comandante in capo amministrava la giustizia e pronunciava discorsi. Vi erano inoltre due spazi aperti: Forum (=piazza) Quaestorium ( sede dell ufficiale addetto agli approvvigionamenti, il quaestor). elenarovelli 128
129 Le vie delimitavano spazi rettangolari all'interno dei quali si installavano le tende; la più importante, quella del comandante (tabernaculum ducis), presentava gli stessi caratteri sacri di un tempio. Lungo la via principalis erano collocati i tabernacula degli ufficiali superiori (i tribuni militum e i praefecti); quelli dei centurioni erano invece parallele al lato posteriore dell accampamento. Gli alloggi per i soldati si trovavano lungo le vie perpendicolari alla via principalis. Gli auxilia e le truppe scelte alleate (extraordinarii) erano attendati nel settore anteriore dell accampamento. Vi erano poi le installazioni di uso collettivo: un laboratorio assicurava la riparazione delle armi danneggiate; un ospedale la cura degli uomini, un'infermeria quella degli animali. elenarovelli 129
130 elenarovelli 130
131 La sorveglianza era assicurata da guardie diurne e notturne; queste ultime (vigiliae) si davano il cambio ogni tre ore, dal tramonto all alba (primae, secundae, tertiae, quartae vigiliae). Posti di guardia fissi erano collocati elenarovelli davanti alle porte (stationes) e molte 131 sentinelle erano sull agger.
132 La tenda (tabernaculum, i per gli ufficiali, tentorium, -i per i soldati) elenarovelli
133 Esistevano tre tipi di tende all'interno dell'accampamento romano: 1. TENDA DEL LEGIONARIO (contubernium, ii) La tenda base del legionario, rimasta praticamente invariata durante la lunga storia dell'esercito romano, era progettata per ospitare al suo interno 8 legionari. Le sue dimensioni erano di 10 piedi di lato e 5 di altezza. Un piede era l'equivalente di 30 cm odierni. La figura del legionario in scala misura 165 cm. Un mulo trasportava un singolo Contubernium, i paletti per piantarlo al terreno, corde, due cesti utilizzati per scavare il fossato attorno al campo, gli strumenti per scavare, una piccola macina per il grano e del cibo supplementare. La tenda era assemblata sul campo ed era fatta di lino e rinforzata con cuoio nei punti delle legature.
134 Le tende erano collocate molto vicine tra loro fino ad incrociare letteralmente i paletti e le corde per sostenerle. In alcune ricostruzioni è possibile osservare delle tende con le armature e le armi posizionate all'esterno. Ciò doveva essere impossibile perché in caso di emergenza notturna i soldati avrebbero dovuto uscire per equipaggiarsi, inciampando tra i cavi. La presenza dei tiranti era invece un ottimo sistema per prevenire pericolose incursioni notturne da parte del nemico. elenarovelli 134
135 Il Contubernium, capace di contenere 8 soldati, veniva utilizzato da 9 o 10 persone. Sembra che 1/4 dei soldati alloggiati nella tenda dovessero rimanere all'erta, quindi solamente 6/8 soldati dormivano al suo interno. Alcuni autori affermano che le legioni, almeno dopo il cambiamento effettuato da Mario, avevano a disposizione un mulo per ogni tenda, addetto al trasporto della stessa e di altro materiale e che gli inservienti ai muli dividessero la tenda con i soldati, aumentando in questo caso il numero degli occupanti di un'unità. Il disegno mostra una tenda base da 10 piedi con 6 soldati posizionati lungo il fondo. Le figure supplementari sulla destra sono state inserite per dimostrare che si potevano creare al massimo 2 posti letto in più, poiché il resto del Contubernium doveva servire come deposito per le corazze e le armi. Era impossibile che un Contubernium potesse contenere 10 persone più le armi e l'abbigliamento, poichè la superficie interna era di 9 metri quadrati. L ipotesi più probabile era quindi che al suo interno vi fossero 6 soldati più 1 inserviente, le armi e corazze e che all'esterno 1 o 2 soldati fossero sempre di guardia, a turni alterni. elenarovelli 135
136 2. LA TENDA DEL GENERALE (praetorium, -ii) Il Generale, come tutti gli ufficiali superiori, aveva una tenda di dimensioni maggiori rispetto a quelle dei soldati e dei legionari. Mediamente la tenda misurava 12 piedi di lato, come pure la parte più alta al suo interno. I paletti dovevano essere trasportati da 2 muli. Una tenda di queste dimensioni poteva essere trasportata anche da un carro trainato da buoi. Il problema del carro però era la lentezza e il limite posto dal fatto che esso non poteva percorrere tutte le strade, soprattutto quelle più impervie, perciò si preferiva ripartire il carico su diversi muli. elenarovelli 136
137 3. LA TENDA DEL CENTURIONE Il Centurione aveva una propria tenda, espressione del rango, addirittura più grande del Contubernium poiché utilizzata anche come ufficio. Anch'essa aveva un lato di 10 piedi ma occupava più spazio poichè aveva un'altezza superiore e di conseguenza i tiranti dovevano essere più distanti. Vi erano anche più paletti: 2 al centro e 4 sui lati. La tenda del Centurione era trasportata da un mulo guidato da un inserviente, il quale era addetto anche alla cura personale dell'ufficiale. L'animale trasportava, oltre al cibo supplementare, anche l'equipaggiamento dell'ufficiale. elenarovelli 137
138 Da sinistra: Il primo mulo porta il contubernium, i cesti per lo scavo, i paletti, gli attrezzi; il secondo mulo porta la tenda del centurione; terzo e quarto mulo portano i paletti per la tenda del generale; quinto e sesto mulo portano la tenda del generale. elenarovelli 138
139 Pellame conciato per tenda militare elenarovelli 139
140 L'organizzazione estremamente complessa del campo, costruito ogni sera su un sito nuovo e smontato ogni mattina, presupponeva che ogni ufficiale dovesse sapere perfettamente quali erano le sue competenze, e ogni soldato conoscere molto bene i propri compiti in modo da non perdere tempo. Queste esigenze implicavano un reclutamento di qualità e un allenamento accurato. elenarovelli 140
141 Quando l accampamento diventa forte elenarovelli 141
142 Il limes Sotto Augusto era la fascia di terreno aperto attraverso la quale le truppe penetravano in zona nemica: era percepito come linea d attacco. Un secolo dopo, esaurita la spinta delle conquiste, le opere si fecero più salde e permanenti e il limes divenne un elemento caratteristico della geografia imperiale. Il limes non fu mai statico: veniva spostato nelle posizioni di volta in volta più idonee. elenarovelli 142
143 Il limes elenarovelli 143
144 Il limes Domiziano fissò una linea stabile di difesa dai bellicosi Germani: un confine lungo 550 km, munito di 221 torri di avvistamento e 49 castra. elenarovelli 144
145 Vallo di Adriano Fu edificato tra il 122 e il 128 d.c. in uno dei punti più stretti dell isola britannica. Era lungo oltre 100 km e per lunghi tratti si sviluppava su alture che facilitavano la difesa. Era munito di circa 400 torrette e di decine di fortini (alla distanza di un miglio circa l uno dall altro).
146 Il limes non divenne mai unicamente una compagine difensiva, nemmeno alla fine dell impero. Rappresentava una base operativa di sorveglianza dei territori al di là della frontiera ed era sede di un personale di guardia numericamente limitato che aveva funzioni militari e civili (segnalazione, polizia, dogana). elenarovelli 146
147 I terrapieni, i fossati e le palizzate non potevano contenere l assedio di un grande esercito: erano opere concepite a difesa dalle piccole incursioni o per far guadagnare tempo ai rinforzi in casi più gravi.
148 Lungo il limes si svilupparono villaggi e servizi di pubblica utilità. Quella che era nata come una linea di protezione dai barbari divenne anche una linea di contatto, spesso valicata dalle merci o dalla cultura. Scena di vita quotidiana: all esterno le foreste, accanto alla torre la porta attraverso la quale avvenivano gli scambi tra soldati e popolazioni del luogo. elenarovelli 148
149 Quando le grandi migrazioni barbariche si riversarono sull impero, il limes venne abbandonato o travolto
150 Strade e ponti Un esercito che si spostava in paese nemico non sempre trovava i supporti cui l'aveva abituato il mondo romano, e quindi doveva intervenire sul territorio Era la fanteria delle legioni a fornire la manodopera, mentre la cavalleria, anche quella degli ausiliari, assicurava la sorveglianza e la protezione del cantiere. elenarovelli 150
151 Dolabra Tagliazolle Per avanzare rapidamente in paese nemico, i generali si preoccupavano di poter disporre di vie facili da percorrere. I fanti abbattevano gli alberi quando si attraversava una foresta, eliminavano massi ingombranti e prosciugavano all'occorrenza paludi di piccole dimensioni. Spianavano il terreno, o quantomeno disponevano dei segnali che indicavano la direzione da seguire. Non appena consolidata una posizione, era sempre l'esercito che provvedeva a rendere definitiva la percorribilità sulle strade, per garantire facili e veloci rifornimenti e comunicazioni. elenarovelli 151
152 All attraversamento dei corsi d'acqua si potevano dare tre soluzioni diverse: fare appello alla marina per attraversare il fiume in barca; sempre con l'aiuto della marina, costruire un ponte di imbarcazioni disponendo delle navi affiancate e solidamente legate l'una all'altra, sulle quali veniva sistemata una passerella; costruire un vero e proprio ponte, in legno o in pietra (scelta spesso privilegiata perché offriva il vantaggio di solidità e di una via di fuga in caso di repentina ritirata > in questo caso il ponte veniva distrutto dopo il passaggio delle truppe). Ponte di barche sul Danubio (colonna Traiana) elenarovelli 152
153 La flotta
154 La flotta romana nacque per scopi essenzialmente militari, tuttavia esistevano imbarcazioni per uso civile da utilizzare come navi da carico o da trasporto merci (in genere a vela), denominate naves onerariae o naves vectoriae (da vehere = trasportare). Più ridotti i phaseli (piccole navi leggere) le cymbae (barche) le lintres (scialuppe). elenarovelli 154
155 La flotta militare Costituita da navi a 2 ordini di remi (biremis) a 3 (triremis) a 4 (quadriremis) a 5 (quinqueremis). In relazione alla velocità e all utilizzo le navi potevano essere Naves praetoriae (ammiraglie) Naves longae (da guerra, velocissime) Naves liburnicae (molto veloci, anche a 10 ordini di remi) Naves actuariae (leggere, da vedetta e per trasporto truppe) Naves speculatoriae (da ricognizione, per spiare le mosse del nemico) Naves tabellariae (piccole, per portare dispacci da porto a porto). elenarovelli 155
156 Navi da guerra (naves longae) Sono a 3,4, 5 ordini di remi. Hanno la prua munita di uno sperone (rostrum, -i) a tre punte, con cui squarciano le navi nemiche. La velocità media di una nave da battaglia è di 5-6 miglia orarie elenarovelli 156
157 Trireme (triremes, -is) elenarovelli 157
158 Trireme elenarovelli 158
159 elenarovelli 159
160 Particolare della prua con rostrum elenarovelli 160
161 Trireme con corvus per arrembaggio elenarovelli 161
162 Quadrireme (quadriremes, -is) elenarovelli 162
163 Quinquireme (quinqueremes, -is) È la nave più agile e robusta, lunga 40 metri e larga 6/7 metri. Porta 300 rematori (schiavi), 180 soldati e una ventina di ufficiali e sottufficiali. elenarovelli 163
164 Capo supremo della flotta militare era il dux (comandante generale dell esercito), che in qualità di comandante della marina da guerra era denominato praefectus classis. Capitano di una singola nave era il navarchus o praefectus navis o magister navis. Suoi subordinati erano il gubernator (timoniere o pilota) i decuriones (comandanti delle sezioni dei rematori) i remiges (equipaggio dei rematori) i nautae (marinai) i classiarii (soldati della marina). elenarovelli 164
165 In età repubblicana La flotta non è permanente, ma esistono arsenali militari (navalia) nella zona del porto romano di Ostia, dove le navi sono costruite e allestite sotto la direzione di un alto magistrato, console o pretore, o sotto la sorveglianza di funzionari speciali (duumviri navales). elenarovelli 165
166 Durante il principato di Augusto Fu resa permanente la flotta da guerra, suddivisa in due squadre: la flotta del Mediterraneo, la classis praetoria Misenensis, di stanza a Capo Miseno (Campania) la flotta dell Adriatico, la classis praetoria Ravennas, di stanza a Ravenna. La chiesa di S.Apollinare in classe, a 5 km. da Ravenna, prende il nome dall antica presenza della flotta. elenarovelli 166
167 Successivamente vennero aggregate altre squadre navali, in funzione di difesa dei confini dell Impero Nacquero così la classis Britannica (sul Mare del Nord) e la classis Pontica (sul Mar Nero) Esistevano più esigue squadre navali fluviali (sul Reno e sul Danubio) A destra: resti di imbarcazione romana rinvenuta lungo il Reno Sotto: ricostruzione di due navi romane del tipo usato sul Reno (Magonza, Museo della navigazione antica) elenarovelli 167
168 Fonti A.Diotti, Littera litterae, Ed.Scolastiche B.Mondadori A.Diotti, Lexis, agenda di lessico e civiltà latina, Ed.Scolastiche B.Mondadori E.Mancino, Romanus civis, Lattes Torino P.Di Sacco, M. Serìo, Odi et amo, Ed.Scolastiche B.Mondadori P.Di Sacco, Corso di storia, Storia antica, Le Monnier Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Exempla humanitatis, vol.1, C.Signorelli Editore G.Pittano, Passato presente, Ed.Scolastiche B.Mondadori Archeo De Agostini n. 249, 250, 251, 252 Siti internet elenarovelli 168
169 Appendici elenarovelli 169
170 Lessico : Il servizio militare Delectus, -us = leva, arruolamento Militia, -ae = servizio militare, obbligatorio in età repubblicana, poi volontario Stipendium, -ii = stipendio dei soldati; servizio militare Emerēre stipendia = compiere il servizio militare Stipendium militibus numerare/persolvěre = dare la paga ai soldati Missio, -onis = congedo, licenza Praemium missionis ferre = ottenere il premio del congedo elenarovelli 170
171 Antepilani, -orum = combattenti in prima fila (hastati e principes) Principia, -orum = prime file dell esercito Primum agmen = avanguardia Novissimum agmen = retroguardia Acies simplex = esercito disposto su una sola linea Acies triplex = esercito disposto su tre linee Aciem instruěre/instituěre = schierare l esercito Triplicem aciem instruere = schierare l esercito su tre linee Lessico: Lo schieramento elenarovelli 171
172 Lessico: La guerra e la pace Bellum instruěre = fare i preparativi di guerra Bellum parare, comparare = preparare la guerra Bellum inferre = portare guerra Bellum indicěre = dichiarare guerra Bellum gerěre = far guerra Bellum componěre = fare la pace Bellum conficěre = finire la guerra
173 Proelium, -ii = battaglia, combattimento Pugna, -ae = battaglia Concursus, -us = scontro (correre tutti insieme verso un obiettivo) Congressus, -us = scontro (radunarsi insieme per combattere) Tumultus, -us pugnae = concitazione della battaglia Proelium committěre = attaccare battaglia Proelium restituěre = rinnovare la battaglia Pari proelio disceděre = terminare la battaglia senza vincitori Proelio superior disceděre = riuscire vincitore in battaglia Ad pugnam lacessere = sfidare a battaglia Proelii committendi signum dare = dare il segnale della battaglia De imperio decertare = combattere per la supremazia Imperium, -ii = comando, potere Circumsedēre = circondare Cuneus, -i = disposizione di battaglia in forma di cuneo Lessico: La battaglia.1
174 La battaglia.2 Impetus, -us = assalto Primo impetu = al primo assalto Impetum sustinēre = sostenere l assalto Impetum frangěre = respingere l assalto Saga suměre = prendere le armi Vi capěre /expugnare = prendere d assalto Vi atque impressione = con la violenza dell assalto Obruěre telis = ricoprire di frecce (uccidere con le frecce) Aquilam defenděre = difendere l insegna Hostes caeděre/conciděre = far strage di nemici
175 Lessico: La sconfitta Aquilam proicěre = gettare l insegna Conturbare ordines = scompigliare le file Caedes, -is = strage Magna caedes facta est = ci fu una grande strage Clades, -is = sconfitta In alicuius manus inciděre = cadere in mano, in potere di qualcuno elenarovelli 175
176 Lessico: La marcia Iter, itineris iustum = marcia ordinaria (circa 25 km.) Iter magnum = marcia rapida Iter maximum = marcia forzata Magnis itineribus = a marce forzate Iter facěre = marciare Iter conficěre = portare a termine una marcia Pilatim iter facĕre = marciare su una sola colonna Passim exercitum ducĕre = marciare in più colonne parallele (una di principes, una di hastati, una di triarii) elenarovelli 176
177 Lessico: Il trionfo Io triumphe! = evviva! (acclamazione del popolo che assiste alla sfilata trionfale) Triumphum decerněre alicui = decretare il trionfo a qualcuno Victor, -oris = vincitore Victoria, -ae = vittoria Res gestae, rerum gestarum = imprese, azioni gloriose elenarovelli 177
178 Lessico: L assedio Obsidio, -onis = assedio Urbem obsidione clauděre = cingere d assedio una città Opera, -um = opere d assedio Urbem munire = fortificare la città Castellum, -i = fortezza, cittadella, riparo, rifugio Expugnatio, -onis = espugnazione Oppugnatio, -onis = assalto di una città Expugnata urbe = dopo l espugnazione di una città Obsidione eximěre/solvěre = liberare dall assedio Obsidionem ferre/pati/sustinēre = sopportare un assedio In obsidione esse = essere assediato Cuniculus, -i = condotto sotterraneo per espugnare una città
179 Lessico: L accampamento Castra poněre/facěre/locare = porre l accampamento, accamparsi Castra movēre = levare il campo, riprendere la marcia Castra removēre = ritirarsi, indietreggiare Se in castra recipěre = ritirarsi nell accampamento Hiberna, -orum = accampamento invernale elenarovelli 179
180 Lessico. La guardia Statio, -onis = posto di guardia, guarnigione Stationem agěre = essere di guardia In stationem succeděre = dare il cambio della guardia Vigilia, -ae = turno di guardia notturno Praesidium, -ii = guardia, difesa, guarnigione militare Excubias agěre alicui = montare la guardia a uno Excubias agěre aliquo loco = tenere le guardie acquartierate in un luogo elenarovelli 180
181 Etimologia: BELLUM Termine più ampio con cui si designa la guerra. Può essere domesticum, intestinum, sociale, civile, navale, terrestre LOCUZIONI VERBALI INDICANTI Il suscitare guerra (b. concitare, excitare, suscitare) Il prepararla (b. parare, comparare, instruere) Il dichiararla (b. nuntiare, denuntiare, indicere) Il cominciarla (b. incipere, inire cum aliquo, belli initium facere, capere) Il rinunciarvi (b. deponere) Il porvi fine (b. componere, conficere, perficere, exstinguere, delere) Il rinnovarla (b. renovare, redintegrare, differre, continuare) elenarovelli 181
182 Derivano da bellum: Bello, -are = guerreggiare Bellator, -oris, m. = guerriero Debello, -are = cessare la guerra per annientamento dell avversario Rebello, -are = rinnovare la guerra Bellicus, a, um = pertinente alla guerra Bellicosus, a, um = guerriero, bellicoso Imbellis, e = inadatto alla guerra Perduellis = nemico pubblico elenarovelli 182
183 Nelle lingue romanze il franco werra = mischia ha sostituito bellum (it. guerra, francese guerre; inglese war) DERIVATI in ITALIANO: bellico, bellicoso debellare, imbelle, ribellare (che non conserva il valore iterativo del prefisso re), rovello. elenarovelli 183
184 Etimologia: MILES È il soldato generico, oppure il fante in opposizione a eques; può significare armata (singolare collettivo). DERIVATI: Militia (militiae = in campo, in guerra; domi militiaeque = in pace e in guerra); militaris = militare, di guerra; milito, -are = con sub + abl. > servire sotto il comando di qualcuno; commilito, -onis = compagno d armi. In italiano milite è termine letterario (popolare è invece soldato, da soldo, -are = assoldare); militare (dotto) indica chi presta servizio nell esercito; militante appartiene all ambito della lotta ideologica: indica chi si impegna attivamente per una causa è anche attributo della comunità terrena dei Cristiani (cfr. Chiesa militante) 184
185 Etimologia: EXERCITUS Da exerceo, -ēre = esercitare, da ex + arceo, -ere = trattenere, tenere lontano dal riposo, tenere in esercizio Si costruisce con l accusativo (exercēre artem = praticare un arte) o con in + elenarovelli 185 ablativo (se exercēre o exercēri in venando = esercitarsi nella caccia)
186 EXERCITUS Il verbo ricorre nelle locuzioni copias exercēre = addestrare le truppe e arma exercēre/armis exercēri = fare esercizi militari. Da qui il derivato exercitus, -us = esercizio, anche militare, che in seguito indica l insieme delle truppe. Le funzioni specifiche sono designate da un aggettivo (pedestris/terrestris/navalis); significa fanteria se in coppia con la cavalleria: exercitus equitatusque/exercitus cum equitatu. DERIVATI: Exercitium = esercizio, occupazione Exercitatio= esercitazione, esperienza, pratica Exercitator= maestro, esercitatore Exercito, -are= esercitare con frequenza, agitare In ITALIANO exercēre è continuato da esercire (participio presente esercente ); exercitus prosegue in esercito, con valore militare, da cui per generalizzazione si è sviluppato il senso di moltitudine, sciame. elenarovelli 186
187 Etimologia: LEGIO Da lego, -ĕre = raccogliere, scegliere, allude alla facoltà di scegliere (i legionari erano arruolati per scelta o avevano la facoltà di designare il proprio compagno d arme). Oggi la legione rievoca il corpo speciale dell esercito francese (l. straniera), oppure una grande moltitudine (es. una l. di zanzare, di turisti) elenarovelli 187
188 Etimologia: CLASSIS = chiamata, richiamo (da calo, - are = chiamare), perciò designa le categorie di cittadini suscettibili di essere chiamate alle armi, infine le truppe vere e proprie. A causa del parallelo exercitus, classis si è specializzato nel valore di flotta. L italiano classe significa gruppo, suddivisione, categoria accanto a eccellenza, stile L aggettivo classicus = cittadino appartenente alla prima classe di Servio Tullio oppure della flotta, navale venne usato per la prima volta nel II secolo da Aulo Gellio per designare uno scrittore come eccellente, esemplare. Classico pertanto identifica il mondo greco e romano, e i classici per antonomasia sono gli scrittori greci e latini. elenarovelli 188
189 Letteralmente punta, filo tagliente e capacità di penetrare, specie dello sguardo (da tale accezione per metonimia si sono designati la pupilla e l occhio). Nella lingua militare è il fronte dell esercito, tagliente come il filo di una lama, e per estensione il complesso delle forze in campo e il combattimento stesso. FAMIGLIA LESSICALE: Acidus, acetus, acerbus (senso del gusto) Acer, acris, acre Acus, -us = ago Acuo, -ĕre = rendere aguzzo DERIVATI in ITALIANO: Acuire, acume, acuto, acutezza, aguzzare, guglia (per aferesi del diminutivo acucula = spilletta), acciaio (da ferrum aciarium,, di lega resistente, adatta alla punta delle armi), Prestiti dal greco a partire dal medesimo costituente sono acme (punta, culmine), acrobata (= colui che cammina sulle punte), acropoli (= la parte più alta della città) Etimologia: ACIES
190 Etimologia: VALLUM Termine collettivo forse ricavato da valla, -orum = palizzata. Indica la palizzata elevata sul terrapieno e, per estensione, l argine munito di pali. DERIVATI: Vallo, -are = trincerare, proteggere; Vallatio, -onis = palizzata, scorta; Vallaris, -e = del vallo ESITI ITALIANI: Da circumvallatio, -onis =vallo che circonda una località assediata deriva circonvallazione = strada o via di scorrimento del traffico attorno a una città; Da intervallum, -i = spazio tra due palizzate deriva intervallo = distanza tra due oggetti o periodo che intercorre tra due eventi elenarovelli 190
Al Clanicularius era affidata la cura e il controllo delle chiavi delle varie porte.
 di MARIA PACE Nel recinto dell accampamento romano si aprivano quattro porte, una su ciascun lato, ampie e comode, sia per l ingresso di bestie, che per eventuali sortite di emergenza degli uomini. Le
di MARIA PACE Nel recinto dell accampamento romano si aprivano quattro porte, una su ciascun lato, ampie e comode, sia per l ingresso di bestie, che per eventuali sortite di emergenza degli uomini. Le
Antica Roma L invincibile esercito. di MARIA PACE
 di MARIA PACE L invincibile esercito romano non era poi così enorme come si pensa e spesso ebbe di fronte eserciti ben più grossi e li sbaragliò. Fu il caso di Cesare, ad esempio, che con i suoi 60mila
di MARIA PACE L invincibile esercito romano non era poi così enorme come si pensa e spesso ebbe di fronte eserciti ben più grossi e li sbaragliò. Fu il caso di Cesare, ad esempio, che con i suoi 60mila
L esercito e la carriera militare
 + L esercito e la carriera militare L ordinamento Militare Organizzazione della legione Lo schieramento in battaglia L evoluzione dell esercito Lessico La Legione comandata dal CONSOLE Inizialmente divisione
+ L esercito e la carriera militare L ordinamento Militare Organizzazione della legione Lo schieramento in battaglia L evoluzione dell esercito Lessico La Legione comandata dal CONSOLE Inizialmente divisione
Inizialmente l esercito romano era formato dalle gentes e dai loro clienti,tuttavia tra il V e il IV sec.a.c. ci fu l inserimento dei plebei ad
 Inizialmente l esercito romano era formato dalle gentes e dai loro clienti,tuttavia tra il V e il IV sec.a.c. ci fu l inserimento dei plebei ad esclusione dei proletari,che portò alla creazione della legione,dal
Inizialmente l esercito romano era formato dalle gentes e dai loro clienti,tuttavia tra il V e il IV sec.a.c. ci fu l inserimento dei plebei ad esclusione dei proletari,che portò alla creazione della legione,dal
Le tende nell'accampamento romano
 Le tende nell'accampamento romano Il contubernium La tenda che ospitava 8 uomini si chiamava contubernium (tenda comune). Sembra che abbia formato l'unità di base dell'esercito romano in tutta la sua storia.
Le tende nell'accampamento romano Il contubernium La tenda che ospitava 8 uomini si chiamava contubernium (tenda comune). Sembra che abbia formato l'unità di base dell'esercito romano in tutta la sua storia.
IL MODELLO MILITARE ELLENICO, OSSIA QUELLO DELLA FALANGE OPLITICA, NACQUE CON IL SORGERE DELLA PÓLIS. CON LA FALANGE OPLITICA L AZIONE INDIVIDUALE,
 IL MODELLO MILITARE ELLENICO, OSSIA QUELLO DELLA FALANGE OPLITICA, NACQUE CON IL SORGERE DELLA PÓLIS. CON LA FALANGE OPLITICA L AZIONE INDIVIDUALE, CHE ERA CARATTERISTICA DEL MODELLO DI COMBATTIMENTO OMERICO,
IL MODELLO MILITARE ELLENICO, OSSIA QUELLO DELLA FALANGE OPLITICA, NACQUE CON IL SORGERE DELLA PÓLIS. CON LA FALANGE OPLITICA L AZIONE INDIVIDUALE, CHE ERA CARATTERISTICA DEL MODELLO DI COMBATTIMENTO OMERICO,
Aprivano la colonna, secondo l ordine di marcia consueto ai romani, ausiliari, con armatura
 di MARIA PACE L esercito romano in marcia era uno spettacolo, impressionante: colorato, rumoroso ed infinito. Vederlo avanzare, inarrestabile, doveva essere motivo di grossi timori e preoccupazioni. Ecco
di MARIA PACE L esercito romano in marcia era uno spettacolo, impressionante: colorato, rumoroso ed infinito. Vederlo avanzare, inarrestabile, doveva essere motivo di grossi timori e preoccupazioni. Ecco
Antica Roma Vita da legionario. di MARIA PACE
 di MARIA PACE Costruito l accampamento, la vita del legionario era scandita dalla disciplina di una ferrea organizzazione e nulla si poteva fare senza un comando impartito col suono della tromba: mangiare,
di MARIA PACE Costruito l accampamento, la vita del legionario era scandita dalla disciplina di una ferrea organizzazione e nulla si poteva fare senza un comando impartito col suono della tromba: mangiare,
La struttura della città
 La struttura della città Quasi tutte le città fondate dai Romani avevano uno schema ben preciso, utilizzato costantemente nella costruzione degli accampamenti romani. Anche Verona fu progettata con la
La struttura della città Quasi tutte le città fondate dai Romani avevano uno schema ben preciso, utilizzato costantemente nella costruzione degli accampamenti romani. Anche Verona fu progettata con la
La civiltà romana Roma e la repubblica
 La civiltà romana Roma e la repubblica La civiltà romana prese origine dal popolo dei Latini, i quali riunirono alcuni villaggi costruiti sui colli lungo il fiume Tevere, in prossimità dell isola Tiberina,
La civiltà romana Roma e la repubblica La civiltà romana prese origine dal popolo dei Latini, i quali riunirono alcuni villaggi costruiti sui colli lungo il fiume Tevere, in prossimità dell isola Tiberina,
Team Building. Gioco completo con 10 prove e relativi giudici di gara in costume 3.400,00 + iva. I giochi (alcuni esempi)
 Team Building Camon In Italy Descizione Team Building Trattasi di una sorta di giochi senza frontiere ambientati nell'antica Roma. I concorrenti vengono divisi in squadre, costituite da 10 persone circa,
Team Building Camon In Italy Descizione Team Building Trattasi di una sorta di giochi senza frontiere ambientati nell'antica Roma. I concorrenti vengono divisi in squadre, costituite da 10 persone circa,
14. c) L'esercito romano: lessico di base e lessico specifico
 14. c) L'esercito romano: lessico di base e lessico specifico L esercito romano in età repubblicana Nei tempi più antichi Roma non disponeva di un esercito permanente. Tutti i cittadini erano tenuti al
14. c) L'esercito romano: lessico di base e lessico specifico L esercito romano in età repubblicana Nei tempi più antichi Roma non disponeva di un esercito permanente. Tutti i cittadini erano tenuti al
Cinture Loriche segmentate Borse e scarselle Tende Gladi e spathae Scudi Loriche hamate Accessori per elmi Elmi ellenici Elmi tardo-imperiali
 Content Cinture 2 Loriche segmentate 3 Borse e scarselle 4 Tende 5 Gladi e spathae 6 Scudi 8 Loriche hamate 10 Accessori per elmi 11 Elmi ellenici 12 Elmi tardo-imperiali 13 Elmi alto-imperiali 14 Elmi
Content Cinture 2 Loriche segmentate 3 Borse e scarselle 4 Tende 5 Gladi e spathae 6 Scudi 8 Loriche hamate 10 Accessori per elmi 11 Elmi ellenici 12 Elmi tardo-imperiali 13 Elmi alto-imperiali 14 Elmi
Abiti romani Ricerca di: Ivana Cerato, Paolo Vigliarolo. Toga
 Abiti romani Ricerca di: Ivana Cerato, Paolo Vigliarolo Toga Quantità: 1 Sesso: M Descrizione: larga ed abbondante (in modo da poter essere riusata anche in foggia più stretta per l età repubblicana) bianca,
Abiti romani Ricerca di: Ivana Cerato, Paolo Vigliarolo Toga Quantità: 1 Sesso: M Descrizione: larga ed abbondante (in modo da poter essere riusata anche in foggia più stretta per l età repubblicana) bianca,
L ordinamento gentilizio arcaico: la gens Gentiles: parentela in linea maschile unita da culti familiari; amministrazione della giustizia; servizio mi
 Le istituzioni nella Roma antica L ordinamento gentilizio L evoluzione nell età monarchica La res publica L ordinamento gentilizio arcaico: la gens Gentiles: parentela in linea maschile unita da culti
Le istituzioni nella Roma antica L ordinamento gentilizio L evoluzione nell età monarchica La res publica L ordinamento gentilizio arcaico: la gens Gentiles: parentela in linea maschile unita da culti
PERIODO STORICO XI - XII SECOLO WHLIVE - GIOCO DI RUOLO DAL VIVO
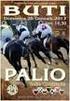 LA LUNGA NOTTE GUIDA A COSTUMI E ACCESSORI PERIODO STORICO XI - XII SECOLO WHLIVE - GIOCO DI RUOLO DAL VIVO 9 Luglio 2016 Fortezza di Sarzanello, Sarzana (SP) http://www.whlive.it/la-lunga-notte/ Contenuti
LA LUNGA NOTTE GUIDA A COSTUMI E ACCESSORI PERIODO STORICO XI - XII SECOLO WHLIVE - GIOCO DI RUOLO DAL VIVO 9 Luglio 2016 Fortezza di Sarzanello, Sarzana (SP) http://www.whlive.it/la-lunga-notte/ Contenuti
AQUILIFER CATALOGO
 COMPOSIZIONE BLISTER: fanteria (comando compreso) - 12 figure miste; cavalleria (comando compreso) - 12 figure miste; artiglieria - cannone + 4 artiglieri misti; personalità e alti ufficiali 6 a piedi
COMPOSIZIONE BLISTER: fanteria (comando compreso) - 12 figure miste; cavalleria (comando compreso) - 12 figure miste; artiglieria - cannone + 4 artiglieri misti; personalità e alti ufficiali 6 a piedi
la città è un luogo organizzato,complesso, formato da diversi elementi: abitazioni, edifici pubblici, strade, piazze, sistemi fognari, acquedotti,
 mila del corno la città è un luogo organizzato,complesso, formato da diversi elementi: abitazioni, edifici pubblici, strade, piazze, sistemi fognari, acquedotti, reti di illuminazione e trasporto. dalle
mila del corno la città è un luogo organizzato,complesso, formato da diversi elementi: abitazioni, edifici pubblici, strade, piazze, sistemi fognari, acquedotti, reti di illuminazione e trasporto. dalle
Armi d'assedio e armi da lancio pesanti
 Armi d'assedio e armi da lancio pesanti http://antichimezzelfi.altervista.org/armilancio.htm Per assalire e distruggere le città dei nemici, l'esercito romano utilizzava armi da lancio e d'assedio. Alcune
Armi d'assedio e armi da lancio pesanti http://antichimezzelfi.altervista.org/armilancio.htm Per assalire e distruggere le città dei nemici, l'esercito romano utilizzava armi da lancio e d'assedio. Alcune
L ordinamento dell esercito romano (che rimase in vita per tutto il periodo repubblicano, nonostante alcune importanti modificazioni) è antichissimo:
 L ESERCITO ROMANO L ordinamento dell esercito romano (che rimase in vita per tutto il periodo repubblicano, nonostante alcune importanti modificazioni) è antichissimo: si basa sulla divisione dei cittadini
L ESERCITO ROMANO L ordinamento dell esercito romano (che rimase in vita per tutto il periodo repubblicano, nonostante alcune importanti modificazioni) è antichissimo: si basa sulla divisione dei cittadini
LE REGOLE Completa le frasi. In classe non si può... In classe si può... In palestra è vietato... In palestra è permesso...
 Storia A2 Classi 3 a, 4 a, 5 a e secondaria Scheda n. 1 LE REGOLE Completa le frasi. In classe non si può... In classe si può... In palestra è vietato... In palestra è permesso... In mensa c è il divieto
Storia A2 Classi 3 a, 4 a, 5 a e secondaria Scheda n. 1 LE REGOLE Completa le frasi. In classe non si può... In classe si può... In palestra è vietato... In palestra è permesso... In mensa c è il divieto
SISTEMA CURTENSE. Fabio Cataneo, Cristiano Cecere, Giovanni Napolitano, Crescenzo Vitolo.
 SISTEMA CURTENSE Fabio Cataneo, Cristiano Cecere, Giovanni Napolitano, Crescenzo Vitolo. 1 CONTESTO STORICO Nell Alto Medioevo le uniche organizzazioni politiche floride erano gli Imperi bizantini e arabi;
SISTEMA CURTENSE Fabio Cataneo, Cristiano Cecere, Giovanni Napolitano, Crescenzo Vitolo. 1 CONTESTO STORICO Nell Alto Medioevo le uniche organizzazioni politiche floride erano gli Imperi bizantini e arabi;
PROGRAMMA PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI ARMIGERO
 PROGRAMMA PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI ARMIGERO pag.1 CENNI DI STORIA La scherma nasce con l uomo attraverso l utilizzazione delle armi che in ogni periodo storico sono state costruite attraverso
PROGRAMMA PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI ARMIGERO pag.1 CENNI DI STORIA La scherma nasce con l uomo attraverso l utilizzazione delle armi che in ogni periodo storico sono state costruite attraverso
Per un uomo valoroso è bello cadere morto combattendo in prima fila per la patria. Struttura sociale e Costituzione di Licurgo
 Per un uomo valoroso è bello cadere morto combattendo in prima fila per la patria Struttura sociale e Costituzione di Licurgo Gli ideali Falange oplitica Diritti solo per gli spartiati Società Struttura
Per un uomo valoroso è bello cadere morto combattendo in prima fila per la patria Struttura sociale e Costituzione di Licurgo Gli ideali Falange oplitica Diritti solo per gli spartiati Società Struttura
La civiltà romana L impero romano
 La civiltà romana L impero romano L impero romano nacque nel 27 a. C. quando Ottaviano, nipote di Cesare, prese il potere e riunì nella sua persona tutte le cariche della repubblica (tribuno della plebe,
La civiltà romana L impero romano L impero romano nacque nel 27 a. C. quando Ottaviano, nipote di Cesare, prese il potere e riunì nella sua persona tutte le cariche della repubblica (tribuno della plebe,
Classe IV materiali di lavoro Storia vita nel Medioevo I PROGRESSI NELL' AGRICOLTURA DURANTE IL SECONDO MEDIOEVO
 Scheda 14 I PROGRESSI NELL' AGRICOLTURA DURANTE IL SECONDO MEDIOEVO Nei secoli dopo il 1000 si ebbero molti progressi per quanto riguarda le tecniche di coltivazione della terra. In particolare: - si ebbe
Scheda 14 I PROGRESSI NELL' AGRICOLTURA DURANTE IL SECONDO MEDIOEVO Nei secoli dopo il 1000 si ebbero molti progressi per quanto riguarda le tecniche di coltivazione della terra. In particolare: - si ebbe
PERCORSI DIDATTICI DI RICERCA STORICA DELLE CLASSI DELL' I.T.I.S. FERMO CORNI DI MODENA
 LABORATORIO DI STORIA I.T.I.S. FERMO CORNI ANNO SCOLASTICO 2011-2012 PERCORSI DIDATTICI DI RICERCA STORICA DELLE CLASSI DELL' I.T.I.S. FERMO CORNI DI MODENA ARCHIVIO STORICO DI MODENA CLASSE II A- B. T.
LABORATORIO DI STORIA I.T.I.S. FERMO CORNI ANNO SCOLASTICO 2011-2012 PERCORSI DIDATTICI DI RICERCA STORICA DELLE CLASSI DELL' I.T.I.S. FERMO CORNI DI MODENA ARCHIVIO STORICO DI MODENA CLASSE II A- B. T.
IV. I REPERTI METALLICI
 IV. I REPERTI METALLICI Il repertorio metallico del castello di Montarrenti è quantitativamente molto esiguo. Si contano in totale 76 pezzi dei quali 2, pari al 3% del totale, riferibili ad attività artigianali
IV. I REPERTI METALLICI Il repertorio metallico del castello di Montarrenti è quantitativamente molto esiguo. Si contano in totale 76 pezzi dei quali 2, pari al 3% del totale, riferibili ad attività artigianali
Antichi romani grandi costruttori
 Colosseo Antichi romani grandi costruttori L anfiteatro Flavio, costruito per volere di Vespasiano della famiglia dei Flavi nel 72d.C, è conosciuto col nome Colosseo per via della colossale statua di Nerone
Colosseo Antichi romani grandi costruttori L anfiteatro Flavio, costruito per volere di Vespasiano della famiglia dei Flavi nel 72d.C, è conosciuto col nome Colosseo per via della colossale statua di Nerone
Dalla didattica della schiacciata all identificazione delle tecniche di attacco caratteristiche dei vari ruoli. Relatore : Romani Roberto
 Dalla didattica della schiacciata all identificazione delle tecniche di attacco caratteristiche dei vari ruoli Relatore : Romani Roberto L attacco da posto 4 Dopo aver insegnato le tecniche di base per
Dalla didattica della schiacciata all identificazione delle tecniche di attacco caratteristiche dei vari ruoli Relatore : Romani Roberto L attacco da posto 4 Dopo aver insegnato le tecniche di base per
NELLA SOCIETA FEUDALE: Abbigliamento
 LA VITA QUOTIDIANA NELLA SOCIETA FEUDALE: Abbigliamento La moda era molto importante nel Medioevo in quanto era dai vestiti che si riconoscevano gli appartenenti alle diverse classi sociali. Abbigliamento
LA VITA QUOTIDIANA NELLA SOCIETA FEUDALE: Abbigliamento La moda era molto importante nel Medioevo in quanto era dai vestiti che si riconoscevano gli appartenenti alle diverse classi sociali. Abbigliamento
Viking ships. Tommaso, Antonio, Rosiris, Nicola
 Viking ships Tommaso, Antonio, Rosiris, Nicola I Vichinghi I Vichinghi furono un grande popolo di navigatori, esperti nella costruzione d imbarcazioni innovative e nella navigazione negli ostili mari del
Viking ships Tommaso, Antonio, Rosiris, Nicola I Vichinghi I Vichinghi furono un grande popolo di navigatori, esperti nella costruzione d imbarcazioni innovative e nella navigazione negli ostili mari del
RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Soloverbi 20%] aprile 2015
![RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Soloverbi 20%] aprile 2015 RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Soloverbi 20%] aprile 2015](/thumbs/93/111155944.jpg) RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Soloverbi %] aprile 1 1 2 Cesare verso mezzanotte inventa sul luogo vari squadroni di cavalleria. corteggia di comprare scorrerie dappertutto, proseguendo
RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Soloverbi %] aprile 1 1 2 Cesare verso mezzanotte inventa sul luogo vari squadroni di cavalleria. corteggia di comprare scorrerie dappertutto, proseguendo
Progetto LA SCUOLA ADOTTA MONUMENTO. Le mura di Cosa. Classi quinte scuola Primaria Neghelli
 Progetto LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO Le mura di Cosa Classi quinte scuola Primaria Neghelli La città di Cosa A circa 7 chilometri a sud-est di Orbetello, sopra il promontorio di Ansedonia, ci sono le
Progetto LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO Le mura di Cosa Classi quinte scuola Primaria Neghelli La città di Cosa A circa 7 chilometri a sud-est di Orbetello, sopra il promontorio di Ansedonia, ci sono le
Missione 1 Battesimo di fuoco
 Missione 1 Battesimo di fuoco 11 novembre 1941 Udino, regione di Rostov. B 1 3 2 4 1: Punto di partenza 5 2: In trincea 3: Avanzata del carro KV-1 4: Dall altra sponda del fiume 5: Il re della collina
Missione 1 Battesimo di fuoco 11 novembre 1941 Udino, regione di Rostov. B 1 3 2 4 1: Punto di partenza 5 2: In trincea 3: Avanzata del carro KV-1 4: Dall altra sponda del fiume 5: Il re della collina
Armature. Il tipo di armatura (leggera, media o pesante) viene determinato a secondo del materiale di cui è costituita l'armatura stessa.
 Armature Il tipo di armatura (leggera, media o pesante) viene determinato a secondo del materiale di cui è costituita l'armatura stessa. Le armatura hanno dei punti ferita che scendono ogniqualvolta vieni
Armature Il tipo di armatura (leggera, media o pesante) viene determinato a secondo del materiale di cui è costituita l'armatura stessa. Le armatura hanno dei punti ferita che scendono ogniqualvolta vieni
classe IV sezione D E. C., V. C., G. S., F. S.
 classe IV sezione D E. C., V. C., G. S., F. S. I Romani posero ogni cura in tre cose soprattutto, che furono dai Greci neglette, cioè nell aprire le strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel
classe IV sezione D E. C., V. C., G. S., F. S. I Romani posero ogni cura in tre cose soprattutto, che furono dai Greci neglette, cioè nell aprire le strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel
LA ROCCA DA SALVARE. Ad un osservazione attenta, si possono quindi distinguere numerose fasi costruttive:
 LA ROCCA DA SALVARE CENNI STORICI La Rocca nasce come edificio militare difensivo: in essa vi erano gli alloggiamenti delle truppe, i depositi delle munizioni, i depositi di viveri, la cappella, le carceri
LA ROCCA DA SALVARE CENNI STORICI La Rocca nasce come edificio militare difensivo: in essa vi erano gli alloggiamenti delle truppe, i depositi delle munizioni, i depositi di viveri, la cappella, le carceri
INDICE SOMMARIO. Prefazione... p. XIII PARTE PRIMA GENESI E IDENTITÀ DELLA CITTÀ-STATO CAPITOLO PRIMO LA FORMAZIONE DELL ORDINAMENTO CITTADINO
 INDICE SOMMARIO Prefazione... p. XIII PARTE PRIMA GENESI E IDENTITÀ DELLA CITTÀ-STATO CAPITOLO PRIMO LA FORMAZIONE DELL ORDINAMENTO CITTADINO 1. L ambiente materiale nel Lazio arcaico e le prime forme
INDICE SOMMARIO Prefazione... p. XIII PARTE PRIMA GENESI E IDENTITÀ DELLA CITTÀ-STATO CAPITOLO PRIMO LA FORMAZIONE DELL ORDINAMENTO CITTADINO 1. L ambiente materiale nel Lazio arcaico e le prime forme
L espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo
 Unità di apprendimento semplificata A cura di Emma Mapelli L espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo 1 Osserva lo schema. Puoi usare il vocabolario, se vuoi. schema 1 Date, parole importanti, numeri
Unità di apprendimento semplificata A cura di Emma Mapelli L espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo 1 Osserva lo schema. Puoi usare il vocabolario, se vuoi. schema 1 Date, parole importanti, numeri
La Scherma è uno sport di combattimento nel quale due avversari si fronteggiano utilizzando tre tipi di armi diverse a seconda della disciplina:
 La Scherma è uno sport di combattimento nel quale due avversari si fronteggiano utilizzando tre tipi di armi diverse a seconda della disciplina: il fioretto la spada la sciabola fioretto spada sciabola
La Scherma è uno sport di combattimento nel quale due avversari si fronteggiano utilizzando tre tipi di armi diverse a seconda della disciplina: il fioretto la spada la sciabola fioretto spada sciabola
I BARBARI. Chi erano?
 I BARBARI Chi erano? Chiamati così dai Greci per indicare chi balbettava, cioè non parlava il greco. Alla fine del IV secolo occupavano un vastissimo territorio Profilo Facebook del barbaro - RESIDENZA:
I BARBARI Chi erano? Chiamati così dai Greci per indicare chi balbettava, cioè non parlava il greco. Alla fine del IV secolo occupavano un vastissimo territorio Profilo Facebook del barbaro - RESIDENZA:
Punti di abilità: 1. Il condottiero agirà con cautela in modo da subire il minor numero di perdite. +3% per livello all armatura di tutto l esercito.
 Ira Nel fragore della battaglia l eroe innalza il morale della sua scorta. +1% per livello alla velocità dell eroe e della sua scorta. Strategia difensiva Il condottiero agirà con cautela in modo da subire
Ira Nel fragore della battaglia l eroe innalza il morale della sua scorta. +1% per livello alla velocità dell eroe e della sua scorta. Strategia difensiva Il condottiero agirà con cautela in modo da subire
Le Regole del Gioco Elementi del Gioco
 Le Regole del Gioco Elementi del Gioco Una partita a scacchi si svolge tra due giocatori che spostano a turno i propri pezzi su una scacchiera quadrata. I pezzi di un giocatore sono bianchi, quelli del
Le Regole del Gioco Elementi del Gioco Una partita a scacchi si svolge tra due giocatori che spostano a turno i propri pezzi su una scacchiera quadrata. I pezzi di un giocatore sono bianchi, quelli del
Roma e Antioco III La prima guerra di Roma in Oriente, a.c.
 Roma e Antioco III La prima guerra di Roma in Oriente, 192-188 a.c. I regni dei Diadochi, c. 300 a.c. L espansione dell impero seleucide sotto Antioco III, 200-194 a.c. Lo scacchiere egeo nel 200 a.c.
Roma e Antioco III La prima guerra di Roma in Oriente, 192-188 a.c. I regni dei Diadochi, c. 300 a.c. L espansione dell impero seleucide sotto Antioco III, 200-194 a.c. Lo scacchiere egeo nel 200 a.c.
L ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA E IMPERIALE
 L ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA E IMPERIALE LA SCULTURA IN EPOCA ROMANA RITRATTISTICA STATUA ONORARIA RILIEVO STORICO CELEBRATIVO COLONNA TRAIANA ARA PACIS STATUA BARBERINI AUGUSTO DI PRIMA PORTA LA SCULTURA
L ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA E IMPERIALE LA SCULTURA IN EPOCA ROMANA RITRATTISTICA STATUA ONORARIA RILIEVO STORICO CELEBRATIVO COLONNA TRAIANA ARA PACIS STATUA BARBERINI AUGUSTO DI PRIMA PORTA LA SCULTURA
La battaglia delle Egadi
 La battaglia delle Egadi Per molti decenni la città di Trapani fu contesa tra i Romani ed i Cartaginesi. Le battaglie decisive si svolsero sul mare. Nella Prima Guerra Punica (249 a.c.), il condottiero
La battaglia delle Egadi Per molti decenni la città di Trapani fu contesa tra i Romani ed i Cartaginesi. Le battaglie decisive si svolsero sul mare. Nella Prima Guerra Punica (249 a.c.), il condottiero
Le abitazioni del Medioevo
 Le abitazioni del Medioevo Il Medioevo è un periodo molto difficile per le popolazioni caratterizzato da molte battaglie e guerre che costringono gli abitanti delle città a cercare protezione. Si creano
Le abitazioni del Medioevo Il Medioevo è un periodo molto difficile per le popolazioni caratterizzato da molte battaglie e guerre che costringono gli abitanti delle città a cercare protezione. Si creano
Expert Level. Tecniche supplementari di difesa da altri tipi di calci
 Expert Level Proiezione Principali 1. Spazzata della gamba in diagonale verso l esterno e indietro (osotogeri) 2. Proiezione di testa 3. Proiezione di anca 4. Proiezione di spalla Calci e spazzate 1. Spazzata
Expert Level Proiezione Principali 1. Spazzata della gamba in diagonale verso l esterno e indietro (osotogeri) 2. Proiezione di testa 3. Proiezione di anca 4. Proiezione di spalla Calci e spazzate 1. Spazzata
Associazione Culturale Cisalpina. Assemblea Ordinaria dei Soci 10 Gennaio 2016
 Assemblea Ordinaria dei Soci 10 Gennaio 2016 Rinnovo cariche sociali 20162018 Candidature Presidente 1. Luca Bonacina Vice Presidente 1. Davide Grassi Co n sig lie ri ( seg g i d isp o n ib ili) 1. Luca
Assemblea Ordinaria dei Soci 10 Gennaio 2016 Rinnovo cariche sociali 20162018 Candidature Presidente 1. Luca Bonacina Vice Presidente 1. Davide Grassi Co n sig lie ri ( seg g i d isp o n ib ili) 1. Luca
Le frecce da caccia dovevano essere più pesanti per generare un forte impatto, favorire la penetrazione dei tessuti, delle cartilagini e proseguire
 FRECCIA Una freccia è composta dall'asta, dalla punta, dall'impennaggio e dalla cocca. La capacità offensiva di una freccia dipende dalla velocità, dal suo peso e dalle caratteristiche della punta (cuspide)
FRECCIA Una freccia è composta dall'asta, dalla punta, dall'impennaggio e dalla cocca. La capacità offensiva di una freccia dipende dalla velocità, dal suo peso e dalle caratteristiche della punta (cuspide)
Tra le architetture antiche i fori imperiali di Roma assieme al Colosseo costituiscono forse l esempio più significativo della grandezza degli
 Tra le architetture antiche i fori imperiali di Roma assieme al Colosseo costituiscono forse l esempio più significativo della grandezza degli Antichi Romani. Roma, fondata nel 753 a.c. tracciando con
Tra le architetture antiche i fori imperiali di Roma assieme al Colosseo costituiscono forse l esempio più significativo della grandezza degli Antichi Romani. Roma, fondata nel 753 a.c. tracciando con
LA CIVILTA ROMANA. NEL 900 a.c., NEI TERRITORI DELL ITALIA CENTRALE, VICINO AL FIUME TEVERE, VIVEVANO DIVERSE TRIBU DI PASTORI E DI AGRICOLTORI.
 NEL 900 a.c., NEI TERRITORI DELL ITALIA CENTRALE, VICINO AL FIUME TEVERE, VIVEVANO DIVERSE TRIBU DI PASTORI E DI AGRICOLTORI. QUESTI POPOLI AVEVANO COSTRUITO I LORO VILLAGGI SULLE COLLINE PERCHE LA LA
NEL 900 a.c., NEI TERRITORI DELL ITALIA CENTRALE, VICINO AL FIUME TEVERE, VIVEVANO DIVERSE TRIBU DI PASTORI E DI AGRICOLTORI. QUESTI POPOLI AVEVANO COSTRUITO I LORO VILLAGGI SULLE COLLINE PERCHE LA LA
MANUALE Espansione # 2
 Commands & Colors: Ancients MANUALE Espansione # 2 Roma ed i Barbari Un gioco di Richard Borg 2 Commands & Colors: Ancients 1. INTRODUZIONE Il sistema di gioco Commands & Colors: Ancients consente ai giocatori
Commands & Colors: Ancients MANUALE Espansione # 2 Roma ed i Barbari Un gioco di Richard Borg 2 Commands & Colors: Ancients 1. INTRODUZIONE Il sistema di gioco Commands & Colors: Ancients consente ai giocatori
La resa a Passo Halfaya 17 gennaio 1942
 La resa a Passo Halfaya 17 gennaio 1942 Il 17 gennaio 1942, alle ore 9.00, il presidio dell Asse di Passo Halfaya si arrese agli Alleati, poco prima del possibile attacco finale che avrebbe dovuto a catturare
La resa a Passo Halfaya 17 gennaio 1942 Il 17 gennaio 1942, alle ore 9.00, il presidio dell Asse di Passo Halfaya si arrese agli Alleati, poco prima del possibile attacco finale che avrebbe dovuto a catturare
I Romani in Valle di Susa 19/05/14
 I Romani in Valle di Susa 19/05/14 La nascita di Roma: inquadramento cronologico DALLA FONDAZIONE ALLA MONARCHIA - Origini leggendarie I Sette re di Roma: dal 754 al 509 a.c. ETA' REPUBBLICANA: dal 509
I Romani in Valle di Susa 19/05/14 La nascita di Roma: inquadramento cronologico DALLA FONDAZIONE ALLA MONARCHIA - Origini leggendarie I Sette re di Roma: dal 754 al 509 a.c. ETA' REPUBBLICANA: dal 509
Le Mura e i Forti di Genova XVI-XIX sec.
 UNITE 5 dicembre 2018 Le Mura e i Forti di Genova XVI-XIX sec. Emiliano Beri Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFiSt) Laboratorio di storia marittima e navale (NavLab) XV-XVI secolo: la diffusione
UNITE 5 dicembre 2018 Le Mura e i Forti di Genova XVI-XIX sec. Emiliano Beri Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFiSt) Laboratorio di storia marittima e navale (NavLab) XV-XVI secolo: la diffusione
Circolo Schermistico Aretino
 Circolo Schermistico Aretino FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA M Alessandro NESPOLI M Jacopo PERUZZI ALESSANDRO NESPOLI - MAESTRO DI SCHERMA (3 livello SnAQ) maestro del Circolo
Circolo Schermistico Aretino FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA M Alessandro NESPOLI M Jacopo PERUZZI ALESSANDRO NESPOLI - MAESTRO DI SCHERMA (3 livello SnAQ) maestro del Circolo
RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale 30%] aprile 2015
![RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale 30%] aprile 2015 RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale 30%] aprile 2015](/thumbs/98/138299375.jpg) RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale 30%] aprile 1 1 2 compiere scorrerie dappertutto, producendo un po' più rullio del solito. Dall'alba tra uscire col campo sul gran numero di bagagli
RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale 30%] aprile 1 1 2 compiere scorrerie dappertutto, producendo un po' più rullio del solito. Dall'alba tra uscire col campo sul gran numero di bagagli
Roma alla conquista dell Italia
 Roma alla conquista dell Italia 1 1 DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA repubblica magistrature repubblicane collegialità annualità libertas imperium potere militare reciproco diritto di veto due consoli potestas
Roma alla conquista dell Italia 1 1 DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA repubblica magistrature repubblicane collegialità annualità libertas imperium potere militare reciproco diritto di veto due consoli potestas
Uno scorcio sull Italia. Lingua e arte per principianti di lingua italiana. 5. Il Colosseo (Anfiteatro Flavio) d.c.
 37 Uno scorcio sull Italia. Lingua e arte per principianti di lingua italiana. 5. Il Colosseo (Anfiteatro Flavio) 70-80 d.c. Livello A2 38 A. Introduzione L'Anfiteatro Flavio, conosciuto come Colosseo,
37 Uno scorcio sull Italia. Lingua e arte per principianti di lingua italiana. 5. Il Colosseo (Anfiteatro Flavio) 70-80 d.c. Livello A2 38 A. Introduzione L'Anfiteatro Flavio, conosciuto come Colosseo,
RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale crocettato 30%] aprile 2015
![RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale crocettato 30%] aprile 2015 RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale crocettato 30%] aprile 2015](/thumbs/72/67894699.jpg) RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale crocettato 30%] aprile 1 1 2 compiere scorrerie dappertutto, producendo un po' più Xyzxz del solito. Xyzxzalba Xyzxz uscire Xyzxz campo Xyzxz gran
RETEINNOVA. ESERCIZIO di COMPRENSIONE DEL TESTO [Casuale crocettato 30%] aprile 1 1 2 compiere scorrerie dappertutto, producendo un po' più Xyzxz del solito. Xyzxzalba Xyzxz uscire Xyzxz campo Xyzxz gran
QUARTA RICOGNIZIONE PORTO ANTICO E CAPITANERIA
 QUARTA RICOGNIZIONE PORTO ANTICO E CAPITANERIA Fin dal secolo IX a.c. alcune genti provenienti dall Est approdarono alla spiaggetta denominata scalo e si stanziarono nella LO SCOGLIO «LA RITORNA» Poco
QUARTA RICOGNIZIONE PORTO ANTICO E CAPITANERIA Fin dal secolo IX a.c. alcune genti provenienti dall Est approdarono alla spiaggetta denominata scalo e si stanziarono nella LO SCOGLIO «LA RITORNA» Poco
La Vita del Fante nella Prima Guerra Mondiale
 La Vita del Fante nella Prima Guerra Mondiale 24 maggio 1915-24 maggio 2017 Serata in ricordo del 102 anniversario dell'entrata in guerra dell'italia nella Prima Guerra Mondiale 24 maggio 1915: l'italia
La Vita del Fante nella Prima Guerra Mondiale 24 maggio 1915-24 maggio 2017 Serata in ricordo del 102 anniversario dell'entrata in guerra dell'italia nella Prima Guerra Mondiale 24 maggio 1915: l'italia
SCALE A PIOLI D.Lgs. 81 / 2008 Art. 113, Allegato XX - Norma UNI EN 131 parte 1 e 2
 SCALE A PIOLI D.Lgs. 81 / 2008 Art. 113, Allegato XX - Norma UNI EN 131 parte 1 e 2 ISTRUZIONI CHE DEVE RILASCIARE IL COSTRUTTORE Descrizione della scala e dei suoi elementi; Indicazioni sul corretto utilizzo;
SCALE A PIOLI D.Lgs. 81 / 2008 Art. 113, Allegato XX - Norma UNI EN 131 parte 1 e 2 ISTRUZIONI CHE DEVE RILASCIARE IL COSTRUTTORE Descrizione della scala e dei suoi elementi; Indicazioni sul corretto utilizzo;
PONTE GALLUCCI A LUCERA (FG)
 PONTE GALLUCCI A LUCERA (FG) UBICAZIONE E CARATTERISTICHE GEOMETRICHE Il ponte è ubicato sull alveo del fiume Salsola a circa 2 Km dal centro di Lucera (FG). Le coordinate geografiche del ponte sono: Longitudine
PONTE GALLUCCI A LUCERA (FG) UBICAZIONE E CARATTERISTICHE GEOMETRICHE Il ponte è ubicato sull alveo del fiume Salsola a circa 2 Km dal centro di Lucera (FG). Le coordinate geografiche del ponte sono: Longitudine
I VIAGGI NEI TESTI OMERICI
 I VIAGGI NEI TESTI OMERICI I VIAGGI GRECI I Greci impararono l arte navale dai Fenici. Nell Egeo le prime imbarcazioni che attraversarono il mare furono quelle dei popoli delle Cicladi. Le navi e le tecniche
I VIAGGI NEI TESTI OMERICI I VIAGGI GRECI I Greci impararono l arte navale dai Fenici. Nell Egeo le prime imbarcazioni che attraversarono il mare furono quelle dei popoli delle Cicladi. Le navi e le tecniche
Preview ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA
 Preview ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA PERNISA MATTEO A seguire un assaggio del libro ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA di Matteo Pernisa. In particolare, nell estratto, l autore analizza alcune soluzioni difensive
Preview ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA PERNISA MATTEO A seguire un assaggio del libro ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA di Matteo Pernisa. In particolare, nell estratto, l autore analizza alcune soluzioni difensive
Il trincerone di Grigno Scheda storica
 Il trincerone di Grigno Scheda storica Scheda tratta da Luca Girotto, Il trincerone di Grigno. Una linea Maginot di Valsugana, 2008 Prima della Grande Guerra, gli apprestamenti difensivi di confine realizzati
Il trincerone di Grigno Scheda storica Scheda tratta da Luca Girotto, Il trincerone di Grigno. Una linea Maginot di Valsugana, 2008 Prima della Grande Guerra, gli apprestamenti difensivi di confine realizzati
5.1 Casa Baronale (ex Castello del 1500) Torre Medioevale Torre della masseria Colabaldi... 75
 5. ARCHITETTURA MILITARE 5.1 Casa Baronale (ex Castello del 1500)... 68 5.2 Torre Medioevale... 72 5.3 Torre della masseria Colabaldi... 75 Il parco degli aranci Olio su legno cm. 100 x 70. 67 5.1 Casa
5. ARCHITETTURA MILITARE 5.1 Casa Baronale (ex Castello del 1500)... 68 5.2 Torre Medioevale... 72 5.3 Torre della masseria Colabaldi... 75 Il parco degli aranci Olio su legno cm. 100 x 70. 67 5.1 Casa
LA DIDATTICA DEL GIOCO
 LA DIDATTICA DEL GIOCO Sono proposte una serie d'esercitazioni, partendo dai fondamentali individuali fino alla costruzione di un gioco di squadra, per migliorare l acquisizione di una tecnica specifica
LA DIDATTICA DEL GIOCO Sono proposte una serie d'esercitazioni, partendo dai fondamentali individuali fino alla costruzione di un gioco di squadra, per migliorare l acquisizione di una tecnica specifica
Quando vissero. Verso il 1100 a.c. in Mesopotamia arrivò un altro popolo:gli Assisi,che vivevano in Siria, sulle montagne vicine al fiume Trigri.
 Assiri Schema Quando vissero Verso il 1100 a.c. in Mesopotamia arrivò un altro popolo:gli Assisi,che vivevano in Siria, sulle montagne vicine al fiume Trigri. Religione La religione Assira. Gli assiri
Assiri Schema Quando vissero Verso il 1100 a.c. in Mesopotamia arrivò un altro popolo:gli Assisi,che vivevano in Siria, sulle montagne vicine al fiume Trigri. Religione La religione Assira. Gli assiri
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE SETTORE MARITTIMO
 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE SETTORE MARITTIMO MODULO : UNO UNITA : TRE SCAFI IN ACCIAIO La necessità di costruire navi sempre più grandi e con una certa rapidità, ha portato ad abbandonare il legno
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE SETTORE MARITTIMO MODULO : UNO UNITA : TRE SCAFI IN ACCIAIO La necessità di costruire navi sempre più grandi e con una certa rapidità, ha portato ad abbandonare il legno
Strategia in tempo reale orientata alla conquista militare. Elementi di ruolo fondamentali nel combattimento.
 Strategia in tempo reale orientata alla conquista militare. Elementi di ruolo fondamentali nel combattimento. Linea di sviluppo basata su battaglie, luoghi e personaggi storici. Scopri tutti i segreti
Strategia in tempo reale orientata alla conquista militare. Elementi di ruolo fondamentali nel combattimento. Linea di sviluppo basata su battaglie, luoghi e personaggi storici. Scopri tutti i segreti
PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
 PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE 2EI Docente Disciplina Prof.ssa SARA ZUPPANI STORIA Unità di Lavoro 1: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE Periodo: settembre dicembre LE ORIGINI DI ROMA Tra storia
PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE 2EI Docente Disciplina Prof.ssa SARA ZUPPANI STORIA Unità di Lavoro 1: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE Periodo: settembre dicembre LE ORIGINI DI ROMA Tra storia
ATTACCO Dal settore GIOVANILE Alla 1^ SQUADRA
 ATTACCO Dal settore GIOVANILE Alla 1^ SQUADRA PalaGeorge MONTICHIARI 31 gennaio 2015 QUANDO INSEGNARLO? Inserire come forma di gioco le fasi di attacco nel minivolley ESEMPIO Motricità generale abbinati
ATTACCO Dal settore GIOVANILE Alla 1^ SQUADRA PalaGeorge MONTICHIARI 31 gennaio 2015 QUANDO INSEGNARLO? Inserire come forma di gioco le fasi di attacco nel minivolley ESEMPIO Motricità generale abbinati
15. L accampamento romano
 15. L accampamento romano Polibio (6, 27-32) descrive come ai suoi tempi (un secolo prima dell età cesariana) i Romani ponevano i loro accampamenti. 27. Il modo di accamparsi dei Romani è il seguente.
15. L accampamento romano Polibio (6, 27-32) descrive come ai suoi tempi (un secolo prima dell età cesariana) i Romani ponevano i loro accampamenti. 27. Il modo di accamparsi dei Romani è il seguente.
ANTROPIZZAZIONE DEL TERRITORIO E INSEDIAMENTI URBANI
 Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Ferrara Corso di PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI Prof. Ing. Maurizio Biolcati Rinaldi ANTROPIZZAZIONE DEL TERRITORIO E INSEDIAMENTI URBANI
Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Ferrara Corso di PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI Prof. Ing. Maurizio Biolcati Rinaldi ANTROPIZZAZIONE DEL TERRITORIO E INSEDIAMENTI URBANI
Coordinativi: Tecnici: Fisici Tattica individuale: Tattica collettiva: DESCRIZIONE FASE INIZIALE: (tempo15/20 minuti)
 del 02/11/2010 30 Messa in moto con la palla: orologio per la tecnica di base due giocatori al centro di un cerchio formato dai compagni di squadra ognuno con un pallone, vanno a cercare un compagno per
del 02/11/2010 30 Messa in moto con la palla: orologio per la tecnica di base due giocatori al centro di un cerchio formato dai compagni di squadra ognuno con un pallone, vanno a cercare un compagno per
L Alto Medioevo: Da Roma ad Aquisgrana. L impero romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero
 L Alto Medioevo: Da Roma ad Aquisgrana L impero romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero II secolo d.c : l apogeo dell Impero Con Traiano (98-117) l Impero Romano raggiunse la massima estensione. Il
L Alto Medioevo: Da Roma ad Aquisgrana L impero romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero II secolo d.c : l apogeo dell Impero Con Traiano (98-117) l Impero Romano raggiunse la massima estensione. Il
Forte San Felice https://www.facebook.com/fortesanfelice
 Forte San Felice Per informazioni: Comitato per il Forte San Felice https://www.facebook.com/fortesanfelice www.comitatofortesanfelice.it info@comitatofortesanfelice.it erminiobibi@hotmail.com Originariamente
Forte San Felice Per informazioni: Comitato per il Forte San Felice https://www.facebook.com/fortesanfelice www.comitatofortesanfelice.it info@comitatofortesanfelice.it erminiobibi@hotmail.com Originariamente
Missione 1 Operazione Mercurio
 Missione 1 Operazione Mercurio 20 maggio 1941 Aerodromo, dintorni di Maleme, Creta. 1 2 3 4 1: Punto di partenza 2: Alla riscossa 3: Circondati 4: Imboscata : Assalto all aerodromo : Offensiva finale Missione
Missione 1 Operazione Mercurio 20 maggio 1941 Aerodromo, dintorni di Maleme, Creta. 1 2 3 4 1: Punto di partenza 2: Alla riscossa 3: Circondati 4: Imboscata : Assalto all aerodromo : Offensiva finale Missione
A.S LA MITICA 5C AGLI SCAVI DI OSTIA ANTICA
 A.S. 2018 19 LA MITICA 5C AGLI SCAVI DI OSTIA ANTICA LA NECROPOLI Appena entrati negli scavi, il maestro Antonio ci ha mostrato diversi tipi di sarcofagi che si dividevano in quelli per i più ricchi e
A.S. 2018 19 LA MITICA 5C AGLI SCAVI DI OSTIA ANTICA LA NECROPOLI Appena entrati negli scavi, il maestro Antonio ci ha mostrato diversi tipi di sarcofagi che si dividevano in quelli per i più ricchi e
MOD.G ALLEGATO 2. Check list per il rischio caduta dall'alto. CPT Firenze Via Lorenzo Il Magnifico, Firenze - Tel. 055/ /
 MOD.G ALLEGATO 2 Check list per il rischio caduta dall'alto CONFORME NON CONFORME A.2.1 Nei lavori in quota oltre i 2 m, sono state adottate adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali
MOD.G ALLEGATO 2 Check list per il rischio caduta dall'alto CONFORME NON CONFORME A.2.1 Nei lavori in quota oltre i 2 m, sono state adottate adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali
Giavellotto. Verifica attrezzi
 Giavellotto Verifica attrezzi Caratteristiche Verifica attrezzi Il giavellotto è composto di tre parti: una testa, un fusto ed una impugnatura di corda. - Il fusto deve essere solido o cavo (vuoto) e deve
Giavellotto Verifica attrezzi Caratteristiche Verifica attrezzi Il giavellotto è composto di tre parti: una testa, un fusto ed una impugnatura di corda. - Il fusto deve essere solido o cavo (vuoto) e deve
Allegato B (Articolo 5 e 11)
 Allegato B (Articolo 5 e 11) Nell ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi: Categoria C : - agente; - assistente; - assistente
Allegato B (Articolo 5 e 11) Nell ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi: Categoria C : - agente; - assistente; - assistente
Cursus honorum. honorum ed era costituito da una serie di tappe successive che culminavano nel
 Magistrature a Roma Età monarchica Le istituzioni dell età monarchica (753-509 a.c) Re: nominato a vita dal senato con ratifica dei comizi curiati (lex curiata de imperio), accentrava in sé le funzioni
Magistrature a Roma Età monarchica Le istituzioni dell età monarchica (753-509 a.c) Re: nominato a vita dal senato con ratifica dei comizi curiati (lex curiata de imperio), accentrava in sé le funzioni
GLI AVVENIMENTI DELLA REPUBBLICA
 GLI AVVENIMENTI DELLA REPUBBLICA 1. ROMA CONQUISTA L'ITALIA ROMA POCO A POCO SI INGRANDISCE. INIZIA INFATTI A CONQUISTARE I TERRITORI VICINI, CACCIANDO VIA LE POPOLAZIONI CHE LI ABITAVANO, CIOÈ: GLI ETRUSCHI
GLI AVVENIMENTI DELLA REPUBBLICA 1. ROMA CONQUISTA L'ITALIA ROMA POCO A POCO SI INGRANDISCE. INIZIA INFATTI A CONQUISTARE I TERRITORI VICINI, CACCIANDO VIA LE POPOLAZIONI CHE LI ABITAVANO, CIOÈ: GLI ETRUSCHI
216 a.c. - LA BATTAGLIA DI CANNE
 La battaglia di Canne fu combattuta tra Cartaginesi e loro alleati ed esercito romano in data il 2 Agosto del 216 a.c. a Canne, una località nel sud della penisola italiana nell'odierna Puglia. Essa fu
La battaglia di Canne fu combattuta tra Cartaginesi e loro alleati ed esercito romano in data il 2 Agosto del 216 a.c. a Canne, una località nel sud della penisola italiana nell'odierna Puglia. Essa fu
Armature. Il tipo di armatura (leggera, media o pesante) viene determinato a secondo del materiale di cui è costituita l'armatura stessa.
 Armature Il tipo di armatura (leggera, media o pesante) viene determinato a secondo del materiale di cui è costituita l'armatura stessa. Le armatura hanno dei punti ferita che scendono ogniqualvolta vieni
Armature Il tipo di armatura (leggera, media o pesante) viene determinato a secondo del materiale di cui è costituita l'armatura stessa. Le armatura hanno dei punti ferita che scendono ogniqualvolta vieni
Lezione 1. Fondamentali
 La Scacchiera La figura seguente illustra il terreno dello scontro tra i due giocatori, i pezzi disponibili e la posizione di inizio del gioco. GIOCATORE CON IL NERO SEDUTO DA QUESTA PARTE GIOCATORE CON
La Scacchiera La figura seguente illustra il terreno dello scontro tra i due giocatori, i pezzi disponibili e la posizione di inizio del gioco. GIOCATORE CON IL NERO SEDUTO DA QUESTA PARTE GIOCATORE CON
I Fenici. Mondadori Education
 I Fenici La civiltà fenicia si sviluppò sulle coste orientali del Mar Mediterraneo, in un territorio stretto e montuoso affacciato sul mare. Dalle foreste che lo ricoprivano i Fenici ricavavano molto legname
I Fenici La civiltà fenicia si sviluppò sulle coste orientali del Mar Mediterraneo, in un territorio stretto e montuoso affacciato sul mare. Dalle foreste che lo ricoprivano i Fenici ricavavano molto legname
Gli alberghi elencati sono convenzionati con RAVENNA SUMMER RUGBY FESTIVAL. hotel OCEANOMARE hotel AMBRA Gran hotel MATTEI. tels
 5 03 2017 2017 ipassatelli... PRIGIONIERI E IBERNATI PER TRENT ANNI ABBIAMO FATTO UN VIAGGIO NEL TEMPO E DI COLPO I NOSTRI SENSI, RISVEGLIATI, HANNO RISSAPORATO ANTICHE SENSAZIONI: IL RUMORE DEI TACCHETTI
5 03 2017 2017 ipassatelli... PRIGIONIERI E IBERNATI PER TRENT ANNI ABBIAMO FATTO UN VIAGGIO NEL TEMPO E DI COLPO I NOSTRI SENSI, RISVEGLIATI, HANNO RISSAPORATO ANTICHE SENSAZIONI: IL RUMORE DEI TACCHETTI
ROMA IMPERIALE. SCUBlMONDO 5 - STORlA. Commercio e artigianato
 Commercio e artigianato ROMA IMPERIALE Prima del periodo imperiale gli artigiani romani realizzavano una quantità limitata di prodotti e li vendevano nell Italia del centro e del sud. Ma durante il periodo
Commercio e artigianato ROMA IMPERIALE Prima del periodo imperiale gli artigiani romani realizzavano una quantità limitata di prodotti e li vendevano nell Italia del centro e del sud. Ma durante il periodo
Parte 3. Gli Inglesi. Sergente inglese
 Parte 3 Gli Inglesi Come già detto, tra gli inglesi ho scelto di riprodurre anche soldati di rango inferiore come sergenti e fanti ed i figurini usati appartengono anche in questo caso a diverse ditte:
Parte 3 Gli Inglesi Come già detto, tra gli inglesi ho scelto di riprodurre anche soldati di rango inferiore come sergenti e fanti ed i figurini usati appartengono anche in questo caso a diverse ditte:
Scritto da Administrator Martedì 08 Gennaio :50 - Ultimo aggiornamento Martedì 23 Aprile :08
 Parte 3 Gli Inglesi Come già detto, tra gli inglesi ho scelto di riprodurre anche soldati di rango inferiore come sergenti e fanti ed i figurini usati appartengono anche in questo caso a diverse ditte:
Parte 3 Gli Inglesi Come già detto, tra gli inglesi ho scelto di riprodurre anche soldati di rango inferiore come sergenti e fanti ed i figurini usati appartengono anche in questo caso a diverse ditte:
ema Si suddividono in: Arma bianca lunga: spade, sciabole Arma bianca corta: daghe, pugnali, coltelli
 Armi ema Bianche Si definiscono armi bianche (dal colore dell acciaio) tutte le armi che feriscono di punta o di taglio; le armi bianche sono tutte quelle armi, destinate esclusivamente al combattimento,
Armi ema Bianche Si definiscono armi bianche (dal colore dell acciaio) tutte le armi che feriscono di punta o di taglio; le armi bianche sono tutte quelle armi, destinate esclusivamente al combattimento,
PRINCIPALI SISTEMI DIFENSVIVI
 PRINCIPALI SISTEMI DIFENSVIVI 1 CENTRO MEDIANO AVANZATO POSIZIONE DI PARTENZA Sistema difensivo che prevede la difesa del pallonetto da parte del centro mediano avanzato (zona 6) particolarmente usato
PRINCIPALI SISTEMI DIFENSVIVI 1 CENTRO MEDIANO AVANZATO POSIZIONE DI PARTENZA Sistema difensivo che prevede la difesa del pallonetto da parte del centro mediano avanzato (zona 6) particolarmente usato
L ORIGINE E SIGNIFICAT O DEL NOME
 I CASTELLI L ORIGINE E SIGNIFICAT O DEL NOME La parola castello deriva dal latino medioevale castellum, che è un diminutivo deformato dal latino classico castrum, il quale però possiede due significati:
I CASTELLI L ORIGINE E SIGNIFICAT O DEL NOME La parola castello deriva dal latino medioevale castellum, che è un diminutivo deformato dal latino classico castrum, il quale però possiede due significati:
I SUMERI - ALLEVAMENTO: ALLEVAVANO PECORE, CAPRE, MAIALI, ASINI E BUOI. - ARTIGIANATO: COSTRUIVANO OGGETTI PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI, COME VASI.
 I SUMERI CIRCA 6000 ANNI FA UNA POPOLAZIONE CHE VIVEVA SULLE MONTAGNE A NORD DELLA MESOPOTAMIA SI SPOSTÒ VERSO SUD, DOVE SI TROVAVANO LE PIANURE. IN QUESTI NUOVI TERRITORI, QUESTE PERSONE COSTRUIRONO CANALI
I SUMERI CIRCA 6000 ANNI FA UNA POPOLAZIONE CHE VIVEVA SULLE MONTAGNE A NORD DELLA MESOPOTAMIA SI SPOSTÒ VERSO SUD, DOVE SI TROVAVANO LE PIANURE. IN QUESTI NUOVI TERRITORI, QUESTE PERSONE COSTRUIRONO CANALI
