ULTERIORI DATI SULL ENTOMOFAUNA LEGATA AL PINO NERO (PINUS NIGRA ARNOLD) SULL APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA VAL LAMONE
|
|
|
- Letizia Arcuri
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna Quad. Studi Nat. Romagna, 29: (dicembre 2009) ISSN Ettore Contarini ULTERIORI DATI SULL ENTOMOFAUNA LEGATA AL PINO NERO (PINUS NIGRA ARNOLD) SULL APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA VAL LAMONE (Insecta Coleoptera, Neuropteroidea, Hymenoptera) Riassunto Dopo il primo contributo (Co n ta r i n i, 1997) sulla coleotterofauna del pino nero sull Appennino toscoromagnolo, l autore riporta nel presente lavoro il frutto di ulteriori indagini avvenute nell ultimo decennio, allargando le conoscenze anche a Neuropteroidea e Hymenoptera, oltre a nuovi dati su Coleoptera di famiglie varie. Abstract [Further data on insects associated with the European Black Pine, Pinus nigra Arnold, in the Tosco- Romagnolo Apennine, with particular regard to the Lamone Valley]. This paper is the continuation of the first contribution (Co n ta r i n i, 1997) to the knowledge of Coleoptera associated with European Black Pine in the Tosco-Romagnolo Apennine, with particular regard to the Lamone Valley. It deals with the researches carried out in last twelve years. Besides new data on Coleoptera, also data on Neuropteroidea and Hymenoptera are reported. Key words: European Black Pine, Coleoptera, Neuropteroidea, Hymenoptera, Apennines. Situazione ambientale odierna delle pinete esaminate Dodici anni dopo un precedente contributo sull argomento (Co n ta r i n i, 1997), ulteriori indagini svolte metodicamente in quest ultimo decennio negli stessi e attigui settori boschivi a pino nero hanno condotto a nuovi ritrovamenti per la zona e a conferme di specie rare già note, in particolare di coleotteri, che meritano di essere qui presentati a completamento faunistico del quadro-dati precedente. S è appena detto in particolare di coleotteri poiché in questo 2 contributo vengono presi in considerazione anche altri ordini di insetti (Neurotteroidei e Imenotteri). Le ricerche hanno interessato varie località della media val Lamone, tra i 330 e i 610 metri circa s.l.m., tutte poste nel comune di Marradi (FI): dal basso verso l alta valle, Camosciano, Badia di Borgo, Val Fontana, Biforco/Cardeto, Camurano, Poggiol di Termini, Fantino, Val Zerbera, Valbura, Crespino. Le formazioni artificiali a pino nero esaminate presentano grossomodo dai 50 ai 70 anni di età, poiché sono il frutto dei primi piani di rimboschimento locale resi operativi poco prima e poco 19
2 dopo l ultima guerra mondiale. In molti settori della val Lamone queste pinete appaiono oggi, però, in più o meno accentuato deperimento, fenomeno che si è enormemente dilatato proprio in quest ultimo decennio, quasi a significare che la loro vita e le loro funzioni protettive dei suoli degradati siano ormai giunte alla fine del loro naturale corso. (Fig. 1). Al loro posto, in molti settori delle pinete esaminate sta rigenerandosi l antico bosco autoctono dove ributtano su spesso, anche vigorosamente, la roverella, l orniello, il carpino nero, il perastro e tutti gli arbusti tipici del querco-ostrieto xerofilo (Fig. 2). E verosimile che una delle cause di deperimento sia dovuto al fatto che i pini, crescendo, hanno trovato sotto il modesto strato umoso-detricolo la roccia e che le radici non abbiano più spazio e sostanza per nutrire la pianta. In varie zone infatti, e specialmente sulla sinistra idrografica della val Lamone tra Camurano e Fantino, le piante sane sono rimaste spesso meno del 30% e anche queste con segni evidenti di deperenza nelle chiome. Molti appaiono gli scheletri ancora in piedi e molte le piante morte al suolo, creando così una notevole necromassa legnosa ai vari livelli di disfacimento: dai primi rametti morti sulle piante vive ai vari gradi di deperimento dei pini, morti ancora eretti (Fig.3), fino ai tronchi caduti in ogni stadio di marcescenza (Figg. 4 e 5) e attaccati dai demolitori vegetali e animali. Motivi dell indagine e metodi di ricerca In questo ampio ventaglio di situazioni, gli insetti xilofagi e xilodetriticoli trovano una grande gamma di adattamenti alle loro esigenze specifiche tanto da creare una successione ecologica di infestazioni temporali nello stesso legname. Al seguito di questa entomofauna specializzata si inserisce nella zoocenosi, naturalmente, anche la sua relativa componente di predatori e di parassiti. Tale composito quadro microfaunistico, in vario modo bio-ecologico o trofico legato al pino nero, appare uno spaccato di piccola ma intensa vita estremamente complessa e nella quale non è facile l accertamento dei complicati rapporti che intercorrono tra gli elementi che compongono la zooassociazione stessa. Ma è questo il motivo principale della ricerca. Oltre agli aspetti qualitativi, vi sono spesso da considerare, per una valutazione globale, anche quelli quantitativi. Questi ultimi, sebbene difficili da stimare come biomasse specifiche per unità di superficie, mostrano spesso dei rapporti abbastanza costanti nel numero di individui tra una specie e l altra. Ossia certe entità risultano, confrontando le varie stazioni di rilevamento dei dati, sempre rare, altre sempre comuni, altre ancora frequenti, e così via. Determinare le cause, magari convergenti in taluni casi, di queste dominanze o di queste rarefazioni appare a volte arduo. Influiscono concause diversissime, dalla prolificità di una specie calcolata in numero di uova deposte alle difficoltà delle femmine con maggiori esigenze nel cercare il luogo adatto all ovodeposizione, dall incidenza a volte molto elevata dei parassitoidi delle larve (specialmente imenotteri aculeati e ditteri tachinidi) alla presenza di predatori sottocorticali come i neurotteroidei 20
3 (inocellidi, rafididi, ecc.), fino all influenza dell andamento stagionale dell annata con le sue conseguenze di maggior o minor incidenza sulle condizioni sanitarie degli stadi preimmaginali: troppa siccità, quindi disidratazione del legno morto e conseguente disidratazione anche delle larve ivi contenute; troppa umidità, dunque insorgenza delle pericolosissime muffe che attaccano i tessuti delle larve stesse. Molto importante per certe valutazioni e stime quantitative risulta l allevamento in laboratorio incamerando a volte anche interi tronchi prelevati a pezzi dal bosco, dopo averne accertato le infestazioni, e portando a termine lo sfarfallamento di tutto il contenuto biologico con i dovuti accorgimenti tecnici. Tale tecnica, se ben applicata, da sempre buoni risultati faunistico-quantitativi e mostra anche un altro pregio, ossia quello della sicura provenienza degli esemplari ottenuti in base al tipo di legno raccolto. Meno idonea invece, a tale proposito, è risultata la tecnica di raccolta con le trappole-esca aeree (con aceto di vino, o birra, e sale da cucina; rispettivamente attirante e conservante). Benchè poste in serie, a varie altezze dal suolo, sulle piante (generalmente dai 3 ai 7 metri), oltre in molti casi a modeste catture quantitative il materiale reperito non permette con sicurezza di verificare la provenienza degli esemplari catturati. Non di rado entrano nelle bottiglie-esca anche specie sicuramente tipiche delle latifoglie; e viceversa se si indagano queste ultime, con lo stesso sistema aereo, in ambienti adiacenti di conifere e boschi a foglia caduca. Risultati delle indagini Vengono qui di seguito presentate e commentate le specie meritevoli di essere evidenziate. Si tratta generalmente di entità non inserite nel precedente lavoro (Co n ta r i n i, 1997), a parte pochi casi in cui per il taxon, pur già citato del pino nero, sono apparsi ulteriori dati sulla conoscenza della sua bio-ecologia, o distribuzione, o frequenza. ORDINE COLEOPTERA Fam. Elateridae Lacon punctatus (Herbst) Sporadici adulti sono stati rinvenuti nel legno morto di pino nero (ceppaie abbastanza fradicie e degradate) durante i mesi invernali, allo stesso modo come nelle pinete costiere di Ravenna la specie viene raccolta su pino domestico (Pinus pinea) e su pino marittimo (Pinus pinaster). La specie risulta presente, però, anche nel legno di varie latifoglie e secondo Platia (1994) la larva sarebbe zoosaprofaga, mentre gli adulti mostrano abitudini notturne con attività sul legname e dentro le carie dei tronchi. Nello stesso legname, specialmente se tenero e spugnoso, essi passano anche i mesi più freddi al riparo dai rigori dell inverno. 21
4 Fig. 1 Aspetto di pineta deperente di pino nero in località Camurano di Marradi (FI) (Foto E. Contarini, 2007). Fig. 2 Aspetto di pineta deperente di pino nero che nell ultimo decennio ha regredito verso l alto incalzata dal rigoglio della vegetazione indigena (roverella, carpino nero, orniello, ginestra odorosa, ecc.) che dopo gli interventi di riforestazione artificiale si sta riappropriando del territorio. Qui in località Poggiol di Termini (Marradi-FI). (Foto E. Contarini, 2006). 22
5 Fig. 3 Primo piano di pini neri morti o molto deperenti in località Monte dell Oro (Camurano di Marradi-FI) (Foto E. Contarini, 2007). Fig. 4 Grosso tronco morto al suolo di pino nero, già molto degradato, con gli evidentissimi attacchi delle numerose specie di parassiti xilofagi e successivamente di entità xilodetriticole che lungo gli anni lo hanno ridotto a una gruviera di gallerie colme di rosure (Foto E. Contarini, 2006). 23
6 Fam. Buprestidae Phaenops knoteki ssp. ochsi (Schaefer) Entità biologicamente legata al legno di varie conifere, per l Italia risultava finora infeudata (Cu r l e t t i, 1994) solamente su abete bianco (Abies alba), insediamento ben noto anche per l alto Appennino tosco-romagnolo e in particolare nell ambito delle Foreste Casentinesi, (ora facenti parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna). Ma Sc h a e f e r (1949) per la Francia come piante nutrici delle larve cita anche l abete rosso (Abies pectinata; ora divenuto Picea excelsa) e il larice (Larix decidua). Inoltre, lo stesso Autore per l area afro-mediterranea riporta la ssp. barbeyi come elemento legato all abete di Numidia (Abies numidica). Sull Appennino tosco-romagnolo, come già accennato, questo buprestide dalle elitre bluastre è sempre stato ritenuta specie caratteristica delle abetine dell orizzonte montano a clima subatlantico. Ora, Phaenops knoteki ochsi è risultata la specie di coleottero, in numero di esemplari per unità di biomassa legnosa, più comune e diffusa nei tronchi morti di pino nero del piano alto-collinare/basso-submontano della val Lamone. Ulteriori ricerche, ampliate, permetteranno in futuro di conoscere se, com è verosimile, questa specie è presente anche nelle vallate parallele, ossia del Senio e del Santerno, a nord, e dell Acerreta, del Tramazzo, del Montone, del Ronco, ecc., a sud. Tornando alla diffusione accertata per la val Lamone, le concentrazioni locali di individui adulti sfarfallati in cattività sono a volte apparse eccezionali, con fino a 28 esemplari per metro di tronco portato in laboratorio in allevamento (sezione centimetri 25-35). periodo di sfarfallamento, generalmente dal 10 al 30 giugno. Ma al di là dei valori quantitativi, senz altro meritevoli di essere sottolineati, risulta importante la presenza della specie come parassita del genere Pinus poiché dalla letteratura specialistica consultata nessun autore nomina questo tipo di piante come nutrici delle larve. Fam. Bostrichidae Scobicia pustulata (Fabricius) Si contano due soli reperti, occasionali, in ambiente pineticolo, vagliando il detrito sottoboschivo alla base di pini deperenti (in località Fantino). Ma si dubita del legame biologico con questo tipo di legname. Verosimilmente, gli esemplari provenivano dai vicini boschi di latifoglie, e in particolare dalle formazioni a roverella dove questa Scobicia risulta diffusa. Fam. Anobiidae Dryophilus pusillus (Gyllenhal) Pochi reperti occasionali rinvenuti sull esterno di cortecce morte, in tronchi caduti di pino nero. 24
7 Fam. Tenebrionidae Uloma culinaris (Linnaeus) Enoplopus dentipes (Rossi) Stenomax lanipes (Linnè) Le tre entità rinvenute mostrano un irrilevante valore bio-ecologico poichè si tratta di tre specie fruitrici del legno molto degradato di ogni tipo dove trovano rifugio, specialmente durante i mesi freddi, e sostanze organiche alimentari che fungono da pabulum. Fam. Cleridae Opilo domesticus (Sturm) Thanasinus formicarius (Linnaeus) Necrobia ruficollis (Fabricius) Essendo a livello larvale una ben nota famiglia di coleotteri predatori, la presenza di queste specie nel legname in questione (sotto cortecce, dentro gallerie di coleotteri xilofagi, nelle carie dei tronchi), sia con larve che con adulti, indica chiaramente un complesso rapporto predatori/predati tra i cleridi e molti altri piccoli invertebrati che con loro convivono, non ultime le larvette di insetti xilofagi e xilodentricoli nonché quelle di vari imenotteri sociali (come vespidi, formicidi del genere Camponotus, ecc.) che vengono aggredite nei loro nidi posti all intorno del legno cariato. Fam. Cerambycidae Asenum tenuicorne Kraatz Benchè specie già citata per la coleotterofauna del pino nero di questo territorio (Co n ta r i n i, 1997), si riprende il discorso poiché le indagini faunistiche di campagna effettuate sistematicamente in quest ultimo decennio hanno ampiamente evidenziato anche gli aspetti quantitativi e di capillare diffusione di questo cerambicide che meritano di essere qui sottolineati. A. tenuicorne è apparso presente in quasi tutti i fusti morti in cui sono avvenuti prelievi legnosi di grosso diametro (almeno 20 centimetri di sezione); convivendo in diversa misura quantitativa con le altre due specie di coleotteri più abbondanti sul pino nero locale: Arphopalus syriacus e il buprestide Phaenops knoteki ochsi. Spesso, a dispetto della presenza massiccia di queste due ultime specie commensali nello stesso fusto, Asenum è apparso tramite sfarfallamento in laboratorio con adulti per metro lineare di tronco. Alla fine della stagione delle schiuse, sotto la corteccia resta un incredibile gruviera di sforacchiature (rivedi fig. 4). Tutte tre le specie succitate mostrano attività intensa sottocorticale dall estate precedente, ossia alla nascita delle larvette, fino alla primavera (aprile-maggio). Dopodichè si infossano nel primo strato di legno sottostante la corteccia (per 1-2 centimetri) e passano allo stadio di ninfa in celletta appositamente costruita da ogni singola larva. Asenum e Phaenops sfarfallano contemporaneamente, grossomodo da metà 25
8 Fig. 5 Pineta a pino nero molto degradata presso Camurano di Marradi (FI) dov è evidenziata la notevole necromassa legnosa al suolo e ancora in piedi (Foto E. Contarini, 2008). 26
9 Fig. 6 Larva del neurotteroideo Parainocellia bicolor (Fam. Inocelliidae), il più diffuso predatore sottocorticale delle larve di coleotteri xilofagi nel territorio qui considerato (Foto E. Contarini, 2007). Fig. 7 Adulto (in preparato da studio su cartellino) di Mantispa styriaca, un neurotteroideo della famiglia mantispidi rinvenuto nella fessurazione dei tronchi morti di pino nero (Foto E. Contarini, 2007). 27
10 giugno a metà luglio, mentre Arhopalus appare con adulti molto scaglionati nel tempo, tra luglio e settembre, a volte fino ai primi di ottobre. In questa fitta convivenza, a volte fors anche difficile per questione di spazi vitali da suddividersi, intervengono i predatori interni, ossia altri invertebrati (in particolare neurotteroidei, vedi oltre, e imenotteri formicidi), e quelli esterni, picchi specialmente che bucherellano fittamente il tronco morto facendo strage di larve. A. tenuicorne si è così dimostrato, dopo le modeste raccolte degli anni 90, una entità largamente diffusa in tutta la media val Lamone e con biomasse locali elevatissime. Come per Phaenops knoteki ochsi (vedi) sarà interessante negli anni prossimi compiere indagini sul pino nero delle valli più a nord e più a sud della val Lamone allo scopo di accertare la presenza della specie. Ma già nella vallata parallela dell Acerreta le indagini svolte da un collega (Us v e l l i, 2003) ne hanno evidenziato la diffusa presenza. Arhopalus (= Criocephalus) syriacus (Reitter) Parlando del congenere Arphopalus (= Criocephalus) ferus (Muls.), nel già citato lavoro sul pino nero dell Appennino tosco-romagnolo (Co n ta r i n i, 1997), si riportava che tale specie, dalla costa adriatica all adiacente Appennino, negli ultimi decenni era divenuta ormai introvabile e che al suo posto nelle pinete litoranee romagnole era dilagato letteralmente il congenere A. syriacus (Reitter), con apparizioni qua e là nell adiacente piano collinare. Quest ultimo però, sempre da Co n ta r i n i (l.c.), si riteneva che in Appennino, e specialmente nella sua parte medio-alta più fresca, non arriva perché specie più xerofila, legata agli ambienti xerotermici e submediterranei. A. ferus, infatti, risulta un elemento legato ad ambienti forestali tendenzialmente più freschi e ombrosi, un po più umidi; mentre A. syriacus, entità a distribuzione più asiatica, appare nettamente di ambienti caldo-asciutti, spesso a boscaglia rada e degradata, con forte penetrazione del sole nel sottobosco. Quindi, una sensibile differenza appare nelle esigenze ecologiche dei due taxa. Tali valutazioni erano già state espresse da Tassi (1968) e riprese e confermate da Co n ta r i n i & Ga r a g n a n i (1980). Nell arco, relativamente breve, degli ultimi anni, con la sicura complicità climatico/ambientale di inverni sempre più tiepidi e mediterranei, A. syriacus è rapidamente riuscito a colonizzare molte pinete sofferenti e degradate di pino nero risalendo le vallate appenniniche. La sua presenza a volte appare addirittura infestante. A livello quantitativo, spesso gli allevamenti in laboratorio hanno evidenziato la presenza di adulti in numero di per metro lineare di tronco prelevato in natura. In un caso limite, da un tronco tagliato a pezzi e portato in allevamento nel mese di marzo, prelevato in località Poggiol di Termini (Marradi-FI), sono sfarfallati oltre 90 adulti, verosimilmente anche per una scarsa competizione degli altri coleotteri xilofagi di norma conviventi (vedi note relative ad Asenum tenuicorne). 28
11 Oxypleurus nodieri Mulsant Specie già citata anche in questo caso nel precedente contributo (Co n ta r i n i, 1997), ma sulla base di reperti non personali (Us v e l l i & Fa b b r i, 1996; Us v e l l i, 2003) per la valle dell Acerreta (Badia della Valle); questa rara specie che rappresenta uno dei cerambicidi di maggior valore faunistico e biogeografico della fauna italiana è stato rinvenuto anche in val Lamone. La sua, seppur molto sporadica, presenza è stata accertata in cime morte di pino nero, di diametro 5-10 centimetri, raccolte da alberi ancora in piedi posti in località Valzerbera di Fantino e Camurano (Marradi-FIaltitudine metri ). Al momento della raccolta del legname infestato, avvenuta a fine inverno, è stato valutato che le piante fossero morte circa un anno prima. La specie, con la sua distribuzione mediterraneo-macaronesica, per l Italia risultava essere, prima di questi recenti rinvenimenti sull Appennino tosco-romagnolo, un elemento faunistico delle regioni tirreniche peninsulari. Fam. Scolytidae Hylurgus palliatus (Gyllenhall) Hylastes angustatus (Herbst) Hylastes ater (Paykull); (= H. piniperda Bedel) Dendroctonus micans (Kugelmann) Lo studio di materiale raccolto negli anni, e in parte accantonato, ha permesso di accertare la presenza, rispetto ai dati presentati in Co n ta r i n i (1997), di altre quattro specie legate al pino nero dell area geografica qui considerata. La diffusione di questi piccoli coleotteri xiloparassiti può avere un ruolo importante (vedi qui di seguito nelle conclusioni ) anche come concausa nello stato di grave deperimento delle pinete locali, in quanto varie specie appartenenti a questa famiglia sono dei parassiti primari che possono arrecare ai boschi anche danni di notevole entità. Essi infestano, infatti, le piante con complessi sistemi di microgallerie sotto le cortecce, tanto da portare prima a uno stato di più o meno accentuata deperenza la chioma poi, a volte, alla morte dell albero indebolito. SUPERORDINE NEUROPTEROIDEA ORDINE RAPHIDIOPTERA Fam. Raphidiidae Phaeostigma notatum (Fabricius) Specie diffusa, per l Italia, solamente nelle regioni settentrionali. La sua presenza sull Appennino tosco-romagnolo rimane comunque con qualche dubbio nella determinazione per la cattura di sole femmine (Pantaleoni R., comunicazione personale dopo aver visionato il materiale). Verosimilmente si tratta della specie qui sopra riportata, a larghissima percentuale di probabilità, ma occorre attendere future indagini faunistiche e la cattura di adulti maschi per disperdere tutte le attuali incertezze sistematiche. 29
12 Fam. Inocelliidae Parainocellia bicolor (Costa) Dalle ricerche effettuate durante molti anni, questo neurotteroideo è apparso il più comune e diffuso tra i predatori sottocorticali del pino nero. Un vero e proprio elemento-chiave della cenosi in esame poiché è apparso come specie-guida sui pini in tutto il territorio preso in esame. La sua presenza capillare è evidenziata dalle frequentatissime larve carnivore viventi nello spesso strato di rosura compattata, dovuta al lavoro delle larve dei coleotteri xilofagi, che funge da umoso cuscinetto tra la corteccia e il legno sottostante. A livello quantitativo, per rendere un idea di frequenza nell unità di spazio, si riporta che in certi tronchi di pino attentamente esaminati, togliendo pezzo a pezzo la corteccia morta, sono stati osservati fino a 6-7 larve di P. bicolor per metro lineare di tronco. E chiaro che tale abbondanza, anche se spesso favorita da altri fattori ecologico-ambientali, appare direttamente legata al grande numero di prede disponibili nello strato sottocorticale. Alla fig. 6 è rappresentata una larva, già matura, di questo neurotteroideo che, squarciato il suo riparo con il sollevamento della corteccia, tenta di ripararsi rapidamente negli anfratti del legno. ORDINE PLANIPENNIA Fam. Mantispidae Mantispa styriaca (Poda) Entità abbastanza diffusa nel territorio in esame (Fig. 7), e ne sono riprova anche le frequenti catture di notte alla luce artificiale in Appennino medio-basso, nel legname di pino nero ne sono stati osservati rari adulti nascosti negli anfratti delle cortecce e nelle fessure dei tronchi abbattuti. Come in tutta la famiglia mantispidi, le larve sono predatrici e posseggono la caratteristica morfologica di cambiare aspetto con le mute, trasformandosi da snelle e dotate di zampe in tozze e apode. Le pupe tornano poi ad essere fornite di zampe e nell insieme, con gli arti anteriori raptatori già ben sviluppati ed evidenti, già assomiglianti ai futuri adulti. Non sono mai state trovate larve nel legno, ma soltanto adulti occasionali che, verosimilmente, avevano trovato rifugio sotto pezzi di corteccia morta sollevata. E il fatto è spiegabile con la particolare vita a livello larvale di questi mantispidi i quali risultano dei predatori di uova e di giovani nei nidi dei ragni. Considerato che negli ammassi di tronchi di pino al suolo, specialmente nei canaloni ripidi dove il legname rotola accumulandosi, proliferano aranei e opilionidi di svariate specie, è verosimile che anche Mantispa styriaca si sviluppi con frequenza. Ma non vi è comunque un diretto rapporto biologico con le pinete e il loro legno. Perlamantispa (= Mantispa) aphavexelte U. & H. Aspöck I pochi adulti osservati lungo gli anni sono stati raccolti sui tronchi di pino 30
13 nero, in natura, mentre erano probabilmente intenti a predare piccoli insetti che frequentano il legname, ditteri in particolare. Come per la specie precedente (vedi), considerata la elevata quantità di necromassa legnosa giacente al suolo ai vari stadi di disfacimento, fino praticamente all humus, si può prospettare che anche codeste larve, predatrici di uova e giovani di ragni, si evolvano negli ammassi legnosi sul terreno dove abbondano aracnidi di numerose specie. ORDINE HYMENOPTERA Fam. Stephanidae Stephanus serrator (Fabricius) Frequenti adulti sono usciti dal legno portato in laboratorio. Si tratta di un tipico parassitoide delle larve dei coleotteri xilofagi. Fam. Formicidae Sono state ripetutamente osservate ricche colonie di due specie di formiche, tipiche del legname avariato, all interno dei tronchi di pino nero ma ancor più spesso nelle ceppaie morte cariate e percorse dalle molte gallerie abbandonate dei coleotteri xilofagi. Più che la specie più piccola, Camponotus truncatus, è apparsa diffusa la congenere, di dimensioni molto maggiori, Camponotus vagus (il cosidetto formicone nero). Considerazioni finali e conclusioni Nel quadro zoocenotico che è stato evidenziato pian-piano, durante le ultraventennali ricerche svolte (vedi tab. 1), la parte senz altro più interessante sotto gli aspetti bio-ecologici e zoogeografici risulta essere quella relativa a un gruppetto di taxa appartenenti alla coleotterofauna xilofaga. Nell ambito di una faunula specializzata più ampia che comprende coleotteri di numerose famiglie, tutti insediati a diverso titolo bioecologico nel legno deperente di pino nero locale, questi elementi caratterizzanti danno un taglio di notevole pregio all associazione qui in esame. Il resto dell entomofauna rilevata, composta da predatori, parassitoidi, fruitori e opportunisti presenti nel legno per le ragioni più varie, per larga parte viene al seguito della componente xilofaga come semplice conseguenza trofica e microambientale di vita offerta da quella comunità stessa di xilofagi recentemente insediatasi nelle pinete dell Appennino tosco-romagnolo. A quest ultimo proposito, è apparsa interessante anche l individuazione di una componente faunistica formata da neurotteroidei i quali, da attivi predatori, entrano a far parte dell associazione degli esapodi del pino nero per ragioni strettamente trofiche. Il più inserito nell ingranaggio bio-etologico predatori-predati è apparso il neurotteroideo inocellide Parainocellia bicolor, nella sua veste di limitatore delle 31
14 COLEOPTERA Fam. ELATERIDAE Lacon punctatus (Herbst) Fam. BUPRESTIDAE Phaenops knoteki ochsi (Schaefer) Anthaxia godeti Castelnau & Gory Anthaxia helvetica apennina Obenberger Chrysobothris solieri Castelnau & Gory Fam. BOSTRICHIDAE Scobicia pustulata (Fabricius) Fam. ANOBIIDAE Dryophilus pusillus (Gyllenhal) Fam. TENEBRIUNIDAE Uloma culinaris (Linnaeus) Enoplopus dentipes (Rossi) Stenomax lanipes (Linnè) Fam. CLERIDAE Opilo domesticus (Sturm) Opilo pallidus (Olivier) Thanasimus formicarius (Linnaeus) Necrobia ruficollis (Fabricius) Fam. CERAMBYCIDAE Corymbia rubra (Linnaeus) Asenum tenuicorne Kraatz Arhopalus ferus (Mulsant) Arhopalus syriacus (Reitter) Oxypleurus nodieri (Mulsant) Hylotrupes bajulus (Linnaeus) Parmena unifasciata (Rossi) Monochamus galloprovincialis (Olivier) Pogonocherus eugeniae Ganglbauer Pogonocherus perroudi Mulsant Acanthocinus griseus (Fabricius) Fam. SCOLYTIDAE Hylurgops palliatus (Gyllenhall) Hylastes angustatus (Herbst) Hylastes ater (Paykull) Dendroctonus micans (Kugelmann) Tomicus destruens (Wollaston) Hylurgus ligniperda (Fabricius) Pitiogenes bidentatus (Herbst) Orthotomicus prossimus (Eichoff) NEUROPTEROIDEA Fam. RAPHIDIIDAE Phaeostigma notatum (Fabricius) Fam. INOCELLIIDAE Parainocellia bicolor (Costa) Fam. MANTISPIDAE Mantispa styriaca (Poda) Perlamantispa aphavexelte U. & H. Aspöck HYMENOPTERA Fam. STEPHANIDAE Stephanus serrator (Fabricius) Fam. FORMICIDAE Camponotus vagus (Scopoli) Camponotus truncatus (Spinola) Tab. 1 Quadro complessivo (dati da Co n ta r i n i, 1997, e dati tratti dal presente lavoro) dell entomofauna del legno di pino nero sull Appennino tosco-romagnolo. 32
15 larve dei coleotteri xilofagi a livello sottocorticale. Questi attivissimi predatori, pur essi allo stato larvale, aggrediscono gli stadi preimmaginali di cerambicidi, buprestidi, anobidi, scolitidi, ecc., per l intero arco di tempo autunno-invernoprimavera fino all impupamento delle loro prede. E non è da escludere che anche parte delle ninfe vengano predate e uccise nelle loro celle ninfali seguendo le tortuose gallerie scavate nel primo strato legnoso dagli stessi stadi larvali dei succitati coleotteri. Ciononostante, la ricchezza numerica di individui di questi ultimi permette ugualmente lo sfarfallamento di numerosissimi esemplari dal legname infestato. Tanto che difficilmente, nelle nostre regioni appenniniche, si possono rilevare delle concentrazioni così elevate di più specie conviventi su conifera e anche su latifoglia. Per portare un esempio significativo, nel periodo giugno-agosto 2007 da un solo tronco di pino nero, di lunghezza metri 2,5 e diametro medio circa 20 centimetri, sono sfarfallati in allevamento 85 adulti appartenenti a 3 taxa: Phaenops knoteki ochsi, Asenum tenuicorne e Arhopalus syriacus. Questo è indubbiamente un caso limite. Ma fino a 50/60 individui, per la stessa quantità di legname, è un evento che si è verificato più volte negli ultimi anni. Una questione di fondo da chiarire, già in parte affrontata in passato (Co n ta r i n i, 1997) ma che rimane in gran parte irrisolta nei suoi nodi biogeografici principali, resta quella dei canali di provenienza delle specie xilofaghe attualmente infeudate sul locale pino nero. Anche ammettendo per il passato una scarsa conoscenza di questa faunula per difetto di ricerche specializzate (scarso uso dell allevamento del legname in laboratorio, mancata applicazione sul campo delle trappole-esca aeree, ecc.) restano sempre da individuare le rotte faunistiche, attive o passive, che questi taxa xilofagi hanno seguito per giungere sul versante adriatico dell Appennino tosco-romagnolo. E che vi siano giunti da poco tempo è una certezza assoluta. Tutti i pini, infatti, oggi presenti sull intero Appennino centro-settentrionale, e quindi non solo il pino nero ma anche tutte le altre specie, risultano tutti di inserimento artificiale. Dall anteguerra ultimo (anni trenta) in poi, ma in particolare negli anni Cinquanta/Sessanta, nell ambito di vasti progetti di rimboschimento su suoli fortemente degradati da secoli di tagli boschivi indiscriminati furono immesse conifere di ogni sorta: da Pinus, (fino alle specie imalaiane!) alla Douglasia americana, da Abies a Picea, da Larix a Cedrus, ecc. Per ritrovare pini indigeni sull Appennino settentrionale, da indagini palinologiche eseguite da studiosi vari sui pollini fossili, a parte qualche molto discusso relitto attuale di pino silvestre sull alto Appennino emiliano, occorre andare indietro nel tempo di varie migliaia di anni, nei periodi freddi postglaciali dell Olocene (Boreale, Subboreale, Atlantico) quando il citato pino silvestre e altri pini arrivavano a colonizzare giù fino alle pianure e al mare Adriatico. Dunque, fino a 60/70 anni fa questa faunula specializzata, strettamente legata biologicamente al pino nero attuale, non poteva ovviamente esistere nel territorio qui esaminato. Da qualche parte è poi chiaro che è arrivata. Conclusione lapalissiana. Ma da dove? E verosimile che ogni specie abbia seguito una sua rotta di colonizzazione, anche considerando la forte capacità 33
16 di dispersione in volo di queste specie macrottere, fino allo stadio di acclimatazione locale favorito negli ultimi due decenni, trattandosi di quasi tutti parassiti secondari, dall attuale situazione ambientale delle pinete che registra una forte moria di pini e di conseguenza una eccezionale possibilità trofica di materiali legnosi a disposizione per lo sviluppo delle larve. E proprio questa enorme necromassa legnosa, lasciata deperire poiché risulta essere un materiale che commercialmente non mostra nessun valore economico (neanche come legna da ardere), ha condotto oltre agli aspetti significativamente qualitativi di questa coleotterofauna xilofaga anche a biomasse specifiche elevate o addirittura eccezionalmente elevate per unità di superficie. Osservando la situazione in proiezione futura, e tenendo conto di un passato appenninico locale senza la presenza dei pini, appare evidente che si tratta di un fenomeno temporale che si prevede avrà un suo decorso limitato ai prossimi decenni. Dopodichè, se continuerà il rapido processo, com è verosimile, di deperimento di queste conifere artificialmente inserite, i resti di tale zoocenosi rimarranno qualitativamente presenti nei relitti pinetali che qua e là senz altro sopravviveranno, ma è indubbio che gli apici eccezionali di biomasse specifiche raggiunti in questi anni non potranno continuare ad esistere. Le entità più mediterranee sono state indubbiamente favorite, come già è stato precedentemente accennato parlando delle singole specie, dagli inverni particolarmente tiepidi che si susseguono con sempre maggior frequenza dagli anni Novanta in poi. E sufficiente, tanto per contrastare le diffuse tesi dei negazionisti climatici di oggigiorno, scorrere i dati relativi alle precipitazioni nevose della prima metà del secolo scorso (anni ) per rendersi conto dei notevoli cambiamenti avvenuti in tempi relativamente brevi. Per il territorio appenninico tosco-romagnolo posto tra i 400 e i 700 metri di altitudine (Za n g h e r i, 1961) si registravano a ogni inverno 4-5 mesi di innevamento del suolo. Vale a dire da novembre a marzo inoltrato sempre con la neve, o quasi, che ricopriva il terreno. Attualmente, sulla stessa area geografica nella maggioranza delle annate non cade neanche un fiocco di neve Tuttalpiù, ogni due-tre anni, si registra una sbiancata di spessore pochi centimetri. L ultimo inverno sufficientemente rigido, degno di questo nome, si è registrato ben 24 anni fa (1985). Questi dati oggettivi dovrebbero portare a considerazioni più razionali rispetto a quelle che frequentemente emergono dalle valutazioni ambientali e naturalistiche di qualche Collega. Tornando, dopo una divagazione che si pensa non superflua, alla coleotterofauna xilofaga del pino nero in esame, certe specie come ad esempio Phaenops knoteki ochsi e Arphopalus syriacus, con una ben nota presenza indigena in passato su Abies alba nell alto Appennino tosco-romagnolo nel primo caso e su Pinus sp. plur. nelle pinete costiere adriatiche romagnole nel secondo caso, mostrano semplicemente un ampliamento di areale distributivo e un adattamento a nuove piante nutrici nell ambito di modificazioni adattive, alimentari ed ecologiche più diverse. Ma per Oxypleurus nodieri, in Italia a diffusione tirrenica, e ancor di 34
17 più per Asenum tenuicorne che risulta specie balcanica non nota per il nostro Paese fino a una ventina di anni fa (Sa m a & Bo c c h i n i, 1992), appare molto più arduo immaginare le vie di penetrazione pioniera nel territorio marradese. A favore dell ipotesi di un pionierismo attivo gioca il fatto che il pino nero è stato capillarmente inserito attraverso centinaia di chilometri di territorio appenninico, con una continuità che oggettivamente può fare da ponte lungo gli anni all espandersi dei parassiti xilofogi che vi sono insediati. Appare quindi ampiamente possibile che, passo dopo passo, pineta dopo pineta, certi coleotteri per contiguità di caratteristiche boschive si siano espansi negli anni attraverso ampi spazi delle nostre regioni appenniniche. Parallelamente, appare più possibile anche la via del trasporto passivo tramite legname da lavoro, infestato, trasportato da una regione italiana all altra o addirittura proveniente dall estero, anche se di norma il materiale spostato consiste in soli tronchi ben ripuliti da rami e chioma e per di più scortecciati. Ma, d altra parte, è noto che basta anche una sola femmina adulta gravida, trasportata passivamente in qualche interstizio del legno, per depositare poi decine di uova su di un legname adatto e dare origine così a una nuova colonia effimera, che può avere o no successo nel tempo tramite possibile acclimatazione. In taluni casi, come per il già citato Arhopalus syriacus, l intensa colonizzazione avvenuta in pochi anni da parte di una specie ha forse portato, o almeno contribuito, alla rapida sostituzione completa di un altro taxon affine, nel nostro caso Arhopalus ferus. La cause di tale sostituzione faunistica possono essere addebitate a ragioni di concorrenza trofica da parte della prima specie, molto invadente a livello di aggressione al legname, a danno della seconda. Ma è verosimile anche che la regressione di A. ferus fino alla sua attuale scomparsa sia dovuta alle difficoltà biologiche incontrate nel suo sviluppo larvale per colpa delle rapide e avverse modificazioni climatico-ambientali verso una maggior xerotermia dei luoghi. Ringraziamenti Sono grato ai Colleghi ed amici carissimi Prof. Roberto Pantaleoni dell Università degli Studi di Sassari, per la determinazione e i ragguagli vari riguardanti i neurotteroidei, e Dr. Remo De Togni di Cerea (VR) per la collaborazione di campagna e l allevamento in parallelo al sottoscritto di materiali legnosi di pino nero provenienti dall Appennino romagnolo. Inoltre, un ringraziamento va anche al Collega Guido Pagliano di Torino per la determinazione, anni addietro, dell imenottero parassitoide citato nel presente lavoro. Bibliografia Ba l a c h o w s k y A., 1949 Faune de France, 50: Coléoptères Scolytides. Librairie de la Faculte des Sciences (Paris). Office Central de Faunistique, 320 pp. 35
18 Co n ta r i n i E., 1997 Aspetti faunistici e zoosociologici nella coleotterofauna legata al pino nero (Pinus nigra Arnold) sull Appennino tosco-romagnolo (Insecta, Coleoptera). Quad. Studi Nat. Romagna, 7: Co n ta r i n i E. & Ga r a g n a n i P., 1981 I cerambicidi delle pinete costiere di Ravenna. Mem. Soc. Entomol. ital., 59: Cu r l e t t i G., 1994 I Buprestidi d Italia. Monografie di Natura Bresciana. Mus. Civ. Sc. Nat. di Brescia, 19: 318 pp. Ma s u t t i L., 1959 Reperti sull entomofauna del Pinus nigra Arn. var austriaca Höss. nelle Prealpi Giulie. Ann. Acc. It. Sc. For., 8: Ma s u t t i L., 1964 Considerazioni preliminari sui Coleotteri Scolitidi della foresta di Campigna e notizie su alcune specie reperibili lungo la catena appenninica. Men. Soc. entomol It., 43: Pl at i a G., 1994 Fauna d Italia. 33. Coleoptera Elateridae. Ed. Calderini (BO): 429 pp. Sama G., 1988 Fauna d Italia. 25. Coleoptera Cerambycidae. Ed. Calderini (BO): 216 pp. Sa m a G. & Bo c c h i n i R., 1992 Asenum tenuicorne Kraatz, 1879, specie nuova per la Romagna e per la fauna italiana. Quad. Studi Nat. Romagna, 1: Sc h a e f e r L., 1949 Les Buprestides de France. Miscellanea Entomologica (supplément). Edit. Scientifiques du Cabinet Entomologique E. Le Moult (Paris), 511 pp planches. Tassi F., 1968 Su alcuni interessanti Longicorni italiani. Boll. Accad. Gioenia Sc. Nat. (Catania), 9, serie IV: Us v e l l i a., anni di ricerche entomologiche a Badia della Valle, Marradi (FI). II. Coleotteri Cerambicidi. Quad. Studi Nat. Romagna, 18: Us v e l l i A. & Fa b b r i R. A., 1996 Segnalazioni faunistiche, n. 14. Quad. Studi Nat. Romagna, 6: Za n g h e r i P., 1961 La provincia di Forlì nei suoi aspetti naturalistici. A cura della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Forlì. 390 pp. Za n g h e r i P., Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna, vivente e fossile della Romagna. Mem. (f.s.) Mus. Civ. St. Nat. di Verona: 5 voll. Indirizzo dell autore: Ettore Contarini via Ramenghi, Bagnacavallo RA 36
Base di lavoro. Idea principale
 Base di lavoro Idea principale «Gli esseri viventi vivono in relazione tra loro e con l ambiente che li ospita, all interno di particolari ecosistemi dotati di un equilibrio ben preciso. Tutti gli organismi
Base di lavoro Idea principale «Gli esseri viventi vivono in relazione tra loro e con l ambiente che li ospita, all interno di particolari ecosistemi dotati di un equilibrio ben preciso. Tutti gli organismi
Al volo - Un veloce sondaggio tra gli studenti sui collegamenti tra Pavia e alcuni aeroporti
 Al volo - Un veloce sondaggio tra gli studenti sui collegamenti tra Pavia e alcuni aeroporti Introduzione I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nella Commissione permanente studenti, in collaborazione
Al volo - Un veloce sondaggio tra gli studenti sui collegamenti tra Pavia e alcuni aeroporti Introduzione I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nella Commissione permanente studenti, in collaborazione
Tasso di occupazione per fasce di età. Provincia di Piacenza, 2009 90,3 83,1 77,7 27,6 16,4. 15-24 anni. 25-34 anni. 45-54 anni.
 La situazione occupazionale dei giovani in provincia di Piacenza Premessa Una categoria di soggetti particolarmente debole nel mercato del lavoro è rappresentata, di norma, dai lavoratori di età più giovane
La situazione occupazionale dei giovani in provincia di Piacenza Premessa Una categoria di soggetti particolarmente debole nel mercato del lavoro è rappresentata, di norma, dai lavoratori di età più giovane
La macchia mediterranea. Creato da Francesco e Samuele.
 La macchia mediterranea Creato da Francesco e Samuele. La macchia mediterranea La macchia mediterranea si chiama così perché é formata da vegetazione che ama i terreni asciutti, il sole, molta luce, un
La macchia mediterranea Creato da Francesco e Samuele. La macchia mediterranea La macchia mediterranea si chiama così perché é formata da vegetazione che ama i terreni asciutti, il sole, molta luce, un
LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI RITORNI AZIONARI FUTURI SARÀ LA MEDESIMA DEL PASSATO?
 LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI RITORNI AZIONARI FUTURI SARÀ LA MEDESIMA DEL PASSATO? Versione preliminare: 25 Settembre 2008 Nicola Zanella E-Mail: n.zanella@yahoo.it ABSTRACT In questa ricerca ho
LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI RITORNI AZIONARI FUTURI SARÀ LA MEDESIMA DEL PASSATO? Versione preliminare: 25 Settembre 2008 Nicola Zanella E-Mail: n.zanella@yahoo.it ABSTRACT In questa ricerca ho
La popolazione residente in provincia di Trento attraverso l anagrafe e i flussi demografici anche in un ottica di Comunità di Valle
 Trento, 23 gennaio 2012 La popolazione residente in provincia di Trento attraverso l anagrafe e i flussi demografici anche in un ottica di Comunità di Valle La popolazione residente in provincia di Trento
Trento, 23 gennaio 2012 La popolazione residente in provincia di Trento attraverso l anagrafe e i flussi demografici anche in un ottica di Comunità di Valle La popolazione residente in provincia di Trento
L età dei vincitori La presenza femminile. L età dei vincitori La presenza femminile. Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
 Premessa Corso-concorso ordinario L età dei vincitori La presenza femminile Corso-concorso riservato L età dei vincitori La presenza femminile Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
Premessa Corso-concorso ordinario L età dei vincitori La presenza femminile Corso-concorso riservato L età dei vincitori La presenza femminile Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato
Monitoraggio sulla conversione dei prezzi al consumo dalla Lira all Euro
 ISTAT 17 gennaio 2002 Monitoraggio sulla conversione dei prezzi al consumo dalla Lira all Euro Nell ambito dell iniziativa di monitoraggio, avviata dall Istat per analizzare le modalità di conversione
ISTAT 17 gennaio 2002 Monitoraggio sulla conversione dei prezzi al consumo dalla Lira all Euro Nell ambito dell iniziativa di monitoraggio, avviata dall Istat per analizzare le modalità di conversione
BIODIVERSITÀ DEI SUOLI ITALIANI: IL CONTRIBUTO DEGLI ACARI ORIBATEI
 Università degli Studi di Siena Dipartimento di Biologia Evolutiva BIODIVERSITÀ DEI SUOLI ITALIANI: IL CONTRIBUTO DEGLI ACARI ORIBATEI Massimo MIGLIORINI, Fabio BERNINI Gli Acari sono un gruppo di aracnidi
Università degli Studi di Siena Dipartimento di Biologia Evolutiva BIODIVERSITÀ DEI SUOLI ITALIANI: IL CONTRIBUTO DEGLI ACARI ORIBATEI Massimo MIGLIORINI, Fabio BERNINI Gli Acari sono un gruppo di aracnidi
SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 2010 11
 SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 2010 11 Le rilevazioni degli apprendimenti A.S. 2010 11 Gli esiti del Servizio nazionale di valutazione 2011 e della Prova nazionale 2011 ABSTRACT Le rilevazioni degli
SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 2010 11 Le rilevazioni degli apprendimenti A.S. 2010 11 Gli esiti del Servizio nazionale di valutazione 2011 e della Prova nazionale 2011 ABSTRACT Le rilevazioni degli
La scuola integra culture. Scheda3c
 Scheda3c Gli ELEMENTI DEL CLIMA che caratterizzano le condizioni meteorologiche di una regione sono: la temperatura, la pressione atmosferica, i venti, l umidità e le precipitazioni. La temperatura è data
Scheda3c Gli ELEMENTI DEL CLIMA che caratterizzano le condizioni meteorologiche di una regione sono: la temperatura, la pressione atmosferica, i venti, l umidità e le precipitazioni. La temperatura è data
Il clima delle Alpi e della Valle d Aosta
 Il clima delle Alpi e della Valle d Aosta Il clima delle Alpi Il clima della Valle d Aosta Precipitazioni durante l alluvione del 2000 Temperature estreme registrate in Valle d Aosta Il ruolo delle montagne
Il clima delle Alpi e della Valle d Aosta Il clima delle Alpi Il clima della Valle d Aosta Precipitazioni durante l alluvione del 2000 Temperature estreme registrate in Valle d Aosta Il ruolo delle montagne
Capitolo 3. L applicazione Java Diagrammi ER. 3.1 La finestra iniziale, il menu e la barra pulsanti
 Capitolo 3 L applicazione Java Diagrammi ER Dopo le fasi di analisi, progettazione ed implementazione il software è stato compilato ed ora è pronto all uso; in questo capitolo mostreremo passo passo tutta
Capitolo 3 L applicazione Java Diagrammi ER Dopo le fasi di analisi, progettazione ed implementazione il software è stato compilato ed ora è pronto all uso; in questo capitolo mostreremo passo passo tutta
COMPRENSORIO ALPINO CN2 Valle Varaita. RISULTATI CENSIMENTI ALLE SPECIE CAMOSCIO E MUFLONE s.v. 2012/2013
 COMPRENSORIO ALPINO CN2 Valle Varaita RISULTATI CENSIMENTI ALLE SPECIE CAMOSCIO E MUFLONE s.v. 2012/2013 - RELAZIONE TECNICA - A cura di Omar Giordano Giorgio Ficetto Tecnici faunistici C.A. CN2 PREMESSA
COMPRENSORIO ALPINO CN2 Valle Varaita RISULTATI CENSIMENTI ALLE SPECIE CAMOSCIO E MUFLONE s.v. 2012/2013 - RELAZIONE TECNICA - A cura di Omar Giordano Giorgio Ficetto Tecnici faunistici C.A. CN2 PREMESSA
SCHEDA TECNICA PER IL MONTAGGIO DELLE COPERTURE LA COPERTURA TOSCANA.
 SCHEDA TECNICA PER IL MONTAGGIO DELLE COPERTURE LA COPERTURA TOSCANA. La COPERTURATOSCANA, prodotta da COTTOREF, è composta da tre articoli fondamentali: tegole, coppi e colmi, oltre ad una serie di pezzi
SCHEDA TECNICA PER IL MONTAGGIO DELLE COPERTURE LA COPERTURA TOSCANA. La COPERTURATOSCANA, prodotta da COTTOREF, è composta da tre articoli fondamentali: tegole, coppi e colmi, oltre ad una serie di pezzi
L uso della Balanced Scorecard nel processo di Business Planning
 L uso della Balanced Scorecard nel processo di Business Planning di Marcello Sabatini www.msconsulting.it Introduzione Il business plan è uno strumento che permette ad un imprenditore di descrivere la
L uso della Balanced Scorecard nel processo di Business Planning di Marcello Sabatini www.msconsulting.it Introduzione Il business plan è uno strumento che permette ad un imprenditore di descrivere la
Intervento del Prof. Massimo Angrisani in merito alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti.
 Intervento del Prof. Massimo Angrisani in merito alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti. 1 ANGRISANI: Grazie, Presidente. Innanzi tutto vorrei rivolgere un saluto all Assemblea dei Delegati,
Intervento del Prof. Massimo Angrisani in merito alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti. 1 ANGRISANI: Grazie, Presidente. Innanzi tutto vorrei rivolgere un saluto all Assemblea dei Delegati,
TEORIA DI LAMARCK O DELLA EREDITARIETA DEI CARATTERI ACQUISITI
 L EVOLUZIONE IN PASSATO SI PENSAVA CHE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI CHE OGGI POPOLANO LA TERRA AVESSERO AVUTO SEMPRE LA FORMA ATTUALE. SI CREDEVA CIOE NELLA TEORIA DELCREAZIONISMO (NELLA CREAZIONE ORIGINALE)
L EVOLUZIONE IN PASSATO SI PENSAVA CHE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI CHE OGGI POPOLANO LA TERRA AVESSERO AVUTO SEMPRE LA FORMA ATTUALE. SI CREDEVA CIOE NELLA TEORIA DELCREAZIONISMO (NELLA CREAZIONE ORIGINALE)
63 7. Quale geometria per la computer grafica? 75 8. L omografia e l affinità nella digitalizzazione e georeferenziazione
 Indice 7 Presentazione 9 Premessa 11 Introduzione 13 1. Rilevamento ed oggetto 19 2. La stazione totale 23 3. La procedura generale 33 4. Dai punti al modello tridimensionale 45 5. Il modello tridimensionale
Indice 7 Presentazione 9 Premessa 11 Introduzione 13 1. Rilevamento ed oggetto 19 2. La stazione totale 23 3. La procedura generale 33 4. Dai punti al modello tridimensionale 45 5. Il modello tridimensionale
6.1 L occupazione femminile
 6.1 L occupazione femminile E oramai noto come la presenza femminile sul mercato del lavoro sia notevolmente cresciuta nell ultimo decennio. La società in trasformazione ha registrato così un importante
6.1 L occupazione femminile E oramai noto come la presenza femminile sul mercato del lavoro sia notevolmente cresciuta nell ultimo decennio. La società in trasformazione ha registrato così un importante
La nevicata eccezionale dell 11 marzo 2004
 La nevicata eccezionale dell 11 marzo 2004 Roberto Barbiero Introduzione Un intensa nevicata ha interessato nella giornata dell 11 marzo 2004 molte regioni del nord Italia. Dalle prime ore della notte
La nevicata eccezionale dell 11 marzo 2004 Roberto Barbiero Introduzione Un intensa nevicata ha interessato nella giornata dell 11 marzo 2004 molte regioni del nord Italia. Dalle prime ore della notte
ALLEGATO 1 Analisi delle serie storiche pluviometriche delle stazioni di Torre del Lago e di Viareggio.
 ALLEGATO 1 Analisi delle serie storiche pluviometriche delle stazioni di Torre del Lago e di Viareggio. Per una migliore caratterizzazione del bacino idrologico dell area di studio, sono state acquisite
ALLEGATO 1 Analisi delle serie storiche pluviometriche delle stazioni di Torre del Lago e di Viareggio. Per una migliore caratterizzazione del bacino idrologico dell area di studio, sono state acquisite
I Biomi. Corso di Ecologia Applicata - Prof. Simona Castaldi Dipartimento di Scienze Ambientali - SUN
 I Biomi Corso di Ecologia Applicata - Prof. Simona Castaldi Dipartimento di Scienze Ambientali - SUN La vita delle piante e degli animali delle comunità naturali è determinata principalmente dal clima
I Biomi Corso di Ecologia Applicata - Prof. Simona Castaldi Dipartimento di Scienze Ambientali - SUN La vita delle piante e degli animali delle comunità naturali è determinata principalmente dal clima
Questionario di gradimento del Museo di Palazzo Grimani Estratto dalla relazione sui dati raccolti giugno 2011 luglio 2012
 Questionario di gradimento del Museo di Palazzo Grimani Estratto dalla relazione sui dati raccolti giugno 2011 luglio 2012 Premessa La seguente analisi dei questionari distribuiti dal Museo di Palazzo
Questionario di gradimento del Museo di Palazzo Grimani Estratto dalla relazione sui dati raccolti giugno 2011 luglio 2012 Premessa La seguente analisi dei questionari distribuiti dal Museo di Palazzo
Guida all uso di Java Diagrammi ER
 Guida all uso di Java Diagrammi ER Ver. 1.1 Alessandro Ballini 16/5/2004 Questa guida ha lo scopo di mostrare gli aspetti fondamentali dell utilizzo dell applicazione Java Diagrammi ER. Inizieremo con
Guida all uso di Java Diagrammi ER Ver. 1.1 Alessandro Ballini 16/5/2004 Questa guida ha lo scopo di mostrare gli aspetti fondamentali dell utilizzo dell applicazione Java Diagrammi ER. Inizieremo con
Erickson. Le carte geografiche, il tempo e il clima, il paesaggio italiano. Scuola primaria. Carlo Scataglini. Collana diretta da Dario Ianes
 Strumenti per la didattica, l educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno Collana diretta da Dario Ianes Carlo Scataglini GEOGRAFIA facile per la classe quarta Le carte geografiche, il tempo
Strumenti per la didattica, l educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno Collana diretta da Dario Ianes Carlo Scataglini GEOGRAFIA facile per la classe quarta Le carte geografiche, il tempo
La dispersione dei prezzi al consumo. I risultati di un indagine empirica sui prodotti alimentari.
 La dispersione dei prezzi al consumo. I risultati di un indagine empirica sui prodotti alimentari. Giovanni Anania e Rosanna Nisticò EMAA 14/15 X / 1 Il problema Un ottimo uso del vostro tempo! questa
La dispersione dei prezzi al consumo. I risultati di un indagine empirica sui prodotti alimentari. Giovanni Anania e Rosanna Nisticò EMAA 14/15 X / 1 Il problema Un ottimo uso del vostro tempo! questa
Appunti sulla Macchina di Turing. Macchina di Turing
 Macchina di Turing Una macchina di Turing è costituita dai seguenti elementi (vedi fig. 1): a) una unità di memoria, detta memoria esterna, consistente in un nastro illimitato in entrambi i sensi e suddiviso
Macchina di Turing Una macchina di Turing è costituita dai seguenti elementi (vedi fig. 1): a) una unità di memoria, detta memoria esterna, consistente in un nastro illimitato in entrambi i sensi e suddiviso
IL CLIMA IN EUROPA PRINCIPALI TIPI DI CLIMA CHE SI INCONTRANO IN EUROPA. ATLANTICO ALPINO MEDITERRANEO CONTINENTALE U N I T A N 1 1
 U N I T A N 1 1 IL CLIMA IN EUROPA PRINCIPALI TIPI DI CLIMA CHE SI INCONTRANO IN EUROPA. ATLANTICO ALPINO MEDITERRANEO CONTINENTALE Libro di geografia classe 1 - Scuola secondaria di primo grado Pagina
U N I T A N 1 1 IL CLIMA IN EUROPA PRINCIPALI TIPI DI CLIMA CHE SI INCONTRANO IN EUROPA. ATLANTICO ALPINO MEDITERRANEO CONTINENTALE Libro di geografia classe 1 - Scuola secondaria di primo grado Pagina
NOTA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA UIL UN OPERAZIONE VERITA SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI PENSIONE
 NOTA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA UIL UN OPERAZIONE VERITA SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI PENSIONE Le ultime settimane sono caratterizzate da una situazione non facile
NOTA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA UIL UN OPERAZIONE VERITA SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI PENSIONE Le ultime settimane sono caratterizzate da una situazione non facile
Città sostenibili. M. Bariselli
 I carabidi delle ombrellifere M. Bariselli La situazione in campagna Agricoltori Cittadini Il gestore del terreno nel quale sia accertata dai tecnici dell AUSL la presenza di colture collegabili all
I carabidi delle ombrellifere M. Bariselli La situazione in campagna Agricoltori Cittadini Il gestore del terreno nel quale sia accertata dai tecnici dell AUSL la presenza di colture collegabili all
DEGUSTAZIONE DI TERRE
 Proposte di degustazione Seminario con degustazione Dalle Terre ai vini emiliani promosso da CRPV, Regione Emilia-Romagna ed Enoteca Regionale Emilia-Romagna. In collaborazione con I.TER, Università Cattolica
Proposte di degustazione Seminario con degustazione Dalle Terre ai vini emiliani promosso da CRPV, Regione Emilia-Romagna ed Enoteca Regionale Emilia-Romagna. In collaborazione con I.TER, Università Cattolica
(funghi, muffe e batteri) alle radici ed al colletto della pianta. Al contrario, la carenza d acqua, porta la pianta a stress da appassimento ed a
 L ACQUA L elemento acqua è costituente degli esseri viventi, sia animali che vegetali, superando in alcuni casi anche il 90% della composizione. L acqua per le piante è un elemento indispensabile in quanto
L ACQUA L elemento acqua è costituente degli esseri viventi, sia animali che vegetali, superando in alcuni casi anche il 90% della composizione. L acqua per le piante è un elemento indispensabile in quanto
La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti
 La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa
La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa
2010 Anno mondiale della Biodiversità. a colloquio con. Costantino Bonomi. Per saperne di più: http://www.mtsn.tn.it/seedbank/index.
 FOCUS ORIZZONTI 2010 Anno mondiale della Biodiversità La Banca dei semi presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali a colloquio con Costantino Bonomi Per saperne di più: http://www.mtsn.tn.it/seedbank/index.html
FOCUS ORIZZONTI 2010 Anno mondiale della Biodiversità La Banca dei semi presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali a colloquio con Costantino Bonomi Per saperne di più: http://www.mtsn.tn.it/seedbank/index.html
SCOPRI LE SPLENDIDE ALPI LIGURI CON L AIUTO DI UNA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
 SCOPRI LE SPLENDIDE ALPI LIGURI CON L AIUTO DI UNA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA È guida ambientale escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita
SCOPRI LE SPLENDIDE ALPI LIGURI CON L AIUTO DI UNA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA È guida ambientale escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita
È crisi delle piccole botteghe, ma i prezzi restano alti
 Editoriale n. 5 del 16/5/2009 Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno È crisi delle piccole botteghe, ma i prezzi restano alti A commento del Rapporto diffuso da Confesercenti La crisi ha toccato e continua
Editoriale n. 5 del 16/5/2009 Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno È crisi delle piccole botteghe, ma i prezzi restano alti A commento del Rapporto diffuso da Confesercenti La crisi ha toccato e continua
,/0(5&$72',&216802,/0(5&$72 '(//(25*$1,==$=,21,,7$/,$12(' (67(52(/(/252&$5$77(5,67,&+(
 ,/0(5&$72',&216802,/0(5&$72 '(//(25*$1,==$=,21,,7$/,$12(' (67(52(/(/252&$5$77(5,67,&+( 6(/(=,21('(,3$(6, Nella precedente ricerca si sono distinti, sulla base di indicatori quali la produzione, il consumo
,/0(5&$72',&216802,/0(5&$72 '(//(25*$1,==$=,21,,7$/,$12(' (67(52(/(/252&$5$77(5,67,&+( 6(/(=,21('(,3$(6, Nella precedente ricerca si sono distinti, sulla base di indicatori quali la produzione, il consumo
LE STRATEGIE DI COPING
 Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
Da 2 a 4 Giocatori Autore Martin Wallace
 Traduzione La Strada Da 2 a 4 Giocatori Autore Martin Wallace Scopo del Gioco Ogni giocatore, impersona un Ricco Mercante ed è alla ricerca di Nuovi Mercati nelle crescenti cittadine che vi permetteranno
Traduzione La Strada Da 2 a 4 Giocatori Autore Martin Wallace Scopo del Gioco Ogni giocatore, impersona un Ricco Mercante ed è alla ricerca di Nuovi Mercati nelle crescenti cittadine che vi permetteranno
4 I LAUREATI E IL LAVORO
 4I LAUREATI E IL LAVORO 4 I LAUREATI E IL LAVORO La laurea riduce la probabilità di rimanere disoccupati dopo i 30 anni L istruzione si rivela sempre un buon investimento a tutela della disoccupazione.
4I LAUREATI E IL LAVORO 4 I LAUREATI E IL LAVORO La laurea riduce la probabilità di rimanere disoccupati dopo i 30 anni L istruzione si rivela sempre un buon investimento a tutela della disoccupazione.
Dossier 7 Il possesso e l acquisto di beni durevoli (1997-2004)
 Dossier 7 Il possesso e l acquisto di beni durevoli (1997-2004) Audizione del Presidente dell Istituto nazionale di statistica, Luigi Biggeri presso le Commissioni congiunte V del Senato della Repubblica
Dossier 7 Il possesso e l acquisto di beni durevoli (1997-2004) Audizione del Presidente dell Istituto nazionale di statistica, Luigi Biggeri presso le Commissioni congiunte V del Senato della Repubblica
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2015
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2015 Ottobre 2015 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti,
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2015 Ottobre 2015 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti,
MA COME VIVE UN APE E QUALI SONO I SUOI COMPITI?
 MA COME VIVE UN APE E QUALI SONO I SUOI COMPITI? LE API VOLANDO DA UN FIORE ALL ALTRO RACCOLGONO IL NETTARE PRODOTTO DAI FIORI E LO UTILIZZANO PER FARE IL MIELE CHE SARA UNA PREZIOSA SCORTA DI CIBO PER
MA COME VIVE UN APE E QUALI SONO I SUOI COMPITI? LE API VOLANDO DA UN FIORE ALL ALTRO RACCOLGONO IL NETTARE PRODOTTO DAI FIORI E LO UTILIZZANO PER FARE IL MIELE CHE SARA UNA PREZIOSA SCORTA DI CIBO PER
Tra il 1998 e oggi il mondo del web è cambiato ed ha subito una profonda trasformazione
 SINTESI DELLA RICERCA CIVITA SU WEB E MUSEI CAMPIONE DI RIFERIMENTO DELLA RICERCA Indagine sull offerta : 110 musei italiani selezionati sulla base del criterio geografico e della tipoloia dei musei; 110
SINTESI DELLA RICERCA CIVITA SU WEB E MUSEI CAMPIONE DI RIFERIMENTO DELLA RICERCA Indagine sull offerta : 110 musei italiani selezionati sulla base del criterio geografico e della tipoloia dei musei; 110
VERIFICA Climi e biomi I/1 I/2 I/3. Vero o Falso? Vero o Falso? Indica tra quelli elencati quali sono gli elementi che determinano il clima.
 ERIICA Climi e biomi Cognome Nome Classe Data I/1 ero o also? Il clima della fascia mediterranea è caratterizzato da estati calde e siccitose La regione della vite corrisponde all incirca alla fascia climatica
ERIICA Climi e biomi Cognome Nome Classe Data I/1 ero o also? Il clima della fascia mediterranea è caratterizzato da estati calde e siccitose La regione della vite corrisponde all incirca alla fascia climatica
ESERCITAZIONE OSSERVARE UN ALBERO
 L esercizio richiesto consiste nella scelta di un albero e il suo monitoraggio/racconto al fine di sviluppare l osservazione attenta come mezzo per la conoscenza del materiale vegetale. L esercitazione
L esercizio richiesto consiste nella scelta di un albero e il suo monitoraggio/racconto al fine di sviluppare l osservazione attenta come mezzo per la conoscenza del materiale vegetale. L esercitazione
L interpretazione dei segni I fori e la rosura dei tarli
 L interpretazione dei segni I fori e la rosura dei tarli La funzione dei fori di sfarfallamento I fori che si notano sulle travi e sui mobili, indipendentemente dalla specie infestante che li ha prodotti,
L interpretazione dei segni I fori e la rosura dei tarli La funzione dei fori di sfarfallamento I fori che si notano sulle travi e sui mobili, indipendentemente dalla specie infestante che li ha prodotti,
Nascita e morte delle stelle
 Nascita e morte delle stelle Se la materia che componeva l universo primordiale fosse stata tutta perfettamente omogenea e diffusa in modo uguale, non esisterebbero né stelle né pianeti. C erano invece
Nascita e morte delle stelle Se la materia che componeva l universo primordiale fosse stata tutta perfettamente omogenea e diffusa in modo uguale, non esisterebbero né stelle né pianeti. C erano invece
L ambiente è costituito da: una componente abiotica - (aria, acqua, terra, rocce, ecc.)
 L ambiente è costituito da: una componente abiotica - (aria, acqua, terra, rocce, ecc.) una componente biotica (esseri viventi) - (batteri, funghi, piante, animali, ecc.) ECOLOGIA (Häckel 1866) Scienza
L ambiente è costituito da: una componente abiotica - (aria, acqua, terra, rocce, ecc.) una componente biotica (esseri viventi) - (batteri, funghi, piante, animali, ecc.) ECOLOGIA (Häckel 1866) Scienza
Area Ricerca e Sviluppo
 Documento Informativo nr. 119 Data di emissione: 04/05/2005 Revisione n. 0 Area Ricerca e Sviluppo LA SHELF-LIFE DEGLI ALIMENTI Riferimento interno: dr.ssa Bastianon Martina - Area Ricerca e Sviluppo,
Documento Informativo nr. 119 Data di emissione: 04/05/2005 Revisione n. 0 Area Ricerca e Sviluppo LA SHELF-LIFE DEGLI ALIMENTI Riferimento interno: dr.ssa Bastianon Martina - Area Ricerca e Sviluppo,
I FATTORI CHE DETERMINANO IL CLIMA
 UNITA N 10 I FATTORI CHE DETERMINANO IL CLIMA Quali sono i fattori che influenzano il clima? Si chiamano fattori climatici le condizioni che producono variazioni negli elementi del clima. Molto importante
UNITA N 10 I FATTORI CHE DETERMINANO IL CLIMA Quali sono i fattori che influenzano il clima? Si chiamano fattori climatici le condizioni che producono variazioni negli elementi del clima. Molto importante
5. IL PC E INTERNET NELLE DIVERSE TIPOLOGIE FAMILIARI
 5. IL PC E INTERNET NELLE DIVERSE TIPOLOGIE FAMILIARI 5.1 Considerazioni generali Il livello di informatizzazione delle famiglie toscane è stato esaminato, oltre che sulla base del territorio, anche tenendo
5. IL PC E INTERNET NELLE DIVERSE TIPOLOGIE FAMILIARI 5.1 Considerazioni generali Il livello di informatizzazione delle famiglie toscane è stato esaminato, oltre che sulla base del territorio, anche tenendo
Osservatorio 2. L INDUSTRIA METALMECCANICA E IL COMPARTO SIDERURGICO. I risultati del comparto siderurgico. Apparecchi meccanici. Macchine elettriche
 Osservatorio24 def 27-02-2008 12:49 Pagina 7 Osservatorio 2. L INDUSTRIA METALMECCANICA E IL COMPARTO SIDERURGICO 2.1 La produzione industriale e i prezzi alla produzione Nel 2007 la produzione industriale
Osservatorio24 def 27-02-2008 12:49 Pagina 7 Osservatorio 2. L INDUSTRIA METALMECCANICA E IL COMPARTO SIDERURGICO 2.1 La produzione industriale e i prezzi alla produzione Nel 2007 la produzione industriale
ENTE BILATERALE TURISMO Della Regione Lazio OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO NEL SETTORE TURISTICO
 ENTE BILATERALE TURISMO Della Regione Lazio OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO NEL SETTORE TURISTICO 1 Rapporto 2007 sulla occupazione nelle imprese ricettive, di viaggi e di ristorazione della Provincia
ENTE BILATERALE TURISMO Della Regione Lazio OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO NEL SETTORE TURISTICO 1 Rapporto 2007 sulla occupazione nelle imprese ricettive, di viaggi e di ristorazione della Provincia
LE PREVISIONI DELLE FAMIGLIE
 LE PREVISIONI DELLE FAMIGLIE Trieste aprile 2013 Riproduzioni e stampe dovranno riportare in modo visibile la fonte e la proprietà dell informazione. Inoltre, su richiesta al Servizio Statistica del Comune
LE PREVISIONI DELLE FAMIGLIE Trieste aprile 2013 Riproduzioni e stampe dovranno riportare in modo visibile la fonte e la proprietà dell informazione. Inoltre, su richiesta al Servizio Statistica del Comune
seveso un laboratorio di idee a partire dal bosco delle querce proposta anno scolastico 2008-2009
 seveso un laboratorio di idee a partire dal bosco delle querce proposta anno scolastico 2008-2009 Per l anno scolastico 2008-2009 il parco naturale Bosco delle Querce propone un percorso di educazione
seveso un laboratorio di idee a partire dal bosco delle querce proposta anno scolastico 2008-2009 Per l anno scolastico 2008-2009 il parco naturale Bosco delle Querce propone un percorso di educazione
Plurilinguismo: dal mondo a casa nostra Poster 6
 1 Plurilingue?! Si, ma come? Spiegazioni Domande Risposte Corrette Note Non è assolutamente possibile dare una breve definizione scientifica che sia in grado di rendere la complessità del sistema di segni
1 Plurilingue?! Si, ma come? Spiegazioni Domande Risposte Corrette Note Non è assolutamente possibile dare una breve definizione scientifica che sia in grado di rendere la complessità del sistema di segni
Le persone che hanno creduto in lui hanno potuto contribuire alla nascita del team, e non solo, ma di giorno in giorno il team si è sviluppato grazie
 presenta LA SUA STORIA Francesco Maria Conti, nato il 29 febbraio del 1964 a Desio e residente in Svizzera, ha dimostrato sempre un vivo interesse per le macchine. Allo sviluppo di questa sua passione
presenta LA SUA STORIA Francesco Maria Conti, nato il 29 febbraio del 1964 a Desio e residente in Svizzera, ha dimostrato sempre un vivo interesse per le macchine. Allo sviluppo di questa sua passione
COME STA LA SCUOLA ITALIANA? ECCO I DATI DEL RAPPORTO INVALSI 2014
 Pagina 1 di 5 COME STA LA SCUOLA ITALIANA? ECCO I DATI DEL RAPPORTO INVALSI 2014 No Comments E stato presentato questa mattina al Ministero dell Istruzione il rapporto INVALSI 2014. Complessivamente sono
Pagina 1 di 5 COME STA LA SCUOLA ITALIANA? ECCO I DATI DEL RAPPORTO INVALSI 2014 No Comments E stato presentato questa mattina al Ministero dell Istruzione il rapporto INVALSI 2014. Complessivamente sono
Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I
 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
55820/2014 ----------------
 55820/2014 Data: 06 settembre 2014 Dove arriva la Bibbia? di Ilvo Diamanti 06 settembre 2014 Dalla ricerca «Gli italiani e la Bibbia» che viene presentata stasera al Festival letteratura di Mantova un
55820/2014 Data: 06 settembre 2014 Dove arriva la Bibbia? di Ilvo Diamanti 06 settembre 2014 Dalla ricerca «Gli italiani e la Bibbia» che viene presentata stasera al Festival letteratura di Mantova un
Come valutare le caratteristiche aerobiche di ogni singolo atleta sul campo
 Come valutare le caratteristiche aerobiche di ogni singolo atleta sul campo Prima di organizzare un programma di allenamento al fine di elevare il livello di prestazione, è necessario valutare le capacità
Come valutare le caratteristiche aerobiche di ogni singolo atleta sul campo Prima di organizzare un programma di allenamento al fine di elevare il livello di prestazione, è necessario valutare le capacità
Giorni ideali per il taglio del legname nell anno 2015. Giorni favorevoli per il taglio di legname da costruzione e uso falegnameria.
 Giorni ideali per il taglio del legname nell anno 2015. Giorni favorevoli per il taglio di legname da costruzione e uso falegnameria. Gli alberi dai quali si ricava legname da costruzione e per la fabbricazione
Giorni ideali per il taglio del legname nell anno 2015. Giorni favorevoli per il taglio di legname da costruzione e uso falegnameria. Gli alberi dai quali si ricava legname da costruzione e per la fabbricazione
Il CREA e il Corpo Forestale rendono accessibile on line l inventario forestale nazionale.
 Il CREA e il Corpo Forestale rendono accessibile on line l inventario forestale nazionale. A cura dell Ufficio Stampa 1 On line l'identikit delle foreste italiane Corpo forestale lancia sito web con dati
Il CREA e il Corpo Forestale rendono accessibile on line l inventario forestale nazionale. A cura dell Ufficio Stampa 1 On line l'identikit delle foreste italiane Corpo forestale lancia sito web con dati
IL CICLO (RITMO) VITALE DELLA MUFFA
 IL CICLO (RITMO) VITALE DELLA MUFFA (Pezzo di formaggio ammuffito) Problema: cos è quest oggetto? Discussione dei bambini: osservazione, annusa mento e proposta di varie risposte, tra cui è formaggio con
IL CICLO (RITMO) VITALE DELLA MUFFA (Pezzo di formaggio ammuffito) Problema: cos è quest oggetto? Discussione dei bambini: osservazione, annusa mento e proposta di varie risposte, tra cui è formaggio con
IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:
 IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti
IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti
 L adozione di un bambino già grande e l arrivo dell adolescenza Marco Chistolini Adolescenza adottiva L adozione è una condizione esistenziale che ha tratti comuni e profonde differenze. Questo assunto
L adozione di un bambino già grande e l arrivo dell adolescenza Marco Chistolini Adolescenza adottiva L adozione è una condizione esistenziale che ha tratti comuni e profonde differenze. Questo assunto
L'aumento del rapporto tra ricchezza e reddito, la disuguaglianza, e la crescita
 VOX 26 Settembre 2013 Thomas Piketty, Gabriel Zucman L'aumento del rapporto tra ricchezza e reddito, la disuguaglianza, e la crescita Ridurre le disuguaglianze economiche è una delle sfide del nostro tempo.
VOX 26 Settembre 2013 Thomas Piketty, Gabriel Zucman L'aumento del rapporto tra ricchezza e reddito, la disuguaglianza, e la crescita Ridurre le disuguaglianze economiche è una delle sfide del nostro tempo.
LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE
 Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
Domande a scelta multipla 1
 Domande a scelta multipla Domande a scelta multipla 1 Rispondete alle domande seguenti, scegliendo tra le alternative proposte. Cercate di consultare i suggerimenti solo in caso di difficoltà. Dopo l elenco
Domande a scelta multipla Domande a scelta multipla 1 Rispondete alle domande seguenti, scegliendo tra le alternative proposte. Cercate di consultare i suggerimenti solo in caso di difficoltà. Dopo l elenco
Il prezzo del gasolio a febbraio 2011 ha raggiunto livelli simili a quelli della primavera 2008, anno in cui il sostenuto aumento del prezzo dei
 Introduzione Nei primi mesi del 2011, l incremento del costo del gasolio sui livelli del 2008 ha compromesso la profittabilità del settore peschereccio, ponendo gli operatori in una situazione di incertezza
Introduzione Nei primi mesi del 2011, l incremento del costo del gasolio sui livelli del 2008 ha compromesso la profittabilità del settore peschereccio, ponendo gli operatori in una situazione di incertezza
SPC e distribuzione normale con Access
 SPC e distribuzione normale con Access In questo articolo esamineremo una applicazione Access per il calcolo e la rappresentazione grafica della distribuzione normale, collegata con tabelle di Clienti,
SPC e distribuzione normale con Access In questo articolo esamineremo una applicazione Access per il calcolo e la rappresentazione grafica della distribuzione normale, collegata con tabelle di Clienti,
igiene Scienza della salute che si propone il compito di promuovere, conservare e potenziare lo stato di salute di una comunità
 igiene Scienza della salute che si propone il compito di promuovere, conservare e potenziare lo stato di salute di una comunità salute Art. 32 della Costituzione Italiana: la Repubblica tutela la salute
igiene Scienza della salute che si propone il compito di promuovere, conservare e potenziare lo stato di salute di una comunità salute Art. 32 della Costituzione Italiana: la Repubblica tutela la salute
Indagine sul Cyber-bullismo
 Indagine sul Cyber-bullismo Realizzata da O.N.F. Osservatorio Nazionale Federconsumatori sul comportamento dei ragazzi italiani dai 12 ai 17 anni RISULTATI DI SINTESI Più di 8 ragazzi su 10 possiedono
Indagine sul Cyber-bullismo Realizzata da O.N.F. Osservatorio Nazionale Federconsumatori sul comportamento dei ragazzi italiani dai 12 ai 17 anni RISULTATI DI SINTESI Più di 8 ragazzi su 10 possiedono
Indice di rischio globale
 Indice di rischio globale Di Pietro Bottani Dottore Commercialista in Prato Introduzione Con tale studio abbiamo cercato di creare un indice generale capace di valutare il rischio economico-finanziario
Indice di rischio globale Di Pietro Bottani Dottore Commercialista in Prato Introduzione Con tale studio abbiamo cercato di creare un indice generale capace di valutare il rischio economico-finanziario
I libri di testo. Carlo Tarsitani
 I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
La Processionaria del Pino
 La Processionaria del Pino Thaumetopoea pityocampa www.gruppoindaco.com Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Lepidoptera, Fam. Thaumetopoeidae Cos'è la Processionaria o a del pino La Processionaria
La Processionaria del Pino Thaumetopoea pityocampa www.gruppoindaco.com Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Lepidoptera, Fam. Thaumetopoeidae Cos'è la Processionaria o a del pino La Processionaria
SETTORE AFFARI GENERALI E CANTIERI DI LAVORO
 DIVISIONE LAVORO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI E CANTIERI DI LAVORO I Cantieri di Lavoro, istituiti con L.R. 55/84, fin dall inizio indirizzati alle fasce più deboli del mercato del
DIVISIONE LAVORO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI E CANTIERI DI LAVORO I Cantieri di Lavoro, istituiti con L.R. 55/84, fin dall inizio indirizzati alle fasce più deboli del mercato del
Capitolo 3: Cenni di strategia
 Capitolo 3: Cenni di strategia Le "Mobilità" L obiettivo fondamentale del gioco è, naturalmente, catturare semi, ma l obiettivo strategico più ampio è di guadagnare il controllo dei semi in modo da poter
Capitolo 3: Cenni di strategia Le "Mobilità" L obiettivo fondamentale del gioco è, naturalmente, catturare semi, ma l obiettivo strategico più ampio è di guadagnare il controllo dei semi in modo da poter
l'insieme di tutti i casi esistenti in un determinato momento ed in una
 Le misure di frequenza delle malattie possono descrivere: l'insieme di tutti i casi esistenti in un determinato momento ed in una determinata popolazione il verificarsi di nuovi casi A questo scopo si
Le misure di frequenza delle malattie possono descrivere: l'insieme di tutti i casi esistenti in un determinato momento ed in una determinata popolazione il verificarsi di nuovi casi A questo scopo si
Innovazione nelle tecnologie dei sistemi fotovoltaici
 Innovazione nelle tecnologie dei sistemi fotovoltaici Prof. Paolo Redi Verso 6GWp I risultati del conto energia a fine 2010 hanno meravigliato molti. Non è detto che la potenza complessiva superi i 6GWp
Innovazione nelle tecnologie dei sistemi fotovoltaici Prof. Paolo Redi Verso 6GWp I risultati del conto energia a fine 2010 hanno meravigliato molti. Non è detto che la potenza complessiva superi i 6GWp
LINEA DIRETTA CON ANFFAS
 LINEA DIRETTA CON ANFFAS SONDAGGIO TELEFONICO Com è nata l idea del Sondaggio? Il sondaggio nasce dall esigenza, fortemente avvertita nel corso degli ultimi anni, da Anffas Nazionale di trovare un modo
LINEA DIRETTA CON ANFFAS SONDAGGIO TELEFONICO Com è nata l idea del Sondaggio? Il sondaggio nasce dall esigenza, fortemente avvertita nel corso degli ultimi anni, da Anffas Nazionale di trovare un modo
IL SISTEMA DI PREVISIONE DEL DISAGIO BIOCLIMATICO IN EMILIA-ROMAGNA
 IL SISTEMA DI PREVISIONE DEL DISAGIO BIOCLIMATICO IN EMILIA-ROMAGNA Studio del fenomeno dell isola di calore Area urbana di Bologna Struttura Tematica di Epidemiologia Ambientale ARPA Emilia Romagna IL
IL SISTEMA DI PREVISIONE DEL DISAGIO BIOCLIMATICO IN EMILIA-ROMAGNA Studio del fenomeno dell isola di calore Area urbana di Bologna Struttura Tematica di Epidemiologia Ambientale ARPA Emilia Romagna IL
IL PARMIGIANO-REGGIANO ED IL MARKETING TERRITORRIALE. Intervento di Kees De Roest Centro Ricerche Produzioni Animali
 Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano Convegno IL PARMIGIANO-REGGIANO ED IL MARKETING TERRITORRIALE Intervento di Kees De Roest Centro Ricerche Produzioni Animali La vendita del Parmigiano-Reggiano
Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano Convegno IL PARMIGIANO-REGGIANO ED IL MARKETING TERRITORRIALE Intervento di Kees De Roest Centro Ricerche Produzioni Animali La vendita del Parmigiano-Reggiano
www.andreatorinesi.it
 La lunghezza focale Lunghezza focale Si definisce lunghezza focale la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo (a infinito ) e il piano su cui si forma l'immagine (nel caso del digitale, il sensore).
La lunghezza focale Lunghezza focale Si definisce lunghezza focale la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo (a infinito ) e il piano su cui si forma l'immagine (nel caso del digitale, il sensore).
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Università di Genova MATEMATICA Il
 Lezione 5:10 Marzo 2003 SPAZIO E GEOMETRIA VERBALE (a cura di Elisabetta Contardo e Elisabetta Pronsati) Esercitazione su F5.1 P: sarebbe ottimale a livello di scuola dell obbligo, fornire dei concetti
Lezione 5:10 Marzo 2003 SPAZIO E GEOMETRIA VERBALE (a cura di Elisabetta Contardo e Elisabetta Pronsati) Esercitazione su F5.1 P: sarebbe ottimale a livello di scuola dell obbligo, fornire dei concetti
PROPOSTE DIDATTICHE 2012-2013
 MUSEO ORNITOLOGICO F. FOSCHI PROPOSTE DIDATTICHE 2012-2013 - ATTIVITA DIDATTICHE DI BASE - ATTIVITA DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO - ATTIVITA DIDATTICHE nel PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI - USCITE
MUSEO ORNITOLOGICO F. FOSCHI PROPOSTE DIDATTICHE 2012-2013 - ATTIVITA DIDATTICHE DI BASE - ATTIVITA DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO - ATTIVITA DIDATTICHE nel PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI - USCITE
Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I.
 Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I. Non esiste, al giorno d oggi, un parere unanime della comunità scientifica sulla definizione di intelligenza. In generale, potremmo dire che è
Che cos è l intelligenza e come funzionano i test del Q.I. Non esiste, al giorno d oggi, un parere unanime della comunità scientifica sulla definizione di intelligenza. In generale, potremmo dire che è
L EFFICACIA DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2007-08
 1 La valutazione L EFFICACIA DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2007-08 Esiti occupazionali a 24 dalla partecipazione Vengono qui riassunti i risultati della
1 La valutazione L EFFICACIA DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2007-08 Esiti occupazionali a 24 dalla partecipazione Vengono qui riassunti i risultati della
La situazione dell investitore è chiaramente scomoda e occorre muoversi su due fronti:
 Analisti e strategisti di mercato amano interpretare le dinamiche dei mercati azionari in termini di fasi orso, fasi toro, cercando una chiave interpretativa dei mercati, a dimostrazione che i prezzi non
Analisti e strategisti di mercato amano interpretare le dinamiche dei mercati azionari in termini di fasi orso, fasi toro, cercando una chiave interpretativa dei mercati, a dimostrazione che i prezzi non
Forum regionale per l Educazione degli Adulti in Toscana
 Forum regionale per l Educazione degli Adulti in Toscana Progetto Linguaggi PASSEPARTOUT POR Toscana Ob. -Competitività regionale e occupazione FSE 007 013 Asse IV Capitale umano A.D. 174 del 30.06.010
Forum regionale per l Educazione degli Adulti in Toscana Progetto Linguaggi PASSEPARTOUT POR Toscana Ob. -Competitività regionale e occupazione FSE 007 013 Asse IV Capitale umano A.D. 174 del 30.06.010
Analisi di bilancio: un modello con grafici
 Esercitazioni svolte di laboratorio 2008 Scuola Duemila 207 Il caso Esercitazione svolta di laboratorio n. 3 Analisi di bilancio: un modello con grafici Roberto Bandinelli Riccardo Mazzoni Gli addetti
Esercitazioni svolte di laboratorio 2008 Scuola Duemila 207 Il caso Esercitazione svolta di laboratorio n. 3 Analisi di bilancio: un modello con grafici Roberto Bandinelli Riccardo Mazzoni Gli addetti
OPEN - Fondazione Nord Est Febbraio 2013
 A7. FECONDITÀ, NUZIALITÀ E DIVORZIALITÀ Diminuisce il tasso di fertilità dopo la crescita degli ultimi anni A livello nazionale il tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna in età feconda)
A7. FECONDITÀ, NUZIALITÀ E DIVORZIALITÀ Diminuisce il tasso di fertilità dopo la crescita degli ultimi anni A livello nazionale il tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna in età feconda)
ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA a cura Giuseppe Polli SECONDA PARTE clicca QUI per accedere direttamente alla prima parte dell'intervento...
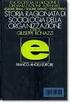 ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA a cura Giuseppe Polli SECONDA PARTE clicca QUI per accedere direttamente alla prima parte dell'intervento... 4 GLI INDICI DI LIQUIDITA L analisi procede con la costruzione
ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA a cura Giuseppe Polli SECONDA PARTE clicca QUI per accedere direttamente alla prima parte dell'intervento... 4 GLI INDICI DI LIQUIDITA L analisi procede con la costruzione
Le pillole di. TURISMO Come la crisi ha cambiato le vacanze degli italiani. (maggio 2014) Ufficio studi. Notizie, commenti, istruzioni ed altro
 Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro TURISMO Come la crisi ha cambiato le vacanze degli italiani (maggio 2014) Ufficio studi a cura di : Luciano Sbraga Giulia R. Erba PREMESSA La rilevazione
Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro TURISMO Come la crisi ha cambiato le vacanze degli italiani (maggio 2014) Ufficio studi a cura di : Luciano Sbraga Giulia R. Erba PREMESSA La rilevazione
COSTRUIRE UN TEAM VINCENTE DENTRO E FUORI DAL CAMPO
 COSTRUIRE UN TEAM VINCENTE DENTRO E FUORI DAL CAMPO I punti chiave per la formazione e gestione del team di lavoro PARTE 1. Le differenze tra gruppo e squadra Come prima indicazione, consiglio di andare
COSTRUIRE UN TEAM VINCENTE DENTRO E FUORI DAL CAMPO I punti chiave per la formazione e gestione del team di lavoro PARTE 1. Le differenze tra gruppo e squadra Come prima indicazione, consiglio di andare
ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA
 NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA MARZO 2010 1. L andamento generale negli alberghi della Provincia di Roma 2.
NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA MARZO 2010 1. L andamento generale negli alberghi della Provincia di Roma 2.
FORMULARIO DI RICHIESTA S U P P O R T Versione 2007 Sostegno ai progetti di promozione della salute realizzati da immigrati e immigrate
 FORMULARIO DI RICHIESTA S U P P O R T Versione 2007 Sostegno ai progetti di promozione della salute realizzati da immigrati e immigrate Nome del progetto Prevenzione Africa Richiedente Nome Imed Omrane
FORMULARIO DI RICHIESTA S U P P O R T Versione 2007 Sostegno ai progetti di promozione della salute realizzati da immigrati e immigrate Nome del progetto Prevenzione Africa Richiedente Nome Imed Omrane
Sicurezza stradale e nuovi cittadini
 Sicurezza stradale e nuovi cittadini Premessa Dall Unità d Italia ad oggi, la presenza straniera nel nostro Paese è profondamente mutata sia nei numeri che nella tipologia. Se, infatti, fino a qualche
Sicurezza stradale e nuovi cittadini Premessa Dall Unità d Italia ad oggi, la presenza straniera nel nostro Paese è profondamente mutata sia nei numeri che nella tipologia. Se, infatti, fino a qualche
