gianluca miligi Sulla domanda metafisica. Gli invïdiosi veri di Sigieri di Brabante
|
|
|
- Antonio Valerio Carella
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 gianluca miligi Sulla domanda metafisica. Gli invïdiosi veri di Sigieri di Brabante
2 Il testo è pubblicato da rivista on-line registrata; codice internazionale issn Il copyright degli articoli è libero. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da Condizioni per riprodurre i materiali: Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all interno di questo sito web sono no copyright, nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Filosofia.it, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale alla homepage o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www. filosofia.it dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo info@filosofia.it, allegando, laddo ve possibile, copia elettronica dell articolo in cui i materiali sono stati riprodotti. essais ISSN
3 Sulla domanda metafisica Gli Invidïosi veri di Sigieri di Brabante di Gianluca Miligi Quando pronuncio la parola Niente, creo qualcosa che non entra in nessun nulla. Wisława Szymborska La più classica e radicale domanda della metafisica, dell ontologia, la sua Grundfrage, è stata tematizzata e a fondo indagata da G.W. Leibniz: Pourquoy il y a plutôt quelque chose que rien?, Perché c è qualcosa piuttosto che il nulla? 1 o, più essenziale: Perché l essere e non il nulla?. Ma a rigore, come pochi sanno, il primo a formulare la domanda metafisica è stato, quasi cinque secoli prima, Sigieri di brabante (1235ca ca) nelle Quaestiones in Metaphysicam: «Quare est magis aliquid quam nihil», recita il testo. traggo questa preziosa indicazione da un interessante saggio del professore, e sincero amico, amedeo G. Conte, dal titolo Opera morta: tre temi emergenti in deontica filosofica, posto in apertura del terzo volume della sua Filosofia del linguaggio normativo. 2 Prima di indagare il testo delle Quaestiones, qualche cenno sulla figura e il pensiero di Sigieri. 3 al filosofo e teologo fiammingo Dante attribuisce attraverso tommaso d aquino, nel canto decimo del Paradiso, nientemeno che facoltà di emanare luce etterna : Questi onde a me ritorna il tuo riguardo, è l lume d uno spirto che n pensieri gravi a morir li parve venir tardo: essa è la luce etterna di Sigieri, che, leggendo nel Vico de li Strami, silogizzò invidïosi veri. 1 G.W. Leibniz, Principes de la nature et de la grace fondés en raison (1714); Princìpi razionali della Natura e della Grazia, 7, in Monadologia, a cura di S. Cariati, Milano, bompiani, 2001, p a.g. Conte, Opera morta: tre temi emergenti in deontica filosofica, in Filosofia del linguaggio normativo iii. Studi , torino, Giappichelli, 2001, p. xxx. 3 al riguardo si può consultare la biografia filosofica di x. PutaLLaz e r. imbach, Professione filosofo. Sigieri di Brabante, Milano, Jaca book, 1998.
4 2 GianLuCa MiLiGi Chi fu veramente Sigieri, astro più luminoso del sole posto al culmine? nella corona dei dodici massimi spiriti sapienti, presieduta da tommaso? in primo luogo risulta singolare la presenza dei due nel medesimo luogo del Paradiso, considerato che l aquinate, sommo Dottore della Chiesa, fu strenuo avversario dell altro e tentò di confutarne le tesi averroistiche sulla unicità dell intelletto scrivendo ad hoc il suo De unitate intellectus contra averroistas (1270). 4 La dottrina dell intelletto agente e possibile unico, separato, non generabile, eterno, era stata definita dal filosofo arabo ibn rushd, il latino averroè ( ) e sostenuta da Sigieri; notiamo solo che la questione, che qui non può essere seguita, si complica relativamente al rapporto tra intelletto agente e possibile. 5 Sempre Dante cita nella Divina Commedia due volte, una direttamente, l altra indirettamente, proprio averroè. nella prima citazione, «averroís che l gran comento feo». (Inf. iv, 144), figura come il grande commentatore di aristotele, e si trova nel castello dei grandi dell antichità poeti, eroi, filosofi, i quali non furono peccatori, perché non poterono nemmeno conoscere il messaggio salvifico del cristianesimo. in secondo luogo, nel Purgatorio, rinveniamo l altra citazione, più interessante dal punto di vista filosofico: «sí che per sua dottrina fé disgiunto / da l anima il possibile intelletto, / perché da lui non vide organo assunto» (Purg. xxv, vv. 63 ss.). Questa dottrina ripresa da Sigieri, a giudizio di Dante, era erronea, ma in più rappresentava realmente una dottrina eversiva per la teologia dogmatica, ossia, come è stato rilevato, «contraria in modo pesante agli insegnamenti del cristianesimo» (Van Steenberghen). Per quale motivo? essenzialmente perché «se vi è un intelletto per tutti gli uomini» (q. 9) infatti «se vi fossero tanti intelletti quanti i singoli uomini, l intelletto sarebbe una facoltà del corpo [materia]»: ma ciò risulta contraddittorio, allora non si può sostenere l immortalità e la salvezza dell anima individuale, del singolo uomo. Le teorizzazioni di averroé e di Sigieri nascono dall interpretazione del De anima di aristotele, in particolare del terzo libro: quella sigeriana è racchiusa nelle Quaestiones in tertium de anima (1269). È qui forse che egli, nel mirabile linguaggio dantesco, silogizzò invidïosi veri, ossia sostenne con rigoroso ragionamento verità che suscitarono controversie, avversioni e condanne, tra cui quella veemente, ma inconsistente da un punto di vista filosofico, di bonaventura da bagnoregio. e a proposito di condanne non si può non ricordare quella famosa, la prima, 4 thomae aquin., Tractatus de unitate intellectus, iv 90, ed. L.W. KeeLer, roma, Pontificia università Gregoriana, Per la traduzione in italiano e il commento di alcuni passi dell opera di averroè, del Grande commento al libro terzo del De anima di aristotele, rimandiamo a a. illuminati, Averroè e l intelletto pubblico. Antologia di scritti di Ibn Rushd sull anima, roma, Manifestolibri, 1996.
5 SuLLa DoManDa MetaFiSiCa 3 con conseguente scomunica, emessa dal Vescovo di Parigi Étienne tempier il 10 dicembre del 1270 contro le dottrine sovversive insegnate nella Facoltà delle arti all università di Parigi sita in Vico de li Strami dal maestro Sigieri e da altri docenti. il primo articolo (gli articoli sono 13) condanna proprio la tesi secondo cui Intellectus omnium hominum est unus et idem numero, «L intelletto di tutti gli uomini è uno e identico per tutti», 6 da cui discende che la proposizione L uomo intende [homo intelligit], ossia che il singolo uomo è in grado da sé di intendere, è falsa o inesatta. È infatti l intelletto unico che genera nel pensiero umano le specie intellettive o concetti universali. 7 ai punti 5 e 6 troviamo invece colpita l altra dottrina sostenuta da quei maestri di filosofia il cui esponente di spicco era proprio Sigieri di brabante (da non dimenticare l altra figura importante, boezio di Dacia): l eternità del mondo Quod mundus est aeternus, mutuata dalla filosofia aristotelica. ad essa è collegata la tesi sesta secondo cui «non vi fu mai un primo uomo», e quindi la specie umana è anch essa eterna. risulta evidente che la dottrina filosofica dell eternità del mondo è esattamente opposta, e se argomentata ne è una possibile, potente, confutazione, a quella della creazione ex nihilo: un altro attacco ai pilastri della teologia e della fede cristiana. È pur vero che la situazione era piuttosto complessa e che tentativi di conciliazione tra le due furono percorsi: è possibile pensare a una creazione in termini di produzione o causazione del mondo ab aeterno; oppure: l eternità del mondo in fondo consiste via negationis nell impossibilità di pensare un inizio del mondo stesso. Vogliamo però anche ricordare quanto sostiene Étienne Gilson nel suo classico La filosofia del Medioevo: oltre all eternità del mondo e della specie umana, Sigieri avrebbe proposto e ciò sembra plausibile, in quanto ne è consequenziale la teoria dell eterno ritorno. 8 Gilson riporta un passo 6 SiGer De brabant, Quaestiones in tertium De anima, éd. critique de b. bazan, Louvain 1972, q. 9, p. 25, 726, 12: «Quod sit unus intellectus in omnibus videtur. nulla forma immaterialis, una in specie, est multiplicata secundum numerum. Sed intellectus est forma immaterialis, una in specie. ergo non est multa in numero. item ratio Commentatoris ad illud. Si intellectus numeraretur numeratione hominum, intellectus esset virtus in corpore. intellectus non est virtus in corpore, ergo non numeraretur numeratione hominum»: questa tesi rientrerà nelle condanne del Per un analisi di natura schiettamente teoretica del rapporto tra unitàunicità dell intelletto e la molteplicità degli individui si veda G. SaSSo, Fondamento e giudizio. Un duplice tramonto?, napoli, bibliopolis, 2003, pp Cfr. É. GiLSon, La filosofia del Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del xiv secolo, trad. it., Firenze, La nuova italia, 1998 (la prima edizione dell opera in francese è del 1922), p. 676: «non solo il mondo e le specie sono eterni, tanto nel passato che nell avvenire, ma i fenomeni e gli avvenimenti si riproducono indefinitamente. ben prima di Vico e nietzsche, ma dopo averroé e con altri pensatori del suo tempo, Sigieri insegna quindi la teoria dell eterno ritorno». Segue nel testo il passo di Sigieri (ma senza indicazione dell opera): «Poiché il primo motore è sempre in atto, e non è in potenza prima di essere in atto, ne risulta che
6 4 GianLuCa MiLiGi in cui egli argomenta in questo modo: se c è un Primo Motore o Mobile sempre in atto, il quale sempre muove e agisce, allora nessuna specie può esser pervenuta in un determinato momento all essere, quindi «le stesse specie che sono esistite ritornano secondo un ciclo [ ]». Per il riferimento essenziale ad aristotele, che connette le due tesi portanti, Sigieri sostiene che «ipse iudicaret intellectum esse factum aeternum sicut mundum. et intellectus, quod intellectus est motor humanae speciei, est unum factum aeternum, non multiplicatum multiplicatione individuali»: 9 l intelletto, unico, non moltiplicato negli individui, è eterno come il mondo. al di là delle parziali rielaborazioni in linea con l ortodossia delle suddette teorie (e il riconoscimento spesso indotto della superiorità della verità rivelata), si può affermare che Sigieri, nel solco dell averroismo, fu un vero pensatore greco nel cuore di quel xiii secolo più difficile del xii in Spagna, in cui operò averroè segnato da dispute teologiche e condanne alla filosofia come pensiero autonomo. ricordiamo solo che dopo nel 1272 fu redatto uno statuto, all università di Parigi, che impediva l insegnamento di alcune dottrine filosofiche, ed emanata una successiva condanna nel 77. Le vie labirintiche dell argomentazione teologicometafisica medievale intorno ai decisivi concetti di eternità, creazione, inizio, necessiterebbero di specifiche competenze e di altra sede di analisi: ciò non implica però, come nel caso di Sigieri, che il loro sostrato filosofico non possa, con le dovute precauzioni filologiche, esser fatto emergere in modo chiaro. Purtroppo ci sembra sia calata un po d ombra sulla sua figura, la cui originalità consiste nella capacità in molti frangenti di pensare e non è poco sino in fondo alcune ardue questioni. non discuteremo qui le modifiche della sua dottrina dell unicità dell intelletto: ricordiamo invece che Sigieri fu nel 1277 chiamato in giudizio davanti al suo tribunale dall inquisitore di Francia per rispondere alla incriminazione di eresia, e di questa insistenza nel controllo del pensiero del maestro fiammingo bisognerebbe dare ragione. i suoi pensieri gravi a morir si spensero, nell attesa di una sentenza conclusiva presso la sede della curia pontificia a orvieto, sotto il pugnale impazzito del suo segretario. muove e agisce sempre ora per il fatto che esso muove e agisce sempre, risulta che nessuna specie arriva all essere senza esservi precedentemente pervenuta, di modo tale che le stesse specie che sono esistite ritornano secondo un ciclo, e le stesse opinioni, le stesse leggi, le stesse religioni [ ]». 9 SiGer De brabant, Quaestiones in tertium De anima, cit., q. 2, p. 6, 47-52: «unde si quaereretur ab aristotele utrum intellectus sit factum novum vel sit factum aeternum, ipse iudicaret intellectum esse factum aeternum sicut mundum. et intellectus, quod intellectus est motor humanae speciei, est unum factum aeternum, non multiplicatum multiplicatione individuali».
7 SuLLa DoManDa MetaFiSiCa 5 rivolgiamoci ora al tema del nulla, connesso a quelli sopra citati, e vediamo come si presenta nelle sigeriane Quaestiones di metafisica, dove troviamo la prima formulazione o, se si vuole, prefigurazione, della domanda metafisicoontologica. innanzi tutto si deve precisare che le Quaestiones in Metaphysicam (QiM), risalenti agli anni intorno al 1273, consistono in reportationes di corsi di lezioni tenuti da Sigieri all università. tra i diversi testi con il medesimo titolo e argomento segnaliamo: QiM. Édition revue de la reportation de Munich. Texte inédit da la reportaion de Vienne, ed. W. DunPhy, Louvaine-la-neuve, edition de L institut Supérieur de Philosophie, 1981 (in Met. 1), quella che ci interessa, e QiM. Texte inédit da la reportaion de Cambridge. Édition revue de la reportation de Paris, éd. a. Maurer, Louvainelaneuve, Édition de L institut Supérieur de Philosophie, 1983 (in Met. 2). nel testo delle Quaestiones, che si apre con l importante dibattito sulla distinzione tra esse ed essentia, si legge: Quare est magis aliquid quam nihil, Perché vi è qualcosa [aliquid] piuttosto che nulla [nihil] : è indubbia la paternità sigeriana, probabilmente inconsapevole, di tale dirompente quaestio. Di formulazioni nel corso della storia della filosofia ve ne sono state diverse oltre Leibniz, Schelling e heidegger, e la diversità terminologica assume talvolta un rilievo imprescindibile in àmbito concettuale. È allora importante, considerato che nostro intento non è di soddisfare erudite curiosità, citare il passo completo dell opera rivelatrice: non enim omne ens entitatis suae causam habet nec omnis quaestio quaerens de esse habet causam. Si enim quaeratur quare magis est aliquid in rerum natura quam nihil, in rebus causatis loquendo, contingit respondere quia est aliquid Primum Movens immobile et Causa Prima intransmutabilis. Si vero quaeratur de tota universitate entium quare magis est in eis aliquid quam nihil, non contingit dare causam, quia idem est quaerere hoc et quaerere quare magis est Deus quam non est, et hoc non habet causam. unde non omnis quaestio habet causam nec etiam omne ens. 10 evidentemente Sigieri imposta la questione (in Met. 1) dando centralità al concetto di causa. nelle posteriori Quaestiones super librum de causis ( ) si afferma che la causa prima è l essere stesso (ipsum esse), e soprattutto che «la causa prima è l essere stesso per sé sussistente», per se subsistens (In librum de Causis 9 bis, 59 rr ). egli definisce quasi 10 SiGer De brabant, Quaestiones in Metaphysicam, ed. W. DunPhy, Louvain-la-neuve, Éditions de l institut Supérieur de Philosophie, 1981, p. 170.
8 6 GianLuCa MiLiGi sempre Dio come Causa prima, e così si chiariscono preliminarmente le coordinate concettuali della domanda metafisica formulata nelle Quaestiones. in ultima analisi, un attenta lettura di questo testo sembra ormai imprescindibile per chi voglia approfondire le radici di una domanda che ha segnato la storia del pensiero occidentale.
9
Introduzione alla Teologia
 Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Prof. Monti a.s
 Conclusioni sulla Patristica ti e considerazioni generali > I PERIODI DELLA PATRISTICA < Abbiamo visto come l avvento del Cristianesimo abbia deviato la filosofia, dandole un nuovo aspetto. Agostino è
Conclusioni sulla Patristica ti e considerazioni generali > I PERIODI DELLA PATRISTICA < Abbiamo visto come l avvento del Cristianesimo abbia deviato la filosofia, dandole un nuovo aspetto. Agostino è
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica
 PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
R I F D R I V I S T A I N T E R N A Z I O N A L E D I F I L O S O F I A D E L D I R I T T O
 R I F D R I V I S T A I N T E R N A Z I O N A L E D I F I L O S O F I A D E L D I R I T T O serie V - anno LXXXIX n. 3 - luglio / settembre 2012 Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b - legge 662/96
R I F D R I V I S T A I N T E R N A Z I O N A L E D I F I L O S O F I A D E L D I R I T T O serie V - anno LXXXIX n. 3 - luglio / settembre 2012 Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b - legge 662/96
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI
 TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
RECENSIONIRECENSIONIRECENSIONI. Da Gehlen a Herder. Origine del linguaggio e ricezione di Herder nel pensiero antropologico tedesco
 RECENSIONIRECENSIONIRECENSIONI mario marino Da Gehlen a Herder. Origine del linguaggio e ricezione di Herder nel pensiero antropologico tedesco Bologna, il Mulino, 2009 www.filosofia.it Il testo è pubblicato
RECENSIONIRECENSIONIRECENSIONI mario marino Da Gehlen a Herder. Origine del linguaggio e ricezione di Herder nel pensiero antropologico tedesco Bologna, il Mulino, 2009 www.filosofia.it Il testo è pubblicato
Quale domanda fondamentale pone?
 S. Tommaso d Aquino Nasce nel 1225 nel castello di Roccasecca presso Aquino, nel basso Lazio, da un antica famiglia nobile (il padre di stirpe longobarda, la madre di stirpe normanna, I primi studi li
S. Tommaso d Aquino Nasce nel 1225 nel castello di Roccasecca presso Aquino, nel basso Lazio, da un antica famiglia nobile (il padre di stirpe longobarda, la madre di stirpe normanna, I primi studi li
recensionirecensionirecensioni Per una fenomenologia dell abitare. Il pensiero di Martin Heidegger come oikosophia virgilio cesarone
 recensionirecensionirecensioni virgilio cesarone Per una fenomenologia dell abitare. Il pensiero di Martin Heidegger come oikosophia Milano-Genova, Marietti 1820, 2008 www.filosofia.it Il testo è pubblicato
recensionirecensionirecensioni virgilio cesarone Per una fenomenologia dell abitare. Il pensiero di Martin Heidegger come oikosophia Milano-Genova, Marietti 1820, 2008 www.filosofia.it Il testo è pubblicato
PROGRAMMA di FILOSOFIA
 PROGRAMMA di FILOSOFIA CLASSE IV C a. s. 2015/2016 Testi: Reale, Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico voll. 1B,2A, 2B. Parte quarta La Scolastica fra XI e XIII secolo Cap. 9 Anselmo d
PROGRAMMA di FILOSOFIA CLASSE IV C a. s. 2015/2016 Testi: Reale, Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico voll. 1B,2A, 2B. Parte quarta La Scolastica fra XI e XIII secolo Cap. 9 Anselmo d
IL RACCONTO DELLA FILOSOFIA
 UGO PERONE IL RACCONTO DELLA FILOSOFIA Breve storia della filosofia Queriniana Indice generale Racconto e storia.... 5 La filosofia si definisce.... 9 1. I primordi 9 2. La filosofia nello spazio della
UGO PERONE IL RACCONTO DELLA FILOSOFIA Breve storia della filosofia Queriniana Indice generale Racconto e storia.... 5 La filosofia si definisce.... 9 1. I primordi 9 2. La filosofia nello spazio della
L indagine sulla natura: il pensiero presocratico
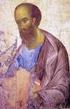 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico
 Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
Cataldo Zuccaro. Teologia morale fondamentale
 Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
Filosofia e cultura ebraica 1. La cultura ebraica dalle origini a Maimonide. Lezioni d'autore
 Filosofia e cultura ebraica 1. La cultura ebraica dalle origini a Maimonide Lezioni d'autore Le fonti Le prime scuole importanti di religione e cultura ebraica risalgono al I sec. a.c. I testi sui quali
Filosofia e cultura ebraica 1. La cultura ebraica dalle origini a Maimonide Lezioni d'autore Le fonti Le prime scuole importanti di religione e cultura ebraica risalgono al I sec. a.c. I testi sui quali
ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
 Giovanni Ancona ANTROPOLOGIA TEOLOGICA Temi fondamentali QUERINIANA Indice generale Introduzione........................................... 5 1. La riflessione teologica intorno al l uomo (antropologia
Giovanni Ancona ANTROPOLOGIA TEOLOGICA Temi fondamentali QUERINIANA Indice generale Introduzione........................................... 5 1. La riflessione teologica intorno al l uomo (antropologia
INDICE GENERALE. Introduzione parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ
 INDICE GENERALE Introduzione...005 parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ I. La fede cristiana nella stagione della postmodernità...015 1.1. Il mondo culturale contemporaneo...015
INDICE GENERALE Introduzione...005 parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ I. La fede cristiana nella stagione della postmodernità...015 1.1. Il mondo culturale contemporaneo...015
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno Classe 1 A
 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2017-2018 Classe 1 A 1. Questioni di morale sociale: matrimonio e famiglia. 2. La realtà antropologica dell uomo e della donna: differenza e diversità. 3. Il progetto di Dio
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2017-2018 Classe 1 A 1. Questioni di morale sociale: matrimonio e famiglia. 2. La realtà antropologica dell uomo e della donna: differenza e diversità. 3. Il progetto di Dio
Principio di non contraddizione e dialettica 3
 Principio di non contraddizione e dialettica 3 DIALET TICA E CONTRADDIZIONE IN HEGEL Passaggio dalla seconda alla terza lezione Nelle prime due lezioni abbiamo mostrato come la relazione tra le categorie
Principio di non contraddizione e dialettica 3 DIALET TICA E CONTRADDIZIONE IN HEGEL Passaggio dalla seconda alla terza lezione Nelle prime due lezioni abbiamo mostrato come la relazione tra le categorie
1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131
 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno Classe 1 A
 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2018-2019 Classe 1 A 1. Il senso religioso: le domande esistenziali dell uomo - partire da se stessi - L uomo composto di corpo e anima. Inscindibilità della natura umana.
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2018-2019 Classe 1 A 1. Il senso religioso: le domande esistenziali dell uomo - partire da se stessi - L uomo composto di corpo e anima. Inscindibilità della natura umana.
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
> NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
Transizione DA cultura Classica A cultura Cristiana
 Transizione DA cultura Classica A cultura Cristiana Attraverso l'applicazione dei criteri della cultura classica alla cultura cristiana Es.: coerenza (identità, non contraddizione, terzo escluso) l'accordo
Transizione DA cultura Classica A cultura Cristiana Attraverso l'applicazione dei criteri della cultura classica alla cultura cristiana Es.: coerenza (identità, non contraddizione, terzo escluso) l'accordo
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
Hume e Smith Filosofia e cittadinanza
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Hume e Smith Filosofia e cittadinanza Comprensione del testo 1. Quali caratteristiche e concetti accomunano la vita e il pensiero
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Hume e Smith Filosofia e cittadinanza Comprensione del testo 1. Quali caratteristiche e concetti accomunano la vita e il pensiero
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Programma di Filosofia Classe 4, sez. B I.I.S. "Croce-Aleramo" Roma anno scolastico
 Programma di Filosofia Classe 4, sez. B I.I.S. "Croce-Aleramo" Roma anno scolastico 2017-2018 Vol. 1B LO STOICISMO 1. La scuola stoica 2. La logica (no) 3. La fisica 4. L antropologia 5. L etica 6. La
Programma di Filosofia Classe 4, sez. B I.I.S. "Croce-Aleramo" Roma anno scolastico 2017-2018 Vol. 1B LO STOICISMO 1. La scuola stoica 2. La logica (no) 3. La fisica 4. L antropologia 5. L etica 6. La
Pastorale delle famiglie
 Pastorale delle famiglie Animatori Filippo e Graziella Anfuso Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it La ragionevolezza della fede in Dio Benedetto
Pastorale delle famiglie Animatori Filippo e Graziella Anfuso Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it La ragionevolezza della fede in Dio Benedetto
Filosofia e cultura ebraica 3. L Illuminismo ebraico e Moses Mendelssohn. Lezioni d'autore
 Filosofia e cultura ebraica 3. L Illuminismo ebraico e Moses Mendelssohn Lezioni d'autore Per Illuminismo ebraico, Haskalah, s intende quel movimento filosofico e culturale che portò la cultura e la tradizione
Filosofia e cultura ebraica 3. L Illuminismo ebraico e Moses Mendelssohn Lezioni d'autore Per Illuminismo ebraico, Haskalah, s intende quel movimento filosofico e culturale che portò la cultura e la tradizione
Pubblicato per. da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN
 Pubblicato per da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-09823-6 Prima edizione: febbraio 2018 Realizzazione editoriale: Studio Editoriale
Pubblicato per da Mondadori Libri S.p.A. Proprietà letteraria riservata 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-09823-6 Prima edizione: febbraio 2018 Realizzazione editoriale: Studio Editoriale
Seminario del 16 febbraio 2008 IL RAPPORTO FRA FEDE E RAGIONE IN TOMMASO D AQUINO. ALBERTO STRUMIA strumia/
 Seminario del 16 febbraio 2008 IL RAPPORTO FRA FEDE E RAGIONE IN TOMMASO D AQUINO ALBERTO STRUMIA www.ciram.unibo.it/ strumia/ Università di Bari Facoltà Teologica dell Emilia-Romagna S O M M A R I O S
Seminario del 16 febbraio 2008 IL RAPPORTO FRA FEDE E RAGIONE IN TOMMASO D AQUINO ALBERTO STRUMIA www.ciram.unibo.it/ strumia/ Università di Bari Facoltà Teologica dell Emilia-Romagna S O M M A R I O S
LA FILOSOFIA MEDIEVALE Caratteri generali
 LA FILOSOFIA MEDIEVALE Caratteri generali Le dinamiche della società medievale (dell ALTO e BASSO Medioevo) determinano le dinamiche stesse della cultura in generale; la identità della filosofia, in particolare;
LA FILOSOFIA MEDIEVALE Caratteri generali Le dinamiche della società medievale (dell ALTO e BASSO Medioevo) determinano le dinamiche stesse della cultura in generale; la identità della filosofia, in particolare;
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI. Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA
 UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA
 PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA Approvati dal Consiglio Direttivo il 25 giugno 2013 e dalla Congregazione per l Educazione Cattolica il primo agosto 2013 Art. 1. Fine
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA Approvati dal Consiglio Direttivo il 25 giugno 2013 e dalla Congregazione per l Educazione Cattolica il primo agosto 2013 Art. 1. Fine
z. bauman La libertà Troina (EN), Città Aperta, 2002 recensionirecensionirecensioni
 recensionirecensionirecensioni z. bauman La libertà Troina (EN), Città Aperta, 2002 www.filosofia.it Il testo è pubblicato da www.filosofia.it, rivista on-line registrata; codice internazionale issn 1722-9782.
recensionirecensionirecensioni z. bauman La libertà Troina (EN), Città Aperta, 2002 www.filosofia.it Il testo è pubblicato da www.filosofia.it, rivista on-line registrata; codice internazionale issn 1722-9782.
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO
 LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
Ordine del mondo. Geometricamente determinato Unico Necessario. Spontaneamente organizzato Universale Contingente
 LEIBNIZ Ordine del mondo Geometricamente determinato Unico Necessario Spontaneamente organizzato Universale Contingente Spinoza Leibniz Lo spirito conciliazionista Meccanicismo Materialismo Scienza Filosofia
LEIBNIZ Ordine del mondo Geometricamente determinato Unico Necessario Spontaneamente organizzato Universale Contingente Spinoza Leibniz Lo spirito conciliazionista Meccanicismo Materialismo Scienza Filosofia
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C.
 ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
INTRODUZIONE ALLA LOGICA DEONTICA
 INTRODUZIONE ALLA LOGICA DEONTICA Parte I: Cenni di antropologia filosofica Schemi ad Uso degli Studenti Roma 2008 0. Schema del Corso BIBLIOGRAFIA GENERALE 0.1. PARTE ANTROPOLOGICA 0.1.1. La libertà 0.1.2.
INTRODUZIONE ALLA LOGICA DEONTICA Parte I: Cenni di antropologia filosofica Schemi ad Uso degli Studenti Roma 2008 0. Schema del Corso BIBLIOGRAFIA GENERALE 0.1. PARTE ANTROPOLOGICA 0.1.1. La libertà 0.1.2.
RELIGIONE - CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 RELIGIONE - CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; Sa riconoscere i segni della presenza
RELIGIONE - CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; Sa riconoscere i segni della presenza
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA. ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B
 PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
GIOVANNI GENTILE ( ) Gentile: lo spirito come atto. Vita ed opere
 GIOVANNI GENTILE (1875-1944) Ritratto di Giovanni Gentile http://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2016/04/giovanni-gentile.jpg Gentile: lo spirito come atto Vita ed opere Settantacinque in
GIOVANNI GENTILE (1875-1944) Ritratto di Giovanni Gentile http://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2016/04/giovanni-gentile.jpg Gentile: lo spirito come atto Vita ed opere Settantacinque in
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Andrea Guarise. PROGETTO DIDATTICO CLASSE 3 a E scientifico
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Es. quadrilatero: specie di poligono, genere di quadrato. La specie ha più caratteristiche, il genere è riferito a più elementi.
 La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
Anassimene. Pitagora e i pitagorici Eraclito Parmenide Lettura tratta da: Parmenide, Sulla natura, Bompiani 2001 Zenone: la dimostrazione per assurdo
 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-89055263 codice fiscale 97504620150
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-89055263 codice fiscale 97504620150
MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE
 Josef Wohlmuth MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE Tentativo di una escatologia tridimensionale, in dialogo con il pensiero ebraico e la filosofia contemporanea QUERINIANA Indice Prefazione..............................................
Josef Wohlmuth MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE Tentativo di una escatologia tridimensionale, in dialogo con il pensiero ebraico e la filosofia contemporanea QUERINIANA Indice Prefazione..............................................
Attualità del pensiero politico di Dante?
 Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
dubbi e attese del paziente
 10 febbraio 2018 XXVI Giornata Mondiale del Malato Associazione Medici Cattolici Italiani Novara Nuova Carta degli Operatori Sanitari dubbi e attese del paziente ROBERTO MARI MISTERI DELLA VITA pg 11 La
10 febbraio 2018 XXVI Giornata Mondiale del Malato Associazione Medici Cattolici Italiani Novara Nuova Carta degli Operatori Sanitari dubbi e attese del paziente ROBERTO MARI MISTERI DELLA VITA pg 11 La
z. bauman Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell effimero Bologna, il Mulino, 2009 recensionirecensionirecensioni
 recensionirecensionirecensioni z. bauman Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell effimero Bologna, il Mulino, 2009 Il testo è pubblicato da, rivista on-line registrata; codice internazionale issn
recensionirecensionirecensioni z. bauman Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell effimero Bologna, il Mulino, 2009 Il testo è pubblicato da, rivista on-line registrata; codice internazionale issn
Lezione Ragione critica e rivelazione
 Lezione Ragione critica e rivelazione percorsi 1 Lo scritto di I. Kant sulla religione 2 Religione o Rivelazione 3 Una questione insoluta? obiettivi Dalla domanda sulla realtà conoscibile alla questione
Lezione Ragione critica e rivelazione percorsi 1 Lo scritto di I. Kant sulla religione 2 Religione o Rivelazione 3 Una questione insoluta? obiettivi Dalla domanda sulla realtà conoscibile alla questione
PIANO DI LAVORO PREVENTIVO
 Docente: ROMANO GASPAROTTI Classe: IV sez. C Disciplina: FILOSOFIA a.s. 2018/2019 PIANO DI LAVORO PREVENTIVO LIVELLO DELLA CLASSE RILEVATO ALL INIZIO DELL ANNO La classe sembra dimostrare un comportamento
Docente: ROMANO GASPAROTTI Classe: IV sez. C Disciplina: FILOSOFIA a.s. 2018/2019 PIANO DI LAVORO PREVENTIVO LIVELLO DELLA CLASSE RILEVATO ALL INIZIO DELL ANNO La classe sembra dimostrare un comportamento
Programma di storia Classe 4 a E a.s Prof. Camilla Hermanin
 Programma di storia Classe 4 a E a.s. 2017-2018 Le conseguenze politiche della Riforma in Europa: disciplinamento sociale e riforma dell istituzione ecclesiastica. La Spagna di Filippo II e la nascita
Programma di storia Classe 4 a E a.s. 2017-2018 Le conseguenze politiche della Riforma in Europa: disciplinamento sociale e riforma dell istituzione ecclesiastica. La Spagna di Filippo II e la nascita
PASSI BIBLICI DIFFICILI
 Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L-36)
 Insegnamento Livello e corso di studio Settore scientifico disciplinare (SSD) Filosofia politica Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L-36) SPS/01 Anno
Insegnamento Livello e corso di studio Settore scientifico disciplinare (SSD) Filosofia politica Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L-36) SPS/01 Anno
P. DANIELE D AGOSTINO
 P. DANIELE D AGOSTINO DATI ANAGRAFICI Nato a Catania 10 giugno 1973 Residenza: Fam. D Agostino - Via Isonzo, 16 94017 Regalbuto EN Domicilio: Seminario Vescovile Via San Francesco di Fuori n. 10-03011
P. DANIELE D AGOSTINO DATI ANAGRAFICI Nato a Catania 10 giugno 1973 Residenza: Fam. D Agostino - Via Isonzo, 16 94017 Regalbuto EN Domicilio: Seminario Vescovile Via San Francesco di Fuori n. 10-03011
Lezione N.7 Il pensiero postmetafisico.
 Lezione N.7 Il pensiero postmetafisico. percorsi 1. Una furia antimetafisica? 2. Lo sguardo sull Intero 3. Pensiero ed Essere 4. La Via salvifica dell esercizio teoretico obiettivi Volendo delineare le
Lezione N.7 Il pensiero postmetafisico. percorsi 1. Una furia antimetafisica? 2. Lo sguardo sull Intero 3. Pensiero ed Essere 4. La Via salvifica dell esercizio teoretico obiettivi Volendo delineare le
RELAZIONE FINALE. Istituto di Istruzione Superiore telefono: ITALO CALVINO fax: via Guido Rossa ROZZANO MI
 Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,
Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA. I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche
 ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
Chi era Etienne Gilson?
 Chi era Etienne Gilson? Gilson, Étienne Storico francese della filosofia (Parigi 1884 - Cravant, Yonne, 1978). Prof. nelle univ. di Lilla (1913), di Strasburgo (1919) e alla Sorbona (1921), directeur d
Chi era Etienne Gilson? Gilson, Étienne Storico francese della filosofia (Parigi 1884 - Cravant, Yonne, 1978). Prof. nelle univ. di Lilla (1913), di Strasburgo (1919) e alla Sorbona (1921), directeur d
PROGRAMMA DI STORIA. Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO
 PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-I fondamenti del potere 2.1-La signoria
PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-I fondamenti del potere 2.1-La signoria
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO
 Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi Anno scolastico 2018/2019 Piano di lavoro per la classe III D Scienze applicate Materia: Filosofia Docente: Marco Latino PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La
Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi Anno scolastico 2018/2019 Piano di lavoro per la classe III D Scienze applicate Materia: Filosofia Docente: Marco Latino PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La
Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi. Anno scolastico 2018/2019. Piano di lavoro per la classe III B Liceo linguistico
 Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi Anno scolastico 2018/2019 Piano di lavoro per la classe III B Liceo linguistico Materia: Filosofia Docente: Camilla Tinelli PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi Anno scolastico 2018/2019 Piano di lavoro per la classe III B Liceo linguistico Materia: Filosofia Docente: Camilla Tinelli PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Curriculum. -Assegnista di Ricerca confermato presso il Dipartimento di Filosofia A. Aliotta per l A. A. 2009/2010;
 Curriculum -Laurea in Sociologia (tesi in sociologia della conoscenza, dal titolo: Protestantesimo e secolarizzazione. La frantumazione dell universo sacro, relatore Prof. A. Cavicchia Scalamonti) conseguita
Curriculum -Laurea in Sociologia (tesi in sociologia della conoscenza, dal titolo: Protestantesimo e secolarizzazione. La frantumazione dell universo sacro, relatore Prof. A. Cavicchia Scalamonti) conseguita
Sacra Scrittura e Simbolo
 Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Filosofia l origine. A cura di Pietro Gavagnin Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.
 Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A COGNOME E NOME: D
 SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A. 2018-2019 COGNOME E NOME: D Arcangeli Marco Antonio QUALIFICA: Professore Associato SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/01, Pedagogia generale e sociale NOME INSEGNAMENTO:
SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A. 2018-2019 COGNOME E NOME: D Arcangeli Marco Antonio QUALIFICA: Professore Associato SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/01, Pedagogia generale e sociale NOME INSEGNAMENTO:
1 novembre 2007 Festa di Ognissanti, memoria della Communio sanctorum Gisbert Greshake
 Premessa I catechismi, i libri di teologia e le esposizioni sistematiche della dogmatica sono per lo più concluse da un capitolo sulle cosiddette cose ultime, che nel linguaggio dei teologi prendono il
Premessa I catechismi, i libri di teologia e le esposizioni sistematiche della dogmatica sono per lo più concluse da un capitolo sulle cosiddette cose ultime, che nel linguaggio dei teologi prendono il
Domenica, 17 dicembre Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano
 Domenica, 17 dicembre 2017 Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano Silvana Borutti Wittgenstein: la filosofia come compito e come risveglio Ora avrei la possibilità di essere una persona
Domenica, 17 dicembre 2017 Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano Silvana Borutti Wittgenstein: la filosofia come compito e come risveglio Ora avrei la possibilità di essere una persona
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALI DI DIPARTIMENTO MICROAREA FILOSOFIA
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALI DI DIPARTIMENTO MICROAREA FILOSOFIA (programmazione elaborata in conformità delle INDICAZIONI NAZIONALI di cui al DM 211 del 7-10-2010) Indirizzi:
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALI DI DIPARTIMENTO MICROAREA FILOSOFIA (programmazione elaborata in conformità delle INDICAZIONI NAZIONALI di cui al DM 211 del 7-10-2010) Indirizzi:
Sezione III. Tradizione
 Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Anno scolastico PROGRAMMA SVOLTO E CONTENUTI MINIMI. Docente: Enzo Citarella. Materia: Filosofia
 Anno scolastico 2015-16 PROGRAMMA SVOLTO E CONTENUTI MINIMI Docente: Enzo Citarella Materia: Filosofia Classe : 4 F Indirizzo Linguistico ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI SECONDO UNITA FORMATIVE
Anno scolastico 2015-16 PROGRAMMA SVOLTO E CONTENUTI MINIMI Docente: Enzo Citarella Materia: Filosofia Classe : 4 F Indirizzo Linguistico ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI SECONDO UNITA FORMATIVE
CICLO ISTITUZIONALE PIANO DI STUDI DEL PROGRAMMA FILOSOFICO TRIENNALE
 CICLO ISTITUZIONALE PIANO DI STUDI DEL PROGRAMMA FILOSOFICO TRIENNALE I anno Filosofico tot. 0 11111 Metodologia A. Sabetta 5041 Introduzione alla filosofia L.M. Epicoco 5010 Storia della filosofia antica
CICLO ISTITUZIONALE PIANO DI STUDI DEL PROGRAMMA FILOSOFICO TRIENNALE I anno Filosofico tot. 0 11111 Metodologia A. Sabetta 5041 Introduzione alla filosofia L.M. Epicoco 5010 Storia della filosofia antica
NICOLA ABBAGNANO TULLIO GREGORY
 COLLEZIONE FONDATA DA NICOLA ABBAGNANO DIRETTA DA TULLIO GREGORY LIBRO DELLA GUARIGIONE LE COSE DIVINE di Avicenna (Ibn Sīnā) a cura di AMOS BERTOLACCI UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 2007 Unione
COLLEZIONE FONDATA DA NICOLA ABBAGNANO DIRETTA DA TULLIO GREGORY LIBRO DELLA GUARIGIONE LE COSE DIVINE di Avicenna (Ibn Sīnā) a cura di AMOS BERTOLACCI UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 2007 Unione
Natura, vita ed evoluzione
 Pontificia Università della Santa Croce Facoltà di Filosofia Natura, vita ed evoluzione La filosofia della natura di fronte all evoluzione biologica III Corso di aggiornamento per docenti di filosofia
Pontificia Università della Santa Croce Facoltà di Filosofia Natura, vita ed evoluzione La filosofia della natura di fronte all evoluzione biologica III Corso di aggiornamento per docenti di filosofia
IL SILLABO TOMISTA Commento alle XXIV Tesi del tomismo
 IL SILLABO TOMISTA Commento alle XXIV Tesi del tomismo d. CURZIO NITOGLIA 6 marzo 2012 http://www.doncurzionitoglia.com/2a_tesi_tomismo_commento_xxiv.htm II Tesi: Atto puro e atto misto ÄL atto come perfezione
IL SILLABO TOMISTA Commento alle XXIV Tesi del tomismo d. CURZIO NITOGLIA 6 marzo 2012 http://www.doncurzionitoglia.com/2a_tesi_tomismo_commento_xxiv.htm II Tesi: Atto puro e atto misto ÄL atto come perfezione
Indice generale. Introduzione all edizione italiana (di SILVANO ZUCAL).. 5. Premessa... 9
 Introduzione all edizione italiana (di SILVANO ZUCAL).. 5 Premessa............................... 9 I. IL PENSIERO GRECO DELLE ORIGINI........... 13 La religione di fronte alla filosofia........... 13
Introduzione all edizione italiana (di SILVANO ZUCAL).. 5 Premessa............................... 9 I. IL PENSIERO GRECO DELLE ORIGINI........... 13 La religione di fronte alla filosofia........... 13
LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE DOCENTE: MANICA ANGELA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI FILOSOFIA A.S. 2018/19 CLASSE III E
 LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE DOCENTE: MANICA ANGELA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI FILOSOFIA AS 2018/19 CLASSE III E La programmazione disciplinare di filosofia parte dalle linee caratterizzanti l indirizzo
LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE DOCENTE: MANICA ANGELA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI FILOSOFIA AS 2018/19 CLASSE III E La programmazione disciplinare di filosofia parte dalle linee caratterizzanti l indirizzo
PROGRAMMA DI STORIA. Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PROF. A.OLIVO
 PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-Gli aspetti economici e sociali 1.1-La rivoluzione
PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-Gli aspetti economici e sociali 1.1-La rivoluzione
Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale
 Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale Prof. Antonio Autiero Napoli, 20 settembre 2010 1 Alcune premesse I Il significato della fede per l etica II Fede
Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale Prof. Antonio Autiero Napoli, 20 settembre 2010 1 Alcune premesse I Il significato della fede per l etica II Fede
Lezione N.13 La religione secondo la modernità critica
 Lezione N.13 La religione secondo la modernità critica percorsi 1. Aporie della modernità 2. Rivelazione come concetto critico 3. L inafferabile concetto di Dio obiettivi Riflettendo sulla domanda fondamentale
Lezione N.13 La religione secondo la modernità critica percorsi 1. Aporie della modernità 2. Rivelazione come concetto critico 3. L inafferabile concetto di Dio obiettivi Riflettendo sulla domanda fondamentale
Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach
 Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. Questioni principali: RELIGIONE POLITICA. All origine c è il
Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. Questioni principali: RELIGIONE POLITICA. All origine c è il
Il medioevo si estende per nove secoli, e la sua cultura è diffusa in tutta l Europa occidentale per mezzo del Latino.
 La cultura medievale Il medioevo si estende per nove secoli, e la sua cultura è diffusa in tutta l Europa occidentale per mezzo del Latino. E una cultura Cristiana, che affronta i problemi alla luce della
La cultura medievale Il medioevo si estende per nove secoli, e la sua cultura è diffusa in tutta l Europa occidentale per mezzo del Latino. E una cultura Cristiana, che affronta i problemi alla luce della
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II NAPOLI. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE - MATERIA: Filosofia - DOCENTE: Mariarosaria Marino
 LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II NAPOLI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE 1 SEZIONE C PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE - MATERIA: Filosofia - DOCENTE: Mariarosaria Marino Libro di testo: Cioffi Luppi
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II NAPOLI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE 1 SEZIONE C PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE - MATERIA: Filosofia - DOCENTE: Mariarosaria Marino Libro di testo: Cioffi Luppi
PROGRAMMAZIONE FINALE DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO : Classe: III B Linguistico
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G.VERONESE G. MARCONI PROGRAMMAZIONE FINALE DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018: Classe: III B Linguistico Docente: Scordo Annunziata Maria COMPETENZE - Riflettere sulle
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G.VERONESE G. MARCONI PROGRAMMAZIONE FINALE DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018: Classe: III B Linguistico Docente: Scordo Annunziata Maria COMPETENZE - Riflettere sulle
Christoph Böttigheimer COMPRENDERE LA FEDE. Una teologia dell atto di fede QUERINIANA
 Christoph Böttigheimer COMPRENDERE LA FEDE Una teologia dell atto di fede QUERINIANA INDICE Prefazione............................................ 5 parte prima COMPRENSIONE DELLA FEDE 1. Considerazioni
Christoph Böttigheimer COMPRENDERE LA FEDE Una teologia dell atto di fede QUERINIANA INDICE Prefazione............................................ 5 parte prima COMPRENSIONE DELLA FEDE 1. Considerazioni
Filosofia e cultura ebraica 2. Dal Medioevo al Rinascimento: i filosofi ebrei tra Spagna, Francia e Italia. Lezioni d'autore
 Filosofia e cultura ebraica 2. Dal Medioevo al Rinascimento: i filosofi ebrei tra Spagna, Francia e Italia Lezioni d'autore Moshè Maimonide fornisce alla riflessione ebraica le basi filosofiche per confrontarsi
Filosofia e cultura ebraica 2. Dal Medioevo al Rinascimento: i filosofi ebrei tra Spagna, Francia e Italia Lezioni d'autore Moshè Maimonide fornisce alla riflessione ebraica le basi filosofiche per confrontarsi
LICEO SCIENTIFICO STATALE GUIDO CASTELNUOVO PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE IV I ANNO SCOLASTICO
 LICEO SCIENTIFICO STATALE GUIDO CASTELNUOVO PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE IV I ANNO SCOLASTICO 2013-2014 Da La filosofia volume 1B N. Abbagnano, G. Fornero, Paravia Unità 5 Capitolo 2: Lo stoicismo 1.
LICEO SCIENTIFICO STATALE GUIDO CASTELNUOVO PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE IV I ANNO SCOLASTICO 2013-2014 Da La filosofia volume 1B N. Abbagnano, G. Fornero, Paravia Unità 5 Capitolo 2: Lo stoicismo 1.
La filosofia come istanza critica. Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè
 Immanuel Kant La filosofia Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè Da dove derivano i giudizi sintetici a priori? 2 La rivoluzione copernicana Kant, per rispondere a questo interrogativo,
Immanuel Kant La filosofia Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè Da dove derivano i giudizi sintetici a priori? 2 La rivoluzione copernicana Kant, per rispondere a questo interrogativo,
"Il velo di Maya Verità e illusione tra Oriente e Occidente
 "Il velo di Maya Verità e illusione tra Oriente e Occidente Può il pensiero sgombrare la mente dai fantasmi e dalle apparenze e giungere ad una visione nitida delle cose? [PP.1] Bruno Bonandi [PP.2] [PP.3]
"Il velo di Maya Verità e illusione tra Oriente e Occidente Può il pensiero sgombrare la mente dai fantasmi e dalle apparenze e giungere ad una visione nitida delle cose? [PP.1] Bruno Bonandi [PP.2] [PP.3]
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
68 h 40 min km. Da Kant a Hegel
 Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
recensionirecensionirecensioni Il paradosso antropologico. Nicchie, micoromondi e dissociazione psichica massimo de carolis
 recensionirecensionirecensioni massimo de carolis Il paradosso antropologico. Nicchie, micoromondi e dissociazione psichica Macerata, Quodlibet, 2008 Il testo è pubblicato da, rivista on-line registrata;
recensionirecensionirecensioni massimo de carolis Il paradosso antropologico. Nicchie, micoromondi e dissociazione psichica Macerata, Quodlibet, 2008 Il testo è pubblicato da, rivista on-line registrata;
La filosofia. Storia della filosofia contemporanea
 La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
DUE SPECIE DI IMPOSSIBILITÀ DERIVANTI DA ANTINOMIA
 10. DUE SPECIE DI IMPOSSIBILITÀ DERIVANTI DA ANTINOMIA Sommario: 1. Alla ricerca del concetto di incompatibilità 2. Impossibilità da contrarietà e impossibilità da contraddittorietà Bibliografia. 1. Alla
10. DUE SPECIE DI IMPOSSIBILITÀ DERIVANTI DA ANTINOMIA Sommario: 1. Alla ricerca del concetto di incompatibilità 2. Impossibilità da contrarietà e impossibilità da contraddittorietà Bibliografia. 1. Alla
