Agentività / Agency Laura M. Ahearn
|
|
|
- Eva Piccinini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Agentività / Agency Laura M. Ahearn Il termine agency [agentività] compare molto spesso negli scritti accademici contemporanei, ma il modo in cui gli studiosi lo interpretano può esser anche molto diverso dall uso comune della parola. Così, ad esempio, quando ho svolto una ricerca con la parola chiave agency presso il catalogo della biblioteca della mia università il sistema informatico ha dato come risultato ben elementi (e si trattava soltanto di libri, non di articoli!): fra questi vi erano libri sulle agenzie di viaggio [travel agency], sulla CIA [Central Intelligence Agency], sulle agenzie di servizio sociale, agenzie di raccolta, sull International Atomic Energy Agency e sull Agenzia spaziale europea. Pochi, se non nessuno, di questi libri utilizza il termine agency nel modo in cui lo usano gli studiosi: vale a dire come un modo per parlare della capacità umana di agire. In inglese anzi, per colmo di ironia, l accezione più comune del termine connota spesso proprio un assenza di quella che gli studiosi sono soliti chiamare agency, poiché la definizione quotidiana di agente implica che si agisca a beneficio di qualcun altro e non di se stessi. Il concetto di agentività ha conquistato una certa diffusione alla fine degli anni 70, come reazione all incapacità dello strutturalismo di tener conto delle azioni degli individui portata avanti da studiosi di numerose discipline. Ispirati da attivisti che mettevano in discussione le strutture di potere esistenti per conquistare una eguaglianza di razza e genere, alcuni accademici cercarono di formulare nuove teorie in grado di assegnare il giusto ruolo agli effetti potenziali dell azione umana. Le teoriche del femminismo, in particolare, analizzarono i modi in cui la sfera personale è anch essa politica in altre
2 AGENTIVITÀ / AGENCY 19 parole i modi in cui le azioni delle persone esercitano il proprio influsso sulle strutture sociali e politiche più vaste, e al tempo stesso sono influenzate da queste. Tra la fine degli anni 70 e l inizio degli anni 80, il sociologo Anthony Giddens fu il primo a diffondere l uso del termine agency; assieme a sociologi ed antropologi quali Pierre Bourdieu e Marshall Sahlins, Giddens incentrò le proprie analisi sui modi in cui le azioni umane sono dialetticamente connesse alla struttura sociale in forma tale da rendere le due dimensioni reciprocamente costitutive. Tutti questi studiosi, cui si aggiunsero alcuni critici della cultura marxisti come Raymond Williams, notarono che gli esseri umani fanno la società proprio come la società fa loro: ne è nata una scuola di pensiero vasta e non ben definita, chiamata da Sherry Ortner studiosa che ha contribuito in prima persona a questo programma di studi teoria della pratica. Gli esponenti della teoria della pratica cercano di risolvere un enigma che da sempre assilla le scienze sociali: in che modo la riproduzione sociale diviene trasformazione sociale? Essi ritengono che la risposta in grado di spiegare questo passaggio stia proprio nel concetto di agentività. Si noti anzitutto che in queste formulazioni il concetto di azione non si identifica affatto con quello di libero arbitrio; al contrario, gli esponenti della teoria della pratica sostengono che le azioni sono sempre sottoposte a vincoli di carattere sociale, culturale e linguistico che le precedono. In questa prospettiva, l azione è una dimensione che viene alla luce nelle pratiche socioculturali e linguistiche; inoltre, sebbene alcuni studiosi utilizzino il termine agency come sinonimo di resistenza, quasi tutti gli esponenti della teoria della pratica sostengono che gli atti compiuti da un agente possono favorire una complicità, un accordo o addirittura un rafforzamento dello status quo ed anzi, a volte producono al tempo stesso tutte e tre queste conseguenze. Gli studiosi che utilizzano il termine agentività debbono tener conto di molti e importanti problemi. L agentività può essere solo proprietà di un individuo? Quali sono i possibili tipi di agenti sovraindividuali? In questo vasto ambito, i teorici possono distinguere fra vari tipi di azione istituzionale e collettiva portata a compimento da entità come gli stati, le corporazioni, le facoltà di antropologia, i sindacati, i lignag-
3 20 LAURA M. AHEARN gi, le famiglie o le semplici coppie. In modo simile, potremmo anche essere in grado di parlare di azione a livello subindividuale (o al livello dividuale, per usare il termine proposto da McKim Marriott, E. Valentine Daniel, Bonnie McElhinny ed altri): in questo modo si riuscirà a far luce su aspetti quali i dialoghi interiori e le soggettività frammentate. Non sembra opportuno considerare automaticamente quello individuale come il livello d analisi adatto a studiosi interessati all azione, dato che concentrarsi in forma esclusiva sull agire del singolo individuo equivale a rendere invisibili strutture sociali più ampie di genere, razza e classe le quali sono tutte in grado di produrre tipi diversi d azione. Inoltre, gli studiosi che analizzano l agentività debbono decidere anche se l azione può scattare in forma inconsapevole: ci si deve chiedere, insomma, quali tipi d azione sono realmente agentivi (o voluti dall agente ). Un atto dev essere pienamente cosciente e intenzionale per poter essere agentivo? E come fa uno studioso a saperlo? Un altro percorso ricco di interessanti prospettive di ricerca consiste nell analizzare teorie dell azione elaborate ed accolte da membri di altre culture o comunità linguistiche. Nel corso delle mie ricerche ho preso in esame racconti di matrimonio e lettere d amore nepalesi per cercare di appurare come, in altre società, la gente interpreta situazioni e attribuisce responsabilità di eventi biasimando gli altri o dando loro credito, chiamando in causa il destino o invocando una forza soprannaturale. Piuttosto che tentare di situare, etichettare e misurare l azione ho provato a mettere in luce in che modo essa viene elaborata concettualmente da persone che vivono in società diverse dalla nostra: chi credono sia in grado di esercitare l agentività? Si tratta di una capacità che si ritiene distribuita in modo diseguale o gerarchico? Dalla loro posizione particolarmente favorevole, gli antropologi del linguaggio possono offrire un importante contributo al dibattito accademico sull agentività. Infatti, poiché sostengono che il linguaggio modella le categorie di pensiero degli individui, gli antropologi del linguaggio interessati all agentività analizzano particolari eventi linguistici per riuscire a mettere in luce il modo in cui le persone pensano alle proprie ed alle altrui azioni. Proprio perché la lingua è azio-
4 AGENTIVITÀ / AGENCY 21 ne sociale, gli studi sull uso della lingua (come quelli che è possibile trovare nel volume curato da Dennis Tedlock e Bruce Mannheim) rivelano in che modo la cultura, in ogni sua forma, emerga in forma dialogica a partire dalle interazioni linguistiche quotidiane, esse stesse a loro volta modellate da formazioni socioculturali. L opera di Alessandro Duranti è un esempio di come prestando attenzione alla lingua si può far luce anche sulla capacità umana di agire. Duranti passa in rassegna le varie forme con cui è possibile attribuire a qualcuno un azione in Samoa, analizzando quella che è nota come marca ergativa una forma grammaticale presente in alcune lingue in base alla quale i soggetti di verbi transitivi subiscono un trattamento differenziato rispetto a quelli dei verbi intransitivi. Secondo l autore, l uso delle marche ergative da parte dei samoani rivela il modo in cui essi attribuiscono la paternità di un azione, in particolare nei casi di lode o di biasimo. Gli individui più potenti hanno maggiori probabilità di far uso della marca ergativa ogniqualvolta desiderano accusare qualcuno di un atto malevolo intenzionalmente compiuto; quanto ai più deboli, costoro cercheranno di reagire alle accuse rivolte loro proponendo definizioni linguistiche alternative degli eventi. Pertanto la grammatica della lode e del biasimo individuata da Duranti dimostra come l azione sia parte integrante delle forme linguistiche di cui un parlante fa uso e al tempo stesso sia modellata da queste. Per scoprire in che modo l agentività si manifesta attraverso la lingua, del resto, i ricercatori possono andare oltre l analisi delle marche ergative e delle forme verbali transitive o intransitive: altrettanto utile potrà infatti rivelarsi l analisi di tratti linguistici diversi quali l uso dei pronomi, la organizzazione in turni di parola, le sovrapposizioni, la struttura narrativa delle storie. In particolare gli antropologi del linguaggio che conducono ricerche nell ambito dei rapporti fra linguaggio e genere hanno dato notevoli contributi allo studio dell azione umana, indagando il carattere multifunzionale di specifici tratti linguistici e dimostrando in che modo le azioni e le parole danno forma alle strutture sociali fondate sul genere e ne subiscono l influsso. Qualunque sia l aspetto dell agentività che i ricercatori desiderano affrontare, gli studiosi interessati all argomento
5 22 LAURA M. AHEARN dovranno comunque tener conto delle affermazioni concernenti la persona, il desiderio e l intenzionalità formulate via via all interno delle loro analisi. Alcuni studi sull agentività confermano idee come quella di un individualismo atomistico tipicamente occidentale comunemente accettate mentre altre negano ogni potere di azione agli individui, assegnandolo invece soltanto ai discorsi o alle forze sociali. Comunque venga definito, il concetto di agentività è all origine di numerose implicazioni per la teoria sociale; ecco perché gli studiosi che utilizzano il termine dovrebbero definirlo di volta in volta in modo chiaro, sia per se stessi che per i propri lettori. Proprio in quest ambito l antropologia del linguaggio, in virtù del suo particolare interesse per l analisi di interazioni concrete, può fungere da utile guida per tutti quei ricercatori che vogliano tentare di comprendere i micro- e macroprocessi della vita sociale. (Cfr. anche corpo, genere, intenzionalità, narrativa, partecipazione, performatività, relatività, turno). Bibliografia Duranti, Alessandro, 1994, From Grammar to Politics: Linguistic Anthropology in a Western Samoan Village, Berkeley, University of California Press. Duranti, Alessandro e Goodwin, Charles, a cura, 1992, Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon, Cambridge, Cambridge University Press. Giddens, Anthony, 1992, Central Problems in Social Theory: Actions, Structure and Contradiction in Social Analysis, Berkeley, University of California Press. Hall, Kira e Bucholtz, Mary, a cura, 1995, Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self, New York, Routledge. Hill, Jane e Irvine, Judith T., a cura, 1992, Responsibility and Evidence in Oral Discourse, Cambridge, Cambridge University Press. McElhinny, Bonnie, 1998, Genealogies of Gender Theory: Practice Theory and Feminism in Sociocultural and Linguistic Anthropology, in «Social Analysis», 42 (3), pp Ochs, Elinor, Schlegloff, Emanuel A. e Thompson, Sandra A., a cura, 1996, Interaction and Grammar, Cambridge, Cambridge University Press.
6 AGENTIVITÀ / AGENCY 23 Ortner, Sherry B., 1996, Making Gender: Toward a Feminist, Minority, Postcolonial, Subaltern, ect., Theory of Practice, in Sherry Ortner, a cura, Making Gender: The Politics and Erotics of Culture, Boston, Beacon Press, pp Taylor, Charles, 1985, Introduction e What Is Human Agency?, in Charles Taylor, a cura, Human Agency and Language: Philosophical Papers 1, Cambridge, Cambridge University Press, pp Tedlock, Dennis e Mannheim, Bruce, a cura, 1995, The Dialogic Emergence of Culture, Urbana, University of Illinois Press.
parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica
 Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica Sommario Quadro storico 3. 4. 5. Quadro storico
Corso di Semiotica per la comunicazione Università di Teramo a.a. 2007/2008 prof. Piero Polidoro parte I teoria generale lezione 1 introduzione alla semiotica Sommario Quadro storico 3. 4. 5. Quadro storico
Pragmatica e atti linguistici
 Pragmatica e atti linguistici Giovanni Manetti, Scienze della comunicazione, Siena c. Giovanni Manetti 1 Charles Morris 1. Sintattica 2. Semantica 3. Pragmatica c. Giovanni Manetti 2 Astratto/Concreto
Pragmatica e atti linguistici Giovanni Manetti, Scienze della comunicazione, Siena c. Giovanni Manetti 1 Charles Morris 1. Sintattica 2. Semantica 3. Pragmatica c. Giovanni Manetti 2 Astratto/Concreto
Grammatica / Grammar John W. Du Bois
 Grammatica / Grammar John W. Du Bois Se il termine grammatica suscita in quasi tutti gli antropologi una reazione di paura e disgusto, per il turpe grammatico è forse venuto il momento di dar di sé un
Grammatica / Grammar John W. Du Bois Se il termine grammatica suscita in quasi tutti gli antropologi una reazione di paura e disgusto, per il turpe grammatico è forse venuto il momento di dar di sé un
ITALIANO UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ
 UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ 1. Adeguare la comunicazione, prestando attenzione all interlocutore, alla situazione,all argomento. 2. Esprimersi
UNITÀ DIDATTICA N. 1 ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ABILITÀ 1. Adeguare la comunicazione, prestando attenzione all interlocutore, alla situazione,all argomento. 2. Esprimersi
La ricerca sociale: metodologia e tecniche
 La ricerca sociale: metodologia e tecniche [Corso di Sociologia generale] a.a. 2014 2015 Docenza: Pierpaola Pierucci - Mail: pierpaola.pierucci@unife.it Quali metodi? Quali tecniche? Ricerca quantitativa
La ricerca sociale: metodologia e tecniche [Corso di Sociologia generale] a.a. 2014 2015 Docenza: Pierpaola Pierucci - Mail: pierpaola.pierucci@unife.it Quali metodi? Quali tecniche? Ricerca quantitativa
FACOLTÀ DI FILOSOFIA FILOSOFICHE
 FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario
FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
PROGRAMMA PREVENTIVO
 COD. Progr.Prev. PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO SCUOLA LICEO LINGUISTICO MANZONI A.S. 2014-2015 DOCENTE: STEFANO MOZZATI MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CLASSE 1 SEZIONE H FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
COD. Progr.Prev. PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO SCUOLA LICEO LINGUISTICO MANZONI A.S. 2014-2015 DOCENTE: STEFANO MOZZATI MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CLASSE 1 SEZIONE H FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
Genere / Gender Mary Bucholtz
 Genere / Gender Mary Bucholtz I linguisti hanno tradizionalmente distinto il genere grammaticale (la classificazione di nomi in base alla morfologia linguistica) dal genere naturale o biologico (la suddivisione
Genere / Gender Mary Bucholtz I linguisti hanno tradizionalmente distinto il genere grammaticale (la classificazione di nomi in base alla morfologia linguistica) dal genere naturale o biologico (la suddivisione
Identità / Identity Paul V. Kroskrity
 Identità / Identity Paul V. Kroskrity L identità viene definita come la costruzione linguistica dell appartenenza ad uno o più gruppi o categorie sociali. Sebbene anche altri criteri non linguistici possano
Identità / Identity Paul V. Kroskrity L identità viene definita come la costruzione linguistica dell appartenenza ad uno o più gruppi o categorie sociali. Sebbene anche altri criteri non linguistici possano
Agency in una comunità di apprendimento online: dall Agency Individuale all Agency Collettiva
 Agency in una comunità di apprendimento online: dall Agency Individuale all Agency Collettiva Maria Antonietta Impedovo Aix-Marseille University, Francia Maria Beatrice Ligorio Università degli Studi di
Agency in una comunità di apprendimento online: dall Agency Individuale all Agency Collettiva Maria Antonietta Impedovo Aix-Marseille University, Francia Maria Beatrice Ligorio Università degli Studi di
L INTERAZIONE SOCIALE
 L INTERAZIONE SOCIALE L interazione tra individui è l oggetto della microsociologia, uno dei due livelli fondamentali dell analisi sociologica. Gli studiosi interessati a questa branca di analisi si occupano
L INTERAZIONE SOCIALE L interazione tra individui è l oggetto della microsociologia, uno dei due livelli fondamentali dell analisi sociologica. Gli studiosi interessati a questa branca di analisi si occupano
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
Introduzione alla psicologia generale
 Introduzione alla psicologia generale 1 Che cos è la psicologia? Tentativi di definizione. Studio su base empirica della soggettività, espressa sia come stati di coscienza sia come manifestazione del comportamento
Introduzione alla psicologia generale 1 Che cos è la psicologia? Tentativi di definizione. Studio su base empirica della soggettività, espressa sia come stati di coscienza sia come manifestazione del comportamento
Narrativa / Narrative Harriet E. Manelis Klein
 Narrativa / Narrative Harriet E. Manelis Klein Il termine narrativa è utilizzato nell analisi di miti, leggende, storie di vita e nell analisi della conversazione sia nel senso di modello esemplare di
Narrativa / Narrative Harriet E. Manelis Klein Il termine narrativa è utilizzato nell analisi di miti, leggende, storie di vita e nell analisi della conversazione sia nel senso di modello esemplare di
Modulo di Psicologia Sociale e dei Gruppi
 Modulo di Psicologia Sociale e dei Gruppi Insegnamento di Psicologia Sociale e di Comunità Antonio Nocera Corso di Laurea in Scienze dell educazione A.A. 2011/2012 Date degli esami 24 gennaio 2012 ore
Modulo di Psicologia Sociale e dei Gruppi Insegnamento di Psicologia Sociale e di Comunità Antonio Nocera Corso di Laurea in Scienze dell educazione A.A. 2011/2012 Date degli esami 24 gennaio 2012 ore
Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio]
![Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio] Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa. Corso di Metodi della ricerca qualitativa - a.a [Eugenio De Gregorio]](/thumbs/54/33896183.jpg) Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa Come si giunge a una conoscenza del mondo? Superstizione (irrazionale) Intuizione (esperienza soggettiva) Ragionamento (induzione o deduzione) Autorità
Epistemologia e metodologia della ricerca qualitativa Come si giunge a una conoscenza del mondo? Superstizione (irrazionale) Intuizione (esperienza soggettiva) Ragionamento (induzione o deduzione) Autorità
Relatività / Relativity Alessandro Duranti
 Relatività / Relativity Alessandro Duranti Il fatto che lingue diverse offrono modi diversi di descrivere la realtà fu il punto di partenza del concetto di relatività linguistica. Di qui si arrivò a pensare
Relatività / Relativity Alessandro Duranti Il fatto che lingue diverse offrono modi diversi di descrivere la realtà fu il punto di partenza del concetto di relatività linguistica. Di qui si arrivò a pensare
ITALIANO CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI NARRATIVI.
 ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA. Programma del corso e guida ai testi d esame
 Programma del corso e guida ai testi d esame 1. PROGRAMMA DEL CORSO Il corso si articola in due moduli: - un primo modulo d introduzione: a) alla specificità della sociologia, come scienza della società,
Programma del corso e guida ai testi d esame 1. PROGRAMMA DEL CORSO Il corso si articola in due moduli: - un primo modulo d introduzione: a) alla specificità della sociologia, come scienza della società,
Scienze della cultura. Laurea in Filosofia o in Storia
 Scienze della cultura Laurea in Filosofia o in Storia Dove siamo? Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 2 Palazzo del Rettorato in Via Università, 4 Segreteria studenti Palazzo di Largo S. Eufemia,
Scienze della cultura Laurea in Filosofia o in Storia Dove siamo? Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 2 Palazzo del Rettorato in Via Università, 4 Segreteria studenti Palazzo di Largo S. Eufemia,
LIVELLO A2 LIVELLO B1
 PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Test informatizzato (durata 45 min): LIVELLO A2 2 cloze test (esercizi gap-fill di grammatica e lessico) livello A2 al fine di individuare i termini o la tipologia
Intenzionalità / Intentionality Alessandro Duranti
 Intenzionalità / Intentionality Alessandro Duranti Nella tradizione filosofica iniziata con gli scolastici e poi ripresa da Franz Brentano ed Edmund Husserl, l intenzionalità è la proprietà che la coscienza
Intenzionalità / Intentionality Alessandro Duranti Nella tradizione filosofica iniziata con gli scolastici e poi ripresa da Franz Brentano ed Edmund Husserl, l intenzionalità è la proprietà che la coscienza
Linee per una educazione all amore ed alla sessualità in età L/C. Bologna 26 gennaio 2014 M.Ornella Fulvio
 Linee per una educazione all amore ed alla sessualità in età L/C Bologna 26 gennaio 2014 M.Ornella Fulvio Questo tempo Rischio o scivolamento - superficialità - paura - caduta della memoria - stanchezza
Linee per una educazione all amore ed alla sessualità in età L/C Bologna 26 gennaio 2014 M.Ornella Fulvio Questo tempo Rischio o scivolamento - superficialità - paura - caduta della memoria - stanchezza
DONNE, SVILUPPO, GIUSTIZIA SOCIALE
 DONNE, SVILUPPO, GIUSTIZIA SOCIALE PROF. BENEDETTA GIOVANOLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 9 ottobre 2015 Contenuti v Donne e giustizia sociale v eguaglianza di genere v pubblico / privato e ruolo
DONNE, SVILUPPO, GIUSTIZIA SOCIALE PROF. BENEDETTA GIOVANOLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 9 ottobre 2015 Contenuti v Donne e giustizia sociale v eguaglianza di genere v pubblico / privato e ruolo
Intelligenza Artificiale. A n n o A c c a d e m i c o La Rappresentazione della Conoscenza: Le Reti Semantiche
 Intelligenza Artificiale A n n o A c c a d e m i c o 2 0 0 8-2 0 0 9 La Rappresentazione della Conoscenza: Le Reti Semantiche Sommario Introduzione alle reti semantiche Le relazioni ISA e PARTOF Esempi
Intelligenza Artificiale A n n o A c c a d e m i c o 2 0 0 8-2 0 0 9 La Rappresentazione della Conoscenza: Le Reti Semantiche Sommario Introduzione alle reti semantiche Le relazioni ISA e PARTOF Esempi
HappyJob Felice del mio lavoro PARTE 2 COSA? LE INTELLIGENZE MULTIPLE
 HappyJob Felice del mio lavoro PARTE 2 COSA? LE INTELLIGENZE MULTIPLE Concetto di intelligenza In questo capitolo capirai cos è l intelligenza, come possiamo suddividerla e potrai scoprire quali sono le
HappyJob Felice del mio lavoro PARTE 2 COSA? LE INTELLIGENZE MULTIPLE Concetto di intelligenza In questo capitolo capirai cos è l intelligenza, come possiamo suddividerla e potrai scoprire quali sono le
La Cultura. Roberto Pedersini
 La Cultura Roberto Pedersini La cultura La cultura è un insieme di valori, definizioni della realtà e codici di comportamento condivisi da persone che hanno in comune uno specifico modo di vita (Clyde
La Cultura Roberto Pedersini La cultura La cultura è un insieme di valori, definizioni della realtà e codici di comportamento condivisi da persone che hanno in comune uno specifico modo di vita (Clyde
SOMMARIO. Sommario. Ringraziamenti Prefazione. Oltre le discipline Capitolo 1 Introduzione. Allestire la scena 1
 SOMMARIO Sommario Ringraziamenti xiii Prefazione. Oltre le discipline xv Capitolo 1 Introduzione. Allestire la scena 1 Una svolta 4 Noi nel testo 6 Barbara 7 Linden 10 Una questione terminologica e transculturale
SOMMARIO Sommario Ringraziamenti xiii Prefazione. Oltre le discipline xv Capitolo 1 Introduzione. Allestire la scena 1 Una svolta 4 Noi nel testo 6 Barbara 7 Linden 10 Una questione terminologica e transculturale
LICEO GINNASIO STATALE G. B. BROCCHI Bassano del Grappa -VI. Progettazione didattico educativa di dipartimento CLASSE INDIRIZZO
 Pagina 1 di 5 DIPARTIMENTO CLASSE INDIRIZZO FRANCESE PRIMO BIENNIO LINGUISTICO SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA ABILITÀ
Pagina 1 di 5 DIPARTIMENTO CLASSE INDIRIZZO FRANCESE PRIMO BIENNIO LINGUISTICO SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA ABILITÀ
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA. Classe quarta
 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGETO FIABE PER CRESCERE 2. Anno scolastico 2014-2015
 PROGETO FIABE PER CRESCERE 2 Anno scolastico 2014-2015 Il Progetto ipotizzato per questo anno scolastico prevede l accostamento al mondo delle fiabe ricche di importanti messaggi grazie all intreccio di
PROGETO FIABE PER CRESCERE 2 Anno scolastico 2014-2015 Il Progetto ipotizzato per questo anno scolastico prevede l accostamento al mondo delle fiabe ricche di importanti messaggi grazie all intreccio di
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
 PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Scuola Primaria di Vestreno Classe IV a.s. 2014/15 Insegnante:Sabrina Rabbiosi DISCIPLINA : Italiano TITOLO ASCOLTO E RACCONTO UDA 1 Comprendere e produrre testi orali
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Scuola Primaria di Vestreno Classe IV a.s. 2014/15 Insegnante:Sabrina Rabbiosi DISCIPLINA : Italiano TITOLO ASCOLTO E RACCONTO UDA 1 Comprendere e produrre testi orali
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) (Classe XV: Scienze politiche e delle relazioni internazionali)
 Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) (Classe XV: Scienze politiche e delle relazioni internazionali) http://users.unimi.it/inteurop Obiettivi formativi Integrare le conoscenze di base tipiche
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) (Classe XV: Scienze politiche e delle relazioni internazionali) http://users.unimi.it/inteurop Obiettivi formativi Integrare le conoscenze di base tipiche
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH)
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH) CURRICOLO A.S. 2012-1013 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE TRAGUARDI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado San Giovanni Teatino (CH) CURRICOLO A.S. 2012-1013 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE TRAGUARDI
Di cosa ci occuperemo nel corso?
 Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche Università degli studi G. D Annunzio Chieti Pescara Corso di Laurea in Economia Aziendale Lezione n. 1 Le Amministrazioni Pubbliche Economia delle
Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche Università degli studi G. D Annunzio Chieti Pescara Corso di Laurea in Economia Aziendale Lezione n. 1 Le Amministrazioni Pubbliche Economia delle
La narrazione di esperienze. L esposizione orale di contenuti disciplinari appresi. La descrizione orale di ambienti, persone
 UNITA DI APPRENDIMENTO 1 Ascolto e parlato Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo. Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. Forme più comuni di parlato: il racconto,
UNITA DI APPRENDIMENTO 1 Ascolto e parlato Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo. Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. Forme più comuni di parlato: il racconto,
POLITICA E SCIENZA POLITICA
 POLITICA E SCIENZA POLITICA 1 Un termine in cerca di significati Politica non vuol dire oggi quello che voleva dire nel passato Politica per i greci (Aristotele) Politica come dimensione intrinseca della
POLITICA E SCIENZA POLITICA 1 Un termine in cerca di significati Politica non vuol dire oggi quello che voleva dire nel passato Politica per i greci (Aristotele) Politica come dimensione intrinseca della
Voto Conoscenze Abilità Competenze Livelli. Abilità per svolgere compiti/mansioni in modo impreciso e disorganizzato
 Griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di competenza Voto Conoscenze Abilità Competenze Livelli 1-5 Conoscenze generali di base approssimate 6 7-8 9-10 Conoscenza teorica e pratica indispensabile
Griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di competenza Voto Conoscenze Abilità Competenze Livelli 1-5 Conoscenze generali di base approssimate 6 7-8 9-10 Conoscenza teorica e pratica indispensabile
Life Skills: le competenze della vita Gianluca Fovi MD, PhD Rieti 24 Maggio 2012
 Life Skills: le competenze della vita Gianluca Fovi MD, PhD Rieti 24 Maggio 2012 Le radici di Unplugged UNPLUGGED MODELLO INFLUENZA SOCIALE LIFE SKILLS EDUCAZIONE NORMATIVA Il Modello dell influenza
Life Skills: le competenze della vita Gianluca Fovi MD, PhD Rieti 24 Maggio 2012 Le radici di Unplugged UNPLUGGED MODELLO INFLUENZA SOCIALE LIFE SKILLS EDUCAZIONE NORMATIVA Il Modello dell influenza
verso l esame di stato scuola secondaria di primo grado
 verso l esame di stato scuola secondaria di primo grado PROVA DI ITALIANO Comprensione della lettura Scuola..................................................................................................................................................
verso l esame di stato scuola secondaria di primo grado PROVA DI ITALIANO Comprensione della lettura Scuola..................................................................................................................................................
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE I SCUOLA PRIMARIA
 Competenza 1 SCHEDA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE I SCUOLA PRIMARIA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà quotidiana. 1.a Osservare
Competenza 1 SCHEDA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE I SCUOLA PRIMARIA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà quotidiana. 1.a Osservare
ITALIANO CLASSE II ANNO SCOLASTICO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE U.A. I LA LETTERATURA
 U.A. I LA LETTERATURA Tempi: anno scolastico l attenzione. Lettura e commento di testi, esercizi di analisi e individuale di testi. Strumenti strumenti multimediali Link interdisciplinari storia, storia
U.A. I LA LETTERATURA Tempi: anno scolastico l attenzione. Lettura e commento di testi, esercizi di analisi e individuale di testi. Strumenti strumenti multimediali Link interdisciplinari storia, storia
 1 Programmi svolti ID Anno scolastico 2014-2015 Disciplina Docente Classe Scienze umane e sociali Orlandino Chiara ID NUCLEO TEMATICO 1 Le scienze umane e sociali e la ricerca in campo sociale (modulo
1 Programmi svolti ID Anno scolastico 2014-2015 Disciplina Docente Classe Scienze umane e sociali Orlandino Chiara ID NUCLEO TEMATICO 1 Le scienze umane e sociali e la ricerca in campo sociale (modulo
L insegnante avvia un progetto con l ausilio di un ambiente di apprendimento
 L insegnante avvia un progetto con l ausilio di un ambiente di apprendimento Materiale della durata di un ora circa, suggerimenti relativi all elaborazione e alla realizzazione di un progetto. 1. Finalità
L insegnante avvia un progetto con l ausilio di un ambiente di apprendimento Materiale della durata di un ora circa, suggerimenti relativi all elaborazione e alla realizzazione di un progetto. 1. Finalità
Introduzione all economia. Scelta individuale. Trade-off (scelte tra alternative)
 Introduzione all economia Scelta individuale Tutte le questioni economiche, in essenza, comportano scelte individuali: decisioni prese da un individuo su cosa fare e cosa non fare Perché gli individui
Introduzione all economia Scelta individuale Tutte le questioni economiche, in essenza, comportano scelte individuali: decisioni prese da un individuo su cosa fare e cosa non fare Perché gli individui
SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI FINE CAPITOLO 1
 SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI FINE CAPITOLO 1 1-1 L affermazione di Emerson riflette la natura del problema economico, dato dal tentativo di soddisfare desideri illimitati attraverso l impiego di risorse
SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI FINE CAPITOLO 1 1-1 L affermazione di Emerson riflette la natura del problema economico, dato dal tentativo di soddisfare desideri illimitati attraverso l impiego di risorse
FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE ANNO ACCADEMICO 2016/2017
 FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE ANNO ACCADEMICO 2016/2017 Le date d esame confermate sono pubblicate all interno del proprio corso in piattaforma, cliccando sul bottone "Servizi di Segreteria a seguire "Esami
FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE ANNO ACCADEMICO 2016/2017 Le date d esame confermate sono pubblicate all interno del proprio corso in piattaforma, cliccando sul bottone "Servizi di Segreteria a seguire "Esami
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre
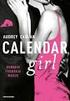 U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
U. A. 1 ITALIANO settembre-ottobre-novembre ABILITÀ a. Ascoltare attivamente e comprendere vari tipi di testo. b. Intervenire appropriatamente ed esprimere attraverso il parlato pensieri e stati d animo.
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A..
 COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II
 ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Funzioni della sociologia in generale e per gli AS COSA VUOL DIRE PENSARE SOCIOLOGICO a) Non ci sono solo individui, c è la società b) Esistono le istituzioni, le norme c) Apparteniamo
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA II Funzioni della sociologia in generale e per gli AS COSA VUOL DIRE PENSARE SOCIOLOGICO a) Non ci sono solo individui, c è la società b) Esistono le istituzioni, le norme c) Apparteniamo
Basi di Dati Concetti Introduttivi
 Università Magna Graecia di Catanzaro Informatica Basi di Dati Concetti Introduttivi Docente : Alfredo Cuzzocrea e-mail : cuzzocrea@si.deis.unical.it Tel. : 0984 831730 Lucidi tratti da: Atzeni, Ceri,
Università Magna Graecia di Catanzaro Informatica Basi di Dati Concetti Introduttivi Docente : Alfredo Cuzzocrea e-mail : cuzzocrea@si.deis.unical.it Tel. : 0984 831730 Lucidi tratti da: Atzeni, Ceri,
Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp , Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a
 Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp. 201-236, Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2015-2016 1 Contenuti 1. Premessa 2. La cultura organizzativa Il concetto e le definizioni
Lezione 5 La cultura organizzativa (Cap. 6: pp. 201-236, Decastri, 2016) Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2015-2016 1 Contenuti 1. Premessa 2. La cultura organizzativa Il concetto e le definizioni
Assi, dimensioni, criteri e obiettivi dell attività organizzatrice
 Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Sociologia Corso di laurea in Scienze dell Organizzazione Anno Accademico 2008/09 Corso Fondamenti di organizzazione Assi, dimensioni, criteri e obiettivi
Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Sociologia Corso di laurea in Scienze dell Organizzazione Anno Accademico 2008/09 Corso Fondamenti di organizzazione Assi, dimensioni, criteri e obiettivi
Analisi dei media. Parte seconda - La teoria sociale dei media di J. Thompson (Cap. IV - La trasformazione della visibilità).
 Analisi dei media Parte seconda - La teoria sociale dei media di J. Thompson (Cap. IV - La trasformazione della visibilità). (Selezione di diapositive) Cap. IV. La trasformazione della visibilità Struttura
Analisi dei media Parte seconda - La teoria sociale dei media di J. Thompson (Cap. IV - La trasformazione della visibilità). (Selezione di diapositive) Cap. IV. La trasformazione della visibilità Struttura
JEROME SEYMOUR BRUNER
 TEORIE DELL APPRENDIMENTO E QUALITÀ DEI PROCESSI (PARTE II) PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 JEROME SEYMOUR BRUNER--------------------------------------------------------------------------------------------
TEORIE DELL APPRENDIMENTO E QUALITÀ DEI PROCESSI (PARTE II) PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 JEROME SEYMOUR BRUNER--------------------------------------------------------------------------------------------
CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE I SCUOLA PRIMARIA Anno scolastico 2016/2017
 SCHEDA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE I SCUOLA PRIMARIA Anno scolastico 2016/2017 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
SCHEDA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE I SCUOLA PRIMARIA Anno scolastico 2016/2017 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE PRIMA OBIETTIVI 1. PRODUZIONE E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 1.2 Ascoltare
Analisi dei media. Parte seconda - La teoria sociale dei media di J. Thompson (Cap. VI Nuovi approdi della tradizione). (Selezione di diapositive)
 Analisi dei media Parte seconda - La teoria sociale dei media di J. Thompson (Cap. VI Nuovi approdi della tradizione). (Selezione di diapositive) Cap. VI Nuovi approdi della tradizione Cos è la tradizione?
Analisi dei media Parte seconda - La teoria sociale dei media di J. Thompson (Cap. VI Nuovi approdi della tradizione). (Selezione di diapositive) Cap. VI Nuovi approdi della tradizione Cos è la tradizione?
Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA
 Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A. 2013-2014. Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA ALCUNE PREMESSE Cosa e la microeconomia? E la disciplina che studia
Economia, Corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrotecnica, A.A. 2013-2014. Prof. R. Sestini SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA ALCUNE PREMESSE Cosa e la microeconomia? E la disciplina che studia
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
 PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Scuola Primaria di BELLANO Classi 4^A e4^b a.s. 2014/2015 Insegnante: Busi Mara DISCIPLINA: ITALIANO TITOLO ATTIVITA MODALITA DI VERIFICA E UN MONDO DI CODICI Comunicare
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO Scuola Primaria di BELLANO Classi 4^A e4^b a.s. 2014/2015 Insegnante: Busi Mara DISCIPLINA: ITALIANO TITOLO ATTIVITA MODALITA DI VERIFICA E UN MONDO DI CODICI Comunicare
Metodologia delle scienze sociali Modelli di indagine. NOME E QUALIFICA DOCENTE Luigi Maria Solivetti (Prof. di ruolo)
 TITOLO DELL INSEGNAMENTO Metodologia delle scienze sociali Modelli di indagine NOME E QUALIFICA DOCENTE Luigi Maria Solivetti (Prof. di ruolo) SETTORE SCIENTIFICO SPS/07 CORSO DI LAUREA Sociologia CODICE
TITOLO DELL INSEGNAMENTO Metodologia delle scienze sociali Modelli di indagine NOME E QUALIFICA DOCENTE Luigi Maria Solivetti (Prof. di ruolo) SETTORE SCIENTIFICO SPS/07 CORSO DI LAUREA Sociologia CODICE
Intervista / Interview Charles L. Briggs
 Intervista / Interview Charles L. Briggs Quello dell intervista è uno degli ambiti più affascinanti e meno studiati della ricerca sociale e linguistica: infatti ricercatori che svolgono il proprio lavoro
Intervista / Interview Charles L. Briggs Quello dell intervista è uno degli ambiti più affascinanti e meno studiati della ricerca sociale e linguistica: infatti ricercatori che svolgono il proprio lavoro
RIM RELAZIONI IINTERNAZIONALI PER IL MARKETING
 RIM RELAZIONI IINTERNAZIONALI PER IL MARKETING CLASSE TERZA RIM CONOSCENZE ABILITA' ECONOMIA AZIENDALE GEOPOLITICA Organizzazione aziendale e analisi del fabbisogno finanziario. Regole e tecniche di contabilità
RIM RELAZIONI IINTERNAZIONALI PER IL MARKETING CLASSE TERZA RIM CONOSCENZE ABILITA' ECONOMIA AZIENDALE GEOPOLITICA Organizzazione aziendale e analisi del fabbisogno finanziario. Regole e tecniche di contabilità
NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
 CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE QUINTA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo e relativi processi di
CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA - CLASSE QUINTA NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO Strategie essenziali dell ascolto finalizzato e dell ascolto attivo e relativi processi di
5 ISTITUTO COMPRENSIVO DONATELLO - PADOVA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE - SECONDARIA
 5 ISTITUTO COMPRENSIVO DONATELLO - PADOVA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE - SECONDARIA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE CLASSI: PRIME TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI
5 ISTITUTO COMPRENSIVO DONATELLO - PADOVA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE - SECONDARIA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE CLASSI: PRIME TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI
SOCIETA EDUCAZIONE FORMAZIONE. A cura di Tortorici Dorotea
 SOCIETA EDUCAZIONE A cura di Tortorici Dorotea FORMAZIONE Che vi sia un rapporto diretto tra società ed educazione è fatto incontrovertibile e riconosciuto. Declinare i termini di tale rapporto, i livelli
SOCIETA EDUCAZIONE A cura di Tortorici Dorotea FORMAZIONE Che vi sia un rapporto diretto tra società ed educazione è fatto incontrovertibile e riconosciuto. Declinare i termini di tale rapporto, i livelli
Laboratorio area antropologica
 Laboratorio area antropologica IDENTITÀ AUTONOMIA COMPETENZE CITTADINANZA In primo luogo, la scuola stessa deve essere una vita di comunità in tutto quello che implica questo concetto: le percezioni e
Laboratorio area antropologica IDENTITÀ AUTONOMIA COMPETENZE CITTADINANZA In primo luogo, la scuola stessa deve essere una vita di comunità in tutto quello che implica questo concetto: le percezioni e
2.I PERCORSI DI STUDIO
 2.I PERCORSI DI STUDIO Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
2.I PERCORSI DI STUDIO Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
Modelli comunicativi e micro-macro link
 Modelli comunicativi e micro-macro link Le nuove tecnologie modificano i profili attuali della comunicazione e del sociale È necessario integrarle nelle teorie comunicative Nell analisi dei rapporti fra
Modelli comunicativi e micro-macro link Le nuove tecnologie modificano i profili attuali della comunicazione e del sociale È necessario integrarle nelle teorie comunicative Nell analisi dei rapporti fra
MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della scuola primaria e secondaria di 1^ grado. anno scolastico 20 /20
 MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della scuola primaria e secondaria di 1^ grado anno scolastico 20 /20 La struttura del documento per la certificazione delle competenze in uscita
MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della scuola primaria e secondaria di 1^ grado anno scolastico 20 /20 La struttura del documento per la certificazione delle competenze in uscita
PIANO DI LAVORO DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA MEDIA -
 PIANO DI LAVORO DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA MEDIA - AREE DA SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua Prima e seconda Media Classe
PIANO DI LAVORO DI LINGUA ITALIANA - SCUOLA MEDIA - AREE DA SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI, ATTIVITÁ COMPETENZE IN USCITA Riflettere sulla lingua Prima e seconda Media Classe
CHE COS è L INTELLIGENZA ARTIFICIALE? Si può definire l intelligenza artificiale (IA) l insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di
 CHE COS è L INTELLIGENZA ARTIFICIALE? Si può definire l intelligenza artificiale (IA) l insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine in grado di risolvere problemi e di riprodurre
CHE COS è L INTELLIGENZA ARTIFICIALE? Si può definire l intelligenza artificiale (IA) l insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine in grado di risolvere problemi e di riprodurre
PRE-CORSO INTENSIVO DI LIVELLO A1 (ELEMENTARE)
 PRE-CORSO INTENSIVO DI LIVELLO A1 (ELEMENTARE) - acquisire le abilità e competenze per interagire, in modo semplice ed essenziale, nelle situazioni più comuni e familiari al fine di soddisfare bisogni
PRE-CORSO INTENSIVO DI LIVELLO A1 (ELEMENTARE) - acquisire le abilità e competenze per interagire, in modo semplice ed essenziale, nelle situazioni più comuni e familiari al fine di soddisfare bisogni
COMUNICAZIONE COMPRENSIBILE
 COMUNICAZIONE COMPRENSIBILE DALLA PARTE DEL LETTORE! Il plain language nasce negli anni 70 nei paesi anglofoni per la semplificazione del linguaggio della burocrazia Negli anni 80 in Italia nasce Due parole
COMUNICAZIONE COMPRENSIBILE DALLA PARTE DEL LETTORE! Il plain language nasce negli anni 70 nei paesi anglofoni per la semplificazione del linguaggio della burocrazia Negli anni 80 in Italia nasce Due parole
ITALIANO classe quarta
 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE ASCOLTO E PARLATO - SA ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SU UN ARGOMENTO TRATTATO - SA PORRE DOMANDE PERTINENTI ALL ARGOMENTO E AL CONTESTO DURANTE O DOPO L ASCOLTO -
LA GRAMMATICA PEDAGOGICA
 LA GRAMMATICA PEDAGOGICA Convegno Il primo passo Torino, 8 aprile 2014 Franca Bosc, Università degli Studi di Milano Nozioni di Lingua e Grammatica : Sistemi logico formali che offrono concettualizzazioni
LA GRAMMATICA PEDAGOGICA Convegno Il primo passo Torino, 8 aprile 2014 Franca Bosc, Università degli Studi di Milano Nozioni di Lingua e Grammatica : Sistemi logico formali che offrono concettualizzazioni
III Circolo di Rho. Programmazione annuale. Lingua Italiana. Classe II
 III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe II ASCOLTARE E PARLARE Interagisce nello scambio comunicativo rispettando le regole. Interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato
III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe II ASCOLTARE E PARLARE Interagisce nello scambio comunicativo rispettando le regole. Interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato
PhD Day La Ricerca si racconta. Il ruolo dei processi decisionali nella progettazione di mercati efficienti
 PhD Day La Ricerca si racconta Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Scuola di Dottorato in Economics and Management of Technology - DREAMT Il ruolo dei processi decisionali nella progettazione
PhD Day La Ricerca si racconta Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Scuola di Dottorato in Economics and Management of Technology - DREAMT Il ruolo dei processi decisionali nella progettazione
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Scienze - COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Scienze - Classe Prima COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d Istruzione:
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Scienze - Classe Prima COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d Istruzione:
PROGRAMMAZIONE ANNUALE a. s
 Scuola Primaria ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRATELLI CASETTI CREVOLADOSSOLA (VB) WWW.iccasetti.gov.it PROGRAMMAZIONE ANNUALE a. s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE COMPETENZE CHIAVE - competenze di
Scuola Primaria ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRATELLI CASETTI CREVOLADOSSOLA (VB) WWW.iccasetti.gov.it PROGRAMMAZIONE ANNUALE a. s. 2014-2015 PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE COMPETENZE CHIAVE - competenze di
OCSE PISA IEA PIRLS INVALSI
 OCSE PISA (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; Programme for International Student Assessment) IEA PIRLS (International association for the Evalutation of educational Achievement;
OCSE PISA (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; Programme for International Student Assessment) IEA PIRLS (International association for the Evalutation of educational Achievement;
Economia Politica. Corso di laurea in Economia e Politiche Europee. Prof. Raffaele Paci
 Economia Politica Corso di laurea in Economia e Politiche Europee Prof. Raffaele Paci Il testo consigliato G. Mankiw, Principi di Economia, Zanichelli, 4 ed. 2007 (oppure edizioni precedenti). N. Gregory
Economia Politica Corso di laurea in Economia e Politiche Europee Prof. Raffaele Paci Il testo consigliato G. Mankiw, Principi di Economia, Zanichelli, 4 ed. 2007 (oppure edizioni precedenti). N. Gregory
SOCIOLINGUISTICA (Primo e secondo periodo) Prof. Piera Molinelli. Codici Modulo A: 3048 Modulo B: MODULO A (primo periodo) Codice: 3048
 1 SOCIOLINGUISTICA (Primo e secondo periodo) Prof. Piera Molinelli Codici Modulo A: 3048 Modulo B: 3448 MODULO A (primo periodo) Codice: 3048 Durata: 30 ore Crediti formativi: 5 Programma: Problemi e metodi
1 SOCIOLINGUISTICA (Primo e secondo periodo) Prof. Piera Molinelli Codici Modulo A: 3048 Modulo B: 3448 MODULO A (primo periodo) Codice: 3048 Durata: 30 ore Crediti formativi: 5 Programma: Problemi e metodi
Tecniche di Vendita. Facoltà di Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Teramo. Prof. Marco Galdenzi Anno accademico 2014/15
 Tecniche di Vendita Facoltà di Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Teramo Prof. Marco Galdenzi Anno accademico 2014/15 Il modello ELM Cialdini ELM - PETTY E CACIOPPO Il modello ELM (Elaboration
Tecniche di Vendita Facoltà di Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Teramo Prof. Marco Galdenzi Anno accademico 2014/15 Il modello ELM Cialdini ELM - PETTY E CACIOPPO Il modello ELM (Elaboration
Italiano Tecnico 2006-2007. Note e bibliografia Criteri redazionali
 Italiano Tecnico 2006-2007 Note e bibliografia Criteri redazionali Le note Funzione e collocazione I testi professionali e scientifici possono essere corredati da note, testi generalmente brevi che accompagnano
Italiano Tecnico 2006-2007 Note e bibliografia Criteri redazionali Le note Funzione e collocazione I testi professionali e scientifici possono essere corredati da note, testi generalmente brevi che accompagnano
Nodi concettuali essenziali della disciplina (Saperi essenziali)
 MATERIA: TEDESCO 2^ lingua CLASSI: PRIME TERZE SECONDE QUARTE QUINTE INDIRIZZI: MARKETING RELAZIONI INTERNAZIONALI AMMINISTRAZIONE FINANZA E Nodi concettuali essenziali della disciplina (Saperi essenziali)
MATERIA: TEDESCO 2^ lingua CLASSI: PRIME TERZE SECONDE QUARTE QUINTE INDIRIZZI: MARKETING RELAZIONI INTERNAZIONALI AMMINISTRAZIONE FINANZA E Nodi concettuali essenziali della disciplina (Saperi essenziali)
CORSI DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI (ITALIANO L2)
 PRE-CORSO INTENSIVO DI LIVELLO A1 (ELEMENTARE) acquisire le abilità e competenze per interagire oralmente, in modo semplice ed essenziale, nelle situazioni più comuni e familiari al fine di soddisfare
PRE-CORSO INTENSIVO DI LIVELLO A1 (ELEMENTARE) acquisire le abilità e competenze per interagire oralmente, in modo semplice ed essenziale, nelle situazioni più comuni e familiari al fine di soddisfare
Peer Education e Prevenzione dalle Malattie Sessualmente Trasmissibili
 Peer Education e Prevenzione dalle Malattie Sessualmente Trasmissibili ASP 7 - SER.T Vittoria Responsabile progetto Dott. Giuseppe Mustile Referenti progetto Dott.ssa Delizia Di Stefano Dott.ssa Melania
Peer Education e Prevenzione dalle Malattie Sessualmente Trasmissibili ASP 7 - SER.T Vittoria Responsabile progetto Dott. Giuseppe Mustile Referenti progetto Dott.ssa Delizia Di Stefano Dott.ssa Melania
Classe quinta Scuola Primaria scienze - COMPETENZE EUROPEE CONTENUTI E ATTIVITA APPRENDIMENTO
 COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITA Comunicazione nella madrelingua (CAPACITA DI ESPRIMERE E INTERPERTARE IN FORMA ORALE E SCRITTA) 1. Espone in forma chiara ciò
COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITA Comunicazione nella madrelingua (CAPACITA DI ESPRIMERE E INTERPERTARE IN FORMA ORALE E SCRITTA) 1. Espone in forma chiara ciò
V Fase: Valutazione. per gestire la complessità del cambiamento
 V Fase: Valutazione 1 2 3 4 5 La valutazione avviene a due livelli Valutazione del piano d azione stesso: come soddisfa gli scopi e gli obiettivi Valutare l efficacia del piano per Ascolta e Innova «Storie
V Fase: Valutazione 1 2 3 4 5 La valutazione avviene a due livelli Valutazione del piano d azione stesso: come soddisfa gli scopi e gli obiettivi Valutare l efficacia del piano per Ascolta e Innova «Storie
- Rettore dell Università (o suo rappresentante ufficiale): ha il compito di proclamare i neolaureati.
 Regolamento per la prova finale Corsi di Laurea Triennale ATTORI: RUOLI E RESPONSABILITÀ - Rettore dell Università (o suo rappresentante ufficiale): ha il compito di proclamare i neolaureati. - Direttore
Regolamento per la prova finale Corsi di Laurea Triennale ATTORI: RUOLI E RESPONSABILITÀ - Rettore dell Università (o suo rappresentante ufficiale): ha il compito di proclamare i neolaureati. - Direttore
Psicologia Sociale (edizione 2010)
 Psicologia Sociale (edizione 2010) Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7,10, 11 Prof. M. Ravennna - Università di Ferrara, a.a. 2011-12 Argomenti del corso 1. INTRODUZIONE
Psicologia Sociale (edizione 2010) Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7,10, 11 Prof. M. Ravennna - Università di Ferrara, a.a. 2011-12 Argomenti del corso 1. INTRODUZIONE
Spazio / Space Elizabeth Keating
 Spazio / Space Elizabeth Keating Lo spazio è parte integrante della vita sociale e degli eventi linguistici, oltre a costituire un importante risorsa per imporre un ordine all esperienza. La distribuzione
Spazio / Space Elizabeth Keating Lo spazio è parte integrante della vita sociale e degli eventi linguistici, oltre a costituire un importante risorsa per imporre un ordine all esperienza. La distribuzione
Lo scambio Piste per un percorso multidisciplinare. Progetto di valorizzazione dell identità dei LES del Lazio
 Lo scambio Piste per un percorso multidisciplinare Progetto di valorizzazione dell identità dei LES del Lazio Lo scambio come tema multidisciplinare Si propone qui una breve pista di indagine su alcuni
Lo scambio Piste per un percorso multidisciplinare Progetto di valorizzazione dell identità dei LES del Lazio Lo scambio come tema multidisciplinare Si propone qui una breve pista di indagine su alcuni
Antropologia culturale - Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini
 Antropologia culturale - Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini Sofferenza sociale Kleinman, Das e Lock (1997): La sofferenza sociale accomuna una serie di problemi umani la cui origine e le cui conseguenze affondano
Antropologia culturale - Prof.ssa Sabrina Tosi Cambini Sofferenza sociale Kleinman, Das e Lock (1997): La sofferenza sociale accomuna una serie di problemi umani la cui origine e le cui conseguenze affondano
Performatività / Performativity Kira Hall
 Performatività / Performativity Kira Hall Il concetto di enunciato performativo, nato nell ambito della filosofia del linguaggio ordinario sviluppata da J. L. Austin, ha influenzato il percorso dell antropologia
Performatività / Performativity Kira Hall Il concetto di enunciato performativo, nato nell ambito della filosofia del linguaggio ordinario sviluppata da J. L. Austin, ha influenzato il percorso dell antropologia
Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience. Par. I Il pubblico dei media
 Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Par. I Il pubblico dei media Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Il pubblico dei media 25/10/2004 Il pubblico dei media
Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Par. I Il pubblico dei media Teoria dei pubblici Comunicazione ed effetti sull audience Il pubblico dei media 25/10/2004 Il pubblico dei media
LAVORARE IN RETE PER L INCLUSIONE DI ALUNNI CON AUTISMO A SCUOLA: LABORATORIO DI STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE
 LAVORARE IN RETE PER L INCLUSIONE DI ALUNNI CON AUTISMO A SCUOLA: LABORATORIO DI STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E ASSISTENTI EDUCATIVI DALLA SCUOLA DELL INFANZIA,
LAVORARE IN RETE PER L INCLUSIONE DI ALUNNI CON AUTISMO A SCUOLA: LABORATORIO DI STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E ASSISTENTI EDUCATIVI DALLA SCUOLA DELL INFANZIA,
