Estratto distribuito da Biblet
|
|
|
- Evelina Fedele
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 265/1 elementi Maior Simone DIRITTO TRIBUTARIO - L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011); - D.L. 225/2010, conv. in L. 10/2011 (Decreto milleproroghe); - D.Lgs. 23/2011 (Federalismo fiscale municipale); - D.Lgs. 68/2011 (Autonomia finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario e delle Provincie); - D.L. 70/2011 (Decreto sviluppo). IMONE EDIZIONI GIURIDICHE SGruppo Editoriale Simone
2
3 Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo: Dalla collana «Last minute» 226 Elementi di diritto costituzionale 227 Elementi di diritto commerciale 227/1 Elementi di diritto delle società 239 Elementi di economia aziendale 239/1 Elementi di ragioneria applicata e professionale 265 Elementi Maior di scienza delle finanze 271 Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici 271/1 Elementi di contabilità e finanza degli enti locali 271/2 Ragioneria pubblica Dal catalogo Edizioni giuridiche Simone 12 Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario 14 Manuale di diritto tributario 14/2 Compendio di diritto tributario 519/1 Codice tributario minor Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati Revisione del testo a cura della dott.ssa Maria Vittoria Ballestra Finito di stampare nel mese di luglio 2011 dalla «Pittogramma s.r.l.» - Via Santa Lucia, 34 - Napoli per conto della Simone S.p.A. - Via F. Russo, 33/D Napoli Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno
4 Premessa Questo volume costituisce un valido strumento di apprendimento degli elementi fondamentali del diritto tributario per quanti affrontano per la prima volta lo studio della materia. La tecnica espositiva agile e priva di eccessivi tecnicismi rende il lavoro estremamente utile sia per gli studenti universitari sia per coloro che devono sostenere i concorsi pubblici. La prima parte del testo (capp. 1-7) fornisce un quadro d insieme del sistema tributario italiano esaminando in particolare il contenzioso, le sanzioni, l accertamento e la riscossione dei tributi. I capitoli successivi (8-14) delineano negli elementi essenziali l imposizione diretta (IRPEF e IRES), l imposizione indiretta (IVA, imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni etc.) e la fiscalità locale (IRAP, ICI, addizionali IRPEF etc.). Il volume contiene puntuali riferimenti normativi essenziali ed è aggiornato alle ultime novità in materia fiscale: L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011); D.L. 225/2010, conv. in L. 10/2011 (Decreto milleproroghe); D.Lgs. 23/2011 (Federalismo fiscale municipale); D.Lgs. 68/2011 (Autonomia finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province); D.L. 70/2011 (Decreto sviluppo). Il testo è arricchito da alcuni approfondimenti sulle tematiche più attuali e da piccoli glossari sul lessico fiscale più comune, posti alla fine di ciascun capitolo.
5
6 Capitolo Primo Il diritto tributario e lo studio dell attività finanziaria dello Stato Sommario: 1. Introduzione Teorie sull attività finanziaria dello Stato I fini dell attività finanziaria Diritto tributario, diritto finanziario e scienza delle finanze. 1. Introduzione L attività finanziaria dello Stato contemporaneo è essenzialmente rivolta alla soddisfazione di bisogni collettivi (o pubblici), cioè di quelle esigenze che sono generali e diffuse in tutti coloro che sono parte della collettività e aderiscono al modello di vita associativa. Il soddisfacimento di tali bisogni, in particolare, tende al miglioramento delle condizioni di convivenza tra i cittadini, favorendo un più elevato livello di prosperità, benessere e tenore di vita dell intero corpo sociale. La soddisfazione di tutti i bisogni ritenuti necessari per il benessere, la sicurezza e la pacifica convivenza dei cittadini viene assicurata mediante la gestione dei pubblici servizi. L espressione «pubblici servizi» individua tutte le prestazioni che gli enti pubblici assolvono: per soddisfare esigenze dell intera collettività (servizi pubblici generali), quali la difesa esterna e la sicurezza interna, che sono goduti indistintamente da tutti i cittadini; per venire incontro alle istanze di singoli gruppi di utenti (servizi ferroviari, postali etc.). Si parla, in questi casi, di servizi pubblici speciali, prestati a vantaggio dei singoli e di cui è possibile individuare i fruitori effettivi; per rispondere contemporaneamente ad una esigenza di carattere generale della collettività e ad un bisogno specifico di alcuni cittadini: è il caso della pubblica istruzione che, pur indirizzandosi solo ai singoli studenti, offre un vantaggio all intera comunità. L esborso che lo Stato impone per poter provvedere ai servizi generali prende il nome di tributo (che si configura poi come imposta o tassa), mentre
7 6 Capitolo Primo il prezzo pubblico costituisce il corrispettivo dei cd. servizi speciali (es.: trasporto ferroviario). 2. Teorie sull attività finanziaria dello Stato L attività finanziaria dello Stato è da sempre oggetto di studio da parte di cultori di diverse discipline, tanto che sulla natura della stessa si possono distinguere: teorie politico-sociologiche, che spiegano l attività finanziaria pubblica sulla base del rapporto di sudditanza dei governati rispetto ai governanti, con il connesso sfruttamento dei primi; teorie delle scelte pubbliche, che analizzano le decisioni del settore pubblico applicando agli operatori pubblici gli stessi modelli di comportamento di quelli privati; teorie economiche, caratterizzate dal tentativo di spiegare l attività finanziaria pubblica utilizzando i principi che l economia politica aveva elaborato per lo studio dell attività economica privata. 3. I fini dell attività finanziaria Gli obiettivi che l attività finanziaria tende a realizzare possono così sintetizzarsi: soddisfare esigenze collettive che, per le loro dimensioni, non possono essere gestite da privati; spezzare situazioni di monopolio che, se lasciate nelle mani dei settori dominanti, determinerebbero vantaggi per alcuni gruppi di potere e gravi discriminazioni a discapito della collettività; soddisfare necessità particolari (ad esempio costruzione di una diga) che, comunque, i singoli non sarebbero in grado di soddisfare; intervenire nei settori di maggior rilevanza sociale (controllare i prezzi di alimenti basilari o di medicinali, garantire l istruzione etc.) in concreto individuati dalla Costituzione. Al fianco di queste finalità altre ne sono state individuate dal PESENTI: 1) assicurare il pieno impiego e lo sviluppo economico; 2) attuare la redistribuzione del reddito utilizzando produttivamente capitali male impiegati o inattivi; 3) contenere la spesa entro limiti tali da evitare l inflazione; 4) distribuire la spesa totale con scelte razionali tra consumi ed investimenti.
8 il diritto tributario e lo studio dell attività finanziaria dello Stato 7 Accanto a questi aspetti propri della finanza tradizionale, si è venuta formando un ulteriore branca dell attività finanziaria, consistente nel prelievo di tributi e contributi da destinare a specifici scopi assistenziali e mutualistici: tale attività viene definita complementare o parafiscale. 4. Diritto tributario, diritto finanziario e scienza delle finanze Il diritto finanziario è quel ramo del diritto amministrativo che, secondo la definizione di LUPI, si riferisce al complesso delle norme giuridiche sull acquisizione delle entrate e sull erogazione delle spese pubbliche. Il diritto tributario, pertanto, sotto questo profilo può essere considerato come una parte del diritto finanziario, in quanto regola la principale fonte di entrate pubbliche, cioè quelle tributarie (LUPI). Relativamente invece ai rapporti tra diritto tributario e scienza delle finanze va detto che entrambi analizzano lo stesso fenomeno da una diversa prospettiva: mentre il primo regola i conflitti di interesse in materia tributaria, la seconda studia i tributi dal punto di vista economico (LUPI). Quali sono i punti di contatto o le divergenze tra il diritto tributario e le altre branche del diritto? Il diritto tributario e la contabilità di Stato costituiscono le due parti fondamentali del diritto finanziario di cui studiano distinte fasi (l una i tributi, l altra la gestione del patrimonio statale e degli enti pubblici). Il diritto finanziario e tributario sono una parte del diritto amministrativo e gli organi tributari, svolgendo una funzione amministrativa, sono organi amministrativi. Il diritto tributario ha ovviamente stretti legami con il diritto costituzionale, dal momento che la Costituzione fissa i principi cardine dell imposizione fiscale. È duplice il legame tra diritto tributario e diritto privato. In primo luogo, dall imposizione tributaria sorge un rapporto giuridico d imposta tra cittadino ed ente impositore che, pur essendo un istituto di carattere pubblicistico, si modella su regole e principi di diritto privato. In secondo luogo il presupposto di fatto per l esplicazione del fenomeno tributario è costituito da istituti privatistici (nascita, cittadinanza, compravendita etc.). Esiste, inoltre, nel nostro sistema una particolare branca del diritto penale, il diritto penale tributario, che qualifica come reati determinati illeciti tributari. La potestà tributaria è spesso vincolata da norme di diritto internazionale che trovano origine in convenzioni internazionali o in regole comunitarie (sorte nell ambito delle Comunità Europee). La potestà tributaria è spesso vincolata da norme di diritto internazionale che trovano origine in convenzioni internazionali o in regole comunitarie (sorte nell ambito delle Comunità Europee).
9 8 Capitolo Primo ANALISI DEL FENOMENO FINANZIARIO (entrate e uscite dello Stato) SCIENZA DELLE FINANZE (Analizza le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico utilizzando modelli teorici) DIRITTO FINANZIARIO (Analizza le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista giuridico) DIRITTO TRIBUTARIO (Studia solo quelle particolari entrate dette «tributi») CONTABILITÀ DI STATO (Studia la gestione del patrimonio statale) Glossario Attività finanziaria: attività dello Stato e degli altri enti pubblici rivolte al soddisfacimento degli interessi generali della collettività attraverso la raccolta e il successivo impiego di mezzi finanziari. Generalmente gli obiettivi della finanza pubblica sono raggruppati in tre categorie: finanziamento delle spese per far fronte ai servizi ed al mantenimento dei beni pubblici; equa redistribuzione dei redditi tra famiglie ed imprese; stabilità e sviluppo dell economia nazionale. Diritto tributario: branca del diritto pubblico che ha ad oggetto i mezzi e le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle spese che lo Stato e gli enti pubblici devono sostenere per svolgere le funzioni loro proprie. Il ( ) può essere definito come un particolare settore del diritto finanziario, caratterizzato dall avere ad oggetto l imposizione, a favore di soggetti pubblici, di prestazioni patrimoniali. Scienza delle finanze: è la disciplina che studia l attività che lo Stato e gli enti pubblici svolgono per procurarsi i mezzi necessari ad adempiere le proprie funzioni, cioè ad appagare i bisogni pubblici mediante la prestazione di pubblici servizi. I problemi oggetto di analisi da parte della ( ) possono essere suddivisi in tre distinti gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde un settore della scienza stessa: la teoria delle scelte pubbliche; la teoria degli effetti economici dell attività pubblica; la politica finanziaria.
10 Capitolo Secondo Le fonti del diritto tributario Sommario: 1. Costituzione e principi giuridici in materia tributaria Le altre fonti del diritto tributario Lo Statuto del contribuente: come si deve legiferare in campo fiscale Interpretazione e integrazione delle norme finanziarie Efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio La lotta all elusione e il diritto d interpello. 1. Costituzione e principi giuridici in materia tributaria A) Generalità Nell ordinamento italiano fonte primaria del diritto tributario è la Costituzione. La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all art. 117 della Costituzione, allo Stato e alle Regioni. Lo Stato ha, in via esclusiva, la potestà di disciplinare il sistema tributario e di stabilire i principi fondamentali in materia fiscale. Le Regioni, invece, hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica e sistema fiscale e hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell ambito sempre dei principi fondamentali istituiti dallo Stato. Gli articoli fondamentali, in materia di imposte, sono: l art. 23, che sancisce la riserva di legge in materia tributaria accogliendo un principio tipico dello «Stato di diritto» che è quello della legalità delle imposte; l art. 53, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Il dettato costituzionale, pertanto, contiene i tre fondamentali principi dell universalità dell imposta, della progressività del sistema tributario e dell uguaglianza del carico tributario. Altri principi in materia sono contenuti negli articoli 75, 81 e 119 della Costituzione.
11 10 Capitolo Secondo L art. 75 afferma che non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie (vedi infra); l art. 81 dispone al terzo comma che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese; l art. 119, infine, demanda agli Enti territoriali una autonomia finanziaria, ultimamente estesa per effetto delle modifiche apportate all articolo citato dalla legge costituzionale n. 3 del (vedi infra). B) Il principio della riserva di legge In base all art. 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Va ricordato che l espressione in base alla legge ha dato luogo a molteplici problemi. Il primo e più importante riguarda il contenuto minimo che deve avere la legge che istituisce un tributo. La riserva di legge prevista dall art. 23 della Costituzione deve essere considerata una riserva relativa e non assoluta: pertanto la legge (o gli atti aventi forza di legge) può non regolare integralmente il rapporto tributario, demandando ad un regolamento (o ad altra fonte subordinata) la disciplina specifica degli elementi fissati in generale dalla legge. La legge deve contenere, quale contenuto minimo gli elementi necessari per individuare il nuovo tributo e cioè: il presupposto di fatto; i soggetti passivi; i principi di determinazione delle aliquote; le sanzioni. A quali funzioni assolve la riserva di legge nell art. 23 della Costituzione? Il principio della riserva di legge sancito dall art. 23 della Costituzione garantisce la libertà dei cittadini, demandando al solo organo che ne rappresenta la totalità (il Parlamento) le scelte fondamentali in materia tributaria, e limita i poteri impositivi degli organi non legislativi, tutelando lo Stato e i cittadini. C) Il principio della generalità del tributo Il principio della generalità o dell universalità del tributo si ricava dall art. 53 della Costituzione, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il termine «tutti» si riferisce non solo ai cittadini italiani ma anche agli stranieri e agli apolidi che operano sul territorio dello Stato e che realizzano i presupposti di legge necessari per essere soggetti all imposizione fiscale.
12 Le fonti del diritto tributario 11 Tale termine, inoltre, si rivolge sia alle imprese individuali che collettive, sia nazionali che straniere. Sono ammesse deroghe al principio che prevede la partecipazione di tutti a concorrere alla spesa pubblica? La generalità dell imposta pone il problema della legittimità delle eccezioni; se, infatti, l art. 53 parla di tutti, si dovrebbe escludere la possibilità di esenzioni a favore di alcuni soggetti. Al contrario, il legislatore può derogare al principio dell universalità dell imposta esentando quei cittadini che si trovino in determinate condizioni. Queste deroghe possono avere natura temporanea o permanente, in relazione a particolari ragioni di giustizia sociale o di politica economica. Di particolare rilevanza sono le deroghe permanenti accordate ai contribuenti titolari di redditi minimi. In questo caso, infatti, rispetto al principio della generalità dell imposta, prevalgono motivazioni di giustizia sociale, in quanto il reddito dei contribuenti meno abbienti è già di per sé tanto basso da non tollerare il prelevamento dell imposta. D) Il principio dell eguaglianza del carico fiscale Il principio dell eguaglianza, se appare chiaro nel suo significato più generale, è di difficile realizzazione dal punto di vista sostanziale: mentre, infatti, tutti sono concordi nel ritenere che le imposte debbano essere distribuite equamente, nel senso che a parità di condizioni economiche i soggetti debbono sopportare parità di gravami tributari, si discute sul come attuare praticamente tale principio. E) Il principio della capacità contributiva In base all art. 53 della Costituzione «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». L art. 53 in sostanza pone una garanzia per i soggetti passivi disponendo che il legislatore nel determinare i tributi deve tener conto della loro capacità contributiva ponendo pertanto un limite alla potestà impositiva in materia fiscale. Il principio della capacità contributiva può essere veramente rispettato solo tenendo conto del sistema fiscale nel suo complesso: infatti, in un sistema tributario ove siano presenti in misura diversa imposte dirette ed imposte indirette, la prevalenza di quest ultime viene a ledere tale principio, in quanto le imposte indirette non tengono conto della capacità contributiva dei singoli ed in tal modo possono incidere in misura maggiore sui redditi dei meno abbienti. F) Il principio della progressività del sistema tributario Un principio di equità, largamente condiviso, vuole che il carico tributario individuale cresca con il crescere della ricchezza del contribuente. Quando il carico tributario cresce in rapporto diretto con il crescere della ricchezza considerata imponibile (es.: Tizio, che ha un reddito doppio di Caio,
13 12 Capitolo Secondo paga un imposta pari a due volte quella pagata da quest ultimo), la tassazione è proporzionale. Quando il carico tributario cresce in misura più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile, la tassazione è definita progressiva. La tassazione progressiva, pertanto, è una tassazione ad aliquote (marginali) crescenti. Il principio della progressività del sistema tributario è affermato dal secondo comma dell art. 53 della Costituzione. Tale principio: si riferisce non solo a tutto il sistema tributario statale, ma anche ai prelievi effettuati a tutti i livelli della pubblica amministrazione (tributi locali, contributi previdenziali etc.); non indica alcun grado specifico di progressività che può, quindi, assumere valori assoluti differenti e scarti di aliquota molto diversificati. La progressività è realizzabile attraverso diverse modalità: si parla, infatti, di progressività per detrazione, per classi, continua e per scaglioni. Per l imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) è stata attuata, nel nostro ordinamento, la progressività per scaglioni: il reddito imponibile è suddiviso in scaglioni a ciascuno dei quali corrisponde un aliquota differente. Ad esempio, agli imponibili fino a 100 si applica l aliquota del 5%; a quelli di 200 si applica per le prime cento l aliquota del 5% e per le seconde cento l aliquota del 6%; a quelli di 300 si applica per le prime cento l aliquota del 5%, per le seconde cento l aliquota del 6% e per le terze cento l aliquota del 7%. 2. Le altre fonti del diritto tributario Le fonti diverse dalla Costituzione sono ad essa subordinate, nel senso che debbono uniformarsi ai principi sanciti dalla stessa. A) La legge La norma tributaria, secondo l art. 23 della Costituzione, ha come fonte di produzione primaria la legge che può creare, modificare, estinguere norme tributarie. Nessun tributo, dunque, può essere creato con atto normativo diverso dalla legge o da atto con forza di legge. Tra i principi generali dell ordinamento tributario, codificati nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), particolarmente rilevante è quello che fissa l irretroattività delle leggi tributarie.
14 Le fonti del diritto tributario 13 Quale è la potestà normativa tributaria delle Regioni? Anche le Regioni godono di potestà impositiva. In particolare le Regioni a statuto ordinario, pur nel silenzio dell art. 117 della Costituzione, godono di competenza normativa tributaria, limitata ai tributi cosiddetti propri, in virtù dell autonomia finanziaria di cui all art. 119: esse, sulla base dell interpretazione data dalla L. 281/70 del medesimo art. 119, possono emanare leggi solo nel quadro di leggi statali. Le Regioni a statuto speciale prevedono, nei rispettivi statuti, la loro autonomia, che va tuttavia temperata con le norme nazionali. L accresciuta autonomia finanziaria degli Enti locali ultimamente estesa per effetto delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 3/2001 si riflette nell ampliamento della potestà regolamentare degli stessi in campo tributario. Attualmente anche ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane oltre che alle Regioni sono state attribuite risorse autonome: il novellato art. 119 Cost. prevede che tali enti territoriali stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In più tali enti dispongono di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio. Proprio in attuazione dell art. 119 della Costituzione è stata emanata dapprima la legge delega 42/2009 e successivamente il D.Lgs. 23/2011 sulla fiscalità municipale e il D.Lgs. 68/2011 sulla fiscalità regionale. B) Decreti legislativi e decreti legge Entrambi sono emanati dal Governo ed hanno la stessa forza della legge. I decreti legge sono emanati dal Governo di propria iniziativa per motivi di necessità ed urgenza (art. 77 della Costituzione) salvo, poi, la conversione in legge da parte delle Camere entro sessanta giorni dalla loro emanazione. Nell ambito delle modalità di legislazione previste dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000) è sancito che nessun tributo può essere introdotto con decreto legge e che la legislazione di urgenza non può individuare soggetti passivi di tributi già esistenti. Attualmente, quindi, è molto più frequente il ricorso ai decreti legislativi i quali invece, presuppongono una delega delle Camere al Governo con preventiva determinazione dei principi e criteri direttivi che il governo è tenuto a seguire (art. 76 della Costituzione). C) Regolamenti, decreti dirigenziali e provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate Tra le fonti secondarie sempre più rilevanza stanno assumendo i regolamenti. Tali atti, emanati dall esecutivo, possono classificarsi, in ragione dell organo da cui promanano, in: governativi, in quanto deliberati dal Consiglio dei Ministri; ministeriali, se deliberati dal singolo Ministro. Su materie già di competenza dei Ministeri ed ora attribuite alle Agenzie fiscali, dispongono con propri provvedimenti i direttori delle suddette agenzie.
15 14 Capitolo Secondo Per tali provvedimenti la pubblicità è garantita in base ad una norma contenuta nella finanziaria per il 2008 con la pubblicazione on line sui siti istituzionali Internet. D) Istruzioni ministeriali Nel campo tributario, caratterizzato da una iperlegificazione, le norme risultano di difficile comprensione e frequentemente in contrasto tra di loro: per questo motivo il Ministero dell economia e delle finanze (o le Agenzie fiscali, sulle materie di propria competenza), per agevolare il lavoro degli uffici finanziari e conseguentemente dei contribuenti e degli operatori del settore, fa seguire all emanazione di una legge, delle circolari che propagano l interpretazione ministeriale delle norme ivi contenute. La forza delle circolari, atti amministrativi a rilevanza interna, è data dal vincolo gerarchico; esse, pertanto, non possono considerarsi fonti di diritto oggettivo, né possono modificare norme preesistenti. Hanno, tuttavia, una forza normativa indiretta, in quanto costituiscono condizione di legittimità degli atti emanati dagli uffici inferiori. E) Fonti comunitarie e internazionali L appartenenza dell Italia ad organismi sovranazionali o internazionali rende necessario accennare alle fonti normative estere. In particolare i trattati delle tre Comunità europee (CECA, EURATOM e CEE) hanno dato vita ad un ordinamento giuridico sovranazionale caratterizzato da propri organi e soprattutto da proprie fonti normative. Nella gerarchia delle fonti, le norme comunitarie sono poste ad un livello più elevato rispetto alle norme interne. Perciò le norme interne non devono essere applicate se in contrasto con il diritto comunitario. Quali sono le fonti normative comunitarie e in cosa divergono tra loro? Tra le fonti comunitarie vanno citate in particolare: i regolamenti che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri senza necessità di ratifica; le direttive che vincolano, invece, lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Ciò significa che i legislatori nazionali hanno un certo margine di discrezionalità nello stabilire i criteri di ricezione delle stesse. Si viene così a creare un rapporto tra direttiva comunitaria e legge di attuazione analogo a quello esistente tra legge delega e decreto legislativo; le decisioni che riguardano casi specifici e sono obbligatorie per i destinatari in esse indicati; le sentenze della Corte di giustizia che hanno effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri.
16 Le fonti del diritto tributario 15 Il diritto tributario internazionale è formato dalle Convenzioni stipulate e ratificate dall Italia con gli altri paesi. Scopo di tali convenzioni è quello di evitare fenomeni di «doppia imposizione» ossia di evitare che uno stesso soggetto sia tassato più volte in Stati diversi. F) Gli usi Sono fonti di diritto non scritte in quanto sono regole costantemente osservate da parte dei singoli (art. 1 disp. prel. c.c.). L uso non può modificare o estinguere una norma tributaria, né completare la norma stessa. 3. Lo Statuto del contribuente: come si deve legiferare in campo fiscale Nel tentativo di mutare radicalmente il quadro dei rapporti tra cittadino e fisco, imputandoli a principi di collaborazione e buona fede, è stato approvato, con L , n. 212, lo Statuto dei diritti del contribuente. Obiettivi primari della nuova normativa sono, pertanto, da un lato, stabilire regole precise che vincolino il legislatore fiscale, riducendo il caotico e disordinato flusso di disposizioni tributarie e, dall altro, tutelare il contribuente contro disposizioni inique, vessatorie e predisposte unicamente a vantaggio della pubblica amministrazione. In questa sede basti ricordare che la L. 212/2000 sancisce: l obbligo per il legislatore di predisporre testi di legge che siano i più chiari possibile; il divieto di introdurre nuovi tributi con decreto legge nonché di individuare con legislazione d urgenza nuovi soggetti passivi di tributi già esistenti; l obbligo per l amministrazione finanziaria di diffondere le informazioni fiscali e portare a conoscenza gli atti, anche con mezzi informatici; la non retroattività della legge; la generalizzazione del diritto di interpello. 4. Interpretazione e integrazione delle norme finanziarie Interpretare una norma significa compiere un operazione mirante a ricercare il significato della stessa attraverso un indagine che può essere: a) letterale, se rivolta allo studio del significato letterale del testo; b) logica, se rivolta alla discussione della disposizione nel suo complesso;
17 16 Capitolo Secondo c) sistematica, se rivolta a coordinare la singola disposizione di legge con le altre norme. 5. Efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio A) Efficacia nel tempo Per quanto riguarda il termine iniziale dell entrata in vigore delle norme tributarie, non esistono difformità dai principi del diritto in generale. Con l art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) è stabilito che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. Le norme tributarie cessano di operare per: abrogazione espressa; abrogazione tacita, allorché venga emanata una legge che detta norme incompatibili con la precedente o ridisciplini interamente la materia; sentenza della Corte costituzionale che riconosca l incostituzionalità della norma. B) Efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie Il principio dell ultrattività è venuto meno sia per le sanzioni di carattere amministrativo (D.Lgs. 472/97) sia con riferimento alle leggi penali tributarie (D.Lgs. 507/99). In seguito a tale abrogazione si applica, sia per le sanzioni amministrative che penali, il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base ad una legge in vigore prima della commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (art. 3, co. 1 e 2, D.Lgs. 472/97). Tale principio è tuttavia mitigato da quello del favor rei secondo il quale si applica la legge più favorevole al contribuente nell ipotesi in cui la violazione nel corso del tempo sia stata punita con sanzioni di diversa entità, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (art. 3, co. 3, D.Lgs. 472/97). C) Efficacia nello spazio La legge tributaria ha carattere strettamente territoriale. Essa, cioè, esplica i suoi effetti solo nel territorio dello Stato, ma il legislatore può configurare, come presupposto di un imposta da applicare in Italia, un fatto che è avvenuto all estero (esempio: possesso di un bene all estero). Le leggi regionali, provinciali e comunali hanno efficacia nell ambito dei confini dell ente locale che le ha emanate.
18 Le fonti del diritto tributario La lotta all elusione e il diritto d interpello Con l elusione il contribuente mira ad evitare il prelievo tributario a suo carico ricorrendo ad opportune scappatoie al limite della legalità. L elusione consiste nello sfruttamento, operato da alcune categorie di soggetti, delle smagliature delle norme tributarie per realizzare un consistente risparmio d imposta. Un primo esempio di norma antielusione si è avuto con l art. 10 della L. 408/90, poi sostituito dall art. 37bis del D.P.R. 600/73 (introdotto dal D.Lgs. 358/97). Tale disposizione, volta ad evitare comportamenti elusivi (che consentono riduzioni o rimborsi di imposta ottenuti aggirando la normativa fiscale), prevede che «sono inopponibili all amministrazione finanziaria tutti quegli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti». Pertanto, affinché la norma possa essere applicata, è necessario che: ci sia un vantaggio fiscale (riduzione o rimborso di imposta); ci sia un comportamento volto ad aggirare il sistema fiscale; gli atti siano posti in essere senza valide ragioni economiche. Di recente la Corte di Cassazione (sent. n del 2009) ha stabilito che ai fini dell applicazione della suddetta norma antielusiva è sufficiente un uso improprio e ingiustificato (non sorretto da idonee valutazioni economiche) di uno strumento giuridico legittimo, che consenta di eludere l applicazione di un regime fiscale. In materia antielusiva un cenno merita anche il co. 2bis dell art. 2 del D.P.R. 917/86, introdotto dall art. 10 della L. 448/98, in base al quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini emigrati nei cd. paradisi fiscali. Tale disposizione consente, in pratica, al fisco di tassare i redditi ovunque prodotti dai cittadini italiani residenti all estero senza dover dimostrare che la residenza dichiarata dal contribuente è fittizia. Sarà cura di quest ultimo dimostrare il contrario al fine di evitare un aumento della tassazione del proprio reddito. Al fine di arginare i comportamenti antielusivi e favorire i rapporti tra contribuente e fisco è stato introdotto nel nostro ordinamento il diritto d interpello (ruling). Quest ultimo consiste nella possibilità per il contribuente di ottenere risposte dall amministrazione finanziaria, sulla correttezza o meno di determinati comportamenti. La richiesta del parere deve essere presentata alla competente Direzione centrale del Dipartimento delle finanze.
19 18 Capitolo Secondo La richiesta del parere può riguardare: i casi d interposizione fittizia (art. 37, co. 3, D.P.R. 600/73); le operazioni o i comportamenti elusivi di cui all art. 37bis del D.P.R. 600/73; la qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza (art. 21, co. 2, L. 413/91). Glossario Capacità contributiva: principio in base al quale la misura dell imposizione tributaria deve essere definita secondo criteri proporzionali (al reddito) e progressivi (con aliquote crescenti per fasce più alte di reddito). Esso costituisce un limite all attività di prelievo fiscale da parte dell ente impositore. La ( ) indica, dunque, l idoneità del soggetto passivo a sopportare l onere economico del tributo e mira a individuare la misura della partecipazione del singolo alle spese pubbliche, prevista dalla Costituzione. L applicazione del principio della ( ) contributiva deve rispettare: l equità orizzontale, garantendo un trattamento uguale per coloro che si trovano nelle stesse condizioni; l equità verticale, tassando in modo diverso i contribuenti con capacità contributiva diversa. Decreto legislativo: atto con efficacia di legge formale emanato dal Governo in base ad una delega legislativa (e nei limiti di questa) dal Parlamento. La delega del Parlamento è conferita con legge formale ordinaria. Destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo: più precisamente è l organo collegiale o Consiglio dei Ministri. La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei casi di particolare complessità della materia sulla quale legifera. La delega deve essere, inoltre, esercitata in un termine prefissato e nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nella legge. Accanto a tali limiti, fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurne di altri, ad esempio imponendo al Governo di ascoltare il parere di commissari parlamentari. Efficacia della norma tributaria nello spazio: la legge tributaria ha carattere strettamente territoriale. Essa, cioè, esplica i suoi effetti solo nel territorio dello Stato, ma il legislatore può configurare, come presupposto di un imposta da applicare in Italia, un fatto che è avvenuto all estero (esempio: possesso di un bene all estero). Efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie: si applica, sia per le sanzioni amministrative sia per quelle penali, il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non ai sensi di una legge in vigore prima della commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Tale principio è tuttavia mitigato da quello del favor rei, che consiste nell applicazione della legge più favorevole al contribuente nell ipotesi in cui la violazione nel corso del tempo sia stata punita con sanzioni di diversa entità, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Progressività del sistema tributario: è un criterio di imposizione in virtù del quale l aliquota d imposta aumenta all aumentare dell imponibile. Il sistema tributario italiano, a norma dell art. 53 Cost., è informato al principio della progressività; ciò non vieta, comunque, che esistano taluni tributi proporzionali o fissi. La ( ) può essere tecnicamente attuata con diverse modalità: per detrazione, quando si colpisce con un aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso; per classi, quando ad ogni classe d imponibile corrisponde un aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta; per scaglioni, quando per ogni classe d imponibile è prevista un aliquota che si applica solo allo scaglione d imponibile compreso in quella classe; continua, quando l aliquota aumenta in misura continua con l aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale essa rimane costante.
20 Le fonti del diritto tributario 19 Statuto del contribuente: legge generale in materia tributaria che si prefigge l obiettivo di regolare i rapporti tra l amministrazione finanziaria e i cittadini stabilendo da un lato regole precise che dovrebbero vincolare il legislatore fiscale riducendo così il caotico e disordinato flusso di disposizioni tributarie e tutelando contemporaneamente il contribuente contro disposizioni inique, vessatorie e predisposte unicamente a vantaggio della pubblica amministrazione. Lo ( ), oltre ad essere legge dello Stato, immediatamente applicabile, è anche un documento programmatico volto a cambiare definitivamente i rapporti cittadino-fisco. In sintesi i provvedimenti oggetto dello ( ) possono essere suddivisi nelle seguenti aree di intervento: norme generali in materia tributaria; conoscenza delle leggi tributarie; rapporti tra contribuente e fisco; diritti del contribuente; garanzie del contribuente in caso di verifiche.
21 192 indice generale 5. L imposta di bollo... Pag Le tasse sulle concessioni governative...» 156 Capitolo Tredicesimo: I monopoli fiscali, le imposte di fabbricazione, i tributi doganali ed i tributi minori 1. Monopoli fiscali...» Imposte di fabbricazione e imposte sui consumi...» Tributi doganali...» Tributi minori...» 161 Capitolo Quattordicesimo: I tributi locali Estratto distribuito da Biblet 1. La legge delega sul federalismo fiscale...» L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)...» Le altre entrate tributarie delle regioni...» Le entrate tributarie delle Province...» L imposta comunale sugli immobili (ICI)...» L addizionale comunale all Irpef...» Le altre entrate dei comuni...» 173
22 elementi Maior Simone Con la collana Elementi, nei formati standard o maior, bastano pochi giorni per cogliere e memorizzare i concetti essenziali della disciplina. Ogni volume tratta, infatti, tutti gli argomenti istituzionali del programma, enfatizzando soprattutto quelli più richiesti dagli esaminatori. In particolare chi è in ritardo con la preparazione potrà concentrarsi solo sulle parti del testo istituzionale richieste dal docente, completando e rifinendo lo studio sugli Elementi per raggiungere una completa preparazione di base del resto del programma. Questo volume, aggiornato al Decreto sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70) e al Federalismo municipale e regionale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68), sintetizza la complessa materia del Diritto Tributario facilitandone lo studio e il ripasso.
Capitolo Primo Il diritto tributario e lo studio. 2. Teorie sull attività finanziaria dello Stato
 Capitolo Primo Il diritto tributario e lo studio dell attività finanziaria dello Stato 1. Introduzione L attività finanziaria dello Stato contemporaneo è essenzialmente rivolta alla soddisfazione di bisogni
Capitolo Primo Il diritto tributario e lo studio dell attività finanziaria dello Stato 1. Introduzione L attività finanziaria dello Stato contemporaneo è essenzialmente rivolta alla soddisfazione di bisogni
CORSO DI DIRITTO PRIVATO
 CORSO DI DIRITTO PRIVATO Anno Accademico 2010/2011 Prof. Francesco Scaglione Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Perugia 1 TESTI 1) F. Galgano, Istituzioni
CORSO DI DIRITTO PRIVATO Anno Accademico 2010/2011 Prof. Francesco Scaglione Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Perugia 1 TESTI 1) F. Galgano, Istituzioni
CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a
 CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a. 2015-2016 Dott.ssa Nicoletta Vettori DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI Corso di laurea in Economia e Commercio AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Amministrazione pubblica
CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a. 2015-2016 Dott.ssa Nicoletta Vettori DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI Corso di laurea in Economia e Commercio AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Amministrazione pubblica
Capitolo Primo Le fonti del diritto tributario
 Capitolo Primo Le fonti del diritto tributario 1. Costituzione e principi giuridici in materia tributaria A) Generalità Nell ordinamento italiano fonte primaria del diritto tributario è la Costituzione.
Capitolo Primo Le fonti del diritto tributario 1. Costituzione e principi giuridici in materia tributaria A) Generalità Nell ordinamento italiano fonte primaria del diritto tributario è la Costituzione.
1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi IVA
 Schema dell opera Pag. Costituzione della Repubblica italiana (Articoli estratti)... 11 Imposte dirette 1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi... 17
Schema dell opera Pag. Costituzione della Repubblica italiana (Articoli estratti)... 11 Imposte dirette 1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi... 17
I TRIBUTI. L art. 53 della Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
 I TRIBUTI: IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI I TRIBUTI Il sistema tributario italiano è regolamentato dalla costituzione e da molte leggi ordinarie. Le fonti costituzionali principali le troviamo nell art. 2
I TRIBUTI: IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI I TRIBUTI Il sistema tributario italiano è regolamentato dalla costituzione e da molte leggi ordinarie. Le fonti costituzionali principali le troviamo nell art. 2
A.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio
 A.A. 2015/2016 Avv. Giuseppe Strangio L ordinamento giuridico Costituisce un insieme di norme giuridiche dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia da un punto di vista dei rapporti
A.A. 2015/2016 Avv. Giuseppe Strangio L ordinamento giuridico Costituisce un insieme di norme giuridiche dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia da un punto di vista dei rapporti
Sapienza Università di Roma
 Sapienza Università di Roma Il potere di indirizzo dell Amministrazione finanziaria. L interpello tributario. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Roberta Corriere Indice PARTE 1
Sapienza Università di Roma Il potere di indirizzo dell Amministrazione finanziaria. L interpello tributario. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Roberta Corriere Indice PARTE 1
COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
 COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO AI SENSI DELL ARTICOLO 52 D. LGS. 446/1997 E S.M.I., PER LA VARIAZIONE DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL
COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO AI SENSI DELL ARTICOLO 52 D. LGS. 446/1997 E S.M.I., PER LA VARIAZIONE DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
 LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.
LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
 COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE
COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE
QUIZ DIRITTO AMMINISTRATIVO
 QUIZ DIRITTO AMMINISTRATIVO QUIZ SU LEZIONE 1 2 3 1. Quale definizione descrive la funzione amministrativa, preordinata alla cura degli interessi pubblici A) PA in senso soggettivo B) PA in senso oggettivo
QUIZ DIRITTO AMMINISTRATIVO QUIZ SU LEZIONE 1 2 3 1. Quale definizione descrive la funzione amministrativa, preordinata alla cura degli interessi pubblici A) PA in senso soggettivo B) PA in senso oggettivo
Iva: cessione terreni. Fondamentale il concetto di edificabilità
 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 64 28.02.2014 Iva: cessione terreni Fondamentale il concetto di edificabilità Categoria: Iva Sottocategoria: Presupposti d imposta La cessione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 64 28.02.2014 Iva: cessione terreni Fondamentale il concetto di edificabilità Categoria: Iva Sottocategoria: Presupposti d imposta La cessione
INDICE SOMMARIO I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO DELLA FINANZA PUBBLICA
 Nota dell autore... p. XVII Prefazione...» XXI PARTE PRIMA I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO DELLA FINANZA PUBBLICA CAPITOLO PRIMO IL DIRITTO DELLA FINANZA PUBBLICA A. Sommario...» 3 B. Considerazioni introduttive...»
Nota dell autore... p. XVII Prefazione...» XXI PARTE PRIMA I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO DELLA FINANZA PUBBLICA CAPITOLO PRIMO IL DIRITTO DELLA FINANZA PUBBLICA A. Sommario...» 3 B. Considerazioni introduttive...»
La disciplina fiscale della cessione di azienda
 La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo
La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo
Capitolo Secondo Le fonti del diritto tributario
 Capitolo Secondo Le fonti del diritto tributario Sommario: 1. Costituzione e principi giuridici in materia tributaria. - 2. Le altre fonti del diritto tributario. - 3. Interpretazione e integrazione delle
Capitolo Secondo Le fonti del diritto tributario Sommario: 1. Costituzione e principi giuridici in materia tributaria. - 2. Le altre fonti del diritto tributario. - 3. Interpretazione e integrazione delle
REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del
 REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del 29.1.2007 Il Sindaco Il Segretario Comunale REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il
REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del 29.1.2007 Il Sindaco Il Segretario Comunale REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il
REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO
 REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO I regolamenti dell esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie. Da non confondere con altri regolamenti Non sono disciplinati dalla Costituzione.
REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO I regolamenti dell esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie. Da non confondere con altri regolamenti Non sono disciplinati dalla Costituzione.
COMUNE DI CASALGRANDE. Provincia di Reggio Emilia N 14 DEL 13/02/2012
 Reg. Pubbl. N. 42 COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA N 14 DEL 13/02/2012 OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
Reg. Pubbl. N. 42 COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA N 14 DEL 13/02/2012 OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
Diritto del Lavoro. Fonti del diritto del lavoro
 Diritto del Lavoro 1 Fonti del diritto del lavoro Schema delle FONTI a seconda della origine 2 Sovranazionali Principi Generali del diritto Norme costituzionali Fonti sovranazionali FONTI COMUNITARIE Fonti
Diritto del Lavoro 1 Fonti del diritto del lavoro Schema delle FONTI a seconda della origine 2 Sovranazionali Principi Generali del diritto Norme costituzionali Fonti sovranazionali FONTI COMUNITARIE Fonti
INDICE. Avvertenza... pag. XI INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI
 INDICE Avvertenza... pag. XI INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa...... pag. 1 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto.......» 3 3. La crisi delle fonti nazionali.........»
INDICE Avvertenza... pag. XI INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa...... pag. 1 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto.......» 3 3. La crisi delle fonti nazionali.........»
Provincia di Perugia
 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) N. 24 DEL 25-11-2013 SETTORE PROPONENTE: FINANZIARIO. ORIGINALE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) N. 24 DEL 25-11-2013 SETTORE PROPONENTE: FINANZIARIO. ORIGINALE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE
REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
 COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO C.A.P. 15049 PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO C.A.P. 15049 PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà
COMUNE DI TORRAZZA COSTE REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.
 COMUNE DI TORRAZZA COSTE PR.PAVIA REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. Approvato con Delibera C.C. n. 13 del 24 aprile 2012 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
COMUNE DI TORRAZZA COSTE PR.PAVIA REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. Approvato con Delibera C.C. n. 13 del 24 aprile 2012 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
CIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali
 CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA Roma, 17 febbraio 2011 Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici territoriali e, p.c. Al Ministero
CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA Roma, 17 febbraio 2011 Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici territoriali e, p.c. Al Ministero
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.
 COMUNE DI FERNO PROVINCIA DI Varese Via Aldo Moro, n 3 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1 INDICE Art. 1 -
COMUNE DI FERNO PROVINCIA DI Varese Via Aldo Moro, n 3 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1 INDICE Art. 1 -
Relazione tecnico-normativa
 Relazione tecnico-normativa Titolo: Sddl concernente Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell Iran per evitare le doppie
Relazione tecnico-normativa Titolo: Sddl concernente Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell Iran per evitare le doppie
FONTE DEL DIRITTO NORME GIURIDICHE. È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare
 FONTE DEL DIRITTO È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare NORME GIURIDICHE Nel nostro ordinamento vale il principio della PLURALITÀ DELLE FONTI: ciò significa
FONTE DEL DIRITTO È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare NORME GIURIDICHE Nel nostro ordinamento vale il principio della PLURALITÀ DELLE FONTI: ciò significa
COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
 COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (Approvato con Delibera di C.C. n 13.del 04/04/2007) Modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 20.02.2012 INDICE
COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (Approvato con Delibera di C.C. n 13.del 04/04/2007) Modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 20.02.2012 INDICE
COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo
 COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo e-mail comunecampagnolacr@libero.it REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Approvato con
COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo e-mail comunecampagnolacr@libero.it REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Approvato con
COMUNE DI CANTAGALLO PROVINCIA DI PRATO REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
 COMUNE DI CANTAGALLO PROVINCIA DI PRATO REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con atto del Consiglio Comunale nr. 13 del 31.03.2007 Pubblicato all Albo Pretorio dal 03 al 17 aprile 2007
COMUNE DI CANTAGALLO PROVINCIA DI PRATO REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con atto del Consiglio Comunale nr. 13 del 31.03.2007 Pubblicato all Albo Pretorio dal 03 al 17 aprile 2007
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
 CORSO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Prof. Paolo Ricci a.a. 2008/2009 CORSO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE II LEZIONE IL D.LGS 267/2000 E I PRINCIPI
CORSO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Prof. Paolo Ricci a.a. 2008/2009 CORSO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE II LEZIONE IL D.LGS 267/2000 E I PRINCIPI
L attuazione della norma tributaria e la dichiarazione
 L attuazione della norma tributaria e la dichiarazione Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attuazione
L attuazione della norma tributaria e la dichiarazione Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attuazione
DIRITTO TRIBUTARIO. Dr. Maurizio Tambascia. Il Sistema Tributario Italiano
 DIRITTO TRIBUTARIO Dr. Maurizio Tambascia Il Sistema Tributario Italiano Nozione di Tributo. E un istituto giuridico che realizza il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica attraverso una
DIRITTO TRIBUTARIO Dr. Maurizio Tambascia Il Sistema Tributario Italiano Nozione di Tributo. E un istituto giuridico che realizza il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica attraverso una
Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI
 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie I criteri per ordinare le fonti del diritto Abrogazione, interpretazione,
Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie I criteri per ordinare le fonti del diritto Abrogazione, interpretazione,
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
 RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre
SOMMARIO. Premessa... 5
 SOMMARIO Premessa... 5 REATI TRIBUTARI IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell art. 9
SOMMARIO Premessa... 5 REATI TRIBUTARI IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell art. 9
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
 RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia
REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
 REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE I.R.P.E.F. RO/043 CITTA DI SANTENA NORMAZIONE Edizione 1 Revisione 1 EDIZIONI REV ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATO IN VIGORE 1 0 C.C. n.64 in data 20.12.2007 1.01.2008
REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE I.R.P.E.F. RO/043 CITTA DI SANTENA NORMAZIONE Edizione 1 Revisione 1 EDIZIONI REV ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATO IN VIGORE 1 0 C.C. n.64 in data 20.12.2007 1.01.2008
LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza
 LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LEGISLAZIONE Forum PA E stato siglato un protocollo di intesa tra
LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LEGISLAZIONE Forum PA E stato siglato un protocollo di intesa tra
INDICE SOMMARIO PARTE GENERALE
 PARTE GENERALE 1. Disposizioni fondamentali................................... 3 1.1. Costituzione della Repubblica Italiana..................... 3 1.2. Trattato sul funzionamento dell Unione europea (Artt.
PARTE GENERALE 1. Disposizioni fondamentali................................... 3 1.1. Costituzione della Repubblica Italiana..................... 3 1.2. Trattato sul funzionamento dell Unione europea (Artt.
INDICE INTRODUZIONE. Sezione I PROFILI TEORICO-GENERALI
 INDICE Presentazione... pag. XIII INTRODUZIONE Sezione I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa... pag. 1 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto...» 3 3. La crisi delle fonti nazionali...»
INDICE Presentazione... pag. XIII INTRODUZIONE Sezione I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa... pag. 1 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto...» 3 3. La crisi delle fonti nazionali...»
SCIENZA DELLE FINANZE
 Programma svolto di SCIENZA DELLE FINANZE Anno scolastico 2013/2014 Classe V C igea Insegnante: professoressa Patrizia Cappelli Testo adottato:" La scienza delle finanze senza ostacoli" di R. Dorella -
Programma svolto di SCIENZA DELLE FINANZE Anno scolastico 2013/2014 Classe V C igea Insegnante: professoressa Patrizia Cappelli Testo adottato:" La scienza delle finanze senza ostacoli" di R. Dorella -
TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale
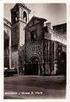 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30) Il catalogo aggiornato
TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30) Il catalogo aggiornato
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel processo di attuazione dell art. 119 Cost.
 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel processo di attuazione dell art. 119 Cost. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale finanze, patrimonio e programmazione Filippo Cacciaguerra
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel processo di attuazione dell art. 119 Cost. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale finanze, patrimonio e programmazione Filippo Cacciaguerra
REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
 REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. INDICE 1 Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Soggetto attivo Pag. 3 Art. 3 Soggetti passivi Pag. 3 Art. 4 Criteri di calcolo dell addizionale Pag. 3
REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. INDICE 1 Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Soggetto attivo Pag. 3 Art. 3 Soggetti passivi Pag. 3 Art. 4 Criteri di calcolo dell addizionale Pag. 3
OGGETTO: IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II
 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II PREMESSO CHE l art.52 del d.lgs.n.446 del 15.12.1997 disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie; CHE l art.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II PREMESSO CHE l art.52 del d.lgs.n.446 del 15.12.1997 disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie; CHE l art.
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
 Le riforma costituzionale del 2001 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, Modifiche al Titolo Quinto della Parte seconda della Costituzione Confermata da referendum
Le riforma costituzionale del 2001 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, Modifiche al Titolo Quinto della Parte seconda della Costituzione Confermata da referendum
COMUNE DI FARA NOVARESE
 COMUNE DI FARA NOVARESE Provincia di Novara REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 06/02/2007 Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/06/2012
COMUNE DI FARA NOVARESE Provincia di Novara REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 06/02/2007 Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/06/2012
RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003
 RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile
PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 in data 31/10/2016 PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA
 CITTA DI ASTI PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 in data 31/10/2016 PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA Nome e cognome Carica Presente Fabrizio BRIGNOLO SINDACO SI Davide ARRI ASSESSORE
CITTA DI ASTI PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 in data 31/10/2016 PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA Nome e cognome Carica Presente Fabrizio BRIGNOLO SINDACO SI Davide ARRI ASSESSORE
Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003
 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
COMUNE DI GRAGNANO Città Metropolitana di Napoli
 COPIA COMUNE DI GRAGNANO Città Metropolitana di Napoli VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ( nominato con D.P.R. del 24-02-2016 ) n. 38 del 09-03-2016 OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
COPIA COMUNE DI GRAGNANO Città Metropolitana di Napoli VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ( nominato con D.P.R. del 24-02-2016 ) n. 38 del 09-03-2016 OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
Comune di Soave REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.
 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 1 INDICE Art. 1 Ambito di applicazione...(pag. 3) Art.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 1 INDICE Art. 1 Ambito di applicazione...(pag. 3) Art.
Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne.
 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO La Costituzione I trattati istitutivi delle comunità europee ed i successivi trattati integrativi e modificativi Le fonti comunitarie: direttive e regolamenti Le leggi Le
LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO La Costituzione I trattati istitutivi delle comunità europee ed i successivi trattati integrativi e modificativi Le fonti comunitarie: direttive e regolamenti Le leggi Le
INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI SEZIONE II LE NORME SULLE FONTI
 INDICE - SOMMARIO Presentazione.... Pag. XIII INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa.... Pag. 2 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto....» 4 3. La crisi delle fonti
INDICE - SOMMARIO Presentazione.... Pag. XIII INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa.... Pag. 2 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto....» 4 3. La crisi delle fonti
INDICE. Capitolo I. Capitolo II
 INDICE Premessa alla quinta edizione.... Pag. IX Premessa alla quarta edizione....» XIII Premessa alla terza edizione....» XVII Premessa alla seconda edizione....» XXI Introduzione....» XXIII Capitolo
INDICE Premessa alla quinta edizione.... Pag. IX Premessa alla quarta edizione....» XIII Premessa alla terza edizione....» XVII Premessa alla seconda edizione....» XXI Introduzione....» XXIII Capitolo
PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI
 INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto
INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto
Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
 INDICE Prefazione alla VI edizione... V Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 1. Il diritto tributario e la struttura dell imposta... 3 1.1. Il diritto tributario...
INDICE Prefazione alla VI edizione... V Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 1. Il diritto tributario e la struttura dell imposta... 3 1.1. Il diritto tributario...
Progetto Fisco e scuola Agenzia delle Entrate e istituzioni scolastiche per la promozione di una CULTURA FISCALE
 Progetto Fisco e scuola Agenzia delle Entrate e istituzioni scolastiche per la promozione di una CULTURA FISCALE Principi costituzionali Art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
Progetto Fisco e scuola Agenzia delle Entrate e istituzioni scolastiche per la promozione di una CULTURA FISCALE Principi costituzionali Art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
 STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, FACOLTÁ DI SOCIOLOGIA A.A. 2008-2009 ANNA TEMPIA 3 LEZIONE CENNI DI TEORIA DELL IMPOSTA (PARTE PRIMA) BIBLIOGRAFIA: P. Bosi (
STATO E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, FACOLTÁ DI SOCIOLOGIA A.A. 2008-2009 ANNA TEMPIA 3 LEZIONE CENNI DI TEORIA DELL IMPOSTA (PARTE PRIMA) BIBLIOGRAFIA: P. Bosi (
GLOSSARIO FISCALE. Patronato INCA CGIL FLC CGIL
 GLOSSARIO FISCALE IRPEF Principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È personale, perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche; Progressiva, perché si applica con aliquote
GLOSSARIO FISCALE IRPEF Principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È personale, perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche; Progressiva, perché si applica con aliquote
Fisco e Tributi. Newsletter marzo Imponibile IVA nella cessione di aree
 Fisco e Tributi Imponibile IVA nella cessione di aree Premessa I requisiti affinché la cessione di una area assuma rilevanza ai fini Iva si verifica: se viene posta in essere da un soggetto passivo; se
Fisco e Tributi Imponibile IVA nella cessione di aree Premessa I requisiti affinché la cessione di una area assuma rilevanza ai fini Iva si verifica: se viene posta in essere da un soggetto passivo; se
REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF
 COMUNE DI SENNA LODIGIANA Provincia di Lodi REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29.03.2007 Modificato con deliberazione del
COMUNE DI SENNA LODIGIANA Provincia di Lodi REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29.03.2007 Modificato con deliberazione del
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
 CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
L Autorità Sanitaria competente e la procedura sanzionatoria in VENETO. SANTORSO 30 ottobre 2014
 SAV Consulenza & Marketing S.r.l L Autorità Sanitaria competente e la procedura sanzionatoria in VENETO a cura del dr. Saverio Linguanti Convegno specialistico VENEZIA 17 ottobre 2014 SANTORSO 30 ottobre
SAV Consulenza & Marketing S.r.l L Autorità Sanitaria competente e la procedura sanzionatoria in VENETO a cura del dr. Saverio Linguanti Convegno specialistico VENEZIA 17 ottobre 2014 SANTORSO 30 ottobre
CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010
 CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 14 aprile 2010 OGGETTO: Accertamenti sulle vendite immobiliari Legge Comunitaria 2008 Modifiche all articolo 54 del DPR 26 ottobre
CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 14 aprile 2010 OGGETTO: Accertamenti sulle vendite immobiliari Legge Comunitaria 2008 Modifiche all articolo 54 del DPR 26 ottobre
===============================================
 =============================================== REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione
=============================================== REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione
IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
 N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.
 Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.
Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.
Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
 RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,
RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,
Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:
 Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto
Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI
 COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI Medaglia d Argento al Merito Civile Cod. Fisc. 00827390725 ----------- ORIGINALE DELIBERAZIONE COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 4 Del 30-07-2015 OGGETTO:
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI Medaglia d Argento al Merito Civile Cod. Fisc. 00827390725 ----------- ORIGINALE DELIBERAZIONE COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 4 Del 30-07-2015 OGGETTO:
Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni
 n. 38/2000 Pag. 4729 Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni Nota del Ministero delle Finanze - (RIS) prot.
n. 38/2000 Pag. 4729 Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni Nota del Ministero delle Finanze - (RIS) prot.
COMUNE di FABRIANO. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
 COMUNE di FABRIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito
COMUNE di FABRIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF
 C O M U N E D I M O N T E S E G A L E (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 29 marzo
C O M U N E D I M O N T E S E G A L E (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 29 marzo
LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Capitolo 20 Le imposte sui consumi
 Capitolo 20 Le imposte sui consumi Le imposte generali sulle vendite e l imposta sul valore aggiunto Le imposte generali sulle vendite possono colpire l intero valore di un bene o l incremento di valore
Capitolo 20 Le imposte sui consumi Le imposte generali sulle vendite e l imposta sul valore aggiunto Le imposte generali sulle vendite possono colpire l intero valore di un bene o l incremento di valore
Il DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze
 Decreto del Ministero dell economia e delle finanze recante Disposizioni di attuazione dell articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
Decreto del Ministero dell economia e delle finanze recante Disposizioni di attuazione dell articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.
 REGOLAMENTO SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELL UTENZA E SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Approvato con Delibera di Consiglio N. 11 del 12.02.2009 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
REGOLAMENTO SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELL UTENZA E SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Approvato con Delibera di Consiglio N. 11 del 12.02.2009 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO
 RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta
RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
 Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
 RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione
RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
 COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
C O M U N E DI O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso)
 C O M U N E DI O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso) Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N /2014 del Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
C O M U N E DI O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso) Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N /2014 del Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Provincia di Venezia Piazza XXV Aprile, 1-30036 - Tel.041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273 Approvato con delibera di C.C. n. 19 del. 18.04.2013 REGOLAMENTO PER L
COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Provincia di Venezia Piazza XXV Aprile, 1-30036 - Tel.041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273 Approvato con delibera di C.C. n. 19 del. 18.04.2013 REGOLAMENTO PER L
PROGETTO: FISCO E SCUOLA A cura di:
 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Trapani PROGETTO: FISCO E SCUOLA A cura di: Dott.ssa Palmeri Gaetana Referente della formazione e del progetto Progetto Fisco e Scuola Ufficio di Trapani Si tratta di un
AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Trapani PROGETTO: FISCO E SCUOLA A cura di: Dott.ssa Palmeri Gaetana Referente della formazione e del progetto Progetto Fisco e Scuola Ufficio di Trapani Si tratta di un
Deliberazione G.C. n. / PARERI ISTRUTTORI. Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Aliquote per l anno 2007
 pag. di Deliberazione G.C. n. / SERVIZIO PROPONENTE: FINANZE PARERI ISTRUTTORI Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Aliquote per l anno 2007 Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs.
pag. di Deliberazione G.C. n. / SERVIZIO PROPONENTE: FINANZE PARERI ISTRUTTORI Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Aliquote per l anno 2007 Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs.
Comune di Udine. Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
 Comune di Udine Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA Oggetto: D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, articolo 74 "Assegno di maternità di base". Ammissione al beneficio. Nascite 2016. N. det.
Comune di Udine Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA Oggetto: D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, articolo 74 "Assegno di maternità di base". Ammissione al beneficio. Nascite 2016. N. det.
RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008
 RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata
RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata
RISOLUZIONE N. 104/E
 RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle
RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle
COMUNE DI SANGANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
 COMUNE DI SANGANO Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/11/2013 Il Regolamento è in vigore dal 01/01/2013
COMUNE DI SANGANO Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/11/2013 Il Regolamento è in vigore dal 01/01/2013
La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali
 CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali Annarita Lomonaco Ufficio Studi Consiglio Nazionale
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali Annarita Lomonaco Ufficio Studi Consiglio Nazionale
UNITÀ DIDATTICA 11 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
 UNITÀ DIDATTICA 11 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 11.1 Il concetto di Stato unitario e stato federale. Accanto ai poteri pubblici centrali vi sono altri poteri pubblici dislocati in periferia, che hanno
UNITÀ DIDATTICA 11 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 11.1 Il concetto di Stato unitario e stato federale. Accanto ai poteri pubblici centrali vi sono altri poteri pubblici dislocati in periferia, che hanno
Variazioni IMU per Equilibri di Bilancio
 Assessorato al Bilancio Finanza e Tributi Variazioni IMU per Equilibri di Bilancio Consiglio Comunale 30 Ottobre 2012 Vers. 30/10/2012 Il Fondo di Riequilibrio assegnato al Comune di Poggio a Caiano al
Assessorato al Bilancio Finanza e Tributi Variazioni IMU per Equilibri di Bilancio Consiglio Comunale 30 Ottobre 2012 Vers. 30/10/2012 Il Fondo di Riequilibrio assegnato al Comune di Poggio a Caiano al
REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF
 COMUNE DI VAL DI NIZZA Provincia di Pavia REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 in data 23.03.2007 S O M M A R I O Articolo 1 Istituzione
COMUNE DI VAL DI NIZZA Provincia di Pavia REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 in data 23.03.2007 S O M M A R I O Articolo 1 Istituzione
REGOLAMENTO Per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
 CITTÀ DI ABBIATEGRASSO Provincia di Milano SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Tributi REGOLAMENTO Per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
CITTÀ DI ABBIATEGRASSO Provincia di Milano SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Tributi REGOLAMENTO Per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico
 RISOLUZIONE 352/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico Con l istanza di interpello di cui all oggetto,
RISOLUZIONE 352/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico Con l istanza di interpello di cui all oggetto,
Il Ministro dell Economia e delle Finanze
 Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
C O M U N E DI L I M B A D I (Provincia di Vibo Valentia) *************
 C O M U N E DI L I M B A D I (Provincia di Vibo Valentia) ************* COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale N. 6 del Reg.
C O M U N E DI L I M B A D I (Provincia di Vibo Valentia) ************* COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale N. 6 del Reg.
