Ministero della Salute UFFICIO LEGISLATIVO
|
|
|
- Niccolina Rocchi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ministero della Salute UFFICIO LEGISLATIVO AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO SENATO 12 Commissione igiene e sanità 2 agosto 2012, ore 8.30 OGGETTO: Patologia diabetica in rapporto al SSN, a conclusione dell indagine conoscitiva promossa dalla Commissione sulla patologia diabetica Introduzione: Il diabete mellito (DM) comprende un gruppo di disturbi metabolici accomunati dal fatto che presentano una persistente instabilità del livello glicemico nel sangue, passando da condizioni di iperglicemia, più frequente, a condizioni di ipoglicemia. E una patologia cronica a larghissima diffusione in tutto il mondo, destinata ad aumentare nel prossimo futuro con il progressivo invecchiamento della popolazione e la sempre maggiore occorrenza delle condizioni di rischio che ne precedono l insorgenza. Il diabete è una patologia rilevante soprattutto per le numerose complicanze micro- e macrovascolari a cui i pazienti vanno incontro. Fra le complicanze microvascolari, la retinopatia diabetica rappresenta la maggiore causa di cecità fra gli adulti e la nefropatia diabetica è la principale causa di insufficienza renale cronica e dialisi. Le persone affette da diabete presentano, inoltre, un rischio più elevato di complicanze macrovascolari (malattie cerebro- e cardio-vascolari) rispetto alla popolazione non diabetica e, in generale, hanno una aspettativa di vita ridotta, qualunque sia l età di esordio della malattia. L impegno per la cura del diabete mellito deve avere come obiettivi fondamentali il mantenimento dello stato di salute fisica, psicologica e sociale del paziente. Questi obiettivi sono perseguibili e raggiungibili attraverso la prevenzione primaria, ove possibile, la diagnosi precoce, una corretta terapia che comprenda l'educazione e la responsabilizzazione del paziente, la prevenzione delle complicanze acute e croniche della malattia, responsabili del 1
2 basso livello della qualità di vita del paziente con diabete e che rappresentano le principali cause degli elevati costi economici e sociali della malattia stessa. L Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che regola e organizza l assistenza diabetologica a favore delle persone in età adulta e in età pediatrica, includendo la necessità della creazione dei servizi di diabetologia per adulti e servizi pediatrici distribuiti uniformemente nel paese. In particolare, si tratta della legge 16 marzo 1987 n. 115 che stabilisce i principi generali di assistenza, affidando alle regioni la responsabilità per l implementazione e la promozione di una assistenza uniforme e omogenea. La citata legge l Italia ha il merito di aver disciplinato il governo e l organizzazione del settore della diabetologia. La qualità organizzativa e l efficienza dell assistenza diabetologica sono correlate con un miglior controllo della malattia, con una migliore prognosi delle complicanze, ai fini di un minore tasso di mortalità collegata al diabete. Dal punto di vista della Sanità pubblica, la qualità dell assistenza e la gestione territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione fondamentale per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle complicanze e in un miglioramento della qualità di vita dei malati. Il diabete costituisce infatti il modello più rappresentativo di una patologia cronica in cui risulta essenziale la continuità tra ospedale e territorio, ovvero tra la medicina specialistica e la medicina delle cure primarie secondo un percorso assistenziale condiviso. Inoltre, vista la stretta correlazione tra eccesso ponderale e diabete di tipo 2, è necessario sviluppare sempre più politiche di prevenzione dell obesità e del sovrappeso che vedano il coinvolgimento non solo del sistema sanitario ma anche di tutti i settori della società che influiscano direttamente o indirettamente sull acquisizione e il mantenimento di stili di vita salutari, corretta nutrizione e attività fisica in particolare. Si distinguono un diabete di tipo 1 (c.d. diabete immuno-mediato, circa il 10% dei casi) e un diabete di tipo 2 (c.d. diabete non immuno-mediato o dell adulto, circa il 90% dei casi). Si tratta di due patologie fondamentalmente distinte, in quanto i due tipi di diabete si differenziano, oltre che per la diversa eziopatogenesi (distruzione autoimmune delle cellule beta del pancreas nel tipo 1, ridotta sensibilità all insulina e insulino-resistenza periferica nel tipo 2), anche per le differenti età di insorgenza (bambini-adolescenti nel tipo 1, adulti nel tipo 2), sintomatologia di esordio (acuta nel tipo 1, più sfumata e graduale nel tipo 2), strategie terapeutiche (insulina dall esordio nel tipo 1, correzione degli stili di vita e ipoglicemizzanti nel tipo 2) e, soprattutto, possibilità di prevenzione primaria. Se, infatti, il diabete di tipo 2 è in parte prevenibile modificando gli stili di vita dei soggetti a rischio, particolarmente per quel che riguarda la nutrizione e l attività fisica, il diabete di tipo 1 può essere difficilmente prevenuto, in quanto sono ancora poco chiari i fattori di rischio che interagiscono con la predisposizione genetica scatenando la reazione autoimmunitaria. I dati epidemiologici Il diabete mellito è la più diffusa malattia metabolica in Italia e nei Paesi sviluppati. Secondo l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono circa 346 milioni le persone affette da diabete in tutto il mondo e più dell 80% delle morti correlate a questa patologia avvengono in Paesi a basso e medio reddito. Già nel 2003, fra le persone di età compresa tra 20 e 79 anni, si stimava una prevalenza mondiale del 5,1%, che si prevedeva in 2
3 aumento fino al 6,3% nel 2025, con il coinvolgimento di 333 milioni di persone in tutto il mondo e un incremento pari al 24% nel periodo. Dati più recenti, tuttavia, parlano di una proiezione che nel 2025 arriva al 7,3% (380 milioni). L OMS stima inoltre che i decessi per diabete sono destinati a raddoppiare tra il 2005 e il 2030 (nel 2004, i dati riferiscono di 3,4 milioni di persone scomparse a causa delle conseguenze di un alto livello di zucchero nel sangue). La mortalità nelle persone con diabete è 1,9 volte quella dei non diabetici e per le donne il rapporto sale a 2,6. nel L OMS ha stimato che il 2% del totale delle morti nel mondo fosse da attribuire al diabete (circa ), sottolineando, tuttavia, come tale contributo alla mortalità generale fosse probabilmente sottostimato, dal momento che il decesso di una persona con diabete è di solito attribuito ad una delle complicanze (cardiopatia, malattia renale, ecc.). Dall annuario Statistico 2011 risulta che il Italia il diabete è la sesta malattia cronica per diffusione, con tasso grezzo di prevalenza del 4.9% (5,0% delle donne e 4, 7 % degli uomini). Quindi si stima che circa di italiani soffrano di diabete mellito. La prevenzione primaria del diabete : prevenire soprappeso e obesità La prevenzione primaria del diabete si identifica con la prevenzione dell eccesso ponderale. È possibile tenere sotto controllo l epidemia di obesità e invertirne l andamento attraverso azioni complessive, che intervengano sui fattori sociali, economici ed ambientali degli stili di vita. Tali azioni, tuttavia, per raggiungere gli obiettivi che si propongono, non possono non prevedere il coinvolgimento attivo di settori della società esterni al Sistema sanitario. Si tratta, infatti, di un problema di Sanità pubblica la cui soluzione non può essere demandata esclusivamente al sistema sanitario, ma che necessita di interventi che siano il più possibile trasversali e intersettoriali, con il coinvolgimento di molti altri soggetti istituzionali e della società civile (Ministeri, Comuni, Province, Associazioni Professionali e di categoria, Associazioni dei consumatori, produttori di alimenti, pubblicitari, mass media, ecc.) così come raccomandato dall Unione Europea (UE) e dall Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La Sanità pubblica, pertanto, deve affrontare il tema del soprappeso e dell obesità attraverso la definizione di una strategia globale, tenendo conto di alcuni elementi fondamentali: a. la prevenzione dell obesità non può essere di competenza esclusiva del Sistema sanitario, ma deve essere espressione di uno specifico impegno di tutte le Istituzioni; b. gli interventi da attuare devono essere finalizzati ad un cambiamento socio-culturale, perché l obesità e le malattie ad essa correlate sono problemi di salute, ma gli interventi utili alla loro soluzione sono da attuarsi, nella larga maggioranza dei casi, al di fuori del mondo sanitario; c. è necessario elaborare programmi di azione che impegnino gli stakeholder in interventi di documentata efficacia, coinvolgendo tutti i soggetti della Società civile (Istituzioni pubbliche, Associazioni di cittadini e consumatori, produttori, distributori e rivenditori di beni di consumo, mondo dello sport, pubblicitari, ecc.) in un processo di cambiamento; d. i decisori istituzionali e gli operatori di Sanità pubblica devono farsi promotori di un azione di advocacy in favore della salute in tutti i settori della società civile. Le politiche intersettoriali per la prevenzione dell obesità devono avere pertanto due obiettivi: 1. creare le condizioni per favorire scelte alimentari nutrizionalmente corrette; 3
4 2. orientare le politiche per uno sviluppo dell ambiente urbano che incoraggi l attività fisica. La prevenzione secondaria e terziaria del diabete : prevenire evoluzione e complicanze La prevenzione secondaria e quella terziaria del diabete si identificano con la diagnosi precoce e con l adeguata gestione della patologia da parte del paziente e del team diabetologico. Riguardo all assistenza delle persone con diabete in Italia, la citata legge n. 115 del 1987 ha previsto l accentramento dell assistenza diabetologica nei Servizi di Diabetologia (SD). Nel rispetto della legge n.115, in Italia è presente una rete dei suddetti Servizi di significativa rilevanza per capillarità di diffusione e organizzazione; si stima che almeno il 70% dei diabetici sia seguito continuativamente da tali servizi. Va comunque posta l attenzione sulla continuità assistenziale collegata ai nuovi modelli assistenziali, come il disease management, il case management e il crhonic care model, che, con un termine molto generale, si possono definire di Gestione Integrata. Questi approcci sono accomunati dal fatto di essere sistemi organizzati, integrati, proattivi, orientati alla popolazione, che pongono al centro dell intero sistema un paziente informato ed educato a giocare un ruolo attivo nella gestione della patologia da cui è affetto. La Gestione Integrata, infatti, attraverso la costruzione di percorsi assistenziali condivisi, si pone attualmente come prototipo di modello organizzativo mirato al miglioramento dell assistenza e alla prevenzione delle complicanze. Linee di attività del Ministero della salute 1 Verifica dello stato di attuazione della legge 115/87 a livello regionale. 2 Istituzione, nel 2003, presso il Ministero della salute della Commissione Nazionale permanente sulla Malattia Diabetica, a cui si è data la connotazione non solo di una task force multidisciplinare e multifunzionale ma soprattutto di una forte alleanza strategica fra Regioni, Associazioni dei pazienti, Società scientifiche e Istituzioni. La Commissione ha l obiettivo di valutare, insieme alle Regioni, le iniziative e i modelli assistenziali adottati nelle diverse realtà locali, di proporre interventi a favore del soggetto diabetico e delle fasce di popolazione a rischio e di definire un Piano Nazionale per la Malattia Diabetica, mirato a migliorare l'assistenza ai diabetici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche e organizzative, e nel rispetto dell autonomia regionale. 3 Attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e progetti CCM. Nella riunione del 29 aprile della Conferenza Stato-Regioni è stata sottoscritta l'intesa sul Piano Nazionale della Prevenzione Tale Piano, distingue, come macro-aree di intervento: a) la medicina predittiva, che si rivolge agli individui sani, ricercando la fragilità o il difetto che conferisce loro una certa predisposizione a sviluppare una malattia b) i programmi di prevenzione collettiva che mirano ad affrontare rischi diffusi nella popolazione generale, sia con l introduzione di politiche favorevoli alla salute o interventi di tipo regolatorio, sia con programmi di promozione della salute o di sanità pubblica. 4
5 c) i programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a rischio e finalizzati a impedire l insorgenza di malattie o a diagnosticare precocemente altre malattie o ancora a introdurre nella pratica clinica la valutazione del rischio individuale e interventi successivi di counselling o di diagnosi precoce e trattamento clinico. 4. Predisposizione e attuazione, attraverso il CCM e in collaborazione con l'istituto Superiore di Sanità (ISS), del progetto IGEA (Integrazione, Gestione e Assistenza per la malattia diabetica) che prevede il coordinamento e il supporto ai progetti regionali del PNP con l'obiettivo di favorire l attuazione di programmi di gestione integrata attraverso lo sviluppo degli strumenti necessari a tale scopo. Valorizzazione della spesa per i ricoveri ospedalieri e day hospital Dalla fonte dei dati costituita dal flusso ministeriale delle Schede di Dimissione Ospedaliere (SDO), emerge che la valorizzazione complessiva per il 2009 dei ricoveri ospedalieri in regime ordinario con diagnosi principale di diabete è pari a Le diagnosi con la maggiore valorizzazione risultano essere il diabete con complicanze periferiche e il diabete mellito senza menzione di complicanze. Il diabete con complicanze circolatorie periferiche presenta la maggiore valorizzazione media per ricovero, pari a La valorizzazione media a livello italiano di un generico ricovero risulta pari a Pertanto, osservando la degenza media si ha un valore medio italiano pari a 8,83 giorni con la media di degenza più elevata per il diabete con complicanze circolatorie periferiche (11, 32 giorni). Invece, la valorizzazione per ricoveri ospedalieri a livello regionale mostra una valorizzazione per paziente diabetico a livello italiano pari a 44,10 con forti variabilità regionali. Tra le regioni italiane con i valori maggiori abbiamo le due provincie autonome di Trento e Bolzano, mentre quelle con i valori più bassi risultano essere la valle d Aosta e la Toscana. La regione con una media di giorni di degenza maggiore è il Piemonte, con 13,44 giorni, viceversa la regione con il minor numero medio di giorni di degenza è l Umbria. Inoltre, per quanto riguarda la valorizzazione media per ricovero la regione più parsimoniosa risulta essere l Umbria con ( - 27, 4% rispetto al valore nazionale) e la regione con la valorizzazione media per ricovero più alta è il Piemonte con ( +49,2%). Nel 2009 la valorizzazione complessiva degli accessi ospedalieri in day hospital con diagnosi principale di diabete è pari a Il diabete con complicanze circolatorie periferiche ha anche la maggior valorizzazione media per accesso, pari a La media a livello italiano di un generico accesso risulta pari a 389. Dati di spesa e consumi per le terapie farmacologiche Secondo il rapporto OsMED L uso dei farmaci in Italia - Rapporto nazionale anno 2011 i farmaci antidiabetici costituiscono la seconda classe, dopo gli inibitori di pompa protonica, a maggiore spesa nell ambito dei farmaci per l apparato gastrointestinale e metabolismo. Nel 2011, a livello territoriale, sono state consumate ogni mille abitanti 53, 3 dosi di farmaci antidiabetici. Dal 2003 i consumi sono aumentati mediamente ogni anno dell 1,9%, mentre si registra rispetto all anno 2010 una riduzione del 2,3,% ( nel 2010 i consumi erano pari a 54,6 DDD/1000 ab. Die). 5
6 La spesa a carico del SSN per i farmaci antidiabetici distribuiti a livello territoriale è stata pari a 9, 36 euro procapite, equivalente ad una spesa complessiva di circa 567 milioni di euro. Considerando che nel 2011 la spesa procapite territoriale lorda è stata pari a 204, 3, la spesa per i farmaci antidiabetici rappresenta il 4, 6% della spesa farmaceutica territoriale. Tale percentuale nel 2007 era pari a 3, 7 %. Prospettive future Il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione volta a affrontare l'epidemia di diabete nell UE. Considerando la situazione epidemiologica del diabete in Europa, la risoluzione, pur non comportando obblighi giuridici diretti, invita: La Commissione europea a elaborare e attuare una strategia mirata dell'ue sul diabete, sotto forma di una raccomandazione del Consiglio dell'unione europea sulla prevenzione, la diagnosi e la gestione del diabete nonché sull'informazione e la ricerca in proposito; a elaborare criteri e metodi comuni standardizzati per la raccolta di dati sul diabete nonché a coordinare, raccogliere, registrare, controllare e gestire, in collaborazione con gli Stati membri, dati epidemiologici esaustivi sul diabete e dati economici sui costi diretti e indiretti della prevenzione e del trattamento di questa malattia; a sostenere gli Stati membri promuovendo lo scambio delle migliori prassi relativamente ai piani nazionali sul diabete, sottolineando la necessità che la Commissione segua costantemente i progressi realizzati per quanto riguarda l'attuazione, da parte degli Stati membri, dei piani nazionali sul diabete e ne illustri ogni tre anni i risultati in una sua relazione; Gli Stati membri a sviluppare, attuare e monitorare piani nazionali sul diabete finalizzati alla promozione della salute, alla riduzione dei fattori di rischio, alla previsione, alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento del diabete, destinati sia alla popolazione in generale sia alle categorie ad alto rischio in particolare, che puntino anche a ridurre le disparità e a utilizzare in modo ottimale le risorse sanitarie; a promuovere la prevenzione del diabete di tipo 2 e dell'obesità (raccomandando strategie da attuare già in età precoce attraverso l'educazione a un'alimentazione sana e l'attività fisica nelle scuole), unitamente a strategie concernenti stili di vita sani (che includano un approccio basato sull'alimentazione e un approccio incentrato sull'esercizio fisico) e alla diagnosi precoce, quali settori d'azione prioritari dei rispettivi piani nazionali sul diabete; a mettere a punto programmi per la gestione delle malattie basati sulle prassi di eccellenza e su orientamenti terapeutici che poggino su dati concreti; a garantire che i pazienti abbiano costantemente accesso, nelle cure primarie e secondarie, a equipe interdisciplinari altamente qualificate, nonché ai 6
7 trattamenti e alle tecnologie legati al diabete, incluse le tecnologie connesse ai servizi elettronici in campo sanitario (e-health), e ad aiutare i pazienti a ottenere e mantenere le capacità e le conoscenze necessarie per essere in grado di gestire quotidianamente la malattia in modo competente e autonomo; La Commissione e gli Stati membri a migliorare il coordinamento delle attività di ricerca europee sul diabete incoraggiando la collaborazione interdisciplinare e creando infrastrutture generali comuni atte ad agevolare l'attività di ricerca europea sul diabete, anche per quanto concerne l'identificazione dei fattori di rischio e la prevenzione; a garantire un sostegno costante al finanziamento della ricerca sul diabete nel contesto dell'attuale e del futuro programma quadro dell'ue in materia di ricerca e sviluppo, considerando il diabete di tipo 1 e di tipo 2 come due malattie distinte; a garantire un seguito opportuno e adeguato ai risultati del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili svoltosi nel settembre Nel prossimo futuro, pertanto, il Ministero della salute, anche dando seguito alla risoluzione dell UE, dovrà, in particolare: procedere all approvazione di un Piano Nazionale Diabete, (su cui già lavora la Commissione Nazionale permanente sulla Malattia Diabetica) ; impegnarsi sempre di più in strategie di prevenzione primaria a carattere intersettoriale; valorizzare la continuità assistenziale in un ottica di Gestione Integrata della patologia diabetica e, più in generale, della cronicità. GR 1 agosto
Diabete e prediabete :attualità e prospettive nel SSN. Annunziata Lapolla DPT di Medicina Università di Padova
 Diabete e prediabete :attualità e prospettive nel SSN Annunziata Lapolla DPT di Medicina Università di Padova L EPIDEMIA DEL DIABETE (WHO) Incremento della prevalenza del diabete Le cause: - Aumento dei
Diabete e prediabete :attualità e prospettive nel SSN Annunziata Lapolla DPT di Medicina Università di Padova L EPIDEMIA DEL DIABETE (WHO) Incremento della prevalenza del diabete Le cause: - Aumento dei
La prevenzione del sovrappeso e dell obesità nel PSR e nel PRP. Roberto Carloni
 La prevenzione del sovrappeso e dell obesità nel PSR e nel PRP Roberto Carloni OBESITA E SOVRAPPESO: UN EMERGENZA PER LA SALUTE PUBBLICA DATI WHO In Europa, come nel resto del mondo, l obesità è in netto
La prevenzione del sovrappeso e dell obesità nel PSR e nel PRP Roberto Carloni OBESITA E SOVRAPPESO: UN EMERGENZA PER LA SALUTE PUBBLICA DATI WHO In Europa, come nel resto del mondo, l obesità è in netto
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita
 Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
Il ruolo attivo del distretto per la prevenzione ed i buoni stili di vita L importanza di un corretto stile di vita per il trattamento del paziente diabetico Giuseppina Floriddia Prevalenza di diabete
Uso dei farmaci nel paziente diabetico
 PREVENIRE LE COMPLICANZE DEL DIABETE: DALLA RICERCA DI BASE ALL ASSISTENZA ASSISTENZA Uso dei farmaci nel paziente diabetico Giampiero Mazzaglia Agenzia Regionale di Sanità Toscana & Società Italiana di
PREVENIRE LE COMPLICANZE DEL DIABETE: DALLA RICERCA DI BASE ALL ASSISTENZA ASSISTENZA Uso dei farmaci nel paziente diabetico Giampiero Mazzaglia Agenzia Regionale di Sanità Toscana & Società Italiana di
III Convegno Prevenire le complicanze del diabete: dalla ricerca di base all assistenza. Il Progetto IGEA
 III Convegno Prevenire le complicanze del diabete: dalla ricerca di base all assistenza Il Progetto IGEA Marina Maggini Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute Istituto
III Convegno Prevenire le complicanze del diabete: dalla ricerca di base all assistenza Il Progetto IGEA Marina Maggini Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute Istituto
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SISTEMI DI SORVEGLIANZA
 PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SISTEMI DI SORVEGLIANZA Dott. Maurizio Castelli Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL della Valle d Aosta Aosta 26 ottobre 2016 Gli stili di vita non salutari determinano
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SISTEMI DI SORVEGLIANZA Dott. Maurizio Castelli Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL della Valle d Aosta Aosta 26 ottobre 2016 Gli stili di vita non salutari determinano
ALCUNI DATI SULLE PATOLOGIE CRONICHE. Fonti: Elaborazioni da OMS, Istat, Sic Sanità in cifre
 ALCUNI DATI SULLE PATOLOGIE CRONICHE Fonti: Elaborazioni da OMS, Istat, Sic Sanità in cifre LE MALATTIE CARDIO VASCOLARI Le malattie cardiovascolari ogni anno provocano oltre 17 milioni di decessi (7,2
ALCUNI DATI SULLE PATOLOGIE CRONICHE Fonti: Elaborazioni da OMS, Istat, Sic Sanità in cifre LE MALATTIE CARDIO VASCOLARI Le malattie cardiovascolari ogni anno provocano oltre 17 milioni di decessi (7,2
il contesto epidemiologico in Emilia Romagna
 L applicazione del Piano sulla Malattia Diabetica nella Regione Emilia Romagna seconda edizione il contesto epidemiologico in Emilia Romagna Lucia Nobilio Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Prevalenza
L applicazione del Piano sulla Malattia Diabetica nella Regione Emilia Romagna seconda edizione il contesto epidemiologico in Emilia Romagna Lucia Nobilio Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Prevalenza
Lazio: la Regione con meno giovani consumatori a rischio di alcolici
 COMUNICATO STAMPA ROMA, 30 MARZO 2015 Lazio: la Regione con meno giovani consumatori a rischio di alcolici Ma è la Regione con più fumatori Il Lazio è la Regione in cui vivono meno giovani con consumi
COMUNICATO STAMPA ROMA, 30 MARZO 2015 Lazio: la Regione con meno giovani consumatori a rischio di alcolici Ma è la Regione con più fumatori Il Lazio è la Regione in cui vivono meno giovani con consumi
IGEA - Integrazione, Gestione E Assistenza per la malattia diabetica Piano di attività biennale
 IGEA - Integrazione, Gestione E Assistenza per la malattia diabetica Piano di attività biennale Responsabile Scientifico: Marina Maggini CNESPS Istituto Superiore di Sanità ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA
IGEA - Integrazione, Gestione E Assistenza per la malattia diabetica Piano di attività biennale Responsabile Scientifico: Marina Maggini CNESPS Istituto Superiore di Sanità ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA
Il PDTA Clinico - Assistenziale Paziente Diabetico. V i n c e n z o O r s a t t i R o s a Borgia P a s q u a l e F a l a s c a A s l 2 Abruzzo
 RIORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE IN RETE Il PDTA Clinico - Assistenziale Paziente Diabetico V i n c e n z o O r s a t t i R o s a Borgia P a s q u a l e F a l a s c a A s l 2 Abruzzo Significativo
RIORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE IN RETE Il PDTA Clinico - Assistenziale Paziente Diabetico V i n c e n z o O r s a t t i R o s a Borgia P a s q u a l e F a l a s c a A s l 2 Abruzzo Significativo
Progetto per l implementazione di un assistenza sanitaria preventiva a livello locale: la Sanità d iniziativa in Regione Toscana
 Progetto per l implementazione di un assistenza sanitaria preventiva a livello locale: la Sanità d iniziativa in Regione Toscana Valentina Barletta Osservatorio di Epidemiologia valentina.barletta@ars.toscana.it
Progetto per l implementazione di un assistenza sanitaria preventiva a livello locale: la Sanità d iniziativa in Regione Toscana Valentina Barletta Osservatorio di Epidemiologia valentina.barletta@ars.toscana.it
Nedo Mennuti : Direttore Rete Territoriale ASL 11 Empoli
 Nedo Mennuti : Direttore Rete Territoriale ASL 11 Empoli 1 Il nuovo welfare Empoli 15 Giugno 2012 Nedo Mennuti : Direttore Rete Territoriale ASL 11 Empoli 2 Transizione epidemiologica - Italia - 1890-1997
Nedo Mennuti : Direttore Rete Territoriale ASL 11 Empoli 1 Il nuovo welfare Empoli 15 Giugno 2012 Nedo Mennuti : Direttore Rete Territoriale ASL 11 Empoli 2 Transizione epidemiologica - Italia - 1890-1997
Lo Studio QUADRI. Castelfranco Veneto, 13 dicembre 2004 Il diabete nel Veneto: dalla conoscenza del problema al miglioramento dell assistenza
 Castelfranco Veneto, 13 dicembre 2004 Il diabete nel Veneto: dalla conoscenza del problema al miglioramento dell assistenza Lo Studio QUADRI Federica Michieletto Servizio sanità pubblica Direzione per
Castelfranco Veneto, 13 dicembre 2004 Il diabete nel Veneto: dalla conoscenza del problema al miglioramento dell assistenza Lo Studio QUADRI Federica Michieletto Servizio sanità pubblica Direzione per
I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO. Dott.G.GIORDANO
 I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO Dott.G.GIORDANO PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE SUPERAMENTO DI UNA ASSISTENZA A COMPARTIMENTI STAGNI VISIONE SISTEMICA DELL ASSISTENZA FONDAMENTALE NELLE PATOLOGIE
I PDTA RUOLO DEL DIABETOLOGO Dott.G.GIORDANO PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE SUPERAMENTO DI UNA ASSISTENZA A COMPARTIMENTI STAGNI VISIONE SISTEMICA DELL ASSISTENZA FONDAMENTALE NELLE PATOLOGIE
Presentazione del Protocollo di intesa per la valorizzazione dei farmacisti e delle farmacie territoriali nell educazione terapeutica
 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITA SPERIMENTALI E MALATTIE RARE U.O. Comunicazione viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030/3838315 Fax 030/3838280 E-mail: comunicazione@aslbrescia.it CONFERENZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITA SPERIMENTALI E MALATTIE RARE U.O. Comunicazione viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030/3838315 Fax 030/3838280 E-mail: comunicazione@aslbrescia.it CONFERENZA
La Relazione sullo Stato di salute della Popolazione: uno strumento per la programmazione sanitaria. Valeria Fano
 Malattie croniche e telemedicina - 29 Novembre 2013 La Relazione sullo Stato di salute della Popolazione: uno strumento per la programmazione sanitaria Valeria Fano UOC Programmazione, Sistemi Informativi
Malattie croniche e telemedicina - 29 Novembre 2013 La Relazione sullo Stato di salute della Popolazione: uno strumento per la programmazione sanitaria Valeria Fano UOC Programmazione, Sistemi Informativi
LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO. Anna Caparra
 LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO Anna Caparra OSAS LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO e una condizione morbosa caratterizzata da episodi ricorrenti di ostruzione completa (apnea)
LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO Anna Caparra OSAS LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO e una condizione morbosa caratterizzata da episodi ricorrenti di ostruzione completa (apnea)
A cura del Gruppo di studio AMD Psicologia e Diabete. Obesità e diabete Scacco matto in 10 mosse
 A cura del Gruppo di studio AMD Psicologia e Diabete Obesità e diabete Scacco matto in 10 mosse Obesità e Diabete: Scacco matto in 10 mosse Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 e il Piano sulla Malattia
A cura del Gruppo di studio AMD Psicologia e Diabete Obesità e diabete Scacco matto in 10 mosse Obesità e Diabete: Scacco matto in 10 mosse Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 e il Piano sulla Malattia
IL DIABETE GIORNATA DI LAVORO SUL PERCORSO INTEGRATO TERRITORIO-OSPEDALE 6 GIUGNO 2011 organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ e ASL Roma G Dott.
 IL DIABETE GIORNATA DI LAVORO SUL PERCORSO INTEGRATO TERRITORIO-OSPEDALE 6 GIUGNO 2011 organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ e ASL Roma G Dott. V. Calzini MMG Il diabete nell ambulatorio del medico
IL DIABETE GIORNATA DI LAVORO SUL PERCORSO INTEGRATO TERRITORIO-OSPEDALE 6 GIUGNO 2011 organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ e ASL Roma G Dott. V. Calzini MMG Il diabete nell ambulatorio del medico
La situazione attuale
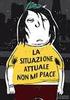 Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
Convegno Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica ed operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell obesità e del diabete mellito Ministero della Salute 27 settembre 2011 Auditorium Biagio
L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo
 L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo Rosangela Ghidelli Coordinatore Infermieristico Caposala U.O. S. Diabetologia e Endocrinologia Azienda Ospedaliera S. Anna Como Presidio
L infermiere punto d unione tra il Paziente, il MMG ed il Diabetologo Rosangela Ghidelli Coordinatore Infermieristico Caposala U.O. S. Diabetologia e Endocrinologia Azienda Ospedaliera S. Anna Como Presidio
Emanuela Bedeschi Responsabile Servizio Sanita' Pubblica Direzione Generale Sanita' e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna
 Le malattie croniche determinano la parte preponderante del carico di morti premature e di disabilità, incidendo pesantemente sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Le persone in posizione di disagio
Le malattie croniche determinano la parte preponderante del carico di morti premature e di disabilità, incidendo pesantemente sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Le persone in posizione di disagio
Dolcemente... pericoloso: il diabete.
 OBIETTIVO PREVENZIONE PER IL TUO CUORE, COL CUORE IN MANO Milano, 24 maggio 2017 Dolcemente... pericoloso: il diabete. Dott. Olga Eugenia Disoteo - Dott. Emanuele Spreafico ASST Grande Ospedale Metropolitano
OBIETTIVO PREVENZIONE PER IL TUO CUORE, COL CUORE IN MANO Milano, 24 maggio 2017 Dolcemente... pericoloso: il diabete. Dott. Olga Eugenia Disoteo - Dott. Emanuele Spreafico ASST Grande Ospedale Metropolitano
2.L assistenza pediatrica ospedaliera
 2.L assistenza pediatrica ospedaliera Prof.ssa Maria Pia Fantini Dott.ssa Lorenza Luciano Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Alma Mater Studiorum Università di Bologna Percorso di aggiornamento
2.L assistenza pediatrica ospedaliera Prof.ssa Maria Pia Fantini Dott.ssa Lorenza Luciano Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Alma Mater Studiorum Università di Bologna Percorso di aggiornamento
CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO
 Promuovere il Patient Engagement nei processi di cura grazie a prove di efficacia e misure di impatto - CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dr.ssa Valeria Mastrilli
Promuovere il Patient Engagement nei processi di cura grazie a prove di efficacia e misure di impatto - CONSENSUS CONFERENCE 15 GIUGNO 2016 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dr.ssa Valeria Mastrilli
Ambulatorio Infermieristico Telemedicina
 Ambulatorio Infermieristico Telemedicina Dott. Orsatti Vincenzo Direttore N.O.D. Distretto n. 1 ASL 2 Abruzzo Dott. Falasca Pasquale Responsabile U.O. Integrazione Ospedale Territorio ASL 2 Abruzzo IL
Ambulatorio Infermieristico Telemedicina Dott. Orsatti Vincenzo Direttore N.O.D. Distretto n. 1 ASL 2 Abruzzo Dott. Falasca Pasquale Responsabile U.O. Integrazione Ospedale Territorio ASL 2 Abruzzo IL
CORSO DI IGIENE LIVELLI DI PREVENZIONE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE SEZIONE DI IGIENE CORSO DI IGIENE LIVELLI DI PREVENZIONE Docente: Prof.ssa Marisa Arpesella Anno Accademico:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE SEZIONE DI IGIENE CORSO DI IGIENE LIVELLI DI PREVENZIONE Docente: Prof.ssa Marisa Arpesella Anno Accademico:
ALLEGATO A. Raccomandazioni per la realizzazione di un programma di Antibiotic Stewardship in ospedale
 ALLEGATO A Raccomandazioni per la realizzazione di un programma di Antibiotic Stewardship in ospedale Premessa In Toscana, negli ospedali durante il 2014 sono stati consumati 88,9 DDD di antibiotici per
ALLEGATO A Raccomandazioni per la realizzazione di un programma di Antibiotic Stewardship in ospedale Premessa In Toscana, negli ospedali durante il 2014 sono stati consumati 88,9 DDD di antibiotici per
Le cure palliative in Italia: un quadro della situazione attuale
 Le cure palliative in Italia: un quadro della situazione attuale 11 novembre 2015, ore 13 Sala Caduti di Nassirya Senato della Repubblica Italo Penco Direttore sanitario Fondazione Roma Sanità OMS: i bisogni
Le cure palliative in Italia: un quadro della situazione attuale 11 novembre 2015, ore 13 Sala Caduti di Nassirya Senato della Repubblica Italo Penco Direttore sanitario Fondazione Roma Sanità OMS: i bisogni
Spesa per presidi e accessibilità delle cure: le differenze regionali. Alessandro Ozzello Gruppo Governo Clinico e HTA
 Spesa per presidi e accessibilità delle cure: le differenze regionali Alessandro Ozzello Gruppo Governo Clinico e HTA Il sottoscritto OZZELLO ALESSANDRO ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi,
Spesa per presidi e accessibilità delle cure: le differenze regionali Alessandro Ozzello Gruppo Governo Clinico e HTA Il sottoscritto OZZELLO ALESSANDRO ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi,
Atlante della salute nelle Regioni italiane La migliore (e la peggiore) performance
 Rapporto Osservasalute 2012 Atlante della salute nelle Regioni italiane La migliore (e la peggiore) performance Piemonte La Regione con la quota più alta di ricoveri con degenza di un solo giorno Ma è
Rapporto Osservasalute 2012 Atlante della salute nelle Regioni italiane La migliore (e la peggiore) performance Piemonte La Regione con la quota più alta di ricoveri con degenza di un solo giorno Ma è
SALUTE E PARTECIPAZIONE Il piano regionale sulla malattia diabetica. Nera Agabiti
 SALUTE E PARTECIPAZIONE Il piano regionale sulla malattia diabetica Nera Agabiti 31 marzo 2016 MISURARE IL CAMBIAMENTO ESITI SALUTE ed EQUITA LEGGE 189/2012 [ ] ciascuna regione promuove un sistema di
SALUTE E PARTECIPAZIONE Il piano regionale sulla malattia diabetica Nera Agabiti 31 marzo 2016 MISURARE IL CAMBIAMENTO ESITI SALUTE ed EQUITA LEGGE 189/2012 [ ] ciascuna regione promuove un sistema di
I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA
 Roma, Istituto Superiore di Sanità, 17/11/2006 Il Diabete in Italia Aspetti Epidemiologici e Modelli Assistenziali I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA Roberto Sivieri Logica del Progetto (1/2)
Roma, Istituto Superiore di Sanità, 17/11/2006 Il Diabete in Italia Aspetti Epidemiologici e Modelli Assistenziali I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA Roberto Sivieri Logica del Progetto (1/2)
Regione Lazio. Vincenzo Romano Spica. Unità di Sanità Pubblica Università degli Studi di Roma «Foro Italico»
 Regione Lazio Vincenzo Romano Spica Unità di Sanità Pubblica Università degli Studi di Roma «Foro Italico» Premessa La Carta di Erice Il Censimento AMPA-Centri Diabetologici Estensione al Centro-Sud e
Regione Lazio Vincenzo Romano Spica Unità di Sanità Pubblica Università degli Studi di Roma «Foro Italico» Premessa La Carta di Erice Il Censimento AMPA-Centri Diabetologici Estensione al Centro-Sud e
INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI. Il diabete mellito di tipo 2, rappresenta il 95% dei casi di diabete, è più
 INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI Il diabete mellito di tipo 2, rappresenta il 95% dei casi di diabete, è più frequente nei pazienti di età superiore a 30 anni, ma può comparire anche nei bambini e negli
INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI Il diabete mellito di tipo 2, rappresenta il 95% dei casi di diabete, è più frequente nei pazienti di età superiore a 30 anni, ma può comparire anche nei bambini e negli
Sovrappeso e obesità nell ASL 1 Belluno I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2011 e OKKIO 2010
 Sovrappeso e obesità nell ASL 1 Belluno I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2011 e OKKIO 2010 Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia Qual è lo stato nutrizionale nella popolazione
Sovrappeso e obesità nell ASL 1 Belluno I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2011 e OKKIO 2010 Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia Qual è lo stato nutrizionale nella popolazione
Sorveglianza delle malattie croniche e dei comportamenti a rischio
 Sorveglianza delle malattie croniche e dei comportamenti a rischio Le malattie croniche sono la causa principale di morte nel mondo Secondo il rapporto Oms, circa 17 milioni di persone muoiono prematuramente
Sorveglianza delle malattie croniche e dei comportamenti a rischio Le malattie croniche sono la causa principale di morte nel mondo Secondo il rapporto Oms, circa 17 milioni di persone muoiono prematuramente
DIPARTIMENTO CARDIOCIRCOLATORIO IPERTENSIONE - ARITMIA
 CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE III CONGRESSO NAZIONALE IL DIRITTO ALLA SALUTE: UN DIRITTO INALIENABILE CRITICITA A CONFRONTO COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE DIPARTIMENTO CARDIOCIRCOLATORIO
CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE III CONGRESSO NAZIONALE IL DIRITTO ALLA SALUTE: UN DIRITTO INALIENABILE CRITICITA A CONFRONTO COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE DIPARTIMENTO CARDIOCIRCOLATORIO
Ministero della Salute
 Ministero della Salute Relazione sullo stato sanitario del Paese 2003-2004 2004 Carlo Donati Direzione Generale del Sistema Informativo Ministero della Salute Roma Basi normative della Relazione La Relazione
Ministero della Salute Relazione sullo stato sanitario del Paese 2003-2004 2004 Carlo Donati Direzione Generale del Sistema Informativo Ministero della Salute Roma Basi normative della Relazione La Relazione
Percorso assistenziale al bambino con eccesso ponderale: un programma di educazione ai corretti stili alimentari e motori
 Percorso assistenziale al bambino con eccesso ponderale: un programma di educazione ai corretti stili alimentari e motori del Fare bambino clic per e modificare dell adolescente lo stile del nell ambulatorio
Percorso assistenziale al bambino con eccesso ponderale: un programma di educazione ai corretti stili alimentari e motori del Fare bambino clic per e modificare dell adolescente lo stile del nell ambulatorio
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE (*)
 DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE (*) La legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore * Legge numero
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE (*) La legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore * Legge numero
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
 SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3507 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CARRARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2005 Modifiche alla legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3507 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CARRARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2005 Modifiche alla legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni
Dimensioni del problema, criticità, costi. Modelli organizzativi gestionali
 Rosario Iannacchero Dimensioni del problema, criticità, costi Modelli organizzativi gestionali Patologia molto frequente nella popolazione generale Solo emicrania: prevalenza media annua stimata negli
Rosario Iannacchero Dimensioni del problema, criticità, costi Modelli organizzativi gestionali Patologia molto frequente nella popolazione generale Solo emicrania: prevalenza media annua stimata negli
L INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PER LA CONTINUITA ASSITENZIALE DELLA PERSONA FRAGILE
 L INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PER LA CONTINUITA ASSITENZIALE DELLA PERSONA FRAGILE L ospedale e il territorio: opportunità e criticità nell integrazione socio-sanitaria Francesca Busa Direttore Distretto
L INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PER LA CONTINUITA ASSITENZIALE DELLA PERSONA FRAGILE L ospedale e il territorio: opportunità e criticità nell integrazione socio-sanitaria Francesca Busa Direttore Distretto
I dati dei sistemi di sorveglianza su sovrappeso, alimentazione, attività fisica
 La prevenzione del sovrappeso e dell obesità come strumento per la prevenzione del diabete e delle malattie croniche Genova 15 dicembre 2011 I dati dei sistemi di sorveglianza su sovrappeso, alimentazione,
La prevenzione del sovrappeso e dell obesità come strumento per la prevenzione del diabete e delle malattie croniche Genova 15 dicembre 2011 I dati dei sistemi di sorveglianza su sovrappeso, alimentazione,
Informazioni da AGD Grosseto
 All. A alla delibera 807 - Regione Toscana - del 1/8/2005 - Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (Intesa Stato Regioni, Province Autonome - 23 marzo 2005). Interventi prioritari per l'anno 2005.
All. A alla delibera 807 - Regione Toscana - del 1/8/2005 - Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (Intesa Stato Regioni, Province Autonome - 23 marzo 2005). Interventi prioritari per l'anno 2005.
La Promozione della salute nei luoghi di lavoro
 La Promozione della salute nei luoghi di lavoro Modena 6 marzo 2014 Adriana Giannini I determinanti della salute Dahlgren G and Whitehead M (1991) La Promozione della salute Processo che mette in grado
La Promozione della salute nei luoghi di lavoro Modena 6 marzo 2014 Adriana Giannini I determinanti della salute Dahlgren G and Whitehead M (1991) La Promozione della salute Processo che mette in grado
Il paziente con multimorbilità: il punto di vista del MMG. Dott. David Coletta - Empoli
 Il paziente con multimorbilità: il punto di vista del MMG Dott. David Coletta - Empoli Il cambiamento di paradigma I bisogni di salute della popolazione e lo stato di benessere percepito hanno subito un
Il paziente con multimorbilità: il punto di vista del MMG Dott. David Coletta - Empoli Il cambiamento di paradigma I bisogni di salute della popolazione e lo stato di benessere percepito hanno subito un
Stato nutrizionale e abitudini alimentari
 Sistema di Sorveglianza PASSI 28 Stato nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta
Sistema di Sorveglianza PASSI 28 Stato nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta
Consumo di farmaci di classe A-SSN in regime di assistenza convenzionata
 ANALISI REGIONALE DELLA SPESA E DEL CONSUMO DEI FARMACI E la Sicilia la Regione in cui si registra la quantità massima di consumi (1.110 dosi giornaliere ogni mille abitanti) e il picco massimo di spesa
ANALISI REGIONALE DELLA SPESA E DEL CONSUMO DEI FARMACI E la Sicilia la Regione in cui si registra la quantità massima di consumi (1.110 dosi giornaliere ogni mille abitanti) e il picco massimo di spesa
implementazione delle linee guida sulla Medicina Generale Indicatori e standard SIMG
 L audit come strumento di implementazione delle linee guida sulla gestione del paziente diabetico in Medicina Generale Indicatori e SIMG Modificato da: Indicatori di qualità e nell assistenza al paziente
L audit come strumento di implementazione delle linee guida sulla gestione del paziente diabetico in Medicina Generale Indicatori e SIMG Modificato da: Indicatori di qualità e nell assistenza al paziente
Le Cure Palliative erogate in Rete
 Le Cure Palliative erogate in Rete La normativa nazionale e regionale Codigoro - 29 settembre 2012 Mauro Manfredini Focus sulla Rete No Terapia del dolore No Cure Palliative Pediatriche LEGGE n. 39 26
Le Cure Palliative erogate in Rete La normativa nazionale e regionale Codigoro - 29 settembre 2012 Mauro Manfredini Focus sulla Rete No Terapia del dolore No Cure Palliative Pediatriche LEGGE n. 39 26
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE
 GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE Il concetto di salute OMS 1946: "la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 5
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E IL CONCETTO DI SALUTE Il concetto di salute OMS 1946: "la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 5
Life Tech Forum. 6 Aprile 2016
 Life Tech Forum 6 Aprile 2016 Sanità digitale L innovazione digitale dei processi sanitari è un passaggio fondamentale per migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi sanitari, limitare sprechi e
Life Tech Forum 6 Aprile 2016 Sanità digitale L innovazione digitale dei processi sanitari è un passaggio fondamentale per migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi sanitari, limitare sprechi e
Integrazione ospedale territorio: l esperienza di una Azienda Ospedaliero Universitaria e una Azienda Sanitaria Locale Romana.
 Integrazione ospedale territorio: l esperienza di una Azienda Ospedaliero Universitaria e una Azienda Sanitaria Locale Romana Assunta De Luca IL CONTESTO L aumento dell aspettativa di vita nei paesi industrializzati
Integrazione ospedale territorio: l esperienza di una Azienda Ospedaliero Universitaria e una Azienda Sanitaria Locale Romana Assunta De Luca IL CONTESTO L aumento dell aspettativa di vita nei paesi industrializzati
Sistema Epidemiologico Regionale Settore Farmaceutico Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie. Montecchio Precalcino, 30/06/2015
 Strumenti per il monitoraggio epidemiologico della qualità clinica dell assistenza al paziente diabetico nella Regione del Veneto attraverso i dati amministrativi Montecchio Precalcino, 30/06/2015 Sistema
Strumenti per il monitoraggio epidemiologico della qualità clinica dell assistenza al paziente diabetico nella Regione del Veneto attraverso i dati amministrativi Montecchio Precalcino, 30/06/2015 Sistema
Stato nutrizionale e abitudini alimentari
 Stato nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
Stato nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
PRESENTAZIONE DI DANIELA BIANCO 11^ FORUM MERIDIANO SANITÀ. Palazzo Rospigliosi - Roma
 PRESENTAZIONE DI DANIELA BIANCO AL 11^ FORUM MERIDIANO SANITÀ Palazzo Rospigliosi - Roma 15 novembre 2016 Questa documentazione costituisce la base sintetica di una presentazione, ed è incompleta senza
PRESENTAZIONE DI DANIELA BIANCO AL 11^ FORUM MERIDIANO SANITÀ Palazzo Rospigliosi - Roma 15 novembre 2016 Questa documentazione costituisce la base sintetica di una presentazione, ed è incompleta senza
PROGETTO INTERATENEO DIABETE E FARMACIA
 PROGETTO INTERATENEO DIABETE E FARMACIA Con il patrocinio di: FOFI Università degli Studi di Torino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino Federfarma Piemonte MATERIALE DIDATTICO REALIZZATO DA
PROGETTO INTERATENEO DIABETE E FARMACIA Con il patrocinio di: FOFI Università degli Studi di Torino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino Federfarma Piemonte MATERIALE DIDATTICO REALIZZATO DA
Il monitoraggio dell attività diabetologica territoriale
 Il monitoraggio dell attività diabetologica territoriale Linee operative per la pianificazione regionale sulla prevenzione delle complicanze del Diabete Piano Regionale della Prevenzione per il triennio
Il monitoraggio dell attività diabetologica territoriale Linee operative per la pianificazione regionale sulla prevenzione delle complicanze del Diabete Piano Regionale della Prevenzione per il triennio
Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto
 Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto Dott.ssa Daniela Galeone Ministero del Lavoro, della Salute e dellepolitiche Sociali Torino,
Progetto interministeriale Scuola e salute Gli accordi interministeriali, filosofia e motivazioni del progetto Dott.ssa Daniela Galeone Ministero del Lavoro, della Salute e dellepolitiche Sociali Torino,
Health Literacy nelle persone con diabete Risultati PASSI
 Health Literacy nelle persone con diabete Risultati PASSI 2012-2015 XL Congresso dell Associazione Italiana di Epidemiologia Torino, 19 21 ottobre 2016 «Le evidenze in epidemiologia: una storia lunga 40
Health Literacy nelle persone con diabete Risultati PASSI 2012-2015 XL Congresso dell Associazione Italiana di Epidemiologia Torino, 19 21 ottobre 2016 «Le evidenze in epidemiologia: una storia lunga 40
TERRITORIO OSPEDALE RESIDENZ.
 continuità posti letto appropriatezza risorse cure intermedie presidi cure primarie Sanità di iniziativa e CCM rete gestita volumi minimi mediabassa compless. osp. di giorno osp. di notte centri elevata
continuità posti letto appropriatezza risorse cure intermedie presidi cure primarie Sanità di iniziativa e CCM rete gestita volumi minimi mediabassa compless. osp. di giorno osp. di notte centri elevata
La Gestione Integrata del Diabete tipo 2
 La Gestione Integrata del Diabete tipo 2 Franco Ghini Referente Area ospedaliera Azienda USL Modena Direttore Sanitario: Andrea Guerzoni ASSISTENZA INTEGRATA... Ospedale Dietista PAZIENTE Team diabetologico
La Gestione Integrata del Diabete tipo 2 Franco Ghini Referente Area ospedaliera Azienda USL Modena Direttore Sanitario: Andrea Guerzoni ASSISTENZA INTEGRATA... Ospedale Dietista PAZIENTE Team diabetologico
Epidemiologia della Malattia Renale cronica. Strutture della Rete Nefrologica Piemontese. Attività
 Scheda Tecnica: dati 2012 Epidemiologia della Malattia Renale cronica Un recente studio della Società Italiana di Nefrologia (SIN), condotto in collaborazione con la Società Italiana di Medicina generale
Scheda Tecnica: dati 2012 Epidemiologia della Malattia Renale cronica Un recente studio della Società Italiana di Nefrologia (SIN), condotto in collaborazione con la Società Italiana di Medicina generale
Il protocollo con la UISP regionale Umbria. Strumento per una nuova alleanza nella rete
 Il protocollo con la UISP regionale Umbria Strumento per una nuova alleanza nella rete Orvieto 21 ottobre 2014 Mariadonata Giaimo Alimentazione e attività fisica degli umbri qualche dato dai sistemi di
Il protocollo con la UISP regionale Umbria Strumento per una nuova alleanza nella rete Orvieto 21 ottobre 2014 Mariadonata Giaimo Alimentazione e attività fisica degli umbri qualche dato dai sistemi di
Diabete: dalla dichiarazione di Berlino la road map per l'italia
 PHARMASTAR 30 maggio 2017 Diabete: dalla dichiarazione di Berlino la road map per l'italia Martedi 30 Maggio 2017 Pazienti, Istituzioni, specialisti diabetologi, medici di medicina generale e sanità del
PHARMASTAR 30 maggio 2017 Diabete: dalla dichiarazione di Berlino la road map per l'italia Martedi 30 Maggio 2017 Pazienti, Istituzioni, specialisti diabetologi, medici di medicina generale e sanità del
Il diabete in Italia: esperienze nell analisi di dati di popolazione. I dati del Piemonte
 Il diabete in Italia: esperienze nell analisi di dati di popolazione I dati del Piemonte Roberto Gnavi, Graziella Bruno ASL 5, Servizio Regionale di Epidemiologia Università di Torino, Dipartimento di
Il diabete in Italia: esperienze nell analisi di dati di popolazione I dati del Piemonte Roberto Gnavi, Graziella Bruno ASL 5, Servizio Regionale di Epidemiologia Università di Torino, Dipartimento di
Come considerano il proprio peso le persone intervistate?
 Situazione nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
Situazione nutrizionale e abitudini alimentari Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante
Stato nutrizionale e abitudini alimentari
 Stato nutrizionale e abitudini alimentari La situazione nutrizionale di una popolazione è un determinante importante delle sue condizioni di salute. In particolare l eccesso di peso, favorendo l insorgenza
Stato nutrizionale e abitudini alimentari La situazione nutrizionale di una popolazione è un determinante importante delle sue condizioni di salute. In particolare l eccesso di peso, favorendo l insorgenza
Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
 LEGGE 16 MARZO 1987, n. 115 (GU n. 071 del 26/03/1987) DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEL DIABETE MELLITO. 097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 053 BALIATICO 097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 004 AMMINISTRAZIONE
LEGGE 16 MARZO 1987, n. 115 (GU n. 071 del 26/03/1987) DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEL DIABETE MELLITO. 097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 053 BALIATICO 097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 004 AMMINISTRAZIONE
STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE CRONICITA SUL TERRITORIO: DOVE SIAMO E COSA MANCA. Eleonora Corsalini Roma, 27 giugno 2014
 STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE CRONICITA SUL TERRITORIO: DOVE SIAMO E COSA MANCA Eleonora Corsalini Roma, 27 giugno 2014 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO Tra il 2000 e il 2010 in UE l aspettativa di
STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE CRONICITA SUL TERRITORIO: DOVE SIAMO E COSA MANCA Eleonora Corsalini Roma, 27 giugno 2014 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO Tra il 2000 e il 2010 in UE l aspettativa di
Tubercolosi, HIV e Migrazione: una reale emergenza? Roma, 19 maggio 2011 Istituto Superiore di Sanità
 Tubercolosi, HIV e Migrazione: una reale emergenza? Roma, 19 maggio 2011 Istituto Superiore di Sanità Maria Grazia Pompa Ufficio V Malattie Infettive e Profilassi Internazionale Direzione Generale della
Tubercolosi, HIV e Migrazione: una reale emergenza? Roma, 19 maggio 2011 Istituto Superiore di Sanità Maria Grazia Pompa Ufficio V Malattie Infettive e Profilassi Internazionale Direzione Generale della
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
 PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Documento di seduta 7.3.2012 B7-0148/2012 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 110, paragrafo
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Documento di seduta 7.3.2012 B7-0148/2012 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 110, paragrafo
LEGGE SUI REGISTRI TUMORI quali prospettive
 LEGGE SUI REGISTRI TUMORI quali prospettive Dott Susanna Busco UOC Epidemiologia Registro tumori di Latina ASL -Latina Sistema di sorveglianza dello stato di salute John Snow Lavorando su una mappa della
LEGGE SUI REGISTRI TUMORI quali prospettive Dott Susanna Busco UOC Epidemiologia Registro tumori di Latina ASL -Latina Sistema di sorveglianza dello stato di salute John Snow Lavorando su una mappa della
M O N I C A B E T T O N I
 M O N I C A B E T T O N I from bench to bed Ricerca traslazionale Obiettivi - migliorare le prestazioni sanitarie - orientare politiche sanitarie - individuare strategie di prevenzione primaria - valutare
M O N I C A B E T T O N I from bench to bed Ricerca traslazionale Obiettivi - migliorare le prestazioni sanitarie - orientare politiche sanitarie - individuare strategie di prevenzione primaria - valutare
Il percorso diabetologico
 Conferenza dei Servizi dell' Azienda USL 6 di Livorno Il percorso diabetologico Dr.ssa D.Pagliacci Coordinatore Sanitario territoriale Zona Val di Cornia Castello Pasquini Castiglioncello (LI) 13.12.2010
Conferenza dei Servizi dell' Azienda USL 6 di Livorno Il percorso diabetologico Dr.ssa D.Pagliacci Coordinatore Sanitario territoriale Zona Val di Cornia Castello Pasquini Castiglioncello (LI) 13.12.2010
Ministero della Salute. GUADAGNARE SALUTE rendere facili le scelte salutari
 Ministero della Salute GUADAGNARE SALUTE rendere facili le scelte salutari GUADAGNARE SALUTE L inattività fisica, la scorretta alimentazione, il soprappeso e/o l obesità, il consumo di alcol ed il tabagismo
Ministero della Salute GUADAGNARE SALUTE rendere facili le scelte salutari GUADAGNARE SALUTE L inattività fisica, la scorretta alimentazione, il soprappeso e/o l obesità, il consumo di alcol ed il tabagismo
Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale
 Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale dott. Raffaele FABRIZIO Bologna, 20 gennaio 2010 La società regionale oggi Invecchiamento popolazione (aumento
Le strategie per la promozione della salute nell anziano del Piano Sociale e Sanitario Regionale dott. Raffaele FABRIZIO Bologna, 20 gennaio 2010 La società regionale oggi Invecchiamento popolazione (aumento
Daniela Galeone. Presentazione della STRATEGIA SULL ATTIVITÀ FISICA PER LA REGIONE EUROPEA DELL OMS
 Daniela Galeone Presentazione della STRATEGIA SULL ATTIVITÀ FISICA PER LA REGIONE EUROPEA DELL OMS 2016-2025 Roma - Camera dei Deputati 6 aprile 2016 Auletta dei gruppi parlamentari Via Campo Marzio 78
Daniela Galeone Presentazione della STRATEGIA SULL ATTIVITÀ FISICA PER LA REGIONE EUROPEA DELL OMS 2016-2025 Roma - Camera dei Deputati 6 aprile 2016 Auletta dei gruppi parlamentari Via Campo Marzio 78
Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale. Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013
 Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia
Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE
 11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE La legge 38 del 2010 La rete delle cure palliative Il CeAD Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE La legge 38 del 2010 La rete delle cure palliative Il CeAD Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010
Sovrappeso ed obesità
 62 RAPPORTO OSSERVASALUTE 2014 Sovrappeso ed obesità Significato. Il sovrappeso e l obesità sono tra i principali fattori di rischio per le patologie non trasmissibili, quali le malattie ischemiche del
62 RAPPORTO OSSERVASALUTE 2014 Sovrappeso ed obesità Significato. Il sovrappeso e l obesità sono tra i principali fattori di rischio per le patologie non trasmissibili, quali le malattie ischemiche del
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
 Numero Atti:52533 Ultima Gazzetta Ufficiale del: 26 gennaio 2016 Ultima Modifica: 27 gennaio 2016 Dettaglio atto Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento
Numero Atti:52533 Ultima Gazzetta Ufficiale del: 26 gennaio 2016 Ultima Modifica: 27 gennaio 2016 Dettaglio atto Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento
Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto: utenza, attività e personale indicatori per la valutazione Area Sanità e Sociale
 Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto: utenza, attività e personale indicatori per la valutazione 0 Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria SETTORE SALUTE MENTALE E SANITÀ
Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto: utenza, attività e personale indicatori per la valutazione 0 Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria SETTORE SALUTE MENTALE E SANITÀ
Test genetici per predire la comparsa del diabete e delle sue complicanze Sabato 11 Giugno :32
 Si chiama medicina di precisione e promette terapie ritagliate su misura del singolo paziente, evitando così farmaci inutili o dannosi e indirizzando le cure verso i trattamenti più efficaci per ogni singola
Si chiama medicina di precisione e promette terapie ritagliate su misura del singolo paziente, evitando così farmaci inutili o dannosi e indirizzando le cure verso i trattamenti più efficaci per ogni singola
Retinopatia diabetica: una lotta possibile SOCIAL MANIFESTO
 Retinopatia diabetica: una lotta possibile SOCIAL MANIFESTO 2 Retinopatia diabetica: una lotta possibile SOCIAL MANIFESTO Negli ultimi anni, sono stati realizzati diversi studi promossi da organismi di
Retinopatia diabetica: una lotta possibile SOCIAL MANIFESTO 2 Retinopatia diabetica: una lotta possibile SOCIAL MANIFESTO Negli ultimi anni, sono stati realizzati diversi studi promossi da organismi di
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3119
 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI, ANDRIA e COSTA COMUNICATO ALLA
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI, ANDRIA e COSTA COMUNICATO ALLA
IL POLICLINICO TOR VERGATA. Tiziana Frittelli 25/02/2015
 IL POLICLINICO TOR VERGATA Tiziana Frittelli 25/02/2015 Chi siamo La Fondazione PTV è stata costituita dalla Regione Lazio e dall Università di Roma-Tor Vergata in base alle previsioni del Protocollo d
IL POLICLINICO TOR VERGATA Tiziana Frittelli 25/02/2015 Chi siamo La Fondazione PTV è stata costituita dalla Regione Lazio e dall Università di Roma-Tor Vergata in base alle previsioni del Protocollo d
Stato nutrizionale e abitudini alimentari
 Stato nutrizionale e abitudini alimentari La situazione nutrizionale di una popolazione è un determinante importante delle sue condizioni di salute. In particolare l eccesso di peso, favorendo l insorgenza
Stato nutrizionale e abitudini alimentari La situazione nutrizionale di una popolazione è un determinante importante delle sue condizioni di salute. In particolare l eccesso di peso, favorendo l insorgenza
Le cure primarie nella definizione dei LEA
 Le cure primarie nella definizione dei LEA Filippo Palumbo Ministero della salute, Dipartimento della qualità Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi
Le cure primarie nella definizione dei LEA Filippo Palumbo Ministero della salute, Dipartimento della qualità Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi
Stato nutrizionale e abitudini alimentari nella ULSS n.1 Belluno
 Stato nutrizionale e abitudini alimentari nella ULSS n.1 Belluno Dati del sistema di sorveglianza Passi 21-213 Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia Lo stato nutrizionale di una popolazione
Stato nutrizionale e abitudini alimentari nella ULSS n.1 Belluno Dati del sistema di sorveglianza Passi 21-213 Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia Lo stato nutrizionale di una popolazione
Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto: utenza, attività e personale indicatori per la valutazione Area Sanità e Sociale
 Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto: utenza, attività e personale indicatori per la valutazione Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria SETTORE TUTELA SALUTE MENTALE DIPARTIMENTI
Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto: utenza, attività e personale indicatori per la valutazione Area Sanità e Sociale Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria SETTORE TUTELA SALUTE MENTALE DIPARTIMENTI
L EDUCAZIONE SINGOLA E DI GRUPPO: A CHI, QUANDO E COME
 L EDUCAZIONE SINGOLA E DI GRUPPO: A CHI, QUANDO E COME Inf. Elide Guerra Servizio di Diabetologia o.c. G.B. Morgagni - Forlì ANIMO BO 2012 Elide Guerra 1 Le evidenze più recenti confermano che migliore
L EDUCAZIONE SINGOLA E DI GRUPPO: A CHI, QUANDO E COME Inf. Elide Guerra Servizio di Diabetologia o.c. G.B. Morgagni - Forlì ANIMO BO 2012 Elide Guerra 1 Le evidenze più recenti confermano che migliore
Inaugurazione nazionale della rete della Gastroenterologia Italiana Gastroepatonet.org
 L organizzazione, in senso economico, è un sistema che elabora informazioni e risolve problemi essa si esprime Intervento a cura di Giovanna Baraldi con la capacità di trasformare le informazioni dei suoi
L organizzazione, in senso economico, è un sistema che elabora informazioni e risolve problemi essa si esprime Intervento a cura di Giovanna Baraldi con la capacità di trasformare le informazioni dei suoi
L assistenza al paziente diabetico nella Regione Lazio
 Graziano Santantonio L assistenza al paziente diabetico nella Regione Lazio U.O.S.D. Diabetologia P.O. San Paolo - Civitavecchia Il sottoscritto DR. GRAZIANO SANTANTONIO ai sensi dell art. 76 comma 4 dell
Graziano Santantonio L assistenza al paziente diabetico nella Regione Lazio U.O.S.D. Diabetologia P.O. San Paolo - Civitavecchia Il sottoscritto DR. GRAZIANO SANTANTONIO ai sensi dell art. 76 comma 4 dell
IBD Unit: modello multidisciplinare e multiprofessionale in continua evoluzione Daniela Valpiani GASTROENTEROLOGIA ed ENDOSCOPIA FORLI
 IBD Unit: modello multidisciplinare e multiprofessionale in continua evoluzione Daniela Valpiani GASTROENTEROLOGIA ed ENDOSCOPIA FORLI La domanda di salute del paziente IBD Il paziente IBD, affetto
IBD Unit: modello multidisciplinare e multiprofessionale in continua evoluzione Daniela Valpiani GASTROENTEROLOGIA ed ENDOSCOPIA FORLI La domanda di salute del paziente IBD Il paziente IBD, affetto
4, milioni. milioni. POPOLAZIONE In aumento anziani e stranieri residenti 7,4% 14% 64,8% 21,2% più di
 POPOLAZIONE In aumento anziani e stranieri 60milioni più di 60.782.668 residenti Al 1 gennaio 2014 la popolazione residente supera i 60 milioni Continua il processo di invecchiamento della popolazione
POPOLAZIONE In aumento anziani e stranieri 60milioni più di 60.782.668 residenti Al 1 gennaio 2014 la popolazione residente supera i 60 milioni Continua il processo di invecchiamento della popolazione
La gestione dei tempi di attesa: la presa in carico del paziente è una soluzione?
 La gestione dei tempi di attesa: la presa in carico del paziente è una soluzione? Agenzia per la Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano BISOGNO-DOMANDA-OFFERTA DETERMINANTI BISOGNO-DOMANDA-OFFERTA
La gestione dei tempi di attesa: la presa in carico del paziente è una soluzione? Agenzia per la Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano BISOGNO-DOMANDA-OFFERTA DETERMINANTI BISOGNO-DOMANDA-OFFERTA
