Serena Masolini. Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XVI (2010), pp. 5-38
|
|
|
- Maria Salvatore
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XVI (2010), pp Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne». Alcune riflessioni sulla q. 11 delle Quaestiones in III de anima di Sigieri di Brabante Serena Masolini When 13th century scholars tried to inquire about how a soul separated from the body may suffer from the infernal hellfire, they found themselves facing a very convoluted theme, straddling the borders between theology and philosophy. This paper analyses Siger of Brabant s position compared with that of Thomas Aquinas and the coeval theological tradition, and shows how this topic may provide a key to further understanding the Parisian Condemnations of 1270 and 1277, as well as the artistae s epistemological program. Keywords: soul, hellfire, latin averroism, censure, historiography. Elevans oculos suos cum esset in tormentis, videbat Abraham a longe et Lazarum in sinu eius, et ipse clamans dixit: pater Abraham miserere mei et mitte Lazarum ut intinguat extremum digiti sui in aqua, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. Lc 16, I teologi del XIII e XIV secolo ritenevano che i passi della Scrittura che identificavano la pena infernale con la pena del fuoco non dovessero essere intesi in senso metaforico. Per quanto offrissero diverse interpretazioni nel definirne la natura, le proprietà ed il modo d azione, erano concordi nel sostenere che i dannati sarebbero stati tormentati dalle fiamme di un fuoco reale, che costituiva una causa oggettivamente separata rispetto alla semplice sofferenza spirituale del punito per l impossibilità di partecipare all eterna beatitudo 1. 1 Per una sintesi del pensiero teologico cristiano sull inferno e sulla natura del fuoco infernale, cfr. M. Richard, Enfer, in Dictionnaire de théologie catholique (DTC), t. V/1, ISSN (print) ISSN (online) 2011 Firenze University Press
2 6 Serena Masolini Nella distinctio 44 del IV libro delle Sentenze, Pietro Lombardo aveva fatto emergere tre dei temi su cui la riflessione patristica aveva maggiormente concentrato la sua attenzione. Il primo riguardava la capacità del fuoco infernale di ardere per l eternità i corpi dei reprobi senza consumarli; il secondo l azione del fuoco sui demoni; il terzo e più delicato la possibilità delle anime nello stato di separazione, ovvero nell intervallo tra la morte individuale e la resurrezione dei corpi, di esperire (sentire) il fuoco corporale ed esserne bruciate, così come rivelava l exemplum di Lazzaro e del ricco epulone narrato nel vangelo di Luca. Data dunque per acquisita la realtà del fuoco infernale, che dopo il Giudizio Universale avrebbe tormentato nello stesso modo i corpi solidi degli uomini dannati e quelli aerei dei demoni, per i maestri che si trovavano a commentare quello che era il testo base dell insegnamento nelle facoltà di teologia, il problema fondamentale diventava chiarirne la modalità d azione nei confronti delle anime separate, ovvero spiegare come potesse una realtà spirituale patire per una causa materiale 2. Si trattava quindi di condurre un indagine razionale sull anima e sulle sue funzioni e mostrare come il fuoco potesse farsi causa strumentale della giustizia divina ed esercitarvi un effetto reale. Che l effetto fosse descritto come reale obiective ovvero meramente appartenente all ordine della conoscenza intellettuale (a) perché oggetti- Letouzey et Ane, Paris 1939, coll ; A. Michel, Feu de l Enfer, in DTC, V/2, coll Per un approccio che guardi più alle narrazioni letterarie ed all immaginario collettivo che alla storia del dogma, si segnalano: M.P. Ciccarese, Le visiones dell aldilà nel cristianesimo occidentale. Genere letterario e tematiche predantesche, in La fine dei tempi. Storia ed escatologia, a cura di M. Naldini, Nardini, Fiesole 1994, pp ; Id., L anticipazione della fine: l immaginario dell aldilà nei primi secoli cristiani, in «Millennium»: l attesa della fine nei primi secoli cristiani, Celid, Torino 2002, pp ; F. Saracino, Lineamenti e retroterra dell immaginario infernale neo-testamentario, in Archeologia dell inferno, a cura di P. Xella, Essedue, Verona 1987, pp Sul corpo dei demoni lo stesso Agostino aveva manifestato delle riserve; poco più avanti rispetto al passo utilizzato da Pietro Lombardo (De civitate dei, XXI, c. 10, PL 41, coll ) scrive infatti: «Nisi quia sunt quaedam sua etiam daemonibus corpora, sicut doctis hominibus visum est, ex isto aere crasso atque umido, cuius impulsus vento flante sentitur. Quod genus elementi si nihil igne perpeti posset, non ureret fervefactus in balneis. Ut enim urat, prior uritur facitque cum patitur. Si autem quisquam nulla habere corpora daemones adseverat, non est de hac re aut laborandum operosa inquisitione aut contentiosa disputatione certandum. Cur enim non dicamus, quamvis miris, tamen veris modis etiam spiritus incorporeos posse poena corporalis ignis affligi». Tommaso ne sosterrà l immaterialità, cfr. S. Tommaso d Aquino, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e testo integrale di Pietro Lombardo, trad. it. R. Coggi, t. X, ESD, Bologna 2001 (d ora in poi: Th-InIVSent), IV, dist. 44, q. 3, a. 3, sol. 3, p. 253: «quod ignis Inferni non sit metaphorice dictus, nec ignis imaginarius, sed verus ignis corporeus; oportet dicere, quod anima ab igne corporeo poenas patietur, cum dominus ignem illum Diabolo et Angelis ejus paratum esse dicat Matth. 25, qui sunt incorporei, sicut et illa».
3 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 7 vamente riconosciuto dall anima come nocivo senza che tuttavia essa ne venisse fisicamente colpita (Alberto Magno, Bonaventura, Egidio Romano); (b) perché percepito come nocivo e tale da fissare l intelletto del reprobo in quella percezione, come in un incatenamento spirituale (Riccardo di Mediavilla, Guglielmo d Ockham, Duns Scoto); (c) perché ricorda ai reprobi la felicità eterna perduta (Durando di San Porziano) o che esso si presentasse effective come una modificazione dell anima separata (d) incatenandola fisicamente (Tommaso e la scuola tomista); (e) andando a colpire la parte materiale dell anima, che anche nello stato di separazione continua a mantenere un rapporto di inclinatio e di appetitus verso il suo corpo (Matteo d Acquasparta) fornire una risposta soddisfacente dal punto di vista filosofico e compatibile con il dato scritturistico non era semplice. La pericolosità del tema non era sfuggita alla campagna di censura intrapresa dal vescovo Tempier che, tanto nell intervento del 1270 quanto in quello del 1277, aveva inserito la tesi «quod anima post mortem separata non patitur ab igne corporeo» 3 fra le proposizioni da mettere al bando. Nella sua analisi della condanna del 1277, Hissette ha individuato l obiettivo polemico degli articoli 135 (113) «quod anima separata non est alterabilis secundum philosophiam, licet secundum fidem alteretur» 4 e 219 (19) «quod anima separata nullo modo patitur ab igne» 5 nel Sigieri delle Quaestiones in III de anima (qq ) e del De anima intellectiva (cap. VI), ed ha presentato le tesi dell inalterabilità dell anima separata e della sua impassibilità al fuoco come conseguenze del monopsichismo averroista sostenuto dal maestro brabantino 6. Allo stesso modo, a proposito della condanna del 1270, Van Steenberghen aveva sostenuto che l articolo 8 fosse uno dei quattro direttamente rivolti ad attaccare gli insegnamenti di Sigieri, al pari della tesi secondo le quali (1) l intelletto degli uomini è numericamente uno e lo stesso, (5) il mondo è eterno, (6) non è esistito un primo uomo 7. 3 Così nella lista del 1270 (ottava proposizione), cfr. Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. Denifle, A. Chatelain, Delalain, Paris 1889, n. 432, pp La condamnation parisienne de Nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et commentaire, ed. D. Piché, C. Lafleur, Vrin, Paris 1999, p Ivi, cit., p R. Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 Mars 1277, Publications Universitaires Vander-Oyez, Louvain Paris 1977, pp e I due testi di Sigieri sono stati editi da Bazán (Siger de Brabant, Quaestiones in tertium de anima, De anima intellectiva, De aeternitate mundi, Publications Universitaires Beatrice- Nauwelaerts, Louvain Paris 1972) e recentemente tradotti in italiano, sulla base di quell edizione, da Antonio Petagine (Sigieri di Brabante, Anima dell uomo, Bompiani, Milano 2007); le citazioni riportate in questo lavoro seguono quest ultimo volume (da ora: QTD per Quaestiones in tertium de anima, DAI per De anima intellectiva). 7 F. Van Steenberghen, La philosophie au XIIIe siècle, Publications Universitaires Beatrice-Nauwelaerts, Louvain Paris 1966, p. 456, n. 83; Id., Maître Siger de Brabant,
4 8 Serena Masolini Confrontata con alcuni studi più recenti, questo tipo di spiegazione appare quanto meno parziale. 8 Per dare una visione più articolata della q. 11, tanto all interno del pensiero del maestro brabantino quanto nella ricezione da parte dei suoi contemporanei, è necessario fare entrare in gioco altri fattori: l atmosfera alla Facoltà delle Arti di Parigi negli anni 70 e la figura dell artista, dei suoi scopi e strumenti operativi, della sua coscienza professionale ; un indagine sul sillabo parigino che guardi non solo al contenuto dottrinale degli articoli condannati, ma anche al senso generale dell intervento di Tempier nelle sue implicazioni pastorali, etiche ed epistemologiche; il confronto con Tommaso; la consapevolezza della mutabilità dei paradigmi interpretativi alla luce di una considerazione sull avventura storiografica che ha vissuto la categoria averroismo tra il XIX e XX secolo 9. Publications Universitaires, Louvain Paris 1977, pp ; si veda anche J.F. Wippel, The Condamnations of 1270 and 1277 at Paris, «Journal of Medieval and Renaissance Studies», 7, 1977, p A. de Libera, L Unité de l Intellect. Commentaire du De unitate intellectus contra averroistas de Thomas d Aquin, Vrin, Paris 2004, pp ; K. Flasch, Die Seele im Feuer. Aristotelische Seelenlehre und augustinisch-gregorianische Eschatologie bei Albert von Köln, Thomas von Aquino, Siger von Brabant und Dietrich von Freiberg, in Albertus Magnus & der Albertinismus. Deutsche philosophische Kultur des Mittelalters, a cura di M.J.F.M. Hoenen, A. de Libera e E.J. Brill, Leiden New York Köln 1995, pp ; R.A. Gauthier, Notes sur Siger de Brabant, I. Siger en 1265, «Revue des sciences philosophiques et théologiques», 67, 1983, pp ; ed in particolare: L. Bianchi, Guglielmo di Baglione, Tommaso d Aquino e la condanna del 1270, «Rivista di storia della filosofia», 39, 1984, pp ; A. Petagine, Aristotelismo difficile. L intelletto umano nella prospettiva di Alberto Magno, Tommaso d Aquino e Sigieri di Brabante, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp e ; S. Piron, Olivi et les averroïstes, «Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie», 53-1, 2006, pp Vista l ampiezza della letteratura su questi temi, ci limitiamo qui segnalare: a) sulle istanze dei maestri della Facoltà delle arti: F.-X. Putallaz, R. Imbach, Professione filosofo. Sigieri di Brabante, trad. it. A. Tombolini, Jaca Book, Milano 1998; O. Boulnois, Le chiasme: la philosophie selon les théologiens et la théologie selon les artiens de 1267 à 1300, in Was ist Philosophie im Mittelalter, W. De Gruyter, Berlin New York 1998, pp ; L. Bianchi, «Velare philosophiam non est bonum». A proposito della nuova edizione delle «Quaestiones in Metaphysicam» di Sigieri di Brabante, «Rivista di storia della filosofia», 2, 1985, pp ; L. Bianchi, E. Randi, Le verità dissonanti, Laterza, Roma Bari 1990; J.F. Wippel, Siger of Brabant: What It Means to Proceed Philosophically, in Was ist Philosophie, cit., pp ; b) sulle condanne del : L. Bianchi, Il vescovo e i filosofi. La condanna parigina del 1277 e l evoluzione dell aristotelismo scolastico, Lubrina, Bergamo 1990; Id., 1277: A Turning Point in Medieval Philosophy?, in Was ist Philosophie, cit., pp ; La condamnation parisienne de 1277, cit., pp (Troisième Partie Commentaire Historico-Philosophique); A. de Libera, Philosophie et censure. Remarques sur la crise universitaire parisienne de , in Was ist Philosophie, cit., pp ; F.-X. Putallaz, Insolente liberté. Controverse et condamnations au XIIIe siècle, Éditions universitaires Éditions du Cerf, Paris-Fribourg 1995; J. Verger, «Rector
5 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 9 Prima tuttavia, è opportuno partire dal testo di Sigieri, riassumendo i risultati delle quaestiones precedenti ed esponendo i contenuti della quaestio di cui ci vogliamo occupare, riservandoci un secondo momento per focalizzare l attenzione sui passi più interessanti e per appellarci alle circostanze esterne che potrebbero fare luce sulla Weltanschauung dell autore e dei suoi avversari. 1. Dentro la quaestio Le Quaestiones in III de anima sono il frutto delle lezioni tenute da Sigieri di Brabante alla Facoltà delle Arti di Parigi tra il 1265 ed il 1270 e costituiscono il primo testo in cui un autore latino cristiano abbia presentato la tesi dell unicità dell intelletto come quella filosoficamente più convincente. Non è certo se il manoscritto a noi pervenuto sia una reportatio di uno studente o una raccolta di appunti preparata dal maestro stesso, se rappresenti la totalità dell insegnamento di Sigieri sul terzo libro del De anima o se sia solo una silloge delle questioni più importanti 10. La quaestio «utrum anima separata pati possit ab igne» viene esaminata da Sigieri in apertura alla quarta parte del suo commento al controverso libro aristotelico quella dedicata alle virtù dell intelletto, ovvero all intelletto possibile ed agente subito dopo averne trattato il problema della passibilità tout court. Nelle prime nove quaestiones Sigieri si era chiesto in cosa differisse l intelletto dalle altre parti dell anima, cosa fosse l intelletto in sé ed in che relazione stesse col corpo, concludendo che: non est caput universitatis». Pouvoir et hiérarchie à l université de Paris au Moyen Âge, in Vaticana et medievalia. Études en l honneur de Louis Duval-Arnould, a cura di J.M. Martin, B. Martin-Hisard, A. Paravicini Bagliani, Sismel, Firenze 2008, pp ; c) su Averroè e l averroismo latino: E. Coccia, La trasparenza delle immagini. Averroè e l averroismo, B. Mondadori, Milano 2005; R.A. Gauthier, Notes sur les débuts ( ) du premier «averroïsme», «Revue des sciences philosophiques et théologiques», 67, 1983, pp ; R. Imbach, L averroïsme latin du XIIIe siècle, in Gli studi di filosofia medievale fra Otto e Novecento, a cura di R. Imbach, A. Maierù, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1991, pp ; e rimandiamo per maggiori approfondimenti alla selezione bibliografica presentata in B.C. Bazán, Radical Aristotelianism in the Faculties of Arts. The case of Siger of Brabant, in Albertus Magnus und die Anfänge der Aristoteles- Rezeption im lateinischen Mittelalter: Von Richardus Rufus bis zu Franciscus de Mayronis, Aschendorff, Münster 2005, pp Petagine, Introduzione a QTD, pp Per uno studio generale sul maestro brabantino, oltre agli studi già citati di Van Steenberghen e Imbach-Putallaz, cfr. T. Dodd, The Life and the Thought of Siger of Brabant, Thirteenth-Century Parisian Philosopher. An Examination of His Views on the Relationship of Philosophy and Theology, E. Mellen, Lewiston Queenston Lampeter 1998.
6 10 Serena Masolini (q. 1) l intelletto, immateriale e proveniente ab extrinseco, forma un unità composita con l anima vegetativo-sensitiva, edotta dalla potenza della materia 11 ; (q. 2) seguendo coerentemente i principi delle fisica aristotelica si deve affermare che l intelletto è prodotto ma è prodotto come qualcosa di eterno («non est novo factum, sed factum aeternum»), derivando dalla Causa Prima, semplice e immutabile; in quanto creatura, tuttavia, l intelletto è totalmente dipendente dalla volontà del suo creatore. Essendo tale volontà impossibile da investigare, poiché la Causa Prima agisce rispondendo solo a se stessa («voluit quia voluit»), la soluzione di Aristotele è da considerarsi possibile ma non necessaria, sebbene più probabile di quella di Agostino 12 ; (q. 3) se si accetta che l intelletto è factus de novo, la creazione deve essere avvenuta in un istante non riducibile al tempo continuo, né all eternità, ma in un tempo non continuo, «composito ex ipsis nunc», sebbene secondo la sua sostanza non stia in nessun tipo di tempo, ma nell aevum 13 ; (q. 4) l intelletto non è generabile; (q. 5) l intelletto non è corruttibile; (q. 6) l intelletto è composto, ma è composto da due atti: uno svolge la funzione della materia, l altro della forma 14 ; (q. 7) l intelletto non è la forma sostanziale del corpo, altrimenti sarebbe qualcosa di organico e non potrebbe ricevere gli intelligibili; l intelletto non comunica direttamente con il corpo, ma attraverso le facoltà che comunicano con esso; il suo rapporto con il corpo è paragonabile a quello del pilota alla nave 15 ; (q. 8) essendo l intelletto perfezione del corpo non secondo la sua sostanza ma secundum potestatem, è operans in corpore come motore (muovendo il totum per se e le singole parti per accidens) e come produttore dell atto dell intelligere: non si trova quindi in nessuna parte del corpo, perché astrae e riceve gli intelligibili lavorando sulle intentiones imaginatae senza entrare in contatto diretto con gli organi corporei 16 ; (q. 9) non essendo virtus in corpore ed essendo immateriale, secundum se, l intelletto è unico e inquantum copulatur nobis diventa, in un certo senso, intelletto dell individuo, a seconda delle sue particolari intentiones imaginatae QTD, q. 1, p Ivi, q. 2, pp Ivi, q. 3, p Ivi, q. 6, p Ivi, q. 7, pp Ivi, q. 8, pp Ivi, q. 9, pp
7 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 11 Arrivato alla decima quaestio, il maestro si chiede dunque «utrum intellectus sit passibilis». Secondo Aristotele, risponde Sigieri, l intelletto non può essere passibile in senso stretto, dal momento che è immateriale e che «omnis passio fit per naturam materiae». Come ha notato il Commentatore, tuttavia, l intelletto partecipa in un certo modo della natura delle virtù passive: l intelletto è possibilis, dunque è passibilis. Se si legge Aristotele attentamente, si può vedere che il filosofo aveva fornito chiaramente le argomentazioni «super quae debemus nos fundare»: per quanto non sia passibile di per sé, l intelletto è potenzialmente ricettivo nei confronti della specie. Il termine passio, infatti, non è univoco, ma può essere inteso in due sensi: la prima accezione è quella di «receptione cum alicuius abiectione», ed è propria della materia che, soggetta ad un atto, non può contemporaneamente riceverne un altro contrario senza l allontanamento del primo. Questo tipo di passio è quello che definisce il rapporto tra senso e sensibile, dal momento che ogni percezione sensibile cancella la percezione precedente, ma non può essere attribuita all intelletto, che non subisce alcuna alterazione materiale durante il processo conoscitivo ed è capace, quando viene informato da un intelligibile in atto, di continuare a pensare senza che gli altri intelligibili vengano espulsi 18. L altro modo è per «sola receptione» e non è proprio della materia ma dell intelletto, in quanto ricettivo della specie in potenza: «hoc intellexit Aristoteles cum dixit: susceptiva tamen speciei est huiusmodi potentia. Unde intellectus de natura passionis solum habet receptionem et non abiectionem alicuius sicut materia, eo quod, cum intellectus actu informatur aliquo intelligibili, potest adhuc intelligere sine abiectione alicuius intelligibilis» 19. Come diceva Aristotele, in poche parole, la conoscenza è quodammodo pati: ricevendo e accogliendo le forme intelligibili, l intelletto è ricettivo e dunque, in un certo qual modo, patisce. La decima questione pone i presupposti filosofici per quella che Sigieri stesso riconosce essere una «quaestio non multum philosophicam»: se la receptio delle specie in potenza è l unico tipo di passibilità a cui l intelletto è sottoposto, è ammissibile il fatto che l anima separata patisca l azione di un fuoco corporeo? Seguiamo adesso l articolazione della quaestio. Le argomentazioni quod non sono riconducibili al fatto che il fuoco, a causa della sua na- 18 Ivi, q. 10, pp : «Unde quantum ad talem dicit Aristoteles quod oportet intellectum esse impassibilem. Hoc satis innuit cum dicit quod intellectus non patitur ab intelligibili sicut sensus a sensibili, eo quod sensibilia aliquam transmutationem possunt inducere in sensum, quoniam intensio sensibilium corrumpit sensum». 19 Ibid.
8 12 Serena Masolini tura elementare, non agisce sull anima separata perché essendo questa immateriale non può essere soggetta a qualitates materiali: (i) Aristotele afferma che l agente deve essere sempre più nobile del soggetto su cui agisce, ma il fuoco, così come ogni corpo elementare, non può essere più nobile dell anima separata; (ii) tutto ciò che patisce, patisce per natura della materia, ma l anima separata è immateriale; (iii) l anima non patisce da un corpo, se non da quel corpo a cui è unita, ma l anima separata non è unita al fuoco, «ergo ab igne non potest pati passione vel tristitia» 20. Sigieri considera quindi un altra strada. Alcuni affermano che l anima non «patitur ab igne» nel senso di essere bruciata da questo nella sua sostanza, ma soffre «quia videt se in igne». Questa posizione tuttavia contraddice Aristotele, che nei libri dell Etica aveva sostenuto che il piacere deriva dalla contemplazione intellettiva. Quando l anima si vede nel fuoco, essendo immateriale, non si vede con una visione prodotta dall immaginazione, ma attraverso una «visione intellectiva». Non vedendosi dunque per mezzo di una visione materiale non può patire per una passione o per una tristezza materiale 21. Sigieri presenta quindi un argomentazione quod sic. Dal momento che la pena deve corrispondere alla colpa, e che l anima ha peccato unita al corpo ed attraverso il corpo, ne consegue che anche nello stato di separazione dovrà essere castigata con una punizione corporale. Non essendoci una realtà corporea che può fare questo se non il fuoco, «ergo ab igne debet pati». Eccoci dunque al momento della solutio. Sigieri confessa che Aristotele non ha mai affrontato il problema «non videmus quod Aristoteles aliquid dixerit de ista quaestione, quia non invenimus quod ipse alicubi determinaverit de statu separationis» 22 la risposta andrà dunque cercata in altri passi dove il filosofo si è occupato di qualcosa di simile, o costruita, tentando di comprendere cosa scaturisca dai presupposti aristotelici. Lo Stagirita non ha detto niente sullo stato di separazione, ma ha riportato e confutato la dottrina pitagorica dell inferno. Pitagora afferma Sigieri sulla scorta del testo aristotelico riteneva che il fuoco fosse al centro della terra, perché essendo l elemento più nobile doveva stare nel luogo più nobile, nel medium appunto, così come il cuore che è l organo più nobile si situa in medio animalis: quel fuoco al centro della terra era il carcere nel quale i condannati di Giove venivano tormentati. 20 Ivi, q. 11, p Ibid. Per la frase: «Dicit Aristoteles in Ethicis quod delectatio est a contemplatione» abbiamo seguito l edizione di Bazán. Il testo del manoscritto è corrotto e riporta «Dicit Aristotiles in Ethicis quod delectatione que est a contemplatione». Vedremo poi come Gauthier, ricorrendo all originale tommasiano, proponga un altra lettura (cfr. infra, n. 44). 22 Ibid.
9 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 13 Coerentemente con la sua teoria dei luoghi, Aristotele replica che quella non può essere la posizione del fuoco. Medium, infatti, può dirsi in due modi: medium naturae e medium magnitudinis. Il medio di natura è effettivamente il luogo più nobile, ma questo non vale necessariamente per il medio secondo grandezza: il medium magnitudinis corrisponde al nobilior locus solo se e in quanto coincidente con il medium naturae. Negli animali i due media sono gli stessi, ma nel cerchio, ad esempio, il centro è solo medium magnitudinis poiché il medium naturae è da identificarsi con la circonferenza. La conclusione dello Stagirita è dunque che il fuoco non si trovi al centro della terra, ma la questione se esso possa colpire o meno i condannati non viene affrontata 23. Sigieri deve quindi costruire la sua risposta, e lo fa cominciando a demolire due teorie tradizionali: (a) Prende di nuovo in considerazione la tesi che l anima soffra per il fatto di vedere se stessa nel fuoco, facendo notare che se l anima avesse solo una visio del fuoco, senza la percezione che esso possa farle del male, non sarebbe chiaro in che modo possa patirne. (b) A coloro che paragonano la visio dell anima separata a quella che proviamo durante i sogni, e che quindi l anima soffrirebbe per il fuoco così come il dormiente che sogna di essere bruciato («sicut somnians aliquando multum patitur ab igne, quia videtur sibi per somnium quod sit in igne et quod comburatur»), Sigieri risponde che la loro non è un argomentazione («sed hoc nihil est»). In questo caso infatti l anima non soffrirebbe per via di una causa reale, ma di un immagine («non patitur ab igne, sed a specie ignis»), e tale passione sarebbe solo un illusione («item passio non esset passio, sed deceptio»). Come dice Aristole, l intelletto svincolato dalla materia non può sbagliarsi, perciò conclude Sigieri: «si iste intellectus non decipitur, nec anima separata decipitur» 24. La terza probabile solutio è già più interessante. (c) Alcuni ritengono che il fuoco debba venire considerato dupliciter: «modo in se et absolute» e così non può influire sull anima immateriale oppure «in quantum est instrumento divinae ultionis». Il fuoco non funzionerebbe quindi da pena infernale in quanto tale, ma in quanto strumento scelto dalla giustizia divina 25. Così esposta la tesi risulta però insufficiente, poiché non dice niente sul modo in cui il fuoco svolge la sua funzione, in particolare su come 23 Ivi, p Ivi, q. 11, 54-63, p. 33. Per quanto riguarda l argomento «quod intellectus ille, qui est sine materia, non est falsus, sed semper verus», nell Aristotele filologicamente corretto, cfr. Gauthier, Notes sur Siger de Brabant, I, cit., pp Ivi, p. 150.
10 14 Serena Masolini possa bruciare continuamente l anima senza che essa si consumi. Ancora la risposta viene da Aristotele, stavolta attraverso il richiamo al classico argomento della convenientia tra ars e instrumentum: «non quaelibet ars utitur quolibet instrumento, sed solum instrumentum sibi conveniente». Lo strumento deve avere una qualche comunicazione con ciò che è soggetto alla sua azione, ma il fuoco non sembra avere nullam convenientiam con l anima senza corpo. Affinché possa avvenire la passio nello stato di separazione, l anima deve essere unita al fuoco in qualche modo; e tale modo risulta essere lo stesso attraverso il quale, quando era sulla terra, si trovava unita al corpo in suis passionibus: «quare, ut videtur, non poterit esse instrumentum suae punitionis nisi ab eo cui unitur in principio. Sicut anima corpori in suis passionibus uniebatur, ita post separationem unitur et ideo poterit ab eo pati» 26. La questione adesso è filosofica al cento per cento: in quale modo l anima si unisce al corpo? La risposta al problema teologico va cercata sul terreno della psicologia razionale. Come abbiamo visto, Sigieri la sua risposta l ha già trovata, e l ha esposta nelle quaestiones 7 e 8: «dico quod unietur ei non sicut forma materiae, sed sicut locatum unitur loco, quia operatur in eo» 27. L anima, ribadisce, non è forma sostanziale del corpo. L intelletto immateriale non può comunicare con ciò che è organico, ma si relaziona ad esso attraverso mediazioni, secundum potestatem, ed è operans in corpore così come il timoniere guida la nave; aggiunge qui: come il locato al luogo. Lo stesso accade all anima separata nei confronti del fuoco: l anima è costretta dalla giustizia divina a stare nel fuoco ed operare in esso, soffrendo per l impossibilità di soddisfare il suo desiderio di operare altrove. Unietur ergo anima igni, quia erit operans in eo. Nunc autem ignis bene potest esse instrumentum divinae iustitiae quantum ad hoc quod ipse determinat locum suum ita quod ipsa non possit alibi esse operans, sed solum in ipso igne. Anima ergo ita detinetur ab igne, detenta tristatur, et in hoc patitur, cum ipsa desideret alibi operari, et non possit. Dicit enim Averroes quod omnis voluntas est delectabilis. Quod ergo impedit voluntatem animae ei unire, in quo quidem delectaretur, si eam compleret, facit eam tristari, et sic anima patitur ab igne 28. L inferno non è tanto un forno quanto un carcere, e la causa di tormento per l anima consiste nel sentirsi frustrata nella sua voluntas, vedersi negata la libertà di azione, essere impedita nell esercizio di quella che è 26 Ibid. 27 Ibid. 28 Ivi, pp
11 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 15 la sua operazione propria, ovvero l intelligere. Il processo di conoscenza, infatti, comincia solo quando l anima intellettiva è messa in condizione di ricevere le species elaborate dai sensi: unicamente a quel punto l intelletto si attiva, astraendo dalle intentiones imaginatae gli intelligibili e depositandoli nell intelletto possibile. Costretta ad operare in un corpo come il fuoco che non permette di costruire le intentiones imaginatae, l anima del dannato si trova priva del materiale di partenza: l intellectus senza species è fermo. L unico modo in cui l anima potrebbe svolgere la sua funzione conoscitiva dopo la morte sarebbe per una visione diretta degli intelligibilia (tale è appunto la visio beatifica), ma alle anime trattenute nell inferno non è concesso saltare le mediazioni e vedere faccia a faccia: ecco dunque la tristitia. L andamento della quaestio sembra a questo punto effettuare uno scarto. Sigieri pone due domande se l anima opera nel fuoco, dov è collocata? se si colloca nel fuoco stesso, quale operazione compie in esso? ma le lascia senza risposta, dopodiché non nomina più l inferno e torna a far parlare Aristotele ed Averroè: «forte, si quaeretur ab Aristotele utrum anima intellectiva esset passibilis, ipse responderet quod ipsa intellectiva separata impassibilis est, et forte ipse cum Commentatore eius diceret quod ipsa inseparabilis est, et si separetur ab hoc corpore, non tamen ab omni corpore simpliciter separatur» 29. In una prospettiva puramente aristotelica l anima separata è impassibile, e se si volesse dire che viene separata, tale separazione deve essere intesa solo per quanto riguarda un determinato corpo, non ogni corpo simpliciter. Per quale motivo? L intelletto è unico secondo la sostanza per tutta la specie umana, solo gli uomini si collegano ad esso, perché solo il corpo umano è capace di costruire i phantasmata di cui si serve per operare. Questo intende Aristotele quando, criticando la tesi pitagorica della trasmigrazione, afferma che «non quaelibet anima ingreditur quodlibet corpus»: «debet intelligi per hoc quod ipse velit dicere quod intellectus, licet non sit nisi unus in substantia, non numeratus substantialiter secundum numerationem hominum, tamen ita appropriat corpus hominis quod non se inclinat ad corpus, id est, brutorum». L intelletto non può mai stare separato absolute, altrimenti sarebbe totalmente impotente: deve essere sempre unito al corpo di uno dei molteplici individui della specie umana, in modo da poter continuare la sua attività, grazie alle loro immagini; immagini che finiscono per appartenere, in un certo senso, ad un unica ragione: «unde, cum intellectus in potentia se habeat ad intentiones imaginatas, determinate respicit intentiones imaginatas hominum, eo quod omnes intentiones imaginatae hominum 29 Ivi, p. 152.
12 16 Serena Masolini unius rationis sunt. Ideo intellectus unicus in omnibus est secundum substantiam suam et secundum suam potestatem» 30. Da questo punto di vista, porsi la questione dell anima separata e della punizione infernale non ha assolutamente senso. 2. Intorno alla quaestio L ultimo paragrafo della q. 11 presenta la posizione che Sigieri sviluppa nel capitolo VI del De anima intellectiva, quando ritorna ad indagare «secundum documenta philosophorum» in che modo essa sia separabile dal corpo e quale condizione abbia quando è separata 31. Il capitolo si apre nuovamente con una presa di coscienza della difficoltà della materia: l argomento non è stato affrontato da Aristotele, dunque il magister in artibus può solo tentare di ricostruire la sua opinione, che sembra appunto essere quella secondo cui l anima può separarsi da un determinato corpo, una volta che questo si è corrotto, ma mai in senso assoluto dal mondo corporeo, poiché sarà sempre atto di un qualche altro corpo. Vale la pena soffermarsi sul quarto argomento. Per poter affermare che l anima possiede uno stato separato, si deve dimostrare che svolge delle operazioni indipendentemente dal corpo di cui è atto, e questo lo si può fare osservando le attività che compie mentre è legata al corpo, o quando ne è separata. L operazione propria esercitata dall anima quando è nel corpo ovvero il pensare non può avere luogo «sine corpore et phantasmata». Delle eventuali azioni che potrebbe compiere in uno stato di separazione non si può sapere invece niente, poiché, per quanto alcuni si ostinino a volerle studiare, agli uomini non è dato di esperire alcun effetto che sia frutto delle attività dell anima separata 32. Questo è dunque ciò che si può ricavare dallo studio della filosofia aristotelica circa la separabilità dell anima. A coloro che sostengono che è erroneo e contrario alla giustizia credere che le anime non si separino totalmente dai corpi e che non vengano punite o premiate proporzionalmente al loro merito, Sigieri risponde che il suo intento non era indagare la verità circa l anima, ma l opinione del Filosofo al riguardo Ibid. 31 DAI, VI, pp Ivi, p. 282: «nec etiam potest videri totaliter separata a corpore per effectus apparentes de ea a corpore separata, cum hominibus communiter, immo etiam ad hoc studere volentibus, non appareant opera animae talem statum habentis». 33 Ivi, p. 284: «Quod si quis dicat hoc esse erroneum animas a corporibus totaliter non separari et eas poenas et praemia recipere secundum ea quae gesserunt in corpore, quod enim non ita fiat, hoc est praeter rationem iustitiae, dicendum, sicut et a principio
13 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 17 Il magister artium difende il suo punto di vista nei confronti della Rivelazione: i filosofi non possono avere esperienza di attività dell anima separata e nel XII libro della Metafisica Aristotele non ha incluso l anima intellettiva tra le sostanze separate. Nulla vieta che alcuni uomini dotati di profezia abbiano conosciuto delle verità inaccessibili all umana ragione, ma tali verità debbono essere indagate, appunto, in altra sede («alibi videre debit») 34. La chiusa della q. 11 ed il capitolo VI presentano la logica conseguenza di una posizione monopsichista, soluzione che Hissette e la storiografia tradizionale hanno considerato come l opinione definitiva di Sigieri e l obiettivo polemico della condanna di Tempier 35. È necessario, tuttavia, porsi due domande: (I) Nella q. 11 Sigieri acconsente incondizionatamente ed unicamente alla via aristotelica dell inseparabilità dell anima dal mondo corporeo o lascia in piedi come possibilità filosoficamente valida, seppure da chiarire in modo ulteriore, la tesi dell anima separata come unita al fuoco sicut locatus in loco? Come avevamo accennato, prima dell ultima parte della quaestio quella che comincia con l ipotetica risposta di Aristotele si avverte come uno scarto nell esposizione. In parte la cesura è limata dalle due domande lasciate in sospeso, che rivestono una sorta di funzione-ponte: «Si tu dices: cur anima operaretur in igne, ubi locatur? Propter hoc enim locatur alicubi, quod ipsa velit determinare <ubi> operetur. Si ergo anima locatur in igne, quam operationem operatur in igne?» 36. Secondo Gauthier, il Sigieri-averroista sta qui lasciando intravedere il suo scetticismo 37. «Il prend philosophiquement une position de dictum est, quod nostra intentio principalis non est inquirere qualiter se habeat veritas de anima, sed quae fuerit opinio Philosophi de ea». 34 Ivi, pp Hissette, Enquête sur les 219 articles, cit., p. 312:«La source de la proposition se trouve dans les Q. in tertium de anima de Siger de Brabant. [ ] Question peu philosophique, constate Siger. Après avoir critiqué diverses solutions émanant de théologiens, il reconnaît la possibilité d une détention de l âme dans le feu, où elle serait condamnée à agir. Mais il ajoute que, si l on interrogeait Aristote sur la question, il répondrait peut-être (forte) que l âme séparée est impassible: ipsa (anima) intellectiva separata impassibilis est. Peut-être ajouterait-il avec son Commentateur que l âme, unique pour tous les hommes, n est jamais séparée de tous les individus. Siger est certainement disposé à accepter ces vues, puisque, tout au long des Quaestiones, il défend le monopsychisme». 36 QTD, q. 11, 89-91, p Gauthier, Notes sur Siger de Brabant, I, cit., pp. 226.
14 18 Serena Masolini philosophe», afferma de Libera 38. Per Petagine, l intento del magister è chiudere la questione lasciandola in sospeso, ovvero «mettendo in evidenza la difficoltà di coniugare l escatologia cristiana, che presuppone una reciproca e biunivoca appartenenza tra l intelletto e il singolo corpo umano, con la psicologia razionale indicata da Aristotele e da Averroè, a cui i teologi Alberto e Tommaso pur intendevano ispirarsi a livello filosofico» 39. Probabilmente è così, ciò non toglie che, pur con i suoi aspetti oscuri, la prospettiva secondo cui l anima che patisce sia operans in igne sembri assai compatibile con la psicologia e la noetica sigieriana. (II) Ammettendo che Sigieri riconosca una certa validità teoretica anche a questa soluzione, quale delle due intendeva colpire Tempier nelle condanne del ? La domanda non è oziosa perché chiama in causa un terzo autorevole protagonista, altra vittima, seppure indiretta, della censura: Tommaso d Aquino. Come è stato ampiamente mostrato da Gauthier in un noto articolo, Sigieri aveva strutturato la sua q. 11 attingendo a piene mani dalle pagine del commento tommasiano al IV libro delle Sentenze, seguendo puntualmente la dist. 44, q. 3, a. 3, qla 3 40 e riprendendo alla lettera o meglio, quasi alla lettera la sua tesi dell alligatio 41. Sigieri segue infatti Tommaso fino a prima della formulazione dei due dubbi-ponte, dopodiché lo abbandona. Gauthier si è impegnato in un analisi accuratissima, quasi chirurgica, sezionando il testo e ricongiungendolo in ogni proposizione alla sua fonte diretta, che è sempre l Aquinate, anche quando sembra che Sigieri voglia far parlare Aristotele. La prima quod non di Sigieri è la seconda che usa Tommaso, anche se quest ultimo la riferisce ad Agostino e non ad Aristotele 42, così come la 38 De Libera, L Unité de l Intellect, cit., pp Petagine, Aristotelismo difficile, cit., p Th-InIVSent, dist. 44, q. 3, a. 3, qla 3, pp e dist. 44, q. 3, a. 3, sol. 3, pp Tommaso ha affrontato lo stesso tema in: Contra Gentiles, IV, c. 90; De anima, a. 21; De veritate, q. 26, a. 1; Quodlibet II, q. 7, a. 1; Quodlibet III, q. 10, a. 1; Compendium theologiae, c Gauthier, Notes sur Siger de Brabant, I, cit., pp , cfr. ivi, p. 217: «Siger emprunte à peu près tous les éléments de sa question à celle de S. Thomas, avec des remaniements de pure forme». 42 Th-InIVSent, dist. 44, q. 3, a. 3, qla 3, p. 242:«Praeterea, Augustinus in eodem lib. [De gen. ad litt., XII, XVI, 33; PL 34, 467], dicit, quod agens semper est nobilius patiente. Sed impossibile est aliquod corporeum esse nobilius anima separata. Ergo non potest ab aliquo corpore pati». Tommaso aveva comunque in precedenza segnalato anche
15 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 19 seconda ricalca la terza, e la terza ricalca la quinta 43. È da Tommaso che il brabantino ricava la citazione dall Etica aristotelica «quod delectatio est a contemplatione» 44 e l argomento quod sic 45. Confrontando le tre ipotesi che entrambi i maestri utilizzano per aprire la sezione della solutio il parallelismo è ancora più evidente. Ecco qui, per intero, il testo di Tommaso: (a Th ) Quidam enim dixerunt, quod hoc ipsum quod est ignem videre, sit animam ab igne pati; unde Gregorius in 4 Dial. [c. 29; PL 77, 368A] dicit: «Ignem eo ipso patitur anima quo videt». Sed istud non videtur sufficere; quia quodlibet visum ex hoc quod videtur, est perfectio videntis; unde non potest in eius poenam cedere inquantum est visus; sed quandoque est punitivum vel contristans per accidens, inquantum scilicet apprehenditur ut nocivum; unde oportet quod praeter hoc quod anima illum ignem videt, sit aliqua comparatio animae ad idem, secundum quam ignis animae noceat. (b Th ) Unde alii dixerunt, quod quamvis ignis corporeus non possit animam exurere, tamen anima apprehendit ipsum ut nocivum sibi; et ad talem apprehenil passo aristotelico e secondo Gauthier è da lì che Sigieri ha preso letteralmente la sua citazione, invece che rifarsi all originale del De anima, cfr. ivi, dist. 1, q. 1, a. 4, qla 1, arg. 3: «Nobilius est agens patiente, secundum Augustinum in XII De Genesi ad litteram et secundum Philosophum in III De anima». 43 Ivi, dist. 44, q. 3, a. 3, qla 3, p Ibid.: «Si dicatur, quod hoc ipso anima punitur ab igne quod ignem videt, ut videtur dicere Gregorius in 4 Dialog. [c. 29; PL 77, 368A]: contra. Si anima videt ignem inferni, non potest videre nisi visione intellectuali, cum non habeat organa quibus visio sensitiva vel imaginaria perficitur. Sed visio intellectualis non videtur quod possit esse causa tristitiae: delectationi enim quae est in considerando, non est tristitia contraria, secundum Philosophum [Top., I 15, 106a36-b1]. Ergo ex tali visione anima non punitur». Gauthier interpola dunque così la proposizione di Sigieri: «Dicit Aristotiles in Ethicis quod <delectatio que est a sensu differt specie a> delectatione que est a contemplatione [Ethic. Nic., X, 1175a21-28]». La sua lettura è certamente sensata, anche se ne dà una giustificazione alquanto macchinosa, cfr. Gauthier, Notes sur Siger de Brabant, cit., p. 218: «cette majeure [cioè, così come è stata resa nell edizione di Bazán] permet seulement de conclure: or, la vision du feu est contemplation; donc elle est source de joie» attraverso la fonte tommasiana si può concludere invece «que la contemplation du feu est source de joie sans tristesse». L argomento che «la contemplation est une source de joie sans mélange de tristesse» viene usato da Tommaso come citazione dai Topici, ma si può trovare anche nell Etica Nicomachea, ecco così che Gauthier si sente autorizzato a rendere quella frase coerente con il successivo discorso di Sigieri, ricorrendo ad un altro argomento sviluppato proprio nell Etica Nicomachea: «Mais Siger, dans sa conclusion, met en vedette une autre idée:la contemplation du feu ne peut être source d une tristesse matérielle: il faut donc qu il ait pris comme majeure la distinction spécifique des plaisir et des peines telle que l établit Aristote: à une opération matérielle suivent des plaisir et des peines matériels, à une opération spirituelle des plaisirs et des peines spirituels. D où la restitution que j ai proposée (et qui a en outre l avantage de garder les mots du ms.)» (cfr. supra, nota 21). 45 Il passo ripreso è il secondo sed contra, cfr. Th-InIVSent, dist. 44, q. 3, a. 3, qla 3, p. 244.
16 20 Serena Masolini sionem afficitur timore et dolore, ut in eis impleatur quod dicitur Psalm. 13, 5: «Trepidaverunt timore, ubi non erat timor». Unde Gregorius in 4 Dial. [c. 29; PL 77, 368A] dicit, quod quia anima cremari se conspicit, crematur. Sed hoc iterum non videtur sufficere; quia secundum hoc passio animae ab igne non esset secundum rei veritatem, sed secundum apparentiam tantum: quamvis enim possit esse vera passio tristitiae vel doloris ex aliqua falsa imaginatione, ut Augustinus dicit 12 super Genes. ad litteram [XXXII 60-61; PL 34, ]; non tamen potest dici quod secundum illam passionem vere patiatur a re, sed a similitudine rei quam concipit. Et iterum iste modus passionis magis recederet a reali passione quam ille qui ponitur per imaginarias visiones; cum ille dicatur per veras imagines rerum esse, quas anima secum defert; iste autem per falsas conceptiones quas anima errans fingit. Et iterum non est probabile quod animae separatae, vel daemones, qui subtilitate ingenii pollent, putarent ignem corporeum sibi nocere posse, si ab eo nullatenus gravarentur. (c Th ) Unde alii dicunt, quod oportet ponere animam etiam realiter ab igne corporeo pati; unde etiam Gregorius in 4 Dial. [c. 29; PL 77, 368A] dicit: «Colligere ex dictis evangelicis possumus quia incendium anima non solum videndo, sed etiam experiendo patiatur». Sed hoc tali modo fieri ponunt. Dicunt enim, quod ignis ille corporeus potest considerari dupliciter. Uno modo secundum quod est res quaedam corporea; et hoc modo non habet quod in animam agere possit; alio modo secundum quod est instrumentum divinae iustitiae vindicantis; hoc enim divinae iustitiae ordo exigit ut anima quae peccando se rebus corporali subdit, eis etiam in poenam subdatur. Instrumentum autem non solum agit in virtute propria, sed etiam in virtute principalis agentis, ut supra, dist. 1, quaest. 1, art. 4, dictum est; et ita non est inconveniens, si ignis ille, cum agat in vi spiritualis agentis, in spiritum agat hominis vel daemonis, per modum etiam quo de sacramentis dictum est, dist. 1, quod animam sanctificant. Sed istud etiam non videtur sufficere: quia omne instrumentum in id circa quod instrumentaliter operatur, habet propriam actionem sibi connaturalem, et non solum actionem secundum quam agit in virtute principalis agentis; immo exercendo primam actionem oportet quod efficiat hanc secundam; sicut aqua lavando corpus in baptismo sanctificat animam, et sera secando lignum perducit ad formam domus. Unde oportet dare igni aliquam actionem in animam quae sit ei connaturalis ad hoc quod sit instrumentum divinae iustitiae peccata vindicantis 46. Le differenze dalla versione di Sigieri? Ovviamente l ampiezza con cui vengono trattate le solutiones e lo sviluppo armonico delle argomentazioni. Al confronto, i passi del brabantino sembrano brutali riassunti 47. Tommaso estende inoltre l indagine alla sorte dei demoni, che sono destinati, in quanto spirituali, a soffrire le stesse pene delle anime umane dannate. 46 Th-InIVSent, dist. 44, q. 3, a. 3, sol. 3, pp Gauthier, Notes sur Siger de Brabant, cit., p. 222: «le résumé est brutal et en fin de compte peu intelligible: on aime à croire que le ms. ne nous a conservé qu un canevas que Siger dans son cours dépeloppait».
17 Una quaestio-limite: «Utrum anima separata pati possit ab igne» 21 Ma soprattutto si può osservare la citazione esplicita delle auctoritates: Tommaso non manca mai di riferire le opinioni alle relative fonti, ovvero Gregorio e Agostino, così come ne dava notizia il testo di Pietro Lombardo. Segnalando i passi dei due Padri, il Dottore Angelico seguito da Sigieri muoveva in realtà una critica ai teologi passati e contemporanei, che da quei testi avevano sviluppato delle teorie sul fuoco dell inferno tali da svilirne l efficacia reale nei confronti dell anima dannata. L idea di una pena tutta spirituale, paragonabile alla dimensione onirica, era già stata infatti denunciata nel secondo articolo della stessa quaestio, ed attribuita ad Avicenna, colpevole di aver dato un interpretazione metaforica dei castighi riducendoli alla sola poena damni, ovvero al dolore spirituale, al rimorso, al desiderio insoddisfatto per l allontanamento da Dio, riducendo la poena sensus ad una sofferenza immaginaria: «sicut in somnis propter similitudines praedictas in imaginatione existentes videtur homini quod torqueatur poenis diversis» 48. All idea di un apprehensio mediante la quale le anime potevano soffrire per il fuoco, senza che tuttavia questo le colpisse o le alterasse fisicamente era ricorso Bonaventura 49. Anche Alberto Magno aveva seguito Agostino nel parlare di similitudines degli organi corporei attraverso le quali le anime dannate potevano percepire il fuoco, così come colui che sogna vede se stesso camminare o sedere 50. Ed è di Alberto una delle più celebri formulazioni della tesi (c), ovvero che il fuoco infernale non deve essere inteso come elementum corporeum ma come instrumentum divinae justitiae, dotato da essa di una vis incorporea tale da permettergli di affliggere anche le realtà spirituali Th-InIVSent, dist. 44, q. 3, a. 2, sol. 1; cfr. Avicenna, Liber de philosophia prima, sive scientia divina, ed. S. Van Riet, E. Peeters-Brill, Louvain-Leiden 1980, p. 520: «Animae vero malae vident etiam poenam quam imaginaverant in hoc mundo et affliguntur ea. Forma enim imaginata non est debilior sensibili, sed est maior impressione et claritate, sicut videmus in somnis; fortasse enim si somniatum maius est pro modo suo quam sensibile, tunc quanto magis illud quod est in alio saeculo fortius est quam quod est in somnis propter paucitatem impedimentium et expoliationem animae et claritatem recipientis». 49 Doctoris Seraphici S. Bonaventurae s.r.e. episc. card. Commentaria in quatuor libros sententiarum magistri Petri Lombardi, IV, In quartum librum sententiarum, in Opera Omnia, ex typographia collegii S. Bonaventurae, Quaracchi, 1889, pp D. Alberti Magni Ratisboniensis episcopi, ord. praed., Commentaria in IV Sententiarium, in Opera omnia, ed. A. Borgnet, t. XXX, Vivés, Paris 1894, dist. 44, F, a. 37, pp e a. 40, p. 598; ivi, dist. 44., G, p. 595: «profiteri animam habere posse similitudinem corporis et corporalium omnino membrorum quisquis renuit, potest negare animam esse quae in somnis videt vel ambulare se, vel sedere, vel huc atque illuc gressu vel etiam volatu ferri: hoc sine quadam similitudine corporis non fit. Proinde si hanc similitudinem etiam apud inferos gerit, non corporalem, sed corpori similitudinem: ita etiam in locis videtur esse non corporalibus, sed corporalium similibus sive in requie sive in doloribus». 51 Ivi, p. 593: «ignis ille corporeus potest accipi dupliciter, scilicet ut instrumentum divinae justitiae vindicantis peccatum commissum contra Deum, et ut elementum corpo-
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica
 PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO
 NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C.
 ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Introduzione alla Teologia
 Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE
 FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva
 TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
> NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
Prof. Monti a.s
 Conclusioni sulla Patristica ti e considerazioni generali > I PERIODI DELLA PATRISTICA < Abbiamo visto come l avvento del Cristianesimo abbia deviato la filosofia, dandole un nuovo aspetto. Agostino è
Conclusioni sulla Patristica ti e considerazioni generali > I PERIODI DELLA PATRISTICA < Abbiamo visto come l avvento del Cristianesimo abbia deviato la filosofia, dandole un nuovo aspetto. Agostino è
gianluca miligi Sulla domanda metafisica. Gli invïdiosi veri di Sigieri di Brabante
 gianluca miligi Sulla domanda metafisica. Gli invïdiosi veri di Sigieri di Brabante www.filosofia.it Il testo è pubblicato da www.filosofia.it, rivista on-line registrata; codice internazionale issn 1722-9782.
gianluca miligi Sulla domanda metafisica. Gli invïdiosi veri di Sigieri di Brabante www.filosofia.it Il testo è pubblicato da www.filosofia.it, rivista on-line registrata; codice internazionale issn 1722-9782.
ANSELMO D AOSTA
 Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI
 TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
TOMMASO d AQUINO MASSARO-FORNERO-REALE-ANTISERI LA SCOLASTICA E LA FILOSOFIA CRISTIANA DEL MEDIOEVO SVILUPPATASI FRA L XI e IL XIV SECOLO ESSA VENNE ELABORATA NELLE SCHOLAE ISTITUITE NEI MONASTERI, DOPO
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO
 LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
Sintesi sul neoplatonismo
 Sintesi sul neoplatonismo Tra il II e III secolo d. C in ambiente ellenistico si sviluppa una tendenza a tornare al pensiero pre-cristiano (in particolare platonismo e aristotelismo), prescindendo dalle
Sintesi sul neoplatonismo Tra il II e III secolo d. C in ambiente ellenistico si sviluppa una tendenza a tornare al pensiero pre-cristiano (in particolare platonismo e aristotelismo), prescindendo dalle
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
Cataldo Zuccaro. Teologia morale fondamentale
 Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia
 APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
Domenica, 17 dicembre Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano
 Domenica, 17 dicembre 2017 Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano Silvana Borutti Wittgenstein: la filosofia come compito e come risveglio Ora avrei la possibilità di essere una persona
Domenica, 17 dicembre 2017 Ristorante Officina 12 Alzaia Naviglio Grande Milano Silvana Borutti Wittgenstein: la filosofia come compito e come risveglio Ora avrei la possibilità di essere una persona
Chi era Etienne Gilson?
 Chi era Etienne Gilson? Gilson, Étienne Storico francese della filosofia (Parigi 1884 - Cravant, Yonne, 1978). Prof. nelle univ. di Lilla (1913), di Strasburgo (1919) e alla Sorbona (1921), directeur d
Chi era Etienne Gilson? Gilson, Étienne Storico francese della filosofia (Parigi 1884 - Cravant, Yonne, 1978). Prof. nelle univ. di Lilla (1913), di Strasburgo (1919) e alla Sorbona (1921), directeur d
Quale domanda fondamentale pone?
 S. Tommaso d Aquino Nasce nel 1225 nel castello di Roccasecca presso Aquino, nel basso Lazio, da un antica famiglia nobile (il padre di stirpe longobarda, la madre di stirpe normanna, I primi studi li
S. Tommaso d Aquino Nasce nel 1225 nel castello di Roccasecca presso Aquino, nel basso Lazio, da un antica famiglia nobile (il padre di stirpe longobarda, la madre di stirpe normanna, I primi studi li
PEDAGOGIA DEL CONFLITTO E DELLA MEDIAZIONE. Prof. Andrea Potestio
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PEDAGOGIA DEL CONFLITTO E DELLA MEDIAZIONE (A.A. 2017/2018) Prof. Andrea Potestio Il diritto di punire P. Ricoeur Corso di Pedagogia del conflitto e della mediazione anno
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PEDAGOGIA DEL CONFLITTO E DELLA MEDIAZIONE (A.A. 2017/2018) Prof. Andrea Potestio Il diritto di punire P. Ricoeur Corso di Pedagogia del conflitto e della mediazione anno
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015
 Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI. Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA
 UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
Logica filosofica. Terza Parte Il ragionamento
 Logica filosofica Terza Parte Il ragionamento Caratteristiche generali del ragionamento Definizione: Il ragionamento è un movimento della mente per il quale passiamo da diversi giudizi confrontatisi fra
Logica filosofica Terza Parte Il ragionamento Caratteristiche generali del ragionamento Definizione: Il ragionamento è un movimento della mente per il quale passiamo da diversi giudizi confrontatisi fra
L indagine sulla natura: il pensiero presocratico
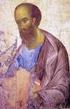 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE
 IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
Seminario Patriarcale di Venezia - Studio teologico a.a MATERIALI PER IL SEMINARIO. 4. La filosofia delle forme simboliche di Ernst Cassirer
 Seminario Patriarcale di Venezia - Studio teologico a.a. 2012-13 Seminario filosofico SIMBOLO E METAFORA: UN APPROCCIO ALLA FILOSOFIA ERMENEUTICA Prof. Marco Da Ponte MATERIALI PER IL SEMINARIO 1. Note
Seminario Patriarcale di Venezia - Studio teologico a.a. 2012-13 Seminario filosofico SIMBOLO E METAFORA: UN APPROCCIO ALLA FILOSOFIA ERMENEUTICA Prof. Marco Da Ponte MATERIALI PER IL SEMINARIO 1. Note
Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo
 Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva
 Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Boezio e la teoria delle proporzioni. Calcidio e il commento al Timeo di Platone
 Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
GESÙ SPIEGATO A TUTTI
 JOSEPH DORÉ GESÙ SPIEGATO A TUTTI Queriniana Ouverture Questa opera si propone, né più né meno, non solo di spiegare Gesù, ma di spiegarlo a tutti! Per permettere a chi lo desidera di mettersi in cammino
JOSEPH DORÉ GESÙ SPIEGATO A TUTTI Queriniana Ouverture Questa opera si propone, né più né meno, non solo di spiegare Gesù, ma di spiegarlo a tutti! Per permettere a chi lo desidera di mettersi in cammino
Ruggero Morresi. Neotopica: un linguaggio, una filosofia. eum > scienze della comunicazione
 Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum > scienze della comunicazione eum > scienze della comunicazione Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum isbn 978-88-6056-161-9
Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum > scienze della comunicazione eum > scienze della comunicazione Ruggero Morresi Neotopica: un linguaggio, una filosofia eum isbn 978-88-6056-161-9
Ruggero Bacone e la «Perspectiva» come scienza sperimentale
 INDICE Avvertenza alla seconda edizione Prefazione alla terza edizione xiii xv Introduzione 1 Roberto Grossatesta e la «Perspectiva» 9 La «Perspectiva» come scienza dimostrativa 9 Le Fonti 14 L'influenza
INDICE Avvertenza alla seconda edizione Prefazione alla terza edizione xiii xv Introduzione 1 Roberto Grossatesta e la «Perspectiva» 9 La «Perspectiva» come scienza dimostrativa 9 Le Fonti 14 L'influenza
PROGRAMMA DI STORIA. Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO
 PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-I fondamenti del potere 2.1-La signoria
PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-I fondamenti del potere 2.1-La signoria
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità
 Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
«Filosofia» Norme redazionali. Titolo paragrafo: Times New Roman, corpo 12, 2 righe vuote sopra, 1 riga vuota sotto, interlinea 1,5
 «Filosofia» Norme redazionali Regole generali Autore: Times New Roman, corpo 14, corsivo, interlinea 1,5 Titolo saggio: Times New Roman, corpo 14, grassetto, interlinea 1,5 Titolo paragrafo: Times New
«Filosofia» Norme redazionali Regole generali Autore: Times New Roman, corpo 14, corsivo, interlinea 1,5 Titolo saggio: Times New Roman, corpo 14, grassetto, interlinea 1,5 Titolo paragrafo: Times New
lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 Declinazione)
 māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
Descartes Meditazioni Metafisiche. Schema
 Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo
 1 Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Eadem anima rationalis ita unitur corpori, ut sit eiusdem forma substantialis unica, et per ipsam habet homo ut sit homo
1 Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Eadem anima rationalis ita unitur corpori, ut sit eiusdem forma substantialis unica, et per ipsam habet homo ut sit homo
LICEO STATALE A. VOLTA Colle di Val D Elsa Sezione Scientifica e Classica
 LICEO STATALE A. VOLTA Colle di Val D Elsa Sezione Scientifica e Classica RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CLASSE V SEZ F LICEO SCIENTIFICO DOCENTE SILVANA D AGOSTINO Per la classe, composta da 14 studenti
LICEO STATALE A. VOLTA Colle di Val D Elsa Sezione Scientifica e Classica RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CLASSE V SEZ F LICEO SCIENTIFICO DOCENTE SILVANA D AGOSTINO Per la classe, composta da 14 studenti
Liceo scientifico A. Righi Bologna a. s PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE FILOSOFIA
 Liceo scientifico A. Righi Bologna a. s. 16-17 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE FILOSOFIA 1. Competenze da acquisire nel corso del secondo biennio e dell ultimo anno Sviluppare l abitudine ad un approccio non
Liceo scientifico A. Righi Bologna a. s. 16-17 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE FILOSOFIA 1. Competenze da acquisire nel corso del secondo biennio e dell ultimo anno Sviluppare l abitudine ad un approccio non
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta
 BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale
 Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale Prof. Antonio Autiero Napoli, 20 settembre 2010 1 Alcune premesse I Il significato della fede per l etica II Fede
Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale Prof. Antonio Autiero Napoli, 20 settembre 2010 1 Alcune premesse I Il significato della fede per l etica II Fede
NUOVO CORSO DI TEOLOGIA MORALE
 NUOVO CORSO DI TEOLOGIA MORALE 5 Gianni Manzone TEOLOGIA MORALE ECONOMICA Queriniana Indice generale Introduzione generale.................................. 5 Abbreviazioni........................................
NUOVO CORSO DI TEOLOGIA MORALE 5 Gianni Manzone TEOLOGIA MORALE ECONOMICA Queriniana Indice generale Introduzione generale.................................. 5 Abbreviazioni........................................
Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento
 _ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
_ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE
 I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006].
![Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006]. Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006].](/thumbs/70/63692369.jpg) Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006]. M. Squillacciotti Anche per chi ha seguito le lezioni senesi
Jean-Marc Lévy-Leblond La velocità dell ombra Torino, Codice edizioni, 2007 Traduzione di F. Niola e V. Roncarolo [Editions du Seuil, 2006]. M. Squillacciotti Anche per chi ha seguito le lezioni senesi
CURRICULUM VITAE Dott. Massimiliano Lenzi
 CURRICULUM VITAE Dott. Massimiliano Lenzi Attuale posizione Cultore della Materia presso la cattedra di Storia della Filosofia Medievale della Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia.
CURRICULUM VITAE Dott. Massimiliano Lenzi Attuale posizione Cultore della Materia presso la cattedra di Storia della Filosofia Medievale della Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia.
1 Il linguaggio matematico
 1 Il linguaggio matematico 1.1 La logica delle proposizioni La matematica è un linguaggio; a differenza del linguaggio letterario che utilizza una logica soggettiva, la matematica si serve di una logica
1 Il linguaggio matematico 1.1 La logica delle proposizioni La matematica è un linguaggio; a differenza del linguaggio letterario che utilizza una logica soggettiva, la matematica si serve di una logica
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio
 Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
ETICA GENERALE ETICA
 ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Regione Siciliana
 I-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CLASSE III SEZ. A DOCENTE: Vincenzo Fusto MATERIA: Filosofia ANALISI DELLA CLASSE CONOSCENZE POSSESSO DEI PREREQUISITI COMPORTAMENTO SOCIALE
I-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CLASSE III SEZ. A DOCENTE: Vincenzo Fusto MATERIA: Filosofia ANALISI DELLA CLASSE CONOSCENZE POSSESSO DEI PREREQUISITI COMPORTAMENTO SOCIALE
DOGMA E REALTÀ CONTRIBUTI EPISTEMOLOGICI ALLA COMPRENSIONE DELLA BIOETICA
 DOGMA E REALTÀ CONTRIBUTI EPISTEMOLOGICI ALLA COMPRENSIONE DELLA BIOETICA 1 FILOSOFIA OGGETTO ESSERE CIÒ CHE È SOGGETTO RAPPRESENTAZIONE DELL ESSERE CIÒ CHE SI VEDE Il punto di unione tra i diversi elementi
DOGMA E REALTÀ CONTRIBUTI EPISTEMOLOGICI ALLA COMPRENSIONE DELLA BIOETICA 1 FILOSOFIA OGGETTO ESSERE CIÒ CHE È SOGGETTO RAPPRESENTAZIONE DELL ESSERE CIÒ CHE SI VEDE Il punto di unione tra i diversi elementi
LICEO SCIENTIFICO STATALE
 LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
Lezione Ragione critica e rivelazione
 Lezione Ragione critica e rivelazione percorsi 1 Lo scritto di I. Kant sulla religione 2 Religione o Rivelazione 3 Una questione insoluta? obiettivi Dalla domanda sulla realtà conoscibile alla questione
Lezione Ragione critica e rivelazione percorsi 1 Lo scritto di I. Kant sulla religione 2 Religione o Rivelazione 3 Una questione insoluta? obiettivi Dalla domanda sulla realtà conoscibile alla questione
La persona umana e i molteplici profili del suo mistero e della sua dignità
 La persona umana e i molteplici profili del suo mistero e della sua dignità don Paolo Fontana Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute Arcidiocesi di Milano 0. Introduzione ANTICHITÀ Persona
La persona umana e i molteplici profili del suo mistero e della sua dignità don Paolo Fontana Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute Arcidiocesi di Milano 0. Introduzione ANTICHITÀ Persona
Esame scritto dell Opzione specifica. Filosofia + Pedagogia/Psicologia
 Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di Immanuel
Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di Immanuel
Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE
 Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE Vita ARISTOTELE NACQUE A STAGIRA NEL NORD DELLA GRECIA NEL 384 A.C. NEL 367, ALL'ETÀ DI 17 ANNI, ANDÒ AD ATENE AL FINE DI ENTRARE A FAR PARTE DELL'ACCADEMIA DI
Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE Vita ARISTOTELE NACQUE A STAGIRA NEL NORD DELLA GRECIA NEL 384 A.C. NEL 367, ALL'ETÀ DI 17 ANNI, ANDÒ AD ATENE AL FINE DI ENTRARE A FAR PARTE DELL'ACCADEMIA DI
La fisica. Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto)
 La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi. Anno scolastico 2018/2019. Piano di lavoro per la classe III B Liceo linguistico
 Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi Anno scolastico 2018/2019 Piano di lavoro per la classe III B Liceo linguistico Materia: Filosofia Docente: Camilla Tinelli PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi Anno scolastico 2018/2019 Piano di lavoro per la classe III B Liceo linguistico Materia: Filosofia Docente: Camilla Tinelli PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Quaestio Annuario di Storia della Metafisica
 Quaestio Annuario di Storia della Metafisica Criteri editoriali Quaestio intende preservare un chiaro layout grafico che rispetti i migliori standard editoriali nella tradizione accademica europea. I contributori
Quaestio Annuario di Storia della Metafisica Criteri editoriali Quaestio intende preservare un chiaro layout grafico che rispetti i migliori standard editoriali nella tradizione accademica europea. I contributori
SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A COGNOME E NOME: D
 SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A. 2018-2019 COGNOME E NOME: D Arcangeli Marco Antonio QUALIFICA: Professore Associato SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/01, Pedagogia generale e sociale NOME INSEGNAMENTO:
SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A. 2018-2019 COGNOME E NOME: D Arcangeli Marco Antonio QUALIFICA: Professore Associato SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/01, Pedagogia generale e sociale NOME INSEGNAMENTO:
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
IMMANUEL KANT
 IMMANUEL KANT 1724-1804 Prof. Monti a.s. 2017-2018 Parte prima Kant prende le mosse dall Empirismo arrivando a elaborare il suo CRITICISMO (anche detto filosofia trascendentale o filosofia del limite )
IMMANUEL KANT 1724-1804 Prof. Monti a.s. 2017-2018 Parte prima Kant prende le mosse dall Empirismo arrivando a elaborare il suo CRITICISMO (anche detto filosofia trascendentale o filosofia del limite )
NON ENIM CORPUS SENTIT, SED ANIMA PER CORPUS. TOMMASO D AQUINO LETTORE DI AGOSTINO
 NON ENIM CORPUS SENTIT, SED ANIMA PER CORPUS. TOMMASO D AQUINO LETTORE DI AGOSTINO FABRIZIO AMERINI È forse superfluo ricordare l importanza di Agostino per Tommaso d Aquino. Nelle opere teologiche, Agostino
NON ENIM CORPUS SENTIT, SED ANIMA PER CORPUS. TOMMASO D AQUINO LETTORE DI AGOSTINO FABRIZIO AMERINI È forse superfluo ricordare l importanza di Agostino per Tommaso d Aquino. Nelle opere teologiche, Agostino
Quaestio 76 De unione animae ad corpus
 Quaestio 76 della Parte I della Summa Theologiae di San Tommaso d Aquino 1 A cura di Marcello Landi 2 Quaestio 76 De unione animae ad corpus Prooemium [31504] Iª q. 76 pr. Deinde considerandum est de unione
Quaestio 76 della Parte I della Summa Theologiae di San Tommaso d Aquino 1 A cura di Marcello Landi 2 Quaestio 76 De unione animae ad corpus Prooemium [31504] Iª q. 76 pr. Deinde considerandum est de unione
La filosofia. Storia della filosofia contemporanea
 La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del
 http://www.philolympia.org/ LA SCRITTURA FILOSOFICA IL TESTO ARGOMENTATIVO IL SAGGIO FILOSOFICO Un saggio filosofico consiste in una difesa ragionata di una determinata asserzione. Non può consistere nella
http://www.philolympia.org/ LA SCRITTURA FILOSOFICA IL TESTO ARGOMENTATIVO IL SAGGIO FILOSOFICO Un saggio filosofico consiste in una difesa ragionata di una determinata asserzione. Non può consistere nella
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE
 FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE
 GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE nato 1310/1315 legge e commenta le Sentenze a Parigi nel 1345 condannato nel 1346 morto probabilmente durante la grande peste del 1348/50 monaco cistercense
GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE nato 1310/1315 legge e commenta le Sentenze a Parigi nel 1345 condannato nel 1346 morto probabilmente durante la grande peste del 1348/50 monaco cistercense
L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi
 Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista. Se Dio esista
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE PER GRUPPI DIDATTICI
 TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE PER GRUPPI DIDATTICI MATERIA: I.R.C. CLASSI TERZE Obiettivi disciplinari * Contenuti o abilità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi Sapersi confrontare con i
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE PER GRUPPI DIDATTICI MATERIA: I.R.C. CLASSI TERZE Obiettivi disciplinari * Contenuti o abilità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi Sapersi confrontare con i
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
Curatela, traduzione, annotazione e commento scientifico di opere filosofiche
 Francesco Marrone - Pubblicazioni Curatela in collaborazione Opera Omnia di Descartes Descartes. Tutte le lettere 1619-1650, a cura di G. Belgioioso, con la collaborazionedi I. Agostini, F. Marrone, F.A.
Francesco Marrone - Pubblicazioni Curatela in collaborazione Opera Omnia di Descartes Descartes. Tutte le lettere 1619-1650, a cura di G. Belgioioso, con la collaborazionedi I. Agostini, F. Marrone, F.A.
Hume e Smith Filosofia e cittadinanza
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Hume e Smith Filosofia e cittadinanza Comprensione del testo 1. Quali caratteristiche e concetti accomunano la vita e il pensiero
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Hume e Smith Filosofia e cittadinanza Comprensione del testo 1. Quali caratteristiche e concetti accomunano la vita e il pensiero
ARISTOTELE ( a.c) Metafisica, libro I
 Tutti gli uomini desiderano per natura di conoscere : ne è prova il piacere che provano per le sensazioni che essi amano per se stesse, soprattutto quelle della vista questo perché la vista, tra i sensi,
Tutti gli uomini desiderano per natura di conoscere : ne è prova il piacere che provano per le sensazioni che essi amano per se stesse, soprattutto quelle della vista questo perché la vista, tra i sensi,
Traduzioni del testo da Saint Agostino, Il libero arbitrio, a cura di Rita Melillo (Roma: Città Nuova, 2011).
 De Libero Arbitrio AGIRE PER IL BENE (M215-14B) Traduzioni del testo da Saint Agostino, Il libero arbitrio, a cura di Rita Melillo (Roma: Città Nuova, 2011). Circostanze Conversazione fra Evodio e Agostino
De Libero Arbitrio AGIRE PER IL BENE (M215-14B) Traduzioni del testo da Saint Agostino, Il libero arbitrio, a cura di Rita Melillo (Roma: Città Nuova, 2011). Circostanze Conversazione fra Evodio e Agostino
PROGRAMMA CONSUNTIVO - FILOSOFIA Pag. 1/6
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V Ambito Territoriale Foggia LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO MARCONI SEDE ASSOCIATA DI
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V Ambito Territoriale Foggia LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO MARCONI SEDE ASSOCIATA DI
I NUMERI REALI E I RADICALI I PARTE
 I NUMERI REALI E I RADICALI I PARTE CLASSI III A E III B Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it INTRODUZIONE AI NUMERI IRRAZIONALI NOTA STORICA La teoria delle monadi è stata elaborata dai Pitagorici nel
I NUMERI REALI E I RADICALI I PARTE CLASSI III A E III B Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it INTRODUZIONE AI NUMERI IRRAZIONALI NOTA STORICA La teoria delle monadi è stata elaborata dai Pitagorici nel
Indice. Premessa 7. Parte I: Dalla narrazione al problema 11. Parte II: Testi 65
 Indice Premessa 7 Parte I: Dalla narrazione al problema 11 1. Una domanda preliminare: a che serve la storia della filosofia? 13 2. La storiografia filosofica nel suo farsi storico: dossografia e vite
Indice Premessa 7 Parte I: Dalla narrazione al problema 11 1. Una domanda preliminare: a che serve la storia della filosofia? 13 2. La storiografia filosofica nel suo farsi storico: dossografia e vite
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA. Facoltà di Filosofia
 CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA Facoltà di Filosofia PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA Facoltà di Filosofia PRESENTAZIONE La Facoltà di Filosofia dell Università Vita-Salute San Raffaele si trova in uno dei maggiori centri di ricerca europei, che pone la persona,
LICEO LINGUISTICO G. CARDUCCI CLASSE III E ANNO SCOLASTICO 2014/2015
 LICEO LINGUISTICO G. CARDUCCI CLASSE III E ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Docente: Malta Rosario Materia: Filosofia I. Obiettivi specifici in termini di competenze (conoscenze e abilità fondamentali) 1. Competenze
LICEO LINGUISTICO G. CARDUCCI CLASSE III E ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Docente: Malta Rosario Materia: Filosofia I. Obiettivi specifici in termini di competenze (conoscenze e abilità fondamentali) 1. Competenze
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
La questione degli universali. Sulle possibilità conoscitive della ragione
 La questione degli universali Sulle possibilità conoscitive della ragione Porfirio e Boezio Nel III sec. d. C. il filosofo neoplatonico Porfirio (allievo di Plotino) pubblica un testo che vuole introdurre
La questione degli universali Sulle possibilità conoscitive della ragione Porfirio e Boezio Nel III sec. d. C. il filosofo neoplatonico Porfirio (allievo di Plotino) pubblica un testo che vuole introdurre
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali
 S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra
 Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA. I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche
 ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131
 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
ANDREA COLLI. Cosa significa che l intelletto umano è «nobile»? Interpretazioni del De anima di Aristotele alla fine del XIII secolo
 Settignano (FI), 10-14 luglio 2012 Associazione Filosofia e cultura Summer School La natura umana ANDREA COLLI Cosa significa che l intelletto umano è «nobile»? Interpretazioni del De anima di Aristotele
Settignano (FI), 10-14 luglio 2012 Associazione Filosofia e cultura Summer School La natura umana ANDREA COLLI Cosa significa che l intelletto umano è «nobile»? Interpretazioni del De anima di Aristotele
Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006
 Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006 Comandamento di Dio Comandamento = mezzo per entrare nella Vita (quella vera quella eterna) => Costruire il Regno di
Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006 Comandamento di Dio Comandamento = mezzo per entrare nella Vita (quella vera quella eterna) => Costruire il Regno di
Tommaso e la dottrina delle relazioni sussistenti
 Giuseppe Bottarini Tommaso e la dottrina delle relazioni sussistenti 1. La nozione filosofica di relazione Per Aristotele la relazione è una delle categorie, cioè uno dei predicati generalissimi con cui
Giuseppe Bottarini Tommaso e la dottrina delle relazioni sussistenti 1. La nozione filosofica di relazione Per Aristotele la relazione è una delle categorie, cioè uno dei predicati generalissimi con cui
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine. Il conseguimento della beatitudine
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
Aristotele e Franklin Filosofia e cittadinanza
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Aristotele e Franklin Filosofia e cittadinanza Comprensione del testo 1. Per Aristotele che cosa significa che la schiavitù
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Aristotele e Franklin Filosofia e cittadinanza Comprensione del testo 1. Per Aristotele che cosa significa che la schiavitù
