Cambiamenti climatici e territorio.
|
|
|
- Lidia Castellani
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Milano, 30 marzo 2017 Bando Cariplo 2017 Progetti territoriali per la città di Milano e provincia Cambiamenti climatici e territorio. Linee guida e proposte operative della Città Metropolitana di Milano: Azioni pilota su quattro Zone Omogenee Proponenti del progetto Partner: Città Metropolitana di Milano (capofila) Area Tutela e Valorizzazione Ambientale (Maria Cristina Pinoschi, Giovanni Roberto Parma, Laura Zanetti, Katia Rossetto) Area Territorio (Emilio De Vita, Marco Felisa, Cinzia Cesarini, Antonietta Esposto) Politecnico di Milano, Dastu, (Eugenio Morello, Stefano Caserini ) Università Iuav di Venezia, Dppac, Planning&Climate Change Lab, (Francesco Musco) Supporto: Comune di Milano, Assessorato Ambiente AMAT CAP Holding Assolombarda Parole chiave: cambiamenti climatici, resilienza urbana, adattamento, mitigazione Durata: 12 mesi, 1 settembre agosto 2018 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO Costruzione di una roadmap verso la redazione di un piano clima per la Città Metropolitana di Milano. Il lavoro avrà l obiettivo di allineare il contesto locale della CMM al dibattito internazionale e ai nuovi temi della pianificazione climatica integrata alla pianificazione territoriale e spaziale e perseguire i target di riduzione delle emissioni di gas serra e di risposta all adattamento già stabiliti a livello internazionale. Nello specifico, a partire dall esperienza pianificatoria della CMM e dal capitale tecnico sui temi proposti, lo studio si prefigge di: (1) portare conoscenza e trasferire i temi del cambiamento climatico all'interno delle pratiche pianificatorie locali, rileggendo strumenti e piani nell ottica della resilienza territoriale; (2) comunicare e disseminare le sfide dei cambiamenti climatici alle popolazioni locali, definendo una strategia di comunicazione; (3) affrontare le sfide spaziali (pianificazione del territorio) e climatiche (pianificazione ambientale) in maniera integrata con obiettivi di efficacia. 1
2 I AMBITO DELL INTERVENTO \ CONTESTO PROGETTUALE OPPORTUNITÀ SU TRE DIMENSIONI OFFERTE DAL CONTESTO Il contesto progettuale offre diverse opportunità e dimostra la maturità e la contingenza dei temi affrontati dalla proposta. Facciamo riferimento a tre dimensioni principali di contesto, ovvero: (1) il contesto internazionale in tema di pianificazione climatica ed energetica; (2) il sistema di riferimento nazionale e locale; (3) l affondo specifico del tema alla scala della città metropolitana come contesto efficace per l azione. 1) Affermazione della pianificazione climatica ed energetica a livello internazionale Il cambiamento climatico è emerso come questione cruciale a partire dall inizio del XXI secolo. Secondo le previsioni dell International Panel for Climate Change, i fenomeni legati al cambiamento del clima si andranno intensificando nei prossimi decenni e gli eventi estremi legati al clima costituiranno un rischio crescente a livello sociale ed ecologico (Ipcc, 2007; 2012). L anno 2013 è stato considerato come uno spartiacque nel dibattito sul clima, dapprima per il superamento dello storico limite di concentrazione della CO 2 in atmosfera e successivamente con la presentazione del quinto rapporto dell Ipcc, che con nuove evidenze scientifiche ha evidenziato come i cambiamenti siano già in atto e quanto possano essere negativi gli scenari di aumento delle temperature per il prossimo secolo. Una pianificazione territoriale orientata ai cambiamenti climatici può essere elemento catalizzatori di un elevato interesse politico e pubblico tanto a livello internazionale e nazionale quanto a livello locale, visti gli impegni su scala globale assunti dopo la Cop 21 di Parigi nel 2015 (Accordo di Parigi), per il piano di azione che dovrà emergere dalla Cop 23 a Bonn che si terrà proprio nei primi mesi di attività di questo progetto di sperimentazione nell area metropolitana milanese. Specifico riferimento del progetto è rappresentato alla Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del 16 aprile COM (2013) 216 e dal programma dal nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l Energia (Mayor Adapt) che verrà sottoscritto dalla Città Metropolitana di Milano. Al contempo il progetto garantirà opportune sinergie anche con le iniziative in corso da parte di Regione Lombardia (specificatamente la Strategia Regionale di Adattamento) e la sperimentazione del progetto Life Master Adapt (sull area di Seveso, che seppure al di fuori della CM può rappresentare un rilevante caso di riferimento). Al contempo l iniziativa rientra i Sustainable Development Goals definiti dalle Nazioni Unite come obiettivi globali di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo del Millennio, scaduti alla fine del 2015, e sono validi per il periodo Sono previsti 17 obiettivi e 169 target specific: in particolare il progetto dà attuazione all obiettivo 11: Sustainable Cities and Communities - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. 2) Affermazione dei temi nel contesto nazionale e locale - Strategia Nazionale per l Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Il Documento di Azione Regionale per l adattamento al cambiamento climatico della Regione Lombardia, approvato con DGR n. 6028/ Legge Consumo di Suolo - Invarianza Idraulica - PAES Comune di Milano e dei comuni dell area metropolitana - PTCP Provincia di Milano - PIano Energetico Regionale e suoi aggiornamenti 2
3 3) Le opportunità offerte dal contesto attuale e specifico della CMM Le opportunità offerte dall istituzione della nuova Città Metropolitana sono molteplici: La volontà strategica e politica di integrare pianificazione territoriale ed ambientale: La definizione in ambito CMM delle aree omogenee (pattern) che richiedono una declinazione ambientale ed energetica (tassonomia delle azioni). La tradizione e la capacità tecnica della ex Provincia di Milano in materia di pianificazione ambientale e territoriale. La CMM è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/13 e vigente dal 19/03/14. L integrazione delle strategie ambientali ed energetiche da avviare con il futuro Piano Territoriale Milanese (PTM) a cura della CMM che sostituirà il PTCP e terrà conto del nuovo quadro legislativo nazionale che ha stabilito i ruoli e i compiti di pianificazione del territorio in capo alle Città metropolitane. Allo stesso modo, il PTM recepirà e declinerà alla scala locale le recenti normative regionali, quali la LR 31/2014 sul consumo di suolo e il conseguente adeguamento del Piano Territoriale Regionale. Il piano avrà come obiettivo quello di investigare e integrare i nuovi temi e le sfide ambientali legate alla mitigazione e all adattamento nella pianificazione Il piano sarà un riferimento per i Comuni della CMM e sarà quindi importante integrare e coordinare i temi della mitigazione e dell adattamento: definendo gli obiettivi in tal senso i Comuni saranno indirizzati e recepiranno le indicazioni del PTM all interno dei loro PGT. L adesione e l impegno preso a livello locale nelle reti e nei progetti di natura internazionale (Milano: 100RC, C40; Milano e Comuni della CMM: Covenant of Mayor (Patto dei Sindaci) & Mayors Adapt). L impegno verso l efficienza energetica del territorio. In particolare, l'area tutela e valorizzazione ambientale di CMM, mediante il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, è impegnata nell'attuazione di politiche, azioni e progetti tesi alla riduzione delle emissioni clima alteranti, all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati e allo sviluppo di interventi per la produzione di energia tradizionali e innovativi. Infatti, l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato è uno dei target europei sui quali il nostro paese, la Regione Lombardia e la Città metropolitana di Milano si è impegnata; si tratta di una grande opportunità di pari importanza rispetto alla promozione delle energie rinnovabile, che sono state già ampiamente incentivate. L'efficienza energetica è infatti un primo passo per costruire una città intelligente, uno strumento importante per diminuire l'impatto dei cambiamenti climatici e ridurre l'inquinamento atmosferico, per innovare complessivamente il nostro sistema produttivo e dei consumi civili, rendendo contemporaneamente più sicuro e meno costoso l'approvvigionamento dell'energia. Efficienza energetica significa vantaggi per l'amministrazione pubblica, le imprese, i cittadini, l'ambiente. Si tratta di un impegno win win che porta benefici a tutti gli attori coinvolti; spinge le imprese a investire sull'eco-sostenibilità del ciclo produttivo creando occupazione e contribuisce a far risparmiare le famiglie e la pubblica amministrazione. L'efficienza energetica negli edifici è un tema che da decenni (dall'entrata in vigore del DPR 412/93) la Città metropolitana di Milano ha individuato come primario nella strategia di risparmio, uso razionale dell'energia e contenimento dell'inquinamento atmosferico. A tal fine ha sviluppato una stretta sinergia con ENEA in merito, che si è rafforzata quest'anno mediante un accordo di collaborazione che vedrà ENEA presente con una propria sede territoriale regionale presso Città Metropolitana e che darà modo di ulteriormente rafforzare la sinergia dei due Enti sulle tematiche energetiche ed ambientali. La conoscenza: le banche dati a disposizione della CMM e del Comune di Milano; il volo fotogrammetrico ad alta precisione dal progetto europeo Decumanus; il recente completamento del database topografico (DBT) 3
4 mette a disposizione una fonte informativa omogenea, aggiornata e ricca di nuove chiavi di lettura delle dinamiche anche idrauliche e idrogeologiche, che potranno essere utilmente integrate ed analizzate per il presente lavoro. La CMM è parte del network +Community, ovvero un programma nato nel luglio 2015 dall impulso dell Area Tutela e valorizzazione ambientale della CMM che raduna attorno a sé soggetti pubblici, privati e di privato sociale che fanno comunità sui temi della sostenibilità, della fruibilità delle risorse ambientali e dell equità nella distribuzione dei beni ambientali (i partner oggi sono oltre a CMM: CAP Holding, Camera di Commercio di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, ARPA Lombardia, ENEA, Fondazione Triulza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Confservizi Cispel Lombardia). +Community mira a costituire una proposta aperta e uno strumento gratuito per condivisione le migliori risorse del partenariato, diffondere e incrementare le competenze del territorio metropolitano sulle diverse matrici ambientali, aumentando la trasparenza, la consapevolezza e la responsabilità sul bene comune. In particolare, + Community offre un percorso di life-long learning e attraverso l organizzazione di momenti formativi si è promosso l aggiornamento delle competenze del personale interno e di training per i Comuni, gli enti esterni e le imprese con l obiettivo di sostenere le loro attività in campo ambientale e migliorare i servizi resi ai cittadini e alle imprese. OGGETTO DELL INTERVENTO. IL CONTESTO DEL TERRITORIO E LA SELEZIONE DELLE QUATTRO ZONE OMOGENEE Perché le aree pilota? La selezione di aree pilota consentirà di effettuare un testing su aree della CMM con caratteristiche diverse; si tratta di una campionatura che potrà permettere al partenariato di calare lo studio e le azioni proposte su aree con diverse caratteristiche socio- demografiche, morfo-tipologiche e ambientali. Le aree pilota fungono quindi da test per poi allargare a conclusione del progetto a tutti i Comuni della CMM. Sulle aree si approfondiranno i piani e gli strumenti in essere, le cartografie e le banche dati presenti e utili ai fini dello studio e si attiveranno le attività di disseminazioni interne e pubbliche (vedi in seguito per i dettagli). Le aree pilota selezionate: quattro zone omogenee della Città Metropolitana La CMM è suddivisa in otto zone omogenee (Figura 1), di cui quattro saranno oggetto di studio del progetto, ovvero i Comuni afferenti alle seguenti zone omogenee: 1) Comune di Milano 2) Adda Martesana 3) Sud Est 4) Sud Ovest (senza i Comuni di Vernate, Binasco e Casarile) 4
5 Figura 1. La mappa della Città Metropolitana di Milano con l identificazione delle otto zone omogenee. II - OBIETTIVI DEL PROGETTO Le modalità di intervento e le azioni progettuali sono stabilite in linea con gli obiettivi di progetto. Il progetto identifica anzitutto obiettivi generali in cui lo studio si cala, in riferimento al contesto internazionale e locali. Gli obiettivi specifici consentono invece di definire le modalità d intervento e le azioni dettagliate. OBIETTIVI GENERALI Gli obiettivi generali riguardano i target più ampi in cui il progetto si inserisce, ovveroo le sfide attuali a livello internazionale e i filoni di sperimentazione e attuazione della ricerca scientifica. 1) In linea con la roadmap europea, lo studio proposto ha come obiettivo di esplorare e perseguire target in materia di mitigazione e adattamento alla scala locale della CMM (vedi tabella 1). 5
6 Tabella 1. Target temporali e misure di mitigazione e adattamento TARGET TEMPORALI MITIGAZIONE ADATTAMENTO Breve termine (2020) Medio termine (2030) -20% emissioni gas climalteranti (obiettivo definito da diversi PAES dei comuni della CMM, rispetto a diversi anni di riferimento) -40% - -50% emissioni gas climalteranti (aggregazione degli ambiti territoriali): da definire come nuovo obiettivo Attuazione di almeno il 20% delle misure di adattamento e loro connessione con la pianificazione urbanistica e territoriale su scala locale e metropolitana Attuazione di almeno il 40% delle misure di adattamento e loro connessione con la pianificazione urbanistica e territoriale su scala locale e metropolitana Lungo termine (2050) Decarbonizzazione 100% Attuazione completa (100%) delle misure di adattamento identificate dalla pianificazione metropolitana 2) Affrontare la sfida della dimensione spaziale delle strategie di mitigazione e dell adattamento ai cambiamenti climatici, ovvero integrare la pianificazione territoriale e la pianificazione energetico-ambientale. In particolare, il progetto si basa sui seguenti principi: a) La spazializzazione delle energie e delle azioni climatiche sono da riferirsi efficacemente alla scala della pianificazione e progettazione del territorio. La realizzazione di sinergie nell impostazione e realizzazione delle azioni mirano appunto a evitare di disperdere l impegno su scale troppo piccole o troppo ampie, con il rischio di ridurre l efficacia delle strategie. b) Le misure intraprese faranno riferimento a zone omogenee identificate sul territorio della CMM e saranno cucite sulle caratteristiche e condizioni specifiche dei tessuti del territorio. Le strategie, infatti, saranno tanto più efficaci quanto più saranno legate al contesto specifico di riferimento. OBIETTIVI SPECIFICI 1) Costruire conoscenza: a) Trasferire conoscenze in merito di pianificazione d azione climatica e di energia negli uffici tecnici dell istituzione CMM e nei Comuni (Approfondire e riportare il dibattito recente sui temi e le soluzioni per affrontare il CC nell ambito istituzionale della CMM) b) Avviare una fase di dibattito interno alle istituzioni pubbliche, in particolare CMM e Comuni afferenti al progetto. c) Disseminare conoscenza sul territorio mediante eventi pubblici e programmazione di campagne di formazione e di informazione.. 2) Dare maggiore rilevanza al tema urbano e spaziale nell ambito locale della CMM (la strategia regionale all adattamento non prende in considerazione le specificità locali) 3) Proporre nuove strategie di aggregazione intercomunale per affrontare la pianificazione energetica e ambientale. Non è infatti auspicabile uno spezzettamento e una riproposizione copia e incolla delle pianificazioni settoriali come avvenuto nel recente passato. A partire dalle otto zone omogenee e dai casi pilota selezionati, si valuteranno le possibili dimensioni aggregative inter-comunali. 4) Completare uno studio che generi un riferimento per la costruzione della normativa locale e per la verifica dei piani comunali. 6
7 5) Costituire uno studio di riferimento da integrare all interno del nuovo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) al fine di raggiungere una efficace integrazione delle strategie energetico-ambientale nella pianificazione. III - STRATEGIA D INTERVENTO Partendo dal bagaglio di conoscenze, piani e programmi già in essere, il progetto propone uno studio istruttorio alla redazione di un piano clima per la CMM. Non va infatti dimenticato che gli strumenti urbanistici e in generale di governo del territorio e dell ambiente (siano essi cogenti o volontari), in molti casi esistono piani e politiche che già trattano al loro interno tematiche legate al clima senza avere uno specifico riferimento nominale, come invece hanno i piani o le politiche di mitigazione\adattamento. Guardare attentamente fra la varietà di piani settoriali che esistono (Piano dei trasporti, Piani del verde pubblico, piani delle acque, Cycling Master Plan, ecc.), così come tra gli altri documenti di politica strategica (e.g. PTCP, Piano strategico metropolitano, ecc.) consentirà quindi una conoscenza di ciò che è in atto (anche se non con specifica volontà) e di come il tema del clima possa essere inserito o integrato in essi. In quest ottica si dimostra necessaria anche la coerenza con le politiche settoriali europee e le strategie e i piani nazionali (o regionali ove esistenti) di adattamento, (Baker e Eckerberg, 2009), al fine di garantire la buona riuscita di un piano locale, sfruttando le possibili sinergie tra livelli amministrativi ed evitando così potenziali conflitti e spreco di risorse (Bulkeley e Betsill,2005). Lo studio si comporrà di: 1. Ricostruzione del quadro conoscitivo in materia di: Mitigazione: monitoraggio dello stato di definizione e attuazione dei PAES presenti nella CMM oggi; Adattamento: monitoraggio delle azioni presenti negli strumenti urbanistici e linee guida locali; Piani e strumenti in vigore in tema ambientale al fine di constatarne l efficacia e le sinergie rispetto ai temi proposti. Nel dettaglio: La ricognizione delle azioni di mitigazione, in particolare: Il monitoraggio dei Piani per l Energia Sostenibile (PAES) sviluppati nei Comuni oggetto del progetto e l analisi delle principali azioni individuate in materia di efficientamento e risparmio energetico, riduzione delle emissioni climalteranti. La mappatura dei principali progetti di produzione di energia innovativa e rinnovabile sui territori analizzati. Lo stato di attuazione delle azioni di efficientamento energetico e climatizzazione degli edifici pubblici e privati e ricognizione di esperienze di eccellenza attuate e/o avviate. L Area Territorio in particolare si occuperà dell individuazione di politiche e azioni di breve, medio e lungo periodo per il risanamento e la qualificazione degli edifici esistenti e di spazi urbani, anche nell'ambito degli strumento di pianificazione territoriale sviluppati dai comuni (PGT), alla luce dei PAES predisposti e della prossima definizione di un piano di indirizzo metropolitano in materia di efficienza energetica e della definizione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Milano, ai sensi della vigente normativa. La ricognizione delle azioni di adattamento, in particolare: Linee guida promosse e adottate a livello locale Misure d intervento presenti in piani e progetti e regolamenti edilizi 7
8 2. Definizione della strategia complessiva e integrata tra risposte alla mitigazione e all adattamento. Un piano per l adattamento, anche se nella forma preliminare, si configura quindi come un piano strategico finalizzato a tracciare un quadro organico di riferimento tra tutte le azioni che insistono sullo stesso territorio comunale. Una delle principali criticità di un piano per l adattamento è proprio quella di integrare informazioni, conoscenze e dati raccolti da diverse istituzioni competenti e tradurle in un piano d azione che costruisca una strategia a lungo termine e sostenga azioni a medio-breve termine. L individuazione delle aree vulnerabili in campo urbano aiuta a determinare il rischio generato dagli impatti attesi. La principale complessità che si presenta in questa fase di analisi delle vulnerabilità è legata alla difficoltà di reperire informazioni utili a sostenere questo processo di analisi. La base informativa richiesta, infatti, non è solitamente prodotta per la stesura del quadro conoscitivo degli attuali strumenti di governo del territorio: informazioni come i mq di vegetazione, l altezza delle alberature, l incidenza solare, la permeabilità del suolo, ecc. non sono spesso disponibili a livello comunale. Trattare il problema del cambiamento climatico nelle attività di governo del territorio obbliga le PA a rivedere profondamente le modalità con le quali si producono, gestiscono, organizzano e diffondono le informazioni territoriali e ambientali. Sulle logiche tradizionali si inseriscono nuovi approcci di governance definibili come Open Governace, composta da strumenti e tecnologie che reggono una gestione smart, orientata verso un organizzazione aperta e trasparente (Maragno et al. 2014). A partire dalle zone omogenee selezionate, istruiremo il lavoro core del progetto, ovvero: Definizione del profilo climatico locale e dei possibili scenari futuri (sulla base di dati disponibili). Definizione della strategia tra pianificazione territoriale e protezione climatica (mitigazione&adattamento). Definizione di una tassonomia delle azioni di adattamento a partire dalle zone omogenee della CMM. Il prontuario è organizzato seguendo la logica: vulnerabilità/goal/target e azione collegata. Per rispondere ad una data vulnerabilità del territorio della città metropolitana, l amministrazione metropolitana si può prefiggere di raggiungere dei goal rappresentati da target (anche quantitativi) e azioni peculiari. La tassonomia illustrerà le strategie di adattamento secondo le caratteristiche urbanistiche delle aree omogenee che saranno prese in esame. 3. Disseminazione tra formazione e sensibilizzazione attraverso l attivazione e confronto con gli interlocutori del territorio (tecnici delle istituzioni pubblici, cittadini). Disseminazione interna (formazione) alle aree tecniche al fine di sensibilizzare e formare il personale tecnico rispetto alle nuove sfide del cambiamento climatico e delle azioni Disseminazione esterna (sensibilizzazione), ovvero la raccolta e promozione delle buone pratiche presenti oggi a livello metropolitano, e i risultati dello studio scientifico proposto, come base di riferimento per le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli interlocutori e della cittadinanza. Nello specifico si lavorerà all interlocuzione con i Comuni pilota e le istituzioni (incluse le università) attive alla scala locale 8
9 IV - ORGANIZZAZIONE E PARTENARIATO Il partenariato comprende enti pubblici e di ricerca al fine di integrare competenze multi-disciplinari, tecniche e scientifiche. I ruoli dei partner sono quindi definiti come segue. CAPOFILA \ Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Area Territorio (CMM) Il partner capofila si impegnerà principalmente a: Coordinare le attività di progetto In particolare, l'area tutela e valorizzazione ambientale della CMM, mediante il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia si impegnerà ad attuare un lavoro di ricognizione, approfondimento e specificazione nell'ambito territoriale prescelto per la definizione del progetto in esame. La ricognizione dello stato dell arte potrà essere impiegato per la fase di sensibilizzazione e disseminazione, in sinergia con il network +Community, ovvero: CMM supporterà gli altri partner con la fornitura dati a disposizione ed eventuali elaborazioni cartografiche specifiche e di servizio al progetto. PARTNER 1 \ Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (POLIMI) Mitigazione: analisi delle azioni di mitigazione oggi presenti sul territorio al fine di mappare gli impegni presi e i risultati ottenuti a livello locale A partire dalla ricognizione, si delinea una roadmap con la di definizione dei target di riduzione delle emissioni di anidride carbonica per il futuro (a breve, medio e lungo termine). Adattamento: costruzione della metodologia e della strategia territoriale ed ambientale Costruzione di una tassonomia e spazializzazione di un abaco delle azioni di adattamento con particolare riferimento alle aree omogenee identificate dalla pianificazione territoriale (con IUAV) Studio critico delle sinergie e conflitti tra azioni di mitigazione e adattamento verso un approccio unitario della pianificazione energetica e climatica (con IUAV) Interlocuzione, confronto ed esplorazione di possibili sinergie con enti di ricerca nazionali e internazionali e progetti di ricerca affini (per esempio il CMCC convenzionato al Politecnico) Disseminazione scientifica degli esiti del lavoro PARTNER 2 \ Università Iuav di Venezia, Planning&Climate Change Lab (IUAV) ( Supporto alla Costruzione della strategia di adattamento ed integrazione nella pianificazione vigente (ordinaria e settoriale) Costruzione di una tassonomia e spazializzazione di un abaco delle azioni di adattamento con particolare riferimento alle aree omogenee identificate dalla pianificazione territoriale (con POLIMI) Progettazione delle soluzioni di adattamento win win (favorendo la resilienza rispetto diversi impatti plausibili) Studio critico delle sinergie e conflitti tra azioni di mitigazione e adattamento verso un approccio unitario della pianificazione energetica e climatica (con POLIMI) Interlocuzione, confronto ed esplorazione di possibili sinergie con enti di ricerca nazionali e internazionali e progetti di ricerca affini (per esempio l attivazione iniziative congiunte con il progetto LIfe + MAster Adapt in partenariato con Regione Lombardia) Disseminazione scientifica degli esiti del lavoro 9
10 SUPPORTER 1 \ Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) fornitura informazioni, dati ed elaborazioni cartografiche a disposizione (in particolare PAES e Mayor Adapt del Comune di Milano) SUPPORTER 2 \ CAP Holding Il gestore del ciclo idrico integrato per la CMM darà un supporto alla ricostruzione del quadro e della strategia metropolitana di gestione delle acque Mette a disposizione informazioni relative alle strategie sulla gestione delle acque al fine di ottimizzare la conservazione della risorse e i dati relative alla qualità delle acque di approvvigionamento e distribuite nella CMM. Fornitura informazioni e dati sulla gestione delle acque metropolitane, soprattutto nei Comuni pilota oggetto dello studio proposto SUPPORTER 3 \ Assolombarda Interlocuzione e coinvolgimento con attori privati per sensibilizzare sul tema dell adattamento e della mitigazione Esplorazione delle opportunità di business in tema di green job Esplorazione degli strumenti finanziari per accelerare gli investimenti per l adattamento. 10
COVENANT CAPACITY GIORNATE DI FORMAZIONE
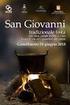 COVENANT CAPACITY GIORNATE DI FORMAZIONE Il Patto dei Sindaci: opportunità di crescita e riconversione per le città del futuro SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), 6-7.02.2014 Con il patrocinio di WORKSHOP IEE
COVENANT CAPACITY GIORNATE DI FORMAZIONE Il Patto dei Sindaci: opportunità di crescita e riconversione per le città del futuro SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), 6-7.02.2014 Con il patrocinio di WORKSHOP IEE
Infoday Programma Spazio Alpino 2014-2020
 Infoday Programma Spazio Alpino 2014-2020 Il Programma e le sue Priorità Milano 04 marzo 2016 Leonardo La Rocca Italian National Contact Point This programme is co- financed by the European Regional Development
Infoday Programma Spazio Alpino 2014-2020 Il Programma e le sue Priorità Milano 04 marzo 2016 Leonardo La Rocca Italian National Contact Point This programme is co- financed by the European Regional Development
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell Ambiente. Deliberazione del 22.12.2003, n. 47/13
 Deliberazione del 22.12.2003, n. 47/13 Oggetto: Adesione della Regione Sardegna alla Campagna UE per il decollo delle Fonti Energetiche Rinnovabili. Programmazione delle attività U.P.B.S05.075 Capitolo
Deliberazione del 22.12.2003, n. 47/13 Oggetto: Adesione della Regione Sardegna alla Campagna UE per il decollo delle Fonti Energetiche Rinnovabili. Programmazione delle attività U.P.B.S05.075 Capitolo
L ORGANIZZAZIONE ZONALE DI ASSOLOMBARDA per una presenza capillare sui 189 Comuni. 26 comuni 482 imprese 26.115 dipendenti
 LA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI E IMPRESE PER LA SICUREZZA URBANA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SUD MILANO Paolo Maria Montalbetti Presidente di zona Sud Assolombarda 23 marzo 2007 L ORGANIZZAZIONE ZONALE
LA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI E IMPRESE PER LA SICUREZZA URBANA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SUD MILANO Paolo Maria Montalbetti Presidente di zona Sud Assolombarda 23 marzo 2007 L ORGANIZZAZIONE ZONALE
IL RUOLO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE PER IL PATTO DEI SINDACI. Arch. Paola Giannarelli
 IL RUOLO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE PER IL PATTO DEI SINDACI Arch. Paola Giannarelli I NUMERI DEL PATTO 5396 FIRMATARI 176 milioni Cittadini coinvolti 231 Regioni, province e reti di supporto 49 Paesi
IL RUOLO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE PER IL PATTO DEI SINDACI Arch. Paola Giannarelli I NUMERI DEL PATTO 5396 FIRMATARI 176 milioni Cittadini coinvolti 231 Regioni, province e reti di supporto 49 Paesi
Istituzioni e Territori
 Istituzioni e Territori Obiettivo Ristrutturare l attuale offerta dei servizi ICT a supporto dell Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico attraverso la realizzazione di un quadro organico di interventi
Istituzioni e Territori Obiettivo Ristrutturare l attuale offerta dei servizi ICT a supporto dell Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico attraverso la realizzazione di un quadro organico di interventi
La certificazione ambientale come opportunità per una gestione partecipata e in qualità delle aree protette
 Agenda 21 Locale EMAS: qualità, innovazione, partecipazione per un futuro sostenibile La certificazione ambientale come opportunità per una gestione partecipata e in qualità delle aree protette Lucia Naviglio,
Agenda 21 Locale EMAS: qualità, innovazione, partecipazione per un futuro sostenibile La certificazione ambientale come opportunità per una gestione partecipata e in qualità delle aree protette Lucia Naviglio,
Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali
 Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali Leonardo Di Maggio Consulente Sogesid presso la Direzione Generale per la Salvaguardia
Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali Leonardo Di Maggio Consulente Sogesid presso la Direzione Generale per la Salvaguardia
IL PROGETTO COOPENERGY: LA GOVERNANCE MULTI-LIVELLO NELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA
 IL PROGETTO COOPENERGY: LA GOVERNANCE MULTI-LIVELLO NELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA Maria Fabianelli, Direttore Divisione Energia Convegno «Le Nuove politiche energetiche in Liguria» Genova - 30 marzo
IL PROGETTO COOPENERGY: LA GOVERNANCE MULTI-LIVELLO NELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA Maria Fabianelli, Direttore Divisione Energia Convegno «Le Nuove politiche energetiche in Liguria» Genova - 30 marzo
L approccio unitario alla programmazione dei Fondi Europei in Emilia-Romagna
 L approccio unitario alla programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei in Emilia-Romagna Caterina Brancaleoni Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Le novità della nuova programmazione
L approccio unitario alla programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei in Emilia-Romagna Caterina Brancaleoni Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Le novità della nuova programmazione
Attività PAES del Comune di Parma Arch. Enzo Bertolotti Comune di Parma
 Arch. Enzo Bertolotti Comune di Parma Il Comune di Parma ha aderito nel maggio 2013 al Patto dei Sindaci. PAES: strumento privilegiato per portare la città di Parma a traguardare gli obiettivi definiti
Arch. Enzo Bertolotti Comune di Parma Il Comune di Parma ha aderito nel maggio 2013 al Patto dei Sindaci. PAES: strumento privilegiato per portare la città di Parma a traguardare gli obiettivi definiti
Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia
 Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia Primi Orientamenti Comitato permanente di promozione del turismo in Italia Riunione del 13 gennaio 2016, Roma Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo
Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia Primi Orientamenti Comitato permanente di promozione del turismo in Italia Riunione del 13 gennaio 2016, Roma Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo
CITTADINANZA ATTIVA. Pianificazione Consapevole e Condivisa CONSULTAZIONE PUBBLICA
 COMUNE DI NOVOLI ASSESSORATO ALL URBANISTICA UFFICIO DEL PIANO Coord.Resp. Arch. Giuseppe Chiriatti PIANO URBANISTICO GENERALE URBANISTICA PARTECIPATA Per uno sviluppo condiviso del nostro Territorio A
COMUNE DI NOVOLI ASSESSORATO ALL URBANISTICA UFFICIO DEL PIANO Coord.Resp. Arch. Giuseppe Chiriatti PIANO URBANISTICO GENERALE URBANISTICA PARTECIPATA Per uno sviluppo condiviso del nostro Territorio A
La pianificazione urbanistica in Toscana: Il Piano di indirizzo territoriale PIT
 Università di Pisa Facoltà di Ingegneria AA 2014/2015 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA Luisa Santini TECNICA URBANISTICA I La pianificazione urbanistica in Toscana: Il Piano di indirizzo
Università di Pisa Facoltà di Ingegneria AA 2014/2015 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA Luisa Santini TECNICA URBANISTICA I La pianificazione urbanistica in Toscana: Il Piano di indirizzo
ALLEGATOB alla Dgr n. 827 del 31 maggio 2016 pag. 1/5
 giunta regionale 10^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 827 del 31 maggio 2016 pag. 1/5 POR, parte FESR, 2014-2020 ASSE 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO AUMENTO DELL INCIDENZA
giunta regionale 10^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 827 del 31 maggio 2016 pag. 1/5 POR, parte FESR, 2014-2020 ASSE 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO AUMENTO DELL INCIDENZA
PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile BRESCIA 2016-2026
 PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile BRESCIA 2016-2026 INTRODUZIONE AL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI BRESCIA Assessorato alle Politiche della Mobilità e ai Servizi Istituzionali Settore Mobilità,
PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile BRESCIA 2016-2026 INTRODUZIONE AL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI BRESCIA Assessorato alle Politiche della Mobilità e ai Servizi Istituzionali Settore Mobilità,
Enti locali e politiche per la sostenibilità 29 novembre 2011 Trento
 Enti locali e politiche per la sostenibilità 29 novembre 2011 Trento La carta Audis ed il progetto Eco Quartieri www.gbcitalia.org Obiettivi della proposta Ecoquartieri Riequilibrare i centri urbani restituendogli
Enti locali e politiche per la sostenibilità 29 novembre 2011 Trento La carta Audis ed il progetto Eco Quartieri www.gbcitalia.org Obiettivi della proposta Ecoquartieri Riequilibrare i centri urbani restituendogli
MANUALE DELLA QUALITA' Rif. norma UNI EN ISO 9004:2009 TAVOLO DI BENCHMARKING
 MANUALE DELLA QUALITA' Rif. norma UNI EN ISO 9004:2009 TAVOLO DI BENCHMARKING ISTITUTO COMPRENSIVO Emanuele Falcetti Apice (Benevento) a. s. 2009/2010 MANUALE DELLA QUALITA' Rif. norma UNI EN ISO 9004:2009
MANUALE DELLA QUALITA' Rif. norma UNI EN ISO 9004:2009 TAVOLO DI BENCHMARKING ISTITUTO COMPRENSIVO Emanuele Falcetti Apice (Benevento) a. s. 2009/2010 MANUALE DELLA QUALITA' Rif. norma UNI EN ISO 9004:2009
Considerazioni di carattere ambientale e appalti pubblici nel diritto interno: TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE
 TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE L. n. 296/2006: art. 1, comma 1126: l attuazione e il monitoraggio di un Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE L. n. 296/2006: art. 1, comma 1126: l attuazione e il monitoraggio di un Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Il progetto U-GOV Contabilità al Politecnico di Torino. Approccio e pianificazione, fattori di complessità e punti di attenzione
 Il progetto U-GOV Contabilità al Politecnico di Torino Approccio e pianificazione, fattori di complessità e punti di attenzione Mario Ravera Bologna, 9 marzo 2010 Indice Premessa e contesto: il Piano dei
Il progetto U-GOV Contabilità al Politecnico di Torino Approccio e pianificazione, fattori di complessità e punti di attenzione Mario Ravera Bologna, 9 marzo 2010 Indice Premessa e contesto: il Piano dei
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E
 PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 - ASSE E Progetto Performance PA Ambito B - Linea 2 Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale Seminario Il sistema di
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 - ASSE E Progetto Performance PA Ambito B - Linea 2 Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale Seminario Il sistema di
GAL MOLISE VERSO IL 2000
 GAL MOLISE VERSO IL 2000 SEMINARIO SULL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I PROGETTI ERASMUS +: CLIMALL E C4ET UNIMOL 01/04/2016 CONTESTO DI ATTUAZIONE COP 21 Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici. Accordo
GAL MOLISE VERSO IL 2000 SEMINARIO SULL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I PROGETTI ERASMUS +: CLIMALL E C4ET UNIMOL 01/04/2016 CONTESTO DI ATTUAZIONE COP 21 Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici. Accordo
Verso una nuova efficienza energetica: cosa dicono le aziende e quali sono le opportunità? I risultati della ricerca DNV GL e GFK Eurisko
 Verso una nuova efficienza energetica: cosa dicono le aziende e quali sono le opportunità? I risultati della ricerca DNV GL e GFK Eurisko Zeno Beltrami 1 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL Con l obiettivo
Verso una nuova efficienza energetica: cosa dicono le aziende e quali sono le opportunità? I risultati della ricerca DNV GL e GFK Eurisko Zeno Beltrami 1 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL Con l obiettivo
Lo Sportello Appalti Imprese: la visione strategica. Maria Paola Corona Presidente di Sardegna Ricerche
 Lo Appalti Imprese: la visione strategica Maria Paola Corona Presidente di Sardegna Ricerche CHI SIAMO Sardegna Ricerche: dove la ricerca diventa impresa Sardegna Ricerche è l ente regionale per la promozione
Lo Appalti Imprese: la visione strategica Maria Paola Corona Presidente di Sardegna Ricerche CHI SIAMO Sardegna Ricerche: dove la ricerca diventa impresa Sardegna Ricerche è l ente regionale per la promozione
https://sviluppo.toscana.it/pasl/print.php?quadro=1&id_pasl=5&id... PATTO PER LO SVILUPPO LOCALE DI AREZZO
 Modulo per la presentazione di progetti (Infrastrutture) inseriti nei Patti per lo Sviluppo Locale (PASL) PATTO PER LO SVILUPPO LOCALE DI AREZZO SCHEDA PROGETTUALE n. 2009AR0698 Alla Regione Toscana Area
Modulo per la presentazione di progetti (Infrastrutture) inseriti nei Patti per lo Sviluppo Locale (PASL) PATTO PER LO SVILUPPO LOCALE DI AREZZO SCHEDA PROGETTUALE n. 2009AR0698 Alla Regione Toscana Area
Albano Laziale, 6 maggio 2015
 Il progetto Open Data e l'agenda Digitale Regionale Luisa Romano Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale Regione Lazio Albano Laziale, 6 maggio 2015 L Agenda Digitale
Il progetto Open Data e l'agenda Digitale Regionale Luisa Romano Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale Regione Lazio Albano Laziale, 6 maggio 2015 L Agenda Digitale
REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA
 COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 17 del 28/04/1997 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 10 del
COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 17 del 28/04/1997 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 10 del
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA
 LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA Contesto della politica Dati internazionali mostrano che le
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O DISABILITÀ ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SINTESI DELLA POLITICA Contesto della politica Dati internazionali mostrano che le
Nutrire Milano Energie per il cambiamento Il progetto dei nuovi connotati territoriali milanesi
 Nutrire Milano Energie per il cambiamento Slow Food Italia promuove il progetto Nutrire Milano, energie per il cambiamento, come intervento di riqualificazione agricola del territorio, educazione alimentare
Nutrire Milano Energie per il cambiamento Slow Food Italia promuove il progetto Nutrire Milano, energie per il cambiamento, come intervento di riqualificazione agricola del territorio, educazione alimentare
Osservatorio sulla Green Economy
 Osservatorio sulla Green Economy Edoardo Croci, Fabio Iraldo IEFE Bocconi Milano, 16 settembre 2013 1 Struttura dell Osservatorio L Osservatorio è articolato in due aree: Policy, che valuta gli approcci
Osservatorio sulla Green Economy Edoardo Croci, Fabio Iraldo IEFE Bocconi Milano, 16 settembre 2013 1 Struttura dell Osservatorio L Osservatorio è articolato in due aree: Policy, che valuta gli approcci
Michele Cagliani, Divisione Valutazioni Ambientali. 28 Marzo 2012
 La Pianificazione dell illuminazione pubblica comunale e i finanziamenti della Regione del Veneto Michele Cagliani, Divisione Valutazioni Ambientali 28 Marzo 2012 Venezia INDICE DELLA PRESENTAZIONE INDICE
La Pianificazione dell illuminazione pubblica comunale e i finanziamenti della Regione del Veneto Michele Cagliani, Divisione Valutazioni Ambientali 28 Marzo 2012 Venezia INDICE DELLA PRESENTAZIONE INDICE
PUMS per MILANO Politiche e modelli europei Patrizia Malgieri TRT Trasporti e Territorio PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE MILANO Milano, 03 07 2013
 PUMS per MILANO Politiche e modelli europei Patrizia Malgieri TRT Trasporti e Territorio PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE MILANO Milano, 03 07 2013 PUMS per MILANO Politiche e modelli europei 1. Il perché
PUMS per MILANO Politiche e modelli europei Patrizia Malgieri TRT Trasporti e Territorio PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE MILANO Milano, 03 07 2013 PUMS per MILANO Politiche e modelli europei 1. Il perché
Il contributo dei nuovi modelli di insediamento produttivo agli obiettivi di rigenerazione urbana. Paola Gallo
 Il contributo dei nuovi modelli di insediamento produttivo agli obiettivi di rigenerazione urbana Paola Gallo Background..Il futuro non è la negazione della tradizione o della memoria storica di un popolo,
Il contributo dei nuovi modelli di insediamento produttivo agli obiettivi di rigenerazione urbana Paola Gallo Background..Il futuro non è la negazione della tradizione o della memoria storica di un popolo,
PROTOCOLLO D INTESA. tra
 PROTOCOLLO D INTESA tra Il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (di seguito MIPAAF ), con sede in Via XX Settembre, n. 20-00187 Roma, rappresentato dal Capo del Dipartimento delle
PROTOCOLLO D INTESA tra Il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (di seguito MIPAAF ), con sede in Via XX Settembre, n. 20-00187 Roma, rappresentato dal Capo del Dipartimento delle
Il Progetto GreenBike
 AEREL CIRPS UNITÀ DI RICERCA APPLICAZIONI ENERGETICHE RINNOVABILI PER GLI EE.LL. SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Il CIRPS - Direzione e Amministrazione Piazza San Pietro in Vincoli, 10-00184 Roma - Italy Unità
AEREL CIRPS UNITÀ DI RICERCA APPLICAZIONI ENERGETICHE RINNOVABILI PER GLI EE.LL. SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Il CIRPS - Direzione e Amministrazione Piazza San Pietro in Vincoli, 10-00184 Roma - Italy Unità
TORINO SOSTENIBILE: DAL PATTO DEI SINDACI A SMART CITY. Torino, 11 marzo 2011
 TORINO SOSTENIBILE: DAL PATTO DEI SINDACI A SMART CITY Torino, 11 marzo 2011 PATTO DEI SINDACI Iniziativa lanciata dalla Commissione Europea il 29 gennaio 2008 a Bruxelles. Il Patto dei Sindaci impegna
TORINO SOSTENIBILE: DAL PATTO DEI SINDACI A SMART CITY Torino, 11 marzo 2011 PATTO DEI SINDACI Iniziativa lanciata dalla Commissione Europea il 29 gennaio 2008 a Bruxelles. Il Patto dei Sindaci impegna
Autorità di bacino del fiume Po
 Autorità di bacino del fiume Po incontro delle Reti Locali interessate da processi di pianificazione strategica partecipata per la riqualificazione dei bacini fluviali Fare meglio con meno Francesco Puma
Autorità di bacino del fiume Po incontro delle Reti Locali interessate da processi di pianificazione strategica partecipata per la riqualificazione dei bacini fluviali Fare meglio con meno Francesco Puma
CASCINA TRIULZA DOPO EXPO MILANO 2015 LAB-HUB: UN PARCO PER L INNOVAZIONE SOCIALE
 CASCINA TRIULZA DOPO EXPO MILANO 2015 LAB-HUB: UN PARCO PER L INNOVAZIONE SOCIALE LAB-HUB: UN PARCO PER L INNOVAZIONE SOCIALE Un parco di sviluppo sull innovazione sociale dedicato a imprese sociali, cooperative,
CASCINA TRIULZA DOPO EXPO MILANO 2015 LAB-HUB: UN PARCO PER L INNOVAZIONE SOCIALE LAB-HUB: UN PARCO PER L INNOVAZIONE SOCIALE Un parco di sviluppo sull innovazione sociale dedicato a imprese sociali, cooperative,
IL PATTO DEI SINDACI: L INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI DEL COMUNE DI VERBANIA. II incontro del gruppo di lavoro Verbania 23 marzo 2015
 IL PATTO DEI SINDACI: L INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI DEL COMUNE DI VERBANIA II incontro del gruppo di lavoro Verbania 23 marzo 2015 SPES Consulting srl Ing. Adriano PESSINA Arch. Andrea Ammenti Le
IL PATTO DEI SINDACI: L INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI DEL COMUNE DI VERBANIA II incontro del gruppo di lavoro Verbania 23 marzo 2015 SPES Consulting srl Ing. Adriano PESSINA Arch. Andrea Ammenti Le
Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 LE VALUTAZIONI DEI PROGRAMMI OPERATIVI PER L ISTRUZIONE 2007/2013
 Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 LE VALUTAZIONI DEI PROGRAMMI OPERATIVI PER L ISTRUZIONE 2007/2013 N. STATO TITOLO OGGETTO 1 Conclusa 2 Conclusa 4 Conclusa 5 Conclusa Fase 1 Pilota -
Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 LE VALUTAZIONI DEI PROGRAMMI OPERATIVI PER L ISTRUZIONE 2007/2013 N. STATO TITOLO OGGETTO 1 Conclusa 2 Conclusa 4 Conclusa 5 Conclusa Fase 1 Pilota -
Il ruolo e le attività della Regione Piemonte. ing. Salvatore La Monica
 Il ruolo e le attività della Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Promozione della salute ed interventi di prevenzione individuale e collettiva Corso Regina Margherita 153 bis Torino Il D.Lgs. 81/08
Il ruolo e le attività della Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Promozione della salute ed interventi di prevenzione individuale e collettiva Corso Regina Margherita 153 bis Torino Il D.Lgs. 81/08
1ª Giornata delle buone prassi per l integrazione delle conoscenze e competenze del Ministero della Salute (Attuazione Legge 38/2010)
 21 novembre 2013 1ª Giornata delle buone prassi per l integrazione delle conoscenze e competenze del Ministero della Salute (Attuazione Legge 38/2010) CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2013 AI SENSI DELLA LEGGE
21 novembre 2013 1ª Giornata delle buone prassi per l integrazione delle conoscenze e competenze del Ministero della Salute (Attuazione Legge 38/2010) CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2013 AI SENSI DELLA LEGGE
Corsi per le Residenze assistenziali
 CEREF Centro Ricerca e Formazione Padova www.ceref.it Corsi per le Residenze assistenziali - 2014 Presentazione CEREF opera dal 1981 nel campo della formazione, della ricerca e della consulenza nei servizi
CEREF Centro Ricerca e Formazione Padova www.ceref.it Corsi per le Residenze assistenziali - 2014 Presentazione CEREF opera dal 1981 nel campo della formazione, della ricerca e della consulenza nei servizi
Verona, 16 febbraio Marco Cavallo, Regione Lombardia - D.G. Sanità
 L impegno della Regione Lombardia nella formazione continua del personale SSR: il sistema lombardo di ECM/CPD Verona, 16 febbraio 2007 Marco Cavallo, Regione Lombardia - D.G. Sanità La previsione normativa:
L impegno della Regione Lombardia nella formazione continua del personale SSR: il sistema lombardo di ECM/CPD Verona, 16 febbraio 2007 Marco Cavallo, Regione Lombardia - D.G. Sanità La previsione normativa:
NETWORK LOGOS PA SCOPRI CHE COSA VUOL DIRE ESSERE ADERENTE SERVIZI ESCLUSIVI E PROMOZIONI ANNO IN CORSO
 NETWORK LOGOS PA SCOPRI CHE COSA VUOL DIRE ESSERE ADERENTE SERVIZI ESCLUSIVI E PROMOZIONI ANNO IN CORSO e per i piccolissimi? Adesione gratuita La Fondazione Logos PA, grazie alla sua decennale attività
NETWORK LOGOS PA SCOPRI CHE COSA VUOL DIRE ESSERE ADERENTE SERVIZI ESCLUSIVI E PROMOZIONI ANNO IN CORSO e per i piccolissimi? Adesione gratuita La Fondazione Logos PA, grazie alla sua decennale attività
SEGRETARIO GENERALE AREA STRATEGICA: AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, CITTADINI, TRASPARENZA E DIALOGO
 AREA STRATEGICA: AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, CITTADINI, TRASPARENZA E DIALOGO Responsabile di riferimento Dr. Luigi Di Natale Area strategica di riferimento (da AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, CITTADINI, TRASPARENZA
AREA STRATEGICA: AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, CITTADINI, TRASPARENZA E DIALOGO Responsabile di riferimento Dr. Luigi Di Natale Area strategica di riferimento (da AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, CITTADINI, TRASPARENZA
STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE
 STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) che, all art. 14, dispone
STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) che, all art. 14, dispone
Piano annuale per la formazione del personale operante nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione - Anno 2014 -
 ALLEGATO N.3 Piano annuale per la formazione del personale operante nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione - Anno 2014 - Indice 1. Premessa 2. Linee guida 3. Materie oggetto di formazione
ALLEGATO N.3 Piano annuale per la formazione del personale operante nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione - Anno 2014 - Indice 1. Premessa 2. Linee guida 3. Materie oggetto di formazione
Misura M19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER (da art. 42 a 44) Interventi
 M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (da art. 42 a 44) Interventi 19.1.1 Sostegno preparatorio 19.2.1 Sostegno all esecuzione degli interventi nell ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (da art. 42 a 44) Interventi 19.1.1 Sostegno preparatorio 19.2.1 Sostegno all esecuzione degli interventi nell ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
Descrizione del fabbisogno e definizione dell oggetto dell incarico
 Allegato n. 2 Fabbisogno Assistenza Tecnica all attuazione dell Accordo di Partenariato Fabbisogno di n. 7 esperti per attività di assistenza tecnica di supporto all Agenzia per la Coesione Territoriale
Allegato n. 2 Fabbisogno Assistenza Tecnica all attuazione dell Accordo di Partenariato Fabbisogno di n. 7 esperti per attività di assistenza tecnica di supporto all Agenzia per la Coesione Territoriale
Descrittori sotto ambito a1
 ALLEGATO 1 Ambiti di Legge e sotto ambiti (Legge 107/15) Indicatori Descrittori Descrittori sotto ambito a1 volti ad evidenziare la qualità dell insegnamento ambito a) l. 107/15: qualità dell insegnamento
ALLEGATO 1 Ambiti di Legge e sotto ambiti (Legge 107/15) Indicatori Descrittori Descrittori sotto ambito a1 volti ad evidenziare la qualità dell insegnamento ambito a) l. 107/15: qualità dell insegnamento
La valutazione delle posizioni al Politecnico di Milano
 Scuola di Management per le Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni Scolastiche La valutazione delle posizioni al Politecnico di Milano Dott. Responsabile Servizio Organizzazione e Sviluppo Struttura
Scuola di Management per le Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni Scolastiche La valutazione delle posizioni al Politecnico di Milano Dott. Responsabile Servizio Organizzazione e Sviluppo Struttura
Udine Fiere dal 23 al 26 gennaio Orario 9.30/ pag. 1/6 segue >>
 Udine Fiere dal 23 al 26 gennaio 2014 Orario 9.30/18.30 pag. 1/6 segue >> L edizione di Agriest con focus su territorio e tutela dell ambiente Interazione tra paesaggio urbano e extraurbano Tutela dell
Udine Fiere dal 23 al 26 gennaio 2014 Orario 9.30/18.30 pag. 1/6 segue >> L edizione di Agriest con focus su territorio e tutela dell ambiente Interazione tra paesaggio urbano e extraurbano Tutela dell
PIANO DI VALUTAZIONE DEL POR FESR EMILIA ROMAGNA Proposta per l'approvazione del Comitato di Sorveglianza, 28 gennaio 2016
 PIANO DI VALUTAZIONE DEL POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 Proposta per l'approvazione del Comitato di Sorveglianza, 28 gennaio 2016 La valutazione: le novità della programmazione 20014-20 Il regolamento
PIANO DI VALUTAZIONE DEL POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 Proposta per l'approvazione del Comitato di Sorveglianza, 28 gennaio 2016 La valutazione: le novità della programmazione 20014-20 Il regolamento
SMART SWAP BUILDING. Strategie per riqualificare l esistente. U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I F E R R A R A dipartimento di architettura
 SMART SWAP BUILDING Strategie per riqualificare l esistente SMART SWAP BUILDING Strategie per riqualificare l esistente Prof. Marcello Balzani Referente Scientifico della Piattaforma Costruzioni Rete Alta
SMART SWAP BUILDING Strategie per riqualificare l esistente SMART SWAP BUILDING Strategie per riqualificare l esistente Prof. Marcello Balzani Referente Scientifico della Piattaforma Costruzioni Rete Alta
Istituzione scolastica
 Le scuole della didattica innovativa d eccellenza Predisposto appositamente per Istituzione scolastica Indice Progetto per un team di scuole di eccellenza...2 Il percorso di affiancamento: come funziona...2
Le scuole della didattica innovativa d eccellenza Predisposto appositamente per Istituzione scolastica Indice Progetto per un team di scuole di eccellenza...2 Il percorso di affiancamento: come funziona...2
Le proposte per la riforma delle autonomie locali in Lombardia
 Applicazione della legislazione in materia di unione/fusione di Comuni: esperienze a confronto giovedì 5 maggio 2016// Centro Studi PIM - Villa Scheibler Le proposte per la riforma delle autonomie locali
Applicazione della legislazione in materia di unione/fusione di Comuni: esperienze a confronto giovedì 5 maggio 2016// Centro Studi PIM - Villa Scheibler Le proposte per la riforma delle autonomie locali
Pianificazione Urbanistica Partecipata
 Pianificazione Urbanistica Partecipata L Amministrazione comunale di Mattinata ha avviato le procedure per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) che, ai sensi della Legge Regionale n 20/2001,
Pianificazione Urbanistica Partecipata L Amministrazione comunale di Mattinata ha avviato le procedure per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) che, ai sensi della Legge Regionale n 20/2001,
GRUPPO DI LAVORO CIIP SSL SCUOLA
 GRUPPO DI LAVORO CIIP SSL SCUOLA INTEGRAZIONE DELLA SSL NELL ISTRUZIONE SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA Roma, 31 o)obre 2014 ing. Elisa GERBINO Segretario ANIS Coordinatore del GdL CIIP Scuola INQUADRAMENTO
GRUPPO DI LAVORO CIIP SSL SCUOLA INTEGRAZIONE DELLA SSL NELL ISTRUZIONE SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA Roma, 31 o)obre 2014 ing. Elisa GERBINO Segretario ANIS Coordinatore del GdL CIIP Scuola INQUADRAMENTO
OGGETTO : NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE LIGURIA. ADEGUAMENTO STRUTTURA E COMPETENZE. LA GIUNTA REGIONALE
 OGGETTO : NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE LIGURIA. ADEGUAMENTO STRUTTURA E COMPETENZE. N. 363 IN 23/04/2004 LA GIUNTA REGIONALE del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA
OGGETTO : NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE LIGURIA. ADEGUAMENTO STRUTTURA E COMPETENZE. N. 363 IN 23/04/2004 LA GIUNTA REGIONALE del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA
Dal PAES a Smart City: il percorso del Comune di Padova
 Dal PAES a Smart City: il percorso del Comune di Padova Marina Mancin - Comune di Padova 7 novembre 2013, Rimini Le città sostenibili: esempi di progetti smart L esperienza di Padova - Le politiche per
Dal PAES a Smart City: il percorso del Comune di Padova Marina Mancin - Comune di Padova 7 novembre 2013, Rimini Le città sostenibili: esempi di progetti smart L esperienza di Padova - Le politiche per
1440 ore annue, con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie
 Ente: ASSOCIAZIONE MANI TESE ONG ONLUS SEDE NAZIONALE: PIAZZA V.GAMBARA 7/9 MILANO serviziocivile@manitese.it www.manitese.it tel. 02 4075165 Titolo del Progetto: CAPACI DI CAMBIARE PROSPETTIVA: RIDURRE,
Ente: ASSOCIAZIONE MANI TESE ONG ONLUS SEDE NAZIONALE: PIAZZA V.GAMBARA 7/9 MILANO serviziocivile@manitese.it www.manitese.it tel. 02 4075165 Titolo del Progetto: CAPACI DI CAMBIARE PROSPETTIVA: RIDURRE,
7 Borsisti Day 20/01/2016 Roma Consortium GARR
 La creazione del Training Lab per la «Comunità GARR» Ideazione e realizzazione della piattaforma e-learning per il community training Studio comparato del panorama europeo di riferimento 7 Borsisti Day
La creazione del Training Lab per la «Comunità GARR» Ideazione e realizzazione della piattaforma e-learning per il community training Studio comparato del panorama europeo di riferimento 7 Borsisti Day
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 2570
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 2570 Circolare n. 1/2014 Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG). L Assessore alla Qualità
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 2570 Circolare n. 1/2014 Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG). L Assessore alla Qualità
FORUM BANCHE E PA 2014. Le priorità dell Agenda Digitale. Rita Camporeale Responsabile Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento
 FORUM BANCHE E PA 2014 Le priorità dell Agenda Digitale Rita Camporeale Responsabile Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Roma, 30 ottobre 2014 L Agenda italiana: il quadro normativo 2014 2013 Legge
FORUM BANCHE E PA 2014 Le priorità dell Agenda Digitale Rita Camporeale Responsabile Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento Roma, 30 ottobre 2014 L Agenda italiana: il quadro normativo 2014 2013 Legge
Il settore dell industria alimentare nel cammino verso la strategia Europa 2020: promuovere l empowerment
 Il settore dell industria alimentare nel cammino verso la strategia Europa 2020: promuovere l empowerment dei membri dei Comitati aziendali europei (CAE) di Campofrìo e Conserve Italia Obiettivo generale
Il settore dell industria alimentare nel cammino verso la strategia Europa 2020: promuovere l empowerment dei membri dei Comitati aziendali europei (CAE) di Campofrìo e Conserve Italia Obiettivo generale
EPBD recast ed il nuovo quadro normativo nazionale: nuovi requisiti minimi e linee guida APE
 : nuovi requisiti minimi e linee guida APE LA FASE ATTUATIVA DELLA LEGGE 90/2013 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Roma, 13 novembre 2015 Enrico Bonacci Agenda Quadro legislativo di riferimento
: nuovi requisiti minimi e linee guida APE LA FASE ATTUATIVA DELLA LEGGE 90/2013 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Roma, 13 novembre 2015 Enrico Bonacci Agenda Quadro legislativo di riferimento
NUOVE PRATICHE FORMATIVE: LA COMUNITA DI PRATICA NELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI 26 FEBBRAIO 2010
 NUOVE PRATICHE FORMATIVE: LA COMUNITA DI PRATICA NELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI 26 FEBBRAIO 2010 Il contesto di riferimento Nel 2008 l AUSL di Aosta ha avviato un progetto di benchmarking della formazione
NUOVE PRATICHE FORMATIVE: LA COMUNITA DI PRATICA NELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI 26 FEBBRAIO 2010 Il contesto di riferimento Nel 2008 l AUSL di Aosta ha avviato un progetto di benchmarking della formazione
CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE. Seminario istituzionale 13 giugno 2016
 CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE Seminario istituzionale 13 giugno 2016 Proposta di legge C.3666 Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie
CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE Seminario istituzionale 13 giugno 2016 Proposta di legge C.3666 Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie
VILLAGGIO ARTIGIANO MODENA OVEST LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELLA RIGENERAZIONE URBANA
 VILLAGGIO ARTIGIANO MODENA OVEST LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELLA RIGENERAZIONE URBANA Modena - 11 aprile 2014 Villaggio Artigiano temi ricorrenti Rigenerazione ed uso intelligente del suolo incremento
VILLAGGIO ARTIGIANO MODENA OVEST LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELLA RIGENERAZIONE URBANA Modena - 11 aprile 2014 Villaggio Artigiano temi ricorrenti Rigenerazione ed uso intelligente del suolo incremento
PATTO DI ACCOGLIENZA FINALITA
 PATTO DI ACCOGLIENZA FINALITA Il Patto di Accoglienza è un documento destinato all integrazione degli alunni disabili all interno del nostro Istituto. Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti
PATTO DI ACCOGLIENZA FINALITA Il Patto di Accoglienza è un documento destinato all integrazione degli alunni disabili all interno del nostro Istituto. Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti
Le fragilitàsociali: gli anziani e il ruolo della rete socio sanitaria.
 Le fragilitàsociali: gli anziani e il ruolo della rete socio sanitaria. Rel. sig. Giancarlo Cavallin Volontarinsieme Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di Treviso Conferenza
Le fragilitàsociali: gli anziani e il ruolo della rete socio sanitaria. Rel. sig. Giancarlo Cavallin Volontarinsieme Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di Treviso Conferenza
Pegognaga Smart City. Un piccolo Comune che guarda al futuro
 Smart City Exhibition Dalla città al territorio: infrastrutture, strumenti e processi per un ecosistema abilitante Bologna 23 Ottobre 2014 Pegognaga Smart City Un piccolo Comune che guarda al futuro con
Smart City Exhibition Dalla città al territorio: infrastrutture, strumenti e processi per un ecosistema abilitante Bologna 23 Ottobre 2014 Pegognaga Smart City Un piccolo Comune che guarda al futuro con
Dipendenze: una sfida continua
 15 maggio 2012 Dipendenze: una sfida continua Il ruolo del Comune nella lotta alle dipendenze a cura di Claudio Maurizio Minoia Potenziare l integrazione fra servizi sociali e sanitari Il processo partecipato
15 maggio 2012 Dipendenze: una sfida continua Il ruolo del Comune nella lotta alle dipendenze a cura di Claudio Maurizio Minoia Potenziare l integrazione fra servizi sociali e sanitari Il processo partecipato
Workshop H Impianti fotovoltaici: opportunità e strategie di sviluppo (Ravenna Provincia del Sole) Ravenna, 29 settembre 2010
 Workshop Workshop H Impianti fotovoltaici: opportunità e strategie di sviluppo (Ravenna Provincia del Sole) Ravenna, 29 settembre 2010 Il fotovoltaico nel nuovo piano triennale di attuazione del Piano
Workshop Workshop H Impianti fotovoltaici: opportunità e strategie di sviluppo (Ravenna Provincia del Sole) Ravenna, 29 settembre 2010 Il fotovoltaico nel nuovo piano triennale di attuazione del Piano
REPORT BANDI PIEMONTE
 REPORT BANDI PIEMONTE INDICE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA PROMOZIONE DI PIANI DI ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI...2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 75% PER INIZIATIVE PROPOSTE DA ORGANIZZAZIONI
REPORT BANDI PIEMONTE INDICE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA PROMOZIONE DI PIANI DI ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI...2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 75% PER INIZIATIVE PROPOSTE DA ORGANIZZAZIONI
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SCENARI DI RISCHIO RISCHIO IDROGEOLOGICO
 SCENARI DI RISCHIO RISCHIO IDROGEOLOGICO OBIETTIVI SENSIBILI Si indicano, al fine di ridurre la vulnerabilità territoriale al danno, un elenco di nominativi da contattare in caso di necessità. Metodologia,
SCENARI DI RISCHIO RISCHIO IDROGEOLOGICO OBIETTIVI SENSIBILI Si indicano, al fine di ridurre la vulnerabilità territoriale al danno, un elenco di nominativi da contattare in caso di necessità. Metodologia,
A cura del Dott. Fulvio Di Dio DOCUMENTI INformazione
 A cura del Dott. Fulvio Di Dio DOCUMENTI INformazione 2009 E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - E vietato il plagio e la copiatura integrale
A cura del Dott. Fulvio Di Dio DOCUMENTI INformazione 2009 E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - E vietato il plagio e la copiatura integrale
Il Piano di Azione per la Sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia Romagna Patrizia Bianconi Regione Emilia Romagna
 Workshop L uso strategico degli acquisti pubblici verdi per un economia sostenibile 25 settembre 2014 -Bari Il Piano di Azione per la Sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia Romagna Patrizia
Workshop L uso strategico degli acquisti pubblici verdi per un economia sostenibile 25 settembre 2014 -Bari Il Piano di Azione per la Sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia Romagna Patrizia
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
 architetto Bruno Nessi CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE GENERALITA : Nome: Bruno Cognome: Nessi Luogo di nascita: Bergamo Data di nascita: 25 marzo 1966 Residenza: via Gasgnoli, 206 Urgnano 24059 (Bg)
architetto Bruno Nessi CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE GENERALITA : Nome: Bruno Cognome: Nessi Luogo di nascita: Bergamo Data di nascita: 25 marzo 1966 Residenza: via Gasgnoli, 206 Urgnano 24059 (Bg)
P.N.S.D. Liceo F. De Andrè
 P.N.S.D Liceo F. De Andrè P N iano azionale S D cuola igitale L idea forte del Piano: la tecnologia al servizio degli apprendimenti per rispondere all esigenza di costruire una nuova visione della formazione
P.N.S.D Liceo F. De Andrè P N iano azionale S D cuola igitale L idea forte del Piano: la tecnologia al servizio degli apprendimenti per rispondere all esigenza di costruire una nuova visione della formazione
LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali
 LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali Scuola di formazione permanente per operatori delle relazioni industriali In collaborazione con Cgil, Cisl e Uil del Trentino Il contesto Trentino Nella vita politica
LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali Scuola di formazione permanente per operatori delle relazioni industriali In collaborazione con Cgil, Cisl e Uil del Trentino Il contesto Trentino Nella vita politica
Buone Prassi Farnesina che innova
 Buone Prassi Farnesina che innova Anno di riferimento: 2015 Titolo Responsabile del Progetto: Min. Plen. Cristiano Maggipinto Cons. Leg. Francesco Maria de Stefani Spadafora Referenti per successivi contatti
Buone Prassi Farnesina che innova Anno di riferimento: 2015 Titolo Responsabile del Progetto: Min. Plen. Cristiano Maggipinto Cons. Leg. Francesco Maria de Stefani Spadafora Referenti per successivi contatti
Regolamento dell Ufficio Tecnico per l A.S. 2011/12
 Regolamento dell Ufficio Tecnico per l A.S. 2011/12 Visto il DPR 15 marzo 2010 n. 88 Vista la Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 linee guida degli Istituti Tecnici Vista la delibera del Collegio
Regolamento dell Ufficio Tecnico per l A.S. 2011/12 Visto il DPR 15 marzo 2010 n. 88 Vista la Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 linee guida degli Istituti Tecnici Vista la delibera del Collegio
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE - Delibera n
 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE - Delibera n. 1243-2015 Programma XII: Ambiente e salute - facilitare una migliore qualità dell ambiente e del territorio, secondo il modello della Salute in tutte le
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE - Delibera n. 1243-2015 Programma XII: Ambiente e salute - facilitare una migliore qualità dell ambiente e del territorio, secondo il modello della Salute in tutte le
Settore Volontariato, Filantropia Beneficienza
 Documento Programmatico Previsionale 2014 Settore Volontariato, Filantropia Beneficienza DISAGIO SOCIALE LINEA B) L A L I N E A D I I N T E R V E N T O La Fondazione riconosce nell area della povertà e
Documento Programmatico Previsionale 2014 Settore Volontariato, Filantropia Beneficienza DISAGIO SOCIALE LINEA B) L A L I N E A D I I N T E R V E N T O La Fondazione riconosce nell area della povertà e
COMUNE DI MONTAIONE Provincia di Firenze. Rel. Fiorenzo Grifoni
 COMUNE DI MONTAIONE Provincia di Firenze Rel. Fiorenzo Grifoni 13.09.2012 Il Comune di Montaione con i suoi 3800 abitanti e 104 KMq è situato nel cuore della Toscana, in Provincia di Firenze. L economia
COMUNE DI MONTAIONE Provincia di Firenze Rel. Fiorenzo Grifoni 13.09.2012 Il Comune di Montaione con i suoi 3800 abitanti e 104 KMq è situato nel cuore della Toscana, in Provincia di Firenze. L economia
La formazione delle nuove professionalità nel mercato liberalizzato del gas
 Competitività e specializzazione del lavoro nei servizi pubblici La formazione delle nuove professionalità nel mercato liberalizzato del gas Firenze 28 novembre 2008 CHI SIAMO Toscana Energia è stata costituita
Competitività e specializzazione del lavoro nei servizi pubblici La formazione delle nuove professionalità nel mercato liberalizzato del gas Firenze 28 novembre 2008 CHI SIAMO Toscana Energia è stata costituita
ASL PROVINCIA DI VARESE UNA VISIONE DI SISTEMA SULL INTEGRAZIONE SOCIO- SANITARIA NELLA NOSTRA PROVINCIA. 29 giugno 2011
 ASL PROVINCIA DI VARESE 29 giugno 2011 UNA VISIONE DI SISTEMA SULL INTEGRAZIONE SOCIO- SANITARIA NELLA NOSTRA PROVINCIA 1 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI ALL INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
ASL PROVINCIA DI VARESE 29 giugno 2011 UNA VISIONE DI SISTEMA SULL INTEGRAZIONE SOCIO- SANITARIA NELLA NOSTRA PROVINCIA 1 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI ALL INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Livello di benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del superiore gerarchico
 Livello di benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del superiore gerarchico Sintesi dei risultati dell indagine 2013 svolta sul personale della Camera di
Livello di benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del superiore gerarchico Sintesi dei risultati dell indagine 2013 svolta sul personale della Camera di
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 FAQ del 23 giugno 2016 In riferimento all Art. 3 comma 2) del bando ed all art. 7: l attuazione di progetti infrastrutturali anche da parte di soggetti privati e la loro eventuale partecipazione al finanziamento
FAQ del 23 giugno 2016 In riferimento all Art. 3 comma 2) del bando ed all art. 7: l attuazione di progetti infrastrutturali anche da parte di soggetti privati e la loro eventuale partecipazione al finanziamento
Obiettivi di accessibilità per l anno 2015
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Obiettivi di accessibilità per l anno 2015 Redatto ai sensi dell articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Redatto il 16/03/2015 1 SOMMARIO Obiettivi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Obiettivi di accessibilità per l anno 2015 Redatto ai sensi dell articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Redatto il 16/03/2015 1 SOMMARIO Obiettivi
RIF. CORSO: 2015-GG-39. Scheda progetto
 RIF. CORSO: 2015-GG-39 Scheda progetto FIGURA PROFESSIONALE Denominazione corso: TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE Durata: 200 Descrizione della figura professionale: Il Tecnico
RIF. CORSO: 2015-GG-39 Scheda progetto FIGURA PROFESSIONALE Denominazione corso: TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE Durata: 200 Descrizione della figura professionale: Il Tecnico
1 - CODICE PROGETTO 1.1.3 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI IMMIGRAZIONE 2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO/AREA FUNZIONALE DEL PPL
 1 - CODICE PROGETTO 1.1.3 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI IMMIGRAZIONE 2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO/AREA FUNZIONALE DEL PPL Il progetto è riconducibile a quella che il Piano Provinciale del Lavoro definisce
1 - CODICE PROGETTO 1.1.3 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI IMMIGRAZIONE 2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO/AREA FUNZIONALE DEL PPL Il progetto è riconducibile a quella che il Piano Provinciale del Lavoro definisce
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE. PFI relativo all assunzione del/la Sig./ra:
 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PFI relativo all assunzione del/la Sig./ra: 1. Azienda Ragione sociale Sede (indirizzo) CAP (Comune) Partita IVA Codice Fiscale Telefono Fax e-mail Legale rappresentante (nome
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PFI relativo all assunzione del/la Sig./ra: 1. Azienda Ragione sociale Sede (indirizzo) CAP (Comune) Partita IVA Codice Fiscale Telefono Fax e-mail Legale rappresentante (nome
IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
 LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 - Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione Obiettivo Tematico 10 - Istruzione e Formazione Obiettivo
LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 - Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione Obiettivo Tematico 10 - Istruzione e Formazione Obiettivo
I distretti urbani del commercio. SCHEMA Regolamento attuativo dell art. 16 della L. R. 1 agosto 2003 n. 11
 I distretti urbani del commercio SCHEMA Regolamento attuativo dell art. 16 della L. R. 1 agosto 2003 n. 11 Sommario Art. 1 Oggetto del regolamento...3 Art. 2 Obiettivi...3 Art. 3 Caratteristiche dei distretti...3
I distretti urbani del commercio SCHEMA Regolamento attuativo dell art. 16 della L. R. 1 agosto 2003 n. 11 Sommario Art. 1 Oggetto del regolamento...3 Art. 2 Obiettivi...3 Art. 3 Caratteristiche dei distretti...3
L adattamento al cambiamento climatico ed esperienze di azioni a livello locale
 14 Novembre 2013 L adattamento al cambiamento climatico ed esperienze di azioni a livello locale Francesco Musco, Iuav Venezia climatechange@iuav.it Insediamenti urbani e cambiamenti climatici Temi e questioni
14 Novembre 2013 L adattamento al cambiamento climatico ed esperienze di azioni a livello locale Francesco Musco, Iuav Venezia climatechange@iuav.it Insediamenti urbani e cambiamenti climatici Temi e questioni
BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA E PARTI SOCIALI REGIONALI PER UN SISTEMA REGIONALE DI MOBILITA DEI CITTADINI TOSCANI TRA PREMESSO
 BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA E PARTI SOCIALI REGIONALI PER UN SISTEMA REGIONALE DI MOBILITA DEI CITTADINI TOSCANI L'anno, il giorno La Regione Toscana TRA E Parti sociali. PREMESSO - Che
BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA E PARTI SOCIALI REGIONALI PER UN SISTEMA REGIONALE DI MOBILITA DEI CITTADINI TOSCANI L'anno, il giorno La Regione Toscana TRA E Parti sociali. PREMESSO - Che
Il sistema di misurazione e di valutazione della Performance dell Università Parthenope del personale responsabile e non di Unità Organizzative
 Il sistema di misurazione e di valutazione della Performance dell Università Parthenope del personale responsabile e non di Unità Organizzative Analisi del contesto interno Personale diviso per area di
Il sistema di misurazione e di valutazione della Performance dell Università Parthenope del personale responsabile e non di Unità Organizzative Analisi del contesto interno Personale diviso per area di
