TRASFORMAZIONI IDROGRAFICHE
|
|
|
- Giacinto Paolini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRASFORMAZIONI IDROGRAFICHE Lo studio dell'evoluzione delle vie d'acqua (fiumi, canali, fossati) è importante per comprendere come lo sviluppo urbano di Ravenna e quindi il suo circuito murario siano stati fortemente condizionati dall'evoluzione dell'idrografia superficiale. Per la ricostruzione di questa evoluzione si possono utilizzare i dati provenienti dai sondaggi stratigrafici e archeologici unitamente a uno studio delle fonti storiche e a una dettagliata analisi cartografica. Allo stato attuale delle conoscenze il quadro delle trasformazioni idrografiche dell'area urbana ravennate è ricostruibile sinteticamente secondo il seguente schema evolutivo: sec I a.c. Per la sua importanza Ravenna è citata numerose volte dagli autori dell'antichità, ma gli unici passi significativi per la ricostruzione dell'idrografia superficiale sono quelli di Strabone (I secolo a.c.) che tramanda l'immagine di una città attorno alla quale si mescolavano le acque del mare, dei fiumi e della laguna. Al I secolo d.c. risale un noto passo di Plinio che dà notizia di una fossa Augusta congiungente il Po con Ravenna. La fossa aveva funzione di collegamento fra il porto, posto a sud-est della città, e il ramo principale di Po. L'alternarsi degli equilibri idraulici e la mutevolezza del quadro sono documentati e confermati anche da altre fonti storiche (Sidonio Apollinare, Giordane). sec. III-V d.c.
2 sec. VI-VII Nonostante la mancanza di fonti letterarie, è stato ipotizzato che il Lamone fluisse ab antiquo dentro Ravenna all'incirca lungo l'attuale direttrice via Maggiore-via Cavour e, dove oggi c'è il Mercato Coperto, confluisse con il Padenna che scorreva lungo l'attuale direttrice di via G. Rossi-IV Novembre- Cairoli-Ricci-Mazzini e andasse in cavo unico verso Sud, verso la Laguna. Nei primi anni del V secolo la capitale fu trasferita da Milano a Ravenna, considerata migliore per la sua inespugnabilità a causa dei terreni paludosi che rendevano difficile il passaggio ai nemici. In realtà le condizioni ambientali non erano così sfavorevoli e non bastavano per difendere la città: fu così che nel V secolo vennero erette le mura cittadine. In queste condizioni le acque del Padenna e del Lamone continuavano a defluire attraverso Ravenna e a confluire proprio nel suo centro; fu sempre in questo periodo che una parte del Lamone venne deviata per alimentare i fossati attorno alle mura.
3 Il Lamone, che nel frattempo aveva assunto l'idronimo di Teguriense, in corrispondenza della Porta Adriana, viene arginato e rettificato più a monte, viene fatto girare attorno alle mura di settentrione e fatto confluire nel Badareno (ramo meridionale del Po Primario). Entro le mura le tracce del Lamone e Badareno restano e si perderanno definitivamente nel secolo XV con il tombamento delle vene. da P. Fabbri, Il Padenna, Ravenna 1975 sec. XIII- XIV da P. Fabbri, Il Padenna, Ravenna 1975 Nel secolo XIII il Lamone subì due diversioni di cui la prima ( ) lo allontanò da Ravenna ( non è certo se per cause naturali o artificiali). Sotto il patrocinio dei Signori Di Polenta si verificarono notevoli cambiamenti dell'andamento idrografico: vennero realizzate opere idrauliche per portare alle mura di Ravenna il Fiume Montone (Forlivensis, Liviensis) e Ronco (Bidente); vennero costruiti una serie di canali deviatori le cui acque servivano principalmente per i mulini e venne scavato il "canal naviglio" fin sotto le mura come valido alternativo del Bidente nelle idrovie di comunicazione con il
4 Nei secoli XIII-XIV il Fiume Montone correva attorno a Ravenna. ln questo periodo viene fatta l'adduzione del Fiume Ronco (Acquedotto). Questo si dirigeva su Ravenna da Sud e ne tangeva le mura tra Porta Sisi e Porta Mama (dove usciva il Padenna). In questo luogo detto "la Voltazza" il fiume girava bruscamente a destra e andava al mare. Alla fine del secolo XIII si verificò un forte dissesto idrologico dovuto principalmente a due cause: un cambiamento climatico verificatosi tra il con aumento dei ghiacciai, e alle nostre latitudini, con aumento della piovosità e diminuzione della temperatura e il massiccio disboscamento dell'appennino Romagnolo. Come conseguenza a tutto ciò ci fu un vistoso aumento del carico di torbide recato dai fiumi verso la pianura. Nel secolo XIV il Badareno viene riempito di materiale, in queste condizioni è difficile la conservazione del piccolo scalo portuale. Nel 1441 Ravenna passa sotto l'amministrazione della Serenissima e perde l'autonomia politica e commerciale. Il porto di mare entra in dissesto e disuso e solo il naviglio viene conservato. I Ravennati si rivolgono verso altre fonti di sfruttamento del suolo, quali l'agricoltura. C'è quindi la necessità di apportare opere di prosciugamento e canalizzazione delle acque con conseguente inaridimento dei flumiselli della città. I canali dentro la città vengono mantenuti solo per i mulini, altri flumiselli furono tombati. Po. sec. XIII- XIV da Faini - Maioli, La Romagna nella cartografia a stampa dal Cinquecento all'ottocento, Rimini 1992 Tra il XV e XIX secolo un vasto deterioramento climatico, denominato Piccola Età del Ghiaccio ( ), investì le nostre zone. Le fronti glaciali avanzarono nella regione alpina. L'aumento della piovosità e la diminuzione della temperatura media crearono numerosi dissesti idrogeologici e influenzarono le attività umane. In questo periodo vennero innescati imponenti fenomeni di erosione del suolo e quantità enormi di sedimenti furono portati al mare, come sta a dimostrare il grande protendimento che ebbe il Po tra il 1600 e il Grandi inondazioni spinsero i Ravennati a fare modifiche idrauliche. Le più grandi alluvioni avvennero nel La più grave fu quella del maggio del 1636 che squarciò le mura di Ravenna presso la Rocca e la Torre Zancana. Il Cardinale Cibo fece spostare la confluenza del Ronco e Montone a circa 2 miglia dalla città. Nel 1651 il Cardinale Doghi fece scavare un nuovo canale che congiungesse la città con il mare. Tale canale era lungo 7 Km e toccava il mare presso la foce del Ronco, Montone e Savio (giungeva fino all'odierno porto sui Fiumi Riuniti). Questo canale fu chiamato Pamphilio, ma non durò molto. La diversione del Ronco e del Montone del 1736 ne occupa parzialmente l'alveo. sec. XVIII
5 da Faini - Maioli, La Romagna nella cartografia a stampa dal Cinquecento all'ottocento, Rimini 1992 Tra il ci fu al diversione di Ronco e Montone. A Ravenna però ora mancava il vecchio Porto Candiano. Venne costruito nel 1739 un nuovo canale-naviglio per collegare la città al mare e venne realizzato sulle vecchie foci del Ronco e Montone. Nel 1780 il Canale Corsini venne aperto al traffico ( distanza dal mare circa 10 Km).
Casa Sicura Eventi Sismici 12 Maggio maggio 2017 Camera di Commercio di Ravenna
 Fotografia dal satellite del 2016 Fotografia aerea del 1954 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna scala 1:250.000 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna scala 1:100.000 In epoca pre-etrusca
Fotografia dal satellite del 2016 Fotografia aerea del 1954 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna scala 1:250.000 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna scala 1:100.000 In epoca pre-etrusca
La formazione del Delta del Po
 La formazione del Delta del Po Il Delta del Po L origine dell attuale territorio deltizio può ricondursi orientativamente al 30.000 a.c., quando la linea di costa cominciò a protendersi verso il mare.
La formazione del Delta del Po Il Delta del Po L origine dell attuale territorio deltizio può ricondursi orientativamente al 30.000 a.c., quando la linea di costa cominciò a protendersi verso il mare.
SCHEDE IDENTIFICATIVE CON DECRETI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE
 SCHEDE IDENTIFICATIVE CON DECRETI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o Legge 22 aprile 1941 n. 633 Comune Località Classe Vincolo Tipo Vincolo N Tutela MODENA MONUMENTALE
SCHEDE IDENTIFICATIVE CON DECRETI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o Legge 22 aprile 1941 n. 633 Comune Località Classe Vincolo Tipo Vincolo N Tutela MODENA MONUMENTALE
n 26 di mercoledì 28/09/2016 Sommario settimana dal 28/09/2016 al 04/10/2016 Riassunto
 Fattori comprensoriali comuni Fonti di approvvigionamento idriche Sommario settimana dal 28/09/2016 al 04/10/2016 Riassunto Fiume PO portata presso località Pontelagoscuro - Fiume PO livello presso opera
Fattori comprensoriali comuni Fonti di approvvigionamento idriche Sommario settimana dal 28/09/2016 al 04/10/2016 Riassunto Fiume PO portata presso località Pontelagoscuro - Fiume PO livello presso opera
n 20 di mercoledì 02/09/2015 Sommario settimana dal 02/09/2015 al 08/09/2015 Riassunto
 Fattori comprensoriali comuni Fonti di approvvigionamento idriche Sommario settimana dal 02/09/2015 al 08/09/2015 Riassunto Fiume PO portata presso località Pontelagoscuro - Fiume PO livello presso opera
Fattori comprensoriali comuni Fonti di approvvigionamento idriche Sommario settimana dal 02/09/2015 al 08/09/2015 Riassunto Fiume PO portata presso località Pontelagoscuro - Fiume PO livello presso opera
La canalizzazione di Bologna. Realizzato da: Federico Cacciari Giorgia Calegari Lorenzo Montanari Tommaso Giacominelli Luca Odorici
 La canalizzazione di Bologna Realizzato da: Federico Cacciari Giorgia Calegari Lorenzo Montanari Tommaso Giacominelli Luca Odorici Bologna, la piccola Venezia dei secoli passati Bologna non ha importanti
La canalizzazione di Bologna Realizzato da: Federico Cacciari Giorgia Calegari Lorenzo Montanari Tommaso Giacominelli Luca Odorici Bologna, la piccola Venezia dei secoli passati Bologna non ha importanti
Buongiorno a tutti, sono Gianandrea Baroncini, Assessore del Comune di Ravenna con delega, fra altre, all ambiente e alla protezione civile.
 Buongiorno a tutti, sono Gianandrea Baroncini, Assessore del Comune di Ravenna con delega, fra altre, all ambiente e alla protezione civile. Nel ringraziare personalmente tutti i presenti, relatori e partecipanti
Buongiorno a tutti, sono Gianandrea Baroncini, Assessore del Comune di Ravenna con delega, fra altre, all ambiente e alla protezione civile. Nel ringraziare personalmente tutti i presenti, relatori e partecipanti
Origini e trasformazioni della Laguna di Venezia
 Assessorato Ambiente Origini e trasformazioni della Laguna di Venezia Claudia Ferrari 1,5 milioni di anni fa 20.000 anni fa Durante l ultima fase di espansione glaciale il livello del mare era circa 120
Assessorato Ambiente Origini e trasformazioni della Laguna di Venezia Claudia Ferrari 1,5 milioni di anni fa 20.000 anni fa Durante l ultima fase di espansione glaciale il livello del mare era circa 120
Altro reperto storico, degno di ammirazione, sono state due vasche realizzate nell 800 su stile romanico.
 Venerdì 5 aprile 2013 io e la mia classe abbiamo effettuato un uscita didattica per conoscere la Jesi medievale - rinascimentale. In particolare abbiamo percorso una parte delle mura di Jesi che circondano
Venerdì 5 aprile 2013 io e la mia classe abbiamo effettuato un uscita didattica per conoscere la Jesi medievale - rinascimentale. In particolare abbiamo percorso una parte delle mura di Jesi che circondano
La riqualificazione fluviale in Emilia-Romagna
 III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale WORKSHOP Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti REGGIO CALABRIA
III Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale WORKSHOP Riqualificare i corsi d acqua nella regione mediterranea ispirazione dalle buone pratiche - impegno per le sfide correnti REGGIO CALABRIA
POLO N. 5 BONDENO, SETTEPOLESINI
 TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
Comacchio, Sacca di Goro, Venezia, Caorle, Marano, Grado
 laguna di Marano Comacchio, Sacca di Goro, Venezia, Caorle, Marano, Grado Origine delle lagune: condizioni geologiche e idrologiche Costa bassa: pianura alluvionale e ampia piattaforma continentale Escursione
laguna di Marano Comacchio, Sacca di Goro, Venezia, Caorle, Marano, Grado Origine delle lagune: condizioni geologiche e idrologiche Costa bassa: pianura alluvionale e ampia piattaforma continentale Escursione
Mappatura della pericolosità sul reticolo secondario, naturale e artificiale e sulle aree costiere lacuali e marine in Regione Veneto
 Allegato 6.6 alla Relazione tecnica del Progetto esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione Mappatura della pericolosità sul reticolo secondario, naturale
Allegato 6.6 alla Relazione tecnica del Progetto esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione Mappatura della pericolosità sul reticolo secondario, naturale
Repertorio Cartografico REGIONE UMBRIA
 Repertorio Cartografico REGIONE UMBRIA Geografia regionale È una tra le più piccole regioni italiane e l unica, dell Italia peninsulare, a non essere bagnata dal mare. I suoi abitanti contano circa 815.000
Repertorio Cartografico REGIONE UMBRIA Geografia regionale È una tra le più piccole regioni italiane e l unica, dell Italia peninsulare, a non essere bagnata dal mare. I suoi abitanti contano circa 815.000
Km 21,5 dislivello Percorso E
 CASALBORSETTI Regione: Emilia- Romagna Prov. di Ravenna - TAPPA 23 CASALBORSETTI RAVENNA Km 21,5 dislivello +20-30 Percorso E Al tempo del Regno d Italia c'erano poche tracce di urbanizzazione e nessuno
CASALBORSETTI Regione: Emilia- Romagna Prov. di Ravenna - TAPPA 23 CASALBORSETTI RAVENNA Km 21,5 dislivello +20-30 Percorso E Al tempo del Regno d Italia c'erano poche tracce di urbanizzazione e nessuno
Le coste: basse (foci fluviali, spiagge, lagune) e alte (ciglione carsico) FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 1
 Le coste: basse (foci fluviali, spiagge, lagune) e alte (ciglione carsico) FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 1 laguna di Marano FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 2 Rappresentazione imprecisa, difficile FVG 17 Lagune
Le coste: basse (foci fluviali, spiagge, lagune) e alte (ciglione carsico) FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 1 laguna di Marano FVG 17 Lagune GFGeol - STAN 2 Rappresentazione imprecisa, difficile FVG 17 Lagune
Il cambiamento climatico e le risorse idriche nel bacino del Po
 Il cambiamento climatico e le risorse idriche nel bacino del Po Parma, 16 luglio 27 Camera di Commercio - Sala Aurea IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI AGENDA Elementi di stato Obiettivo
Il cambiamento climatico e le risorse idriche nel bacino del Po Parma, 16 luglio 27 Camera di Commercio - Sala Aurea IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI AGENDA Elementi di stato Obiettivo
PROGETTO ANCONAPACO Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico delle aree di collina, pianura e costiere
 Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico delle aree di collina, pianura e costiere ANALISI DELL EROSIONE E DEL TRASPORTO SOLIDO NEI BACINI IDROGRAFICI COSTIERI DELLE
Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico delle aree di collina, pianura e costiere ANALISI DELL EROSIONE E DEL TRASPORTO SOLIDO NEI BACINI IDROGRAFICI COSTIERI DELLE
Restauro del castello di Piombino 3 dicembre 2008
 Restauro del castello di Piombino 3 dicembre 2008 G. Stradano L assedio di Piombino (seconda metà XVI secolo) Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento P. Galle (su disegno di G. Stradano) L assedio
Restauro del castello di Piombino 3 dicembre 2008 G. Stradano L assedio di Piombino (seconda metà XVI secolo) Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento P. Galle (su disegno di G. Stradano) L assedio
Acque sotterranee, lo stato chimico è buono
 Acque sotterranee, lo stato chimico è buono Il monitoraggio dell'ispra ha rilevato uno stato buono delle acque sotterranee e superficiali, mentre la situazione è meno confortante per quelle di bacini e
Acque sotterranee, lo stato chimico è buono Il monitoraggio dell'ispra ha rilevato uno stato buono delle acque sotterranee e superficiali, mentre la situazione è meno confortante per quelle di bacini e
La pianificazione della risorsa idrica in Emilia-Romagna Rosanna Bissoli
 RICARICA DELLA CONOIDE DEL MARECCHIA Rimini 15 aprile 2016 La pianificazione della risorsa idrica in Emilia-Romagna Rosanna Bissoli I Piani di gestione delle acque 2015-2021 I Piani di gestione delle acque
RICARICA DELLA CONOIDE DEL MARECCHIA Rimini 15 aprile 2016 La pianificazione della risorsa idrica in Emilia-Romagna Rosanna Bissoli I Piani di gestione delle acque 2015-2021 I Piani di gestione delle acque
Tour in Umbria 6 notti/7 giorni nel Ternano
 Tour in Umbria 6 notti/7 giorni nel Ternano 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 TOUR IN UMBRIA 6 notti / 7 giorni Giove, Arrone, San Gemini, Acquasparta, Lugnano In Teverina Giorno 1 Arrivo all'aeroporto di Roma Trasferimento
Tour in Umbria 6 notti/7 giorni nel Ternano 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 TOUR IN UMBRIA 6 notti / 7 giorni Giove, Arrone, San Gemini, Acquasparta, Lugnano In Teverina Giorno 1 Arrivo all'aeroporto di Roma Trasferimento
Classe IV materiali di lavoro Storia vita nel Medioevo I PROGRESSI NELL' AGRICOLTURA DURANTE IL SECONDO MEDIOEVO
 Scheda 14 I PROGRESSI NELL' AGRICOLTURA DURANTE IL SECONDO MEDIOEVO Nei secoli dopo il 1000 si ebbero molti progressi per quanto riguarda le tecniche di coltivazione della terra. In particolare: - si ebbe
Scheda 14 I PROGRESSI NELL' AGRICOLTURA DURANTE IL SECONDO MEDIOEVO Nei secoli dopo il 1000 si ebbero molti progressi per quanto riguarda le tecniche di coltivazione della terra. In particolare: - si ebbe
Sezione 4. Ambito n 1 LUNIGIANA Province: Massa. BENI PAESAGGISTICI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DELL' ART.136 DEL D.Lgs.
 Ambito n 1 LUNIGIANA Province: Massa Territori appartenenti ai Comuni: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca
Ambito n 1 LUNIGIANA Province: Massa Territori appartenenti ai Comuni: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE Comune di Ravenna Compilatore: GEB srl IN SE SR
 Aggiornato al: 18.09.2009 SCENARI DI EVENTO pag. 2.1 2 SCENARI DI EVENTO Il primo passo nella redazione di un Piano di Emergenza di Protezione Civile si realizza con la creazione degli Scenari di Evento.
Aggiornato al: 18.09.2009 SCENARI DI EVENTO pag. 2.1 2 SCENARI DI EVENTO Il primo passo nella redazione di un Piano di Emergenza di Protezione Civile si realizza con la creazione degli Scenari di Evento.
Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali
 Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali Leonardo Di Maggio Consulente Sogesid presso la Direzione Generale per la Salvaguardia
Le iniziative del Ministero dell Ambiente in materia di difesa delle coste dal 2006 e gli obiettivi di indirizzo generali Leonardo Di Maggio Consulente Sogesid presso la Direzione Generale per la Salvaguardia
TAPPA 24 RAVENNA FORLI
 RAVENNA Regione: Emilia Romagna Prov. Ravenna TAPPA 24 RAVENNA FORLI km 30,7 dislivello +50-20 Percorso E Ravenna è una città di 160.243 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna e capitale
RAVENNA Regione: Emilia Romagna Prov. Ravenna TAPPA 24 RAVENNA FORLI km 30,7 dislivello +50-20 Percorso E Ravenna è una città di 160.243 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna e capitale
2.4 LE VIE DI COMUNICAZIONE
 2.4 LE VIE DI COMUNICAZIONE Studi e analisi per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Nel farsi del territorio, così come nella sua articolazione su date soglie temporali, assume un ruolo
2.4 LE VIE DI COMUNICAZIONE Studi e analisi per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Nel farsi del territorio, così come nella sua articolazione su date soglie temporali, assume un ruolo
Il contributo dell Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli Le mappe di pericolosità dei corpi idrici naturali
 DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO CICLO DI INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI (27 febbraio 17 aprile 2014) Il contributo dell Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli Le mappe di pericolosità
DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO CICLO DI INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI (27 febbraio 17 aprile 2014) Il contributo dell Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli Le mappe di pericolosità
Stato del litorale emiliano-romagnolo erosione e interventi di difesa
 Stato del litorale emiliano-romagnolo erosione e interventi di difesa Ravenna, 30 Novembre 2016 M. Aguzzi, N. De Nigris, M. Morelli, T. Paccagnella, S. Unguendoli Unità Mare Costa - Servizio IdroMeteoClima
Stato del litorale emiliano-romagnolo erosione e interventi di difesa Ravenna, 30 Novembre 2016 M. Aguzzi, N. De Nigris, M. Morelli, T. Paccagnella, S. Unguendoli Unità Mare Costa - Servizio IdroMeteoClima
Arturo Gallia Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato di ricerca in Storia
 Psicologia Arturo Gallia Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato di ricerca in Storia Claudia Caronti Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Magistrale per la protezione dai rischi naturali Un esempio:
Psicologia Arturo Gallia Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato di ricerca in Storia Claudia Caronti Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Magistrale per la protezione dai rischi naturali Un esempio:
LEGGI O ASCOLTA IL TESTO POI ORGANIZZA IL CONTENUTO NELLA MAPPA IL LAGO E UNA GRANDE MASSA D'ACQUA DOLCE, RACCOLTA IN UNA CAVITÀ
 LEGGI O ASCOLTA IL TESTO POI ORGANIZZA IL CONTENUTO NELLA MAPPA IL LAGO E UNA GRANDE MASSA D'ACQUA DOLCE, RACCOLTA IN UNA CAVITÀ DELLA TERRA. E ALIMENTATO DA FIUMI CHIAMATI IMMISSARI, DA SORGENTI, DA GHIACCIAI
LEGGI O ASCOLTA IL TESTO POI ORGANIZZA IL CONTENUTO NELLA MAPPA IL LAGO E UNA GRANDE MASSA D'ACQUA DOLCE, RACCOLTA IN UNA CAVITÀ DELLA TERRA. E ALIMENTATO DA FIUMI CHIAMATI IMMISSARI, DA SORGENTI, DA GHIACCIAI
Il paese è situato nell Europa centro-settentrionale, bagnato dal Mare del Nord (nord e ovest) mentre confina con la Germania (est) e con il Belgio
 Paesi Bassi Il paese è situato nell Europa centro-settentrionale, bagnato dal Mare del Nord (nord e ovest) mentre confina con la Germania (est) e con il Belgio (sud). Le 445 km di coste sabbiose, circa
Paesi Bassi Il paese è situato nell Europa centro-settentrionale, bagnato dal Mare del Nord (nord e ovest) mentre confina con la Germania (est) e con il Belgio (sud). Le 445 km di coste sabbiose, circa
1I TORRENTI MONTANI.
 1I TORRENTI MONTANI I torrenti montani sono corsi d'acqua che, come dice il loro nome, si originano a quote elevate. A differenza dei loro parenti più grandi, i fiumi, sono caratterizzati da acque molto
1I TORRENTI MONTANI I torrenti montani sono corsi d'acqua che, come dice il loro nome, si originano a quote elevate. A differenza dei loro parenti più grandi, i fiumi, sono caratterizzati da acque molto
SI POSSONO PREVEDERE LE ALLUVIONI?
 SI POSSONO PREVEDERE LE ALLUVIONI? Si possono prevedere le alluvioni? Più grande è il corso d acqua, più aumenta la capacità di previsione Grandi fiumi: il livello delle acque si alza lentamente (diverse
SI POSSONO PREVEDERE LE ALLUVIONI? Si possono prevedere le alluvioni? Più grande è il corso d acqua, più aumenta la capacità di previsione Grandi fiumi: il livello delle acque si alza lentamente (diverse
Opere di protezione e di mitigazione dei rischi idrogeologici nella Regione Sardegna Ing. Alberto Piras Direttore del Servizio Opere Idriche e
 Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (S.O.I.) Fabbisogno economico per le problematiche di dissesto idrogeologico rilevato dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)approvato con Decreto
Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (S.O.I.) Fabbisogno economico per le problematiche di dissesto idrogeologico rilevato dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)approvato con Decreto
BENI STORICO ARCHITETTONICI:
 REPERTORIO COMUNALE PER I BENI STORICI E PAESISTICI Legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 Art. 2.2 NTA Piano Territoriale Provinciale BENI STORICO ARCHITETTONICI: Tipologia Nome Numero di riferimento nel
REPERTORIO COMUNALE PER I BENI STORICI E PAESISTICI Legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 Art. 2.2 NTA Piano Territoriale Provinciale BENI STORICO ARCHITETTONICI: Tipologia Nome Numero di riferimento nel
LA GIUNTA REGIONALE. SU PROPOSTA dell Assessore all Ambiente;
 Oggetto: Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000. LA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000. LA GIUNTA REGIONALE
Regione: Toscana Prov. Arezzo
 CASTIGLION FIORENTINO Regione: Toscana Prov. Arezzo TAPPA 33 CASTIGLION FIORENTINO - CORTONA Km 12,8 dislivello +400-240 Percorso E Il nucleo abitato castiglionese si sviluppò in epoca etrusca, già a partire
CASTIGLION FIORENTINO Regione: Toscana Prov. Arezzo TAPPA 33 CASTIGLION FIORENTINO - CORTONA Km 12,8 dislivello +400-240 Percorso E Il nucleo abitato castiglionese si sviluppò in epoca etrusca, già a partire
LA PIANURA PADANA SI ESTENDE TRA LE ALPI E L APPENNINO SETTENTRIONALE
 LA PIANURA PADANA SI ESTENDE TRA LE ALPI E L APPENNINO SETTENTRIONALE MILIONI DI ANNI FA C ERA IL MARE, I DETRITI TRASPORTATI DAI FIUMI CHE SCENDEVANO DALLE MONTAGNE SI SONO ACCUMULATI SUL FONDO DEL MARE
LA PIANURA PADANA SI ESTENDE TRA LE ALPI E L APPENNINO SETTENTRIONALE MILIONI DI ANNI FA C ERA IL MARE, I DETRITI TRASPORTATI DAI FIUMI CHE SCENDEVANO DALLE MONTAGNE SI SONO ACCUMULATI SUL FONDO DEL MARE
La subsidenza della fascia costiera emiliano-romagnola: Ing. Mentino Preti
 La subsidenza della fascia costiera emiliano-romagnola: Ing. Mentino Preti Ravenna, 30 settembre 2013 Sala D attore - Ravenna 1 Considerazioni generali Il litorale emiliano-romagnolo è uno dei pochi tratti
La subsidenza della fascia costiera emiliano-romagnola: Ing. Mentino Preti Ravenna, 30 settembre 2013 Sala D attore - Ravenna 1 Considerazioni generali Il litorale emiliano-romagnolo è uno dei pochi tratti
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1
 COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1 1. INQUADRAMENTO Comune di: Civitella di Romagna. Località: S. Martino in Varolo. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav.
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1 1. INQUADRAMENTO Comune di: Civitella di Romagna. Località: S. Martino in Varolo. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav.
UTOE 7 Cisanello Parco Centrale S.N. 7.5
 UTOE 7 Cisanello Parco Centrale S.N. 7.5 QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione dell area... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e
UTOE 7 Cisanello Parco Centrale S.N. 7.5 QUADRO CONOSCITIVO LOCALIZZATO Indice Inquadramento territoriale, descrizione e contestualizzazione dell area... 2 Pericolosità idraulica, acque superficiali e
Pisa com'era: archeologia, urbanistica e strutture materiali (secoli V - XIV)
 EUROPAMEDITERRANEA QUADERNI 7 Fabio Redi Pisa com'era: archeologia, urbanistica e strutture materiali (secoli V - XIV) presentazione di Gabriella Rossetti?zlO GISEM LIGUORI EDITORE Ricostruzione dell'ambiente
EUROPAMEDITERRANEA QUADERNI 7 Fabio Redi Pisa com'era: archeologia, urbanistica e strutture materiali (secoli V - XIV) presentazione di Gabriella Rossetti?zlO GISEM LIGUORI EDITORE Ricostruzione dell'ambiente
RT - Relazioni LT RV DEC - Attività Generale di Decommissioning 01/08/2012 ETQ LT - Sito di Latina
 01 LT RV 00487 ETQ-00018326 RT - Relazioni DEC - Attività Generale di Decommissioning 01/08/2012 LT - Sito di Latina Progetto Riqualificazione Area Esterna Antistante Ex Pontile - Relazione Idrologica
01 LT RV 00487 ETQ-00018326 RT - Relazioni DEC - Attività Generale di Decommissioning 01/08/2012 LT - Sito di Latina Progetto Riqualificazione Area Esterna Antistante Ex Pontile - Relazione Idrologica
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO PORTO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO Ditta: PROGETTO DI POTENZIAMENTO,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO TURISTICO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO PO FESR 2007/2013,
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO PORTO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO Ditta: PROGETTO DI POTENZIAMENTO,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO TURISTICO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO PO FESR 2007/2013,
L Osservatorio apre alle scuole
 Regione Siciliana Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque L Osservatorio apre alle scuole Ing. Maria Teresa Noto Novembre - Dicembre 2009 1 L e i suoi compiti istituzionali L (ex Ufficio Idrografico
Regione Siciliana Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque L Osservatorio apre alle scuole Ing. Maria Teresa Noto Novembre - Dicembre 2009 1 L e i suoi compiti istituzionali L (ex Ufficio Idrografico
Stime costi annuali per la società legati all erosione a livello europeo (SEC (2006) 1165)
 Premessa: Questa presentazione ha lo scopo di illustrare, in modo estremamente semplificato, le cause di degradazione del suolo, così come esse sono state individuate dalla Soil Thematic Strategy dell
Premessa: Questa presentazione ha lo scopo di illustrare, in modo estremamente semplificato, le cause di degradazione del suolo, così come esse sono state individuate dalla Soil Thematic Strategy dell
LAMINAZIONE DELLE PIENE E RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE IN ROMAGNA
 Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli LAMINAZIONE DELLE PIENE E RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE IN ROMAGNA Geom. Fausto Pardolesi Ing. Davide Sormani I Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale SARZANA
Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli LAMINAZIONE DELLE PIENE E RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE IN ROMAGNA Geom. Fausto Pardolesi Ing. Davide Sormani I Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale SARZANA
LE OPERE DI SBARRAMENTO
 LE OPERE DI SBARRAMENTO LE DIGHE Sono opere di sbarramento, di un corso d acqua, che determinano la formazione di un invaso o lago artificiale. L opera può avere diversi scopi: Regolare le portate fluviali
LE OPERE DI SBARRAMENTO LE DIGHE Sono opere di sbarramento, di un corso d acqua, che determinano la formazione di un invaso o lago artificiale. L opera può avere diversi scopi: Regolare le portate fluviali
Variazioni del profilo di fondo alveo
 Assetto Schedatura morfologico dei tratti e idraulico fluviali Fiume: Baganza Ordine: III sx/dx Po: Destra P Lunghezza tratto (Km):,0 Tratto: PR_04000 - BA_01000 confluenza Baganza in Parma - località
Assetto Schedatura morfologico dei tratti e idraulico fluviali Fiume: Baganza Ordine: III sx/dx Po: Destra P Lunghezza tratto (Km):,0 Tratto: PR_04000 - BA_01000 confluenza Baganza in Parma - località
L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando:
 L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando: 1) laghi 2) fiumi 3) falde acquifere LE FALDE ACQUIFERE L'acqua penetra nel terreno
L'acqua che scende dal cielo (pioggia, neve) finisce nel mare (acque esterne) o sulla superficie terrestre formando: 1) laghi 2) fiumi 3) falde acquifere LE FALDE ACQUIFERE L'acqua penetra nel terreno
Il quadro conoscitivo: le mappe della pericolosità e del rischio di inondazione marina
 DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO SEINONDA CICLO DI INCONTRI TECNICI A SCALA INTERPROVINCIALE (20 maggio 10 giugno 2015) Progetti di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO SEINONDA CICLO DI INCONTRI TECNICI A SCALA INTERPROVINCIALE (20 maggio 10 giugno 2015) Progetti di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
Club Alpino Italiano Sezione di Salerno
 Club Alpino Italiano Sezione di Salerno Domenica 19 luglio 2015 Monte Miletto e circhi glaciali dell Aquilania Monti del Matese Escursione intersezionale con il CAI di Benevento Percorso: Campitello Matese
Club Alpino Italiano Sezione di Salerno Domenica 19 luglio 2015 Monte Miletto e circhi glaciali dell Aquilania Monti del Matese Escursione intersezionale con il CAI di Benevento Percorso: Campitello Matese
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO PORTO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO Ditta: PROGETTO DI POTENZIAMENTO,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO TURISTICO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO PO FESR 2007/2013,
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO PORTO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO Ditta: PROGETTO DI POTENZIAMENTO,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO TURISTICO DELL'ACQUASANTA DI PALERMO PO FESR 2007/2013,
SCUOLA PRIMARIA RONZO-CHIENIS
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it REPUBBLICA ITALIANA
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI IL FIUME PIAVE
 FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI IL FIUME PIAVE Il Contratto di Fiume Basso Piave Le tappe del processo di concertazione : 16 aprile 2014 primo incontro tra gli Enti e i portatori di
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI IL FIUME PIAVE Il Contratto di Fiume Basso Piave Le tappe del processo di concertazione : 16 aprile 2014 primo incontro tra gli Enti e i portatori di
Evoluzione del territorio litorale molisano
 Evoluzione del territorio litorale molisano Ente per le Nuove Tecnologie, l Energia, e per l Ambiente Italia Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Climatici e Sviluppo Sostenibile S. Cardinali, E. Valpreda,
Evoluzione del territorio litorale molisano Ente per le Nuove Tecnologie, l Energia, e per l Ambiente Italia Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Climatici e Sviluppo Sostenibile S. Cardinali, E. Valpreda,
Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana
 Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
SCUOLA PRIMARIA MORI
 SCUOLA PRIMARIA MORI CLASSE: 5 A DOCENTE: BENONI MERCEDES DISCLIPLINA: GEOGRAFIA Anno Scolastico: 2015-2016 Leggere l organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi
SCUOLA PRIMARIA MORI CLASSE: 5 A DOCENTE: BENONI MERCEDES DISCLIPLINA: GEOGRAFIA Anno Scolastico: 2015-2016 Leggere l organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
 La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
Il Lambro è lungo 134 km, nasce a una quota di 1456 m sul livello del mare; sfocia nel Po. Il Lambro ha un regime torrentizio cioè non ha sempre la
 Il Lambro è lungo 134 km, nasce a una quota di 1456 m sul livello del mare; sfocia nel Po. Il Lambro ha un regime torrentizio cioè non ha sempre la stessa portata d acqua, in estate è spesso in secca.
Il Lambro è lungo 134 km, nasce a una quota di 1456 m sul livello del mare; sfocia nel Po. Il Lambro ha un regime torrentizio cioè non ha sempre la stessa portata d acqua, in estate è spesso in secca.
VIAGGIO D ISTRUZIONE IN TRENO, BARCA E BICICLETTA
 VIAGGIO D ISTRUZIONE IN TRENO, BARCA E BICICLETTA Portogruaro - Cervignano - Terzo di Aquileia - Aquileia - Grado - Marano Lagunare - Lignano - Concordia Sagittaria. PORTOGRUARO (Ve) La città è sorta
VIAGGIO D ISTRUZIONE IN TRENO, BARCA E BICICLETTA Portogruaro - Cervignano - Terzo di Aquileia - Aquileia - Grado - Marano Lagunare - Lignano - Concordia Sagittaria. PORTOGRUARO (Ve) La città è sorta
DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COSTIERE. Venezia, 7 Novembre 2014 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
 DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COSTIERE Venezia, 7 Novembre 2014 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Il piano di gestione del rischio alluvioni per i fenomeni
DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COSTIERE Venezia, 7 Novembre 2014 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Il piano di gestione del rischio alluvioni per i fenomeni
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
 1 Utilizza i punti cardinali e coordinate geografiche per orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 2 Analizza fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a
1 Utilizza i punti cardinali e coordinate geografiche per orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 2 Analizza fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a
PROVINCIA DI SIRACUSA. Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento
 Allegato 7 - Siracusa PROVINCIA DI SIRACUSA Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento tratto(metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto Lat. Long. E Lat. Long. E Da lato est
Allegato 7 - Siracusa PROVINCIA DI SIRACUSA Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento tratto(metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto Lat. Long. E Lat. Long. E Da lato est
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
 IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
LUOGHI DI INTERESSE Parco Archeologico di Himera - Tempio della Vittoria Acquedotto Romano Riserva Naturale del monte S. Calogero
 LUOGHI DI INTERESSE Parco Archeologico di Himera - Tempio della Vittoria Colonia Greca fondata da un nucleo misto di genti ioniche e doriche nell anno 648 a. C. ad ovest del fiume omonimo. Il complesso
LUOGHI DI INTERESSE Parco Archeologico di Himera - Tempio della Vittoria Colonia Greca fondata da un nucleo misto di genti ioniche e doriche nell anno 648 a. C. ad ovest del fiume omonimo. Il complesso
BOLLETTINO BALNEAZIONE
 BOLLETTINO BALNEAZIONE N 04 - Luglio 2013 Periodo di monitoraggio: 11 maggio - 07 ottobre Il Bollettino - come previsto dalla normativa vigente* - prevede l informazione al pubblico relativamente a: 1.
BOLLETTINO BALNEAZIONE N 04 - Luglio 2013 Periodo di monitoraggio: 11 maggio - 07 ottobre Il Bollettino - come previsto dalla normativa vigente* - prevede l informazione al pubblico relativamente a: 1.
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012
 Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico
 AUTORITA' di BACINO del RENO Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i. I RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI Zonizzazione Aree a Rischio SCHEDA N. 145 Località:
AUTORITA' di BACINO del RENO Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i. I RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI Zonizzazione Aree a Rischio SCHEDA N. 145 Località:
Catasto Ghiacciai della Regione autonoma Valle d Aosta: aggiornamento e Piano di prevenzione dei rischi glaciali
 Workshop Valutazione del rischio idraulico in ambito montano ed applicazione della direttiva alluvioni Libera Università di Bolzano, 3-4 maggio 2012 Catasto Ghiacciai della Regione autonoma Valle d Aosta:
Workshop Valutazione del rischio idraulico in ambito montano ed applicazione della direttiva alluvioni Libera Università di Bolzano, 3-4 maggio 2012 Catasto Ghiacciai della Regione autonoma Valle d Aosta:
PROGETTAZIONI FLUVIALI A VALENZA PLURIMA DEL PIANO NAZIONALE RISCHIO IDROGEOLOGICO : ALCUNI ESEMPI
 PROGETTAZIONI FLUVIALI A VALENZA PLURIMA DEL PIANO NAZIONALE RISCHIO IDROGEOLOGICO 2015-2020 : ALCUNI ESEMPI SUI FIUMI ROMAGNOLI IN LINEA CON LE DIRETTIVE EUROPEE. D. Sormani (*), P. Ercoli (**), C. Iuzzolino
PROGETTAZIONI FLUVIALI A VALENZA PLURIMA DEL PIANO NAZIONALE RISCHIO IDROGEOLOGICO 2015-2020 : ALCUNI ESEMPI SUI FIUMI ROMAGNOLI IN LINEA CON LE DIRETTIVE EUROPEE. D. Sormani (*), P. Ercoli (**), C. Iuzzolino
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL AUTORITÀ DI BACINO
 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL AUTORITÀ DI BACINO Legge regionale 3 luglio 2002 TRE ORGANI DI GOVERNO (art. 6 LR 16/2002): COMITATO ISTITUZIONALE ( dpr n. 0301/Pres. 8/10/02) COMITATO TECNICO (costituito
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL AUTORITÀ DI BACINO Legge regionale 3 luglio 2002 TRE ORGANI DI GOVERNO (art. 6 LR 16/2002): COMITATO ISTITUZIONALE ( dpr n. 0301/Pres. 8/10/02) COMITATO TECNICO (costituito
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA
 CONCORSO PER L AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE: strutture della società, insediamenti ed organizzazione del territorio, attività produttive ELENCO TEMI XIV CICLO Tema
CONCORSO PER L AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE: strutture della società, insediamenti ed organizzazione del territorio, attività produttive ELENCO TEMI XIV CICLO Tema
Autorità di Bacino DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
 Autorità di Bacino DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE evento alluvionale del 31 ottobre - 2 novembre 2010 PIANO DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Autorità di Bacino DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE evento alluvionale del 31 ottobre - 2 novembre 2010 PIANO DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
BOLLETTINO BALNEAZIONE
 BOLLETTINO BALNEAZIONE N 03 - Giugno 2015 Periodo di monitoraggio: 23 Maggio - 4 Ottobre Il bollettino balneazione - come previsto dalla normativa vigente* - prevede l informazione al pubblico relativamente
BOLLETTINO BALNEAZIONE N 03 - Giugno 2015 Periodo di monitoraggio: 23 Maggio - 4 Ottobre Il bollettino balneazione - come previsto dalla normativa vigente* - prevede l informazione al pubblico relativamente
LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA
 zona E LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA TEMPORALI VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. GIALLA Occasionale pericolo: fenomeni puntuali
zona E LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA TEMPORALI VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. GIALLA Occasionale pericolo: fenomeni puntuali
L estuario del Fiume Lamone e interazione acque superficiali acque sotterranee in zona costiera
 Integrated Geoscience Research Group L estuario del Fiume Lamone e interazione acque superficiali acque sotterranee in zona costiera Faenza 13 Dicembre 2008 Dott. Mario Laghi Intrusione salina nell acquifero
Integrated Geoscience Research Group L estuario del Fiume Lamone e interazione acque superficiali acque sotterranee in zona costiera Faenza 13 Dicembre 2008 Dott. Mario Laghi Intrusione salina nell acquifero
Dalle criticità idrauliche alla gestione della vegetazione: la manutenzione dei corsi d acqua nell approccio regionale
 LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE TRA RISCHIO IDRAULICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO Dalle criticità idrauliche alla gestione della vegetazione: la manutenzione dei corsi d acqua nell
LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE TRA RISCHIO IDRAULICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO Dalle criticità idrauliche alla gestione della vegetazione: la manutenzione dei corsi d acqua nell
Resoconto sullo stato delle risorse idriche al 31 dicembre 2017
 Resoconto sullo stato delle risorse idriche al 31 dicembre 2017 Fiume Marzenego alla confluenza con lo scolo Fossalta a Massanzago (PD) Fiumicello Muson Vecchio al ponte della ex ferrovia Ostiglia a Camposampiero
Resoconto sullo stato delle risorse idriche al 31 dicembre 2017 Fiume Marzenego alla confluenza con lo scolo Fossalta a Massanzago (PD) Fiumicello Muson Vecchio al ponte della ex ferrovia Ostiglia a Camposampiero
Paesaggio agrario: le determinanti nell'evoluzione dei segni agricoli. comunicazione di Alessandra Furlani, agronomo direttore TERRITORI
 Paesaggio agrario: le determinanti nell'evoluzione dei segni agricoli comunicazione di Alessandra Furlani, agronomo direttore TERRITORI Bologna, 13 dicembre 2013 Il nostro Paese è unico nel contesto internazionale
Paesaggio agrario: le determinanti nell'evoluzione dei segni agricoli comunicazione di Alessandra Furlani, agronomo direttore TERRITORI Bologna, 13 dicembre 2013 Il nostro Paese è unico nel contesto internazionale
Tale distanza è misurata da Cremona a faro Pila. L'uscita diretta a mare non è funzionale.
 Descrizione generale Il fiume Po è l'asse centrale del sistema Idroviario Padano Veneto. La parte attualmente navigata va da Cremona al mare per una lunghezza di circa 280 km. Tale distanza è misurata
Descrizione generale Il fiume Po è l'asse centrale del sistema Idroviario Padano Veneto. La parte attualmente navigata va da Cremona al mare per una lunghezza di circa 280 km. Tale distanza è misurata
Il ciclo idrologico globale M. Marani
 Il ciclo idrologico globale M. Marani P=109 10 3 Gm 3 /yr Avvezione=36 10 3 Gm 3 /yr P=468 10 3 Gm 3 /yr ET=73 10 3 Gm 3 /yr Infiltrazione Q=35 10 3 Gm 3 /yr Continenti Qsub=1 10 3 Gm 3 /yr E=504 10 3
Il ciclo idrologico globale M. Marani P=109 10 3 Gm 3 /yr Avvezione=36 10 3 Gm 3 /yr P=468 10 3 Gm 3 /yr ET=73 10 3 Gm 3 /yr Infiltrazione Q=35 10 3 Gm 3 /yr Continenti Qsub=1 10 3 Gm 3 /yr E=504 10 3
CIAO MI PRESENTO: IO SONO UN FIUME, SONO UN CORSO D ACQUA DOLCE. NASCO IN MONTAGNA E SCENDO GIU FINO AL MARE.
 CIAO MI PRESENTO: IO SONO UN FIUME, SONO UN CORSO D ACQUA DOLCE. NASCO IN MONTAGNA E SCENDO GIU FINO AL MARE. I FIUMI COME ME NASCONO DALL ACQUA DEI GHIACCIAI CHE SI SCIOGLIE MA ANCHE DALLA PIOGGIA. APPENA
CIAO MI PRESENTO: IO SONO UN FIUME, SONO UN CORSO D ACQUA DOLCE. NASCO IN MONTAGNA E SCENDO GIU FINO AL MARE. I FIUMI COME ME NASCONO DALL ACQUA DEI GHIACCIAI CHE SI SCIOGLIE MA ANCHE DALLA PIOGGIA. APPENA
BOLLETTINO BALNEAZIONE
 BOLLETTINO BALNEAZIONE N - Maggio 22 Periodo di monitoraggio: 12 maggio - 30 settembre Il Bollettino - come previsto dalla normativa vigente* - prevede l informazione al pubblico relativamente a: 1. Durata
BOLLETTINO BALNEAZIONE N - Maggio 22 Periodo di monitoraggio: 12 maggio - 30 settembre Il Bollettino - come previsto dalla normativa vigente* - prevede l informazione al pubblico relativamente a: 1. Durata
Figura 1. Pianta prospettica della città di Fano, Blavius Jr, 1663
 ALLA RICERCA DEL PORTO DI FANO (PU): IPOTESI DI IDENTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PORTUALI DI EPOCA TARDOANTICA E ALTO MEDIEVALE SULLA BASE DELLE FONTI STORICO-ARCHEOLOGICHE Abstract La costa fanese è caratterizzata
ALLA RICERCA DEL PORTO DI FANO (PU): IPOTESI DI IDENTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PORTUALI DI EPOCA TARDOANTICA E ALTO MEDIEVALE SULLA BASE DELLE FONTI STORICO-ARCHEOLOGICHE Abstract La costa fanese è caratterizzata
Una regione bagnata da due mari
 Una regione bagnata da due mari La Basilicata o anche comunemente Lucania Confina a nord e ad est con la Puglia, ad ovest con la Campania, a sud con la Calabria, a sud-ovest è bagnata dal mar Tirreno e
Una regione bagnata da due mari La Basilicata o anche comunemente Lucania Confina a nord e ad est con la Puglia, ad ovest con la Campania, a sud con la Calabria, a sud-ovest è bagnata dal mar Tirreno e
BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LAMONE
 PROVINCIA DI FORLI'-CESENA Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora e Fauna Piazza Morgagni, 2-47121 Forlì e-mail: florfaun@provincia.fc.it ELENCO STRUTTURATO PER BACINI IDROGRAFICI DELLE ZONE DI PROTEZIONE
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora e Fauna Piazza Morgagni, 2-47121 Forlì e-mail: florfaun@provincia.fc.it ELENCO STRUTTURATO PER BACINI IDROGRAFICI DELLE ZONE DI PROTEZIONE
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
GLI ETRUSCHI L ETRURIA AVEVA:
 GLI ETRUSCHI LA CIVILTÀ ETRUSCA SI SVILUPPÒ VERSO L 800 A.C. IN ETRURIA. L ETRURIA ERA UNA ZONA TRA IL FIUME ARNO E IL FIUME TEVERE UNA CITTÀ IMPORTANTE DELL ETRURIA ERA POPULONIA GLI ETRUSCHI OCCUPAVANO
GLI ETRUSCHI LA CIVILTÀ ETRUSCA SI SVILUPPÒ VERSO L 800 A.C. IN ETRURIA. L ETRURIA ERA UNA ZONA TRA IL FIUME ARNO E IL FIUME TEVERE UNA CITTÀ IMPORTANTE DELL ETRURIA ERA POPULONIA GLI ETRUSCHI OCCUPAVANO
ACQUE DI BALNEAZIONE
 ACQUE DI BALNEAZIONE SCHEDA INFORMATIVA PUNTO DI CAMPIONAMENTO N. 72 1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione* ISOLA DI ALBARELLA NORD ALBARELLA 2 Id acqua di balneazione* IT005029040006
ACQUE DI BALNEAZIONE SCHEDA INFORMATIVA PUNTO DI CAMPIONAMENTO N. 72 1.1 Dati identificativi 1 Denominazione acqua di balneazione* ISOLA DI ALBARELLA NORD ALBARELLA 2 Id acqua di balneazione* IT005029040006
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1
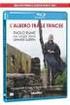 Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
Cosa sono le acque continentali?
 Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
La sorgente è il punto dove nasce il fiume e di solito si trova in montagna.
 I fiumi e i laghi Il fiume I fiumi sono corsi d acqua di grandi dimensioni e perenni, cioè non sono mai completamente asciutti. I ruscelli sono corsi d acqua di piccole dimensioni. I torrenti sono corsi
I fiumi e i laghi Il fiume I fiumi sono corsi d acqua di grandi dimensioni e perenni, cioè non sono mai completamente asciutti. I ruscelli sono corsi d acqua di piccole dimensioni. I torrenti sono corsi
Autorità di Bacino DELL ADIGE E DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
 Autorità di Bacino DELL ADIGE E DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE ACQUA: A CHI RIVOLGERSI, QUANDO DOVE, PERCHE. LE CHIAVI PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE ing. Roberto Casarin
Autorità di Bacino DELL ADIGE E DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE ACQUA: A CHI RIVOLGERSI, QUANDO DOVE, PERCHE. LE CHIAVI PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE ing. Roberto Casarin
Milano, 23 aprile 2009
 Milano, 23 aprile 2009 Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po via Garibaldi, 75-43100 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it - partecipo@adbpo.it Piano distrettuale di gestione delle
Milano, 23 aprile 2009 Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po via Garibaldi, 75-43100 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it - partecipo@adbpo.it Piano distrettuale di gestione delle
Autorità di Bacino. Acque dolci in laguna per la sicurezza idraulica del territorio
 Autorità di Bacino DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE Acque dolci in laguna per la sicurezza idraulica del territorio Mira, 13 febbraio 2012 ing. Roberto Casarin IL BACINO
Autorità di Bacino DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE Acque dolci in laguna per la sicurezza idraulica del territorio Mira, 13 febbraio 2012 ing. Roberto Casarin IL BACINO
