Ristretti Orizzonti. Studenti incontrano il carcere, il carcere entra nelle classi
|
|
|
- Ernesto Tosi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1
2 Ristretti Orizzonti PAROLE IN LIBERTÀ tra carcere e scuole Studenti incontrano il carcere, il carcere entra nelle classi Iniziativa realizzata grazie al contributo del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova Progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere
3 Il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere è realizzato dalla redazione di Ristretti Orizzonti in collaborazione con l associazione Granello di Senape e la Casa di reclusione di Padova, grazie al sostegno e al finanziamento del Comune di Padova - Assessorato alle Politiche Sociali. La pubblicazione Parole in libertà tra carcere e scuole è stata realizzata grazie al contributo di: Comune di Padova - Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova - Assessorato alle Politiche Scolastiche Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Padova Regione Veneto - Assessorato alle Politiche Sociali Progetto editoriale ed editing di Ornella Favero, in collaborazione con Francesco Morelli, Marino Occhipinti, Elton Kalica Progetto grafico, impaginazione e vignette di Graziano Scialpi Supplemento al numero 1/2009 di Ristretti Orizzonti Pubblicazione registrata del Tribunale di Venezia n 1315 dell 11 gennaio 1999 Spedizione in A.P. art. 2 comma 20/C Legge 662/96 Filiale di Padova Direttore responsabile Ornella Favero Hanno collaborato al progetto: Redazione di Ristretti Orizzonti - Casa di reclusione di Padova Salvatore Allia, Andrea Andriotto, Daniele Barosco, Maurizio Bertani, Sandro Calderoni, Gian Luca Cappuzzo, Gentian Germani, Giampaolo Casu, Adnene El Barrak, Antonio Floris, Franco Garaffoni, Maher Gdoura, Milan Grgic, Dritan Iberisha, Bardhyl Ismaili, Elton Kalica, Pierin Kola, Davor Kovač, Jovica Labus, Marco Libietti, Vanni Lonardi, Mohamed Alì Madouri, Prince Maxwho Obayangbon, Marino Occhipinti, Pierluigi Paviola, Elvin Pupi, Kamel Said, Rachid Salem, Mario Sergi, Walter Sponga, Serghei Vitali, Fabio Zanni Redazione Giudecca Claudia, Claudine, Cristina, Katharine, Maria, Natasha, Sara Segreteria Redazionale Alessandro Busi, Gabriella Brugliera, Vanna Chiodarelli, Lucia Faggion Sede esterna Ufficio stampa e Centro studi Paola Marchetti, Francesco Morelli, Nicola Sansonna Redattori esterni e collaboratori Paolo Moresco, Bruno Boscato, Giovanni Viafora, Elisa Nicoletti, Paolo Pasimeni
4 Parole in libertà tra carcere e scuole Nell ambito del progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere quest anno abbiamo deciso di preparare un libro sul metodo, di creare cioè uno strumento utile a insegnanti, genitori, studenti per affrontare un percorso che metta in relazione le scuole con il carcere, e soprattutto che dia modo ai ragazzi delle scuole di fare un esperienza significativa di conoscenza e approfondimento di temi complessi, che non riguardano solo chi in carcere ci finisce, ma tutti noi: le piccole violazioni della legalità che creano una specie di terreno fertile per violazioni più gravi, le trasgressioni, i comportamenti a rischio che poi finiscono per trasformarsi in reato, la sicurezza e tutto quello che la mette in pericolo. Nella scelta dei materiali, abbiamo privilegiato i seguenti criteri: Presentare i materiali di base per iniziare in una scuola questo progetto, per dar modo agli insegnanti, che vogliano coinvolgere altri colleghi o spiegare ai genitori il percorso, di adattare alle esigenze delle diverse classi i percorsi proposti Fornire alcuni esempi di percorsi, già sperimentati da insegnanti in scuole diverse Dare agli insegnanti utili strumenti di lavoro sulla scrittura, in particolare la scrittura autobiografica e la scrittura giornalistica Fornire alcune basi teoriche, ma sempre a partire dall esperienza: lezioni sulla giustizia minorile, sull esecuzione della pena, sulla mediazione penale, tenute ai ragazzi delle scuole da esperti (docenti di Diritto penale e di Diritto minorile, Magistrati di Sorveglianza, mediatori penali) Studiare delle forme di coinvolgimento delle famiglie, sempre basandosi su esempi di percorsi già sperimentati in alcune scuole 1
5 2
6 SOMMARIO 1. Il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere 2. Smontare la notizia: un percorso per smontare le notizie, ma anche per imparare a scriverle Il caso della semilibertà concessa a Pietro Maso La notizia letta sui quotidiani, il punto di vista dei detenuti, le riflessioni dei ragazzi di una terza media, l approfondimento di Gianfranco Bettin, sociologo e scrittore Come organizzare un piccolo laboratorio di scrittura giornalistica Tema scelto: La sicurezza vista dai giovani La sicurezza vista da un direttore di giornale Intervista della redazione di Ristretti Orizzonti al direttore del Mattino di Padova 3. Altre scritture La cartografia dell esperienza Laboratori di scrittura autobiografica e memoriale Adriana Lorenzi, l autrice del testo, conduce laboratori di scrittura autobiografica Narrare l esperienza nei contesti formativi Il Laboratorio di scrittura nel carcere di Rebibbia: un esperienza esportabile anche nelle scuole? Luciana Scarcia, l autrice del testo, conduce laboratori di scrittura a Rebibbia La galera raccontata attraverso un dente Un curioso esempio di scrittura autobiografica di Elton Kalica, detenuto della redazione di Ristretti Orizzonti 4. Un percorso sulla mediazione: Uno strumento che si preoccupa di provare a riparare una relazione che si è rotta di Federica Brunelli, mediatrice dell Ufficio per la mediazione penale di Milano Un nuovo modo di intendere la pena I ragazzi del Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato raccontano l incontro con una mediatrice penale Quando chi ha subito un reato e chi lo ha commesso sono di fronte Un confronto tra Elena Baccarin, insegnante, e due detenuti 5. Un percorso sulla giustizia: La Giustizia minorile di Elisabetta Palermo, docente di Diritto penale dell Università di Padova Fare con i ragazzi un opera di chiarificazione rispetto ai messaggi dei mass media di Paolo Canevelli, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia 3
7 Vent anni di carcere possono essere veramente il massimo della pena Un intervista al magistrato-scrittore Gianrico Carofiglio Un ragazzo che sbaglia invece che essere un rifiuto può diventare una risorsa intervista a don Ettore Cannavera, cappellano del carcere minorile di Quartucciu e responsabile della comunità La Collina Come funzionano le pene intervista ai Magistrati di Sorveglianza di Padova, Giovanni Maria Pavarin e Marcello Bortolato Laddove c è un carcere con pene altissime, c è in realtà maggiore criminalità di Mauro Palma, Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura, dei trattamenti e delle pene inumane e degradanti 6. Un percorso su sicurezza, insicurezza, legalità, trasgressione, bullismo Quanto si sentono insicuri i giovani? a cura degli studenti delle scuole coinvolte nel progetto scuole-carcere La trasgressione e la normalità viste dai ragazzi a cura degli studenti dell Istituto d arte Selvatico di Padova Cos è questo bullismo di cui tutti parlano? a cura degli studenti della Scuola media Mameli-Falconetto di Padova 7. Il punto di vista degli insegnanti Rompere la routine quotidiana dei programmi per occuparci della vita vissuta di Giuliana De Cecchi, insegnante di Lettere, Itas P. Scalcerle di Padova Persone che offrono all attenzione e allo studio dei giovani la loro tormentata esperienza di Antonio Bincoletto, insegnante di Lettere, Liceo Marchesi-Fusinato di Padova Da un atteggiamento diffidente e colpevolista alla scoperta di un mondo ricco di umanità e di sofferenza di Maria D Abruzzo, insegnante di Lettere, Liceo Socio-Psico-Pedagogico Duca D Aosta di Padova Un progetto per abituare i ragazzi a pensare con la propria testa di Lucia Tussardi, insegnante di Lettere, Scuola media Mameli-Falconetto di Padova Una scuola in cui il progetto con il carcere è diventato davvero di tutti di Stefano Cappuccio, insegnante tecnico pratico nei Laboratori di Automazione Industriale, I.T.I.S. G. Natta di Padova È fondamentale educare alla possibilità e non al giudizio a priori di Incoronata Pergola, insegnante di Lettere, Scuola media M. Buonarroti di Sarmeola di Rubano Imparare a combattere l abitudine al male di Ombretta Fittà, insegnante di Lettere, Scuola media M. Buonarroti di Rubano Insegnare in carcere di Daniela Lucchesi, insegnante di Lettere nella Casa di reclusione di Padova 4
8 8. Il punto di vista dei genitori Un progetto nel quale possono essere i ragazzi stessi a coinvolgere i loro genitori lettera ai genitori per spiegare il percorso scuole-carcere Quando i genitori accettano di farsi insegnare qualcosa dai loro figli dei genitori dei ragazzi della 4 a SD dell Istituto professionale Leonardo da Vinci Di questa esperienza abbiamo condiviso tutti una valutazione molto positiva lettera aperta di un gruppo di genitori della 3 a F della Scuola media Buonarroti di Rubano Riflessioni sulla sicurezza, le pene, la funzione del carcere a cura dei genitori dei ragazzi di una Scuola media È difficile dire Io ho un figlio in carcere di N. A., padre di un ragazzo detenuto 9. Ma i detenuti, perché accettano di raccontarsi? Le domande severe dei ragazzi di Paola Marchetti Quando racconto la galera agli studenti, mi si stringe lo stomaco dai crampi di dolore di Elton Kalica Le parole giuste per potersi raccontare di Sandro Calderoni I genitori di questi ragazzi sono stati coraggiosi a lasciarli entrare in carcere di Marino Occhipinti Noi detenuti abbiamo un po imparato a dialogare con il nostro passato di Maurizio Bertani Piano piano, senza accorgermene, stavo cadendo sempre più in basso di Andrea Andriotto 5
9 6
10 Capitolo 1 IL CARCERE ENTRA A SCUOLA LE SCUOLE ENTRANO IN CARCERE Un progetto di incontro e di confronto sulle pene, la legalità, la devianza, la sicurezza, la vita detentiva La caratteristica fondamentale di questo progetto è che i percorsi vengono adattati ai diversi gruppi classe. I temi sui quali si lavora sono: il rispetto della legalità, i comportamenti a rischio e la devianza, il disagio minorile, la giustizia penale minorile, percorsi di vita di detenuti e detenute e riflessione sui reati e sulle pene, la questione sicurezza oggi così pesantemente al centro dell attenzione, l evoluzione della struttura penitenziaria in Italia, le diverse figure professionali che operano in carcere. Ogni percorso sarà studiato e messo a punto con gli insegnanti della classe interessata e i volontari di associazioni che operano in carcere e si occupano di creare questo confronto tra il carcere e le scuole, non esiste un percorso standard. Nel corso degli anni sempre più spesso nel progetto sono stati coinvolti i genitori, alcuni hanno anche partecipato a incontri con i detenuti nelle scuole e sono poi entrati in carcere per incontrare la redazione di Ristretti Orizzonti. Gli insegnanti interessati a presentare il progetto anche ai genitori possono usufruire di materiali pensati con questa finalità, che saranno forniti all inizio del percorso (il testo di una lettera, un foglio informativo che spiega con testimonianze di detenuti e di studenti il senso di tutto il progetto). Se lo si ritiene utile, si può anche organizzare un incontro con modalità da definire insieme. 7
11 8
12 UN PROGETTO NEL QUALE POSSONO ESSERE I RAGAZZI STESSI A COINVOLGERE I LORO GENITORI Il progetto viene presentato agli insegnanti interessati in un incontro in carcere nella redazione di Ristretti Orizzonti alla fine dell anno scolastico, per dar modo agli insegnanti stessi di decidere se parteciparvi nell anno scolastico successivo. All inizio del nuovo anno scolastico gli insegnanti coinvolti incontrano i volontari responsabili del progetto per scegliere il percorso più adatto alle loro classi e fissare le date dei primi incontri. Gli insegnanti poi presentano alla classe il progetto (e ne danno comunicazione ai genitori con le modalità che ritengono più idonee) e iniziano a organizzare il lavoro, che può prevedere gruppi di studio su temi diversi, come la detenzione femminile, i minori in carcere, la pena di morte etc., letture, incontri per tutta la classe. La prima tappa è dedicata alla scrittura libera: per tastare le conoscenze degli studenti sul carcere, le pene, la sicurezza i ragazzi sono invitati a scrivere le loro riflessioni seguendo alcune tracce proposte (che idea hanno del carcere e di chi ci finisce dentro, delle pene, della sicurezza nella loro città etc.). Incontri nelle scuole con detenuti in permesso o ex detenuti (è disponibile a venire nelle classi anche una detenuta del carcere della Giudecca), famigliari (è disponibile spesso a intervenire il padre di un detenuto), volontari, operatori, per cominciare ad affrontare più da vicino i temi della legalità e della devianza. Sono possibili anche incontri dedicati alla giustizia minorile, con una docente di Diritto penale minorile, alla mediazione penale e al rapporto con le vittime, con mediatori dell Ufficio per la mediazione penale di Milano, incontri sull esecuzione della pena con il Magistrato di Sorveglianza, incontri dedicati al ruolo delle figure professionali che operano con i detenuti e le loro famiglie (educatori e assistenti sociali dell Ufficio per l esecuzione penale esterna, agenti di Polizia penitenziaria). È possibile anche un percorso di lettura, che prevede: letture sulla base di una bibliografia di romanzi sui temi della legalità, della devianza, del carcere (per esempio. autori noir italiani, sul tema del lato oscuro delle nostre città, ma anche i libri di testimonianze realizzati da Ristretti Orizzonti: Donne in sospeso, L amore a tempo di galera, Ragazzini e ragazzacci ). 9
13 Il percorso dedica ampio spazio alla scrittura, con incontri a cura della Redazione di Ristretti Orizzonti, e la produzione, da parte di studenti e detenuti, di testi, con riflessioni sull esperienza appena fatta. L attenzione è rivolta soprattutto alla scrittura giornalistica e alla scrittura autobiografica, con piccoli laboratori nelle scuole e confronti con giornalisti liberi e giornalisti detenuti sulla comunicazione. È possibile un percorso sull informazione: dalla lettura guidata di notizie riguardanti il carcere, le pene, la sicurezza, alla comparazione con le stesse notizie commentate dai detenuti, alla loro riscrittura sulla base di più punti di vista. A tal fine, agli insegnanti interessati verranno periodicamente inviati via mail dossier su temi di attualità, attinenti al progetto, con articoli tratti dai principali quotidiani, articoli scritti da detenuti (per esempio, gli articoli scritti da Ristretti Orizzonti per il quotidiano Il Mattino di Padova) e altri materiali informativi. Riprese con la videocamera, con l ausilio di detenuti del Tg Due Palazzi e di Ristretti Orizzonti in permesso premio, di riflessioni degli studenti dei gruppi individuati sui temi oggetto del progetto e sul carcere, e possibile produzione di un video o produzione di spot che potrebbero riguardare la vita carceraria e le condizioni della detenzione, ma anche il tema della devianza e del pregiudizio. Visione di un film su questi temi, e recensioni a cura degli studenti e dei detenuti, incontro con i registi (si propone il film L ora d amore, presentato alla Festa del Cinema di Roma). Visita in carcere e incontro con la redazione di Ristretti Orizzonti, se gli insegnanti ritengono le classi sufficientemente mature per questa esperienza. Durante l incontro gli studenti possono porre ai detenuti domande sul carcere, ma anche sulle pene, sui percorsi che portano a uscire dalla legalità. Nel progetto saranno utilizzati i materiali forniti dal Centro di Documentazione Due Palazzi, e in particolare le Rassegne stampa a tema, la rivista Ristretti Orizzonti e la pubblicazione Ragazzini e ragazzacci sul disagio minorile, curata dall associazione Il Granello di Senape, il video Voci da dentro realizzato nel carcere minorile di Treviso, e sarà attivata una sezione del sito per permettere agli studenti di scrivere con più immediatezza le loro riflessioni sul progetto. 10
14 Fase conclusiva del progetto: Qualora i genitori siano interessati nell ambito del progetto a partecipare ad un incontro in carcere possono comunicarlo all insegnante di riferimento, che si metterà in contatto con l associazione che cura il progetto. È previsto un concorso, riservato agli studenti che partecipano al progetto, dove una giuria qualificata sceglierà e premierà gli scritti, i video, le opere grafiche più originali realizzati dai ragazzi (i premi in palio sono computer portatili e macchine fotografiche digitali). Incontro finale alla sala MPX, con i consigli di scrittura di uno scrittore (gli anni scorsi sono stati Carlo Lucarelli e Gianfranco Bettin a dare i loro consigli agli studenti), la proiezione di un film e la premiazione degli studenti vincitori del concorso. Pubblicazione delle testimonianze dei detenuti, di lettere e articoli degli studenti, di contributi di insegnanti, operatori, genitori in un DVD e un libro curati dalla rivista Ristretti Orizzonti, dedicati a questa esperienza, da distribuire poi nelle biblioteche scolastiche e civiche. 11
15 12
16 Capitolo 2 SMONTARE LA NOTIZIA Un percorso per smontare le notizie, ma anche per imparare a scriverle Giornalisti e magistrati sono spesso oggetto di pesanti critiche tra la popolazione. In una piccola indagine, fatta nell ambito del progetto Scuole-carcere da una classe del Liceo Socio-Psico-Pedagogico Duca d Aosta, risulta che il 61,8 per cento degli intervistati ritiene l informazione manipolatoria e il 15,6 esagerata. Non sono, ovviamente, dati con pretesa di scientificità, però crediamo che gli umori che si respirano tra la popolazione siano un po questi. Il nostro progetto però non intende affatto fare il gioco facile di sparare a zero sull informazione e sulla Giustizia, quanto piuttosto di aiutare i ragazzi a leggere in modo critico una notizia, e in particolare proprio le notizie che riguardano la Giustizia, e a provare a misurarsi con i problemi veri, che forse non sono i generici attacchi ai magistrati, ma le riflessioni serie sul senso della pena, sul carcere, sui tempi interminabili dei processi, che sono, quelli sì, un problema. E che vanno spiegati: perché se si dice, di una persona che ha commesso un reato e però è fuori dal carcere, che è già fuori, invece di attaccare acriticamente i magistrati è importante ragionare sulle garanzie che ogni cittadino deve avere, prima fra tutte quella che, se non costituisce un pericolo per la società, possa aspettare fuori, da presunto innocente, il processo. Come del resto avviene negli altri Paesi civili, e basta guardare qualsiasi telefilm americano tipo Law & Order per capirlo. Il problema vero è un altro, che in Italia a volte si può attendere anche dieci e più anni prima della condanna definitiva, e del carcere. Questo progetto cerca quindi di insegnare a smontare le notizie per analizzarle sentendo anche la voce dell altra parte, quella degli autori di reato. E propone un piccolo laboratorio di scrittura giornalistica, per imparare a scrivere un articolo, a fare una inchiesta, ad approfondire un tema, fra quelli che televisioni e giornali pongono ogni giorno alla nostra attenzione. 13
17 14
18 UNA NOTIZIA PASSATA AI RAGGI X Il caso della semilibertà concessa a Pietro Maso Lavorare con le notizie sulla giustizia, sulla sicurezza, sul carcere e imparare a leggerle con più attenzione è uno dei percorsi di questo progetto. Agli insegnanti interessati viene fornito periodicamente un piccolo dossier in cui si presenta una notizia, che ha suscitato particolari polemiche sui media, così come è stata data da uno o più quotidiani nazionali, e poi quella stessa notizia presentata e commentata da alcuni detenuti nello spazio che gestisce sul quotidiano Il Mattino di Padova ogni lunedì la redazione di Ristretti Orizzonti. L esempio che segue è il caso della semilibertà concessa a Pietro Maso, il ragazzo che uccise i genitori per l eredità e che, dopo diciassette anni di carcere, ora può usufruire di una misura alternativa. Il dossier è composto da articoli dei quotidiani principali (qui a titolo di esempio pubblichiamo l articolo apparso sul Giornale), da tre articoli scritti da detenuti, che analizzano da punti di vista diversi questa notizia, e da un articolo scritto per Ristretti Orizzonti da Gianfranco Bettin, sociologo e scrittore che al caso Maso ha dedicato un libro, Eredi. Maso, sì alla semilibertà: è già fuori dopo 17 anni Maso impunito, Carretta ammazza ed eredita di Michele Brambilla (Il Giornale, 14 ottobre 2008) Se non fosse una tragedia, anzi due tragedie, verrebbe da fare una battuta e dire che Ferdinando Carretta ha dato una lezione a Pietro Maso. Quest ultimo infatti uccise i genitori nel 1991 allo scopo di ereditare; benché dichiarato totalmente capace di intendere e volere dal perito, si è visto riconoscere la seminfermità mentale dai giudici, e condannare a trent anni anziché all ergastolo come la premeditazione avrebbe richiesto. Ma siccome in Italia anche una semi-condanna è pur sempre troppo, e quindi va più o meno dimezzata di default, dopo diciassette anni l imputato (oggi trentasettenne, e quindi ancora in eccellente salute) è tornato libero. Tuttavia chi pensava che Maso se la fosse cavata a buon mercato ha dovuto ricredersi ieri mattina quando ha appreso che a un altro parricida e matricida (e pure fratricida, per giunta), Ferdinando Carretta appunto, è andata ancora meglio. Carretta, che ha 46 anni, di galera non ha fatto neppure un giorno. Dopo il triplice delitto - agosto sparì nel nulla. Ricomparve dieci anni più tardi a Londra, e non perché in preda a un rimorso di coscienza avesse deciso di costituirsi, ma perché fu casualmente riconosciuto e fermato. La giustizia italiana lo considerò totalmente incapace di intendere e volere, e quindi lo mandò assolto, ordinando solo un ricovero in un ospedale psichiatrico, nel quale Carretta è rimasto sette anni. Ci sarebbe da disquisire su come un uomo 15
19 totalmente incapace di intendere e volere abbia potuto vivere e lavorare, da solo, in Inghilterra per dieci anni: ma la discussione apparirebbe perfino oziosa se confrontata con un altra. E cioè: come sia possibile che lo Stato italiano assegni in eredità a un pluriomicida tutti i beni delle sue vittime. Eppure questo è successo: Ferdinando Carretta, dopo aver ucciso i genitori e il fratello, dopo essere scappato, dopo essere stato dichiarato non punibile, dopo essersi liberato perfino del ricovero coatto, eredita. Casa e contanti di famiglia sono suoi. Carretta è riuscito dove Maso ha fallito. La singolare coincidenza - assegnazione dell eredità a Carretta lo stesso giorno della scarcerazione di Maso - non è forse casuale, o almeno speriamo che non lo sia. Speriamo che sia il segno di una giustizia divina che, dovendo aspettare il giorno del Giudizio per regolare i conti, perlomeno manda all umanità un segnale per metterla di fronte alle proprie assurdità e responsabilità. Intendiamoci. Noi non siamo forcaioli e anzi ci rallegriamo per ogni storia di pentimento, di redenzione, di riscatto. Due millenni di cristianesimo sono costellati di miracoli del cuore che hanno portato assassini e peccatori fra i peggiori - da Saulo di Tarso a Agostino d Ippona - ad essere tra i santi più grandi. Può dunque darsi che anche Maso e Carretta siano pentiti, chissà: non possiamo entrare nelle coscienze. Maso dice di aver scoperto proprio la fede cristiana, e di esserne stato radicalmente trasformato; Carretta parla di «un rimorso ancora grande». LA PAGINA DI RISTRETTI ORIZZONTI PER IL MATTINO DI PADOVA Pietro Maso fuori dal carcere, dopo soli 17 anni Diciassette anni di carcere: sono pochi? sono niente? sono un segnale di resa dello Stato che non sa punire? sono un messaggio di lassismo ai figli, che così non avranno paura di nulla, neppure di uccidere i genitori, perché tanto nel nostro Paese in carcere non ci sta nessuno? Si sono sentite in questi giorni migliaia di parole sulla semilibertà che Pietro Maso ha ottenuto dopo diciassette anni passati in carcere per aver ammazzato i genitori. Una storia orribile, non c è dubbio, però ci piacerebbe ugualmente tentare di ragionare su questa vicenda a partire da una riflessione: provate a pensare agli ultimi diciassette anni della vostra vita, a quello che avete fatto, i figli avuti, qualche persona cara che è morta, la miriade di avvenimenti che ha riempito le vostre giornate. Sono davvero così pochi diciassette anni? Quel limbo tra carcere e libertà Libero. Penso a come potrà realmente essere, oggi, la libertà di Pietro Maso. Ma semilibertà non è sinonimo di libertà. Scontare una pena in semilibertà significa prima di tutto aver scontato già anni di carcere mantenendo un comportamento eccellente e aver dimostrato disponibilità al confronto con gli operatori, significa aver intrapreso un percorso critico rispetto al reato commesso, essersi sottoposti a perizie redatte da 16
20 vari esperti del settore (psicologi, educatori, psichiatri, assistenti sociali). Ho trascorso più di un anno in un regime come la semilibertà e non ho mai avuto la sensazione di essere libero. La mattina prima di uscire dal carcere mi veniva consegnato il foglio di trattamento, dove c era scritto tutto quello che potevo, ma soprattutto quello che non potevo fare: Seguirà la via più breve senza soste intermedie - non si accompagnerà a pregiudicati o tossicodipendenti - non assumerà sostanze stupefacenti - non si allontanerà dal territorio comunale - non farà uso del telefono cellulare - dovrà pranzare e cenare solo nei due locali prescritti - trascorrerà in istituto le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali - non frequenterà luoghi di dubbia fama - per gli spostamenti potrà utilizzare la bicicletta o l autobus (qualsiasi cambiamento di veicolo dovrà essere prima autorizzato dalla direzione) uscirà dall istituto alle ore sette e trenta e vi farà rientro alle ore ventuno svolgerà attività lavorativa dalle ore otto alle ore diciotto, con pausa pranzo dalle tredici e trenta alle quindici. E in qualsiasi momento della giornata poteva capitare una pattuglia della polizia per un controllo. È solo nell istante in cui ho letto tutte quelle regole che mi sono reso conto del perché di quel termine: semilibertà. Semilibertà non perché si trascorre mezza giornata in carcere e mezza fuori, ma perché le ore fuori si vivono a metà. Si vivono costantemente con l ansia di non poter sbagliare, perché una sola trasgressione comporta l immediata revoca del beneficio. Semilibertà perché l essere obbligato a seguire tutte quelle regole comporta, ovviamente, di vivere una semi-vita. Di giorno sul posto di lavoro ti confronti con persone che hanno comunque una vita normale, che la sera, finito l orario di lavoro, tornano a casa con la famiglia, mentre tu, persona semilibera, la sera, dopo una dura giornata di lavoro, torni in carcere. Non è una passeggiata affrontare la semilibertà, ma è un passaggio che dovrebbe essere obbligatorio per chi sta scontando una pena in carcere, perché è l unico modo per dare la possibilità a una persona di riallacciare i contatti con il mondo esterno seguendo un percorso graduale, ed è sicuramente la strada migliore per permetterle di ricostruirsi una vita quanto più normale possibile. E ciò non per essere buoni con chi sbaglia, ma per dare qualche garanzia in più alla società che volente e nolente prima o poi dovrà riaccogliere quella persona. Andrea A. Non possiamo ritornare nelle nostre famiglie come alieni Mi chiedo quanto giornali e telegiornali abbiano influenzato questa scontentezza che molti cittadini esprimono alla notizia che Pietro Maso è stato ammesso alla semilibertà. Me lo chiedo perché sono anni che i media si scagliano contro la legge Gozzini, che permette ai detenuti di usufruire di benefici, come appunto lavorare fuori e rientrare in carcere la sera. Sono detenuto da 14 anni e sono convinto che è una cosa giusta dare questa possibilità anche a chi ha commesso un reato grave, perché solo così le persone possono crearsi una vita regolare, e allora è difficile che tornino a commettere reati. In questi anni ho visto diversi detenuti usufruire della legge Gozzini. Intanto non tutti sono 17
21 riusciti a concludere la pena lavorando fuori, poiché le regole sono molto severe e al primo sbaglio ti sospendono dal lavoro e non esci più. Ma di quelli che ce l hanno fatta, quasi nessuno poi è tornato a commettere reati. Nello stesso tempo vedo tutti i giorni detenuti uscire dal carcere dopo aver scontato tutta la pena: le istituzioni, dopo anni di cella, li mollano come cani randagi, e poi nel giro di pochi giorni sono di nuovo qui dentro, perché là fuori la vita è dura e se non hai nessuno non ti salvi. Io capisco che quella di uscire alla mattina e andare a lavorare viene vissuta come una libertà immeritata per Pietro Maso, ma se si vuole vivere in una società civile dove tutti hanno una seconda possibilità, e se il carcere, come dicono, deve essere un luogo di rieducazione, forse bisogna accettare il fatto che dopo diciassette anni anche chi ha ucciso cominci ad uscire dal carcere gradualmente. Io ho una condanna a 30 anni e fuori ho una moglie e una figlia di 15 anni, che quando sono entrato in carcere aveva solo un anno. Quattordici anni di carcere non sono pochi, perché vuol dire che mia figlia nemmeno mi conosce, vuol dire che ci siamo conosciuti solo attraverso quell ora di colloquio ogni tanto. Ci siamo conosciuti solo di vista, perché quel poco affetto che ho cercato di darle durante i colloqui sicuramente non le ha riempito la vita. I miei famigliari possono venire da me una volta ogni tre-quattro mesi, poiché per affrontare il viaggio servono soldi, e oggi è difficile anche per una famiglia italiana arrivare a fine mese, figurarsi per una famiglia straniera, soprattutto per una donna sola con una figlia da crescere e un marito in galera con una pena cosi lunga. Uno può dire che avrei dovuto pensarci prima, ed è vero. Ma nella vita ci sono anche sbagli gravissimi come quello che ho fatto io, però se ci condannate a trent anni di carcere, non potete farci ritornare nelle nostre famiglie dopo trent anni come degli alieni che scendono da Marte e non sanno da dove riprendere la loro vita. Così non si recupera il detenuto, ma si restituisce alla famiglia e alla società una persona più pericolosa di prima. Dritan Iberisha Qual è una pena abbastanza dolorosa da soddisfare la collettività? In questi giorni ho letto e ascoltato per televisione i cittadini esprimere commenti di contrarietà riguardo alla semilibertà concessa a Pietro Maso. Mi domando allora: quale potrebbe essere una pena abbastanza dolorosa da soddisfare la collettività? Voglio precisare che se io fossi un normale cittadino, e non un detenuto che conosce anche questo versante della vita, protesterei forse ancora più degli altri di fronte alla gravità del fatto. Però purtroppo so cos è la galera perché ci vivo da quasi dieci anni e perché anch io ho ucciso una persona, e allora, spinto dalla mia esperienza, vorrei provare a chiarire alcune cose. Così magari qualcuno sentirà meno rabbia verso quella concessione di semilibertà, che io reputo quanto mai umana. Dicono che Pietro Maso sia già libero dopo aver scontato soltanto 17 anni. Intanto preciso che i restanti 13 anni (di una pena di 30) non glieli hanno abbonati, anzi durante quel periodo per lui la vera libertà continuerà a rimanere soltanto un sogno. Senza dubbio la possibilità di accedere a una misura alternativa come la se- 18
22 milibertà è per un detenuto un passo importante, e significa anche un riscatto, un modo per far vedere che le cose possono cambiare in meglio se si riesce a dare prova di attenzione, di responsabilità, di capacità di pensare di più agli altri e al bene della società. Forse siamo tutti troppo abituati all idea che la pena consista solo nel carcere, e una persona libera, che non ha mai avuto a che fare così a lungo con forti vincoli anche sulle cose più banali di tutti i giorni, come succede a chi sconta una pena, fatica in realtà a capire che la semilibertà fa sempre parte del carcere, e gli anni che Pietro Maso deve ancora scontare non si possono definire con la parola libertà in senso compiuto. Se solo potessi condividere con qualche cittadino regolare le mie esperienze in carcere e far capire quanto dolore e quanta amarezza c è nel profondo del mio cuore, gli farei vedere come vivo ossessionato dal desiderio di tornare indietro nel tempo per evitare la follia che mi ha portato a perdere il controllo e fare una cosa così grave. E come succede a me, sono certo che Pietro Maso, in galera o in semilibertà, continuerà a fare i conti con i propri fantasmi per il resto della sua vita, che è la punizione più dolorosa che esiste. Prince Obayangbon Aiutare i ragazzi a farsi una loro idea sui fatti della vita In una terza media, un piccolo esperimento di approfondimento di una notizia sul carcere e sulla pena, analizzata da tanti punti di vista, compresi quelli di alcuni detenuti I ragazzi della classe terza A della Scuola media Maneli-Falconetto hanno fatto un piccolo esperimento: invece di leggere solo la solita notizia standard sulla semilibertà a Pietro Maso, così come l abbiamo sentita in tanti telegiornali e letta su tanti giornali, hanno potuto, con la loro insegnante, conoscere più punti di vista: quelli riportati dai quotidiani più importanti, ma anche quelli dei detenuti, che hanno scritto le loro testimonianze sul Mattino di Padova. Quelle che seguono sono alcune delle riflessioni dei ragazzi, che fanno capire tutto il senso del progetto di confronto fra le scuole e il carcere: non l obiettivo di far cambiare idea agli studenti sui temi della pena e del carcere, ma piuttosto quello di aiutarli a farsi una loro idea, basata sull ascolto attento di voci diverse. Semilibertà vuol dire allargare i confini del carcere di A. 3 a A Scuola media Falconetto È difficile esprimere la propria opinione su certi argomenti, come ad esempio la semilibertà di Pietro Maso. Io non so mai cosa dire a proposito perché appena trovo un tema a favore ne emerge subito uno contro, che lo contraddice. Un diciannovenne 19
23 che uccide i suoi genitori per l eredità è quasi senza dubbio una persona malata, perché altrimenti avrebbe compiuto questo ingiusto delitto? Avrebbe avuto tutto il tempo per pensarci su, per pentirsi, per ragionare, per capire che questo l avrebbe portato a dover scontare una pena. Invece no. Lui mai si è fermato, mai ha riflettuto su ciò che stava per compiere, quando invece ne ha avuto tutto il tempo. Proprio per questo sono del parere che questa persona aveva problemi di tipo mentale. Ma può una persona malata a tal punto da uccidere i suoi genitori, guarire? Io stento a crederci, ma a quanto pare Maso si è convertito, ha capito che aveva sbagliato. E poi questa semilibertà tanto discussa, si può veramente definire una libertà? Secondo me no. Secondo me vuol dire allargare i confini del carcere, perché uno non è mai così libero se deve stare attento a qualsiasi cosa faccia e in qualunque posto vada. Quindi tirando le somme, credo che questa semilibertà sia una cosa abbastanza utile per riallacciare i rapporti del detenuto con il mondo esterno, e poi come abbiamo visto non è assolutamente pericolosa. In definitiva credo che nelle condanne debba venire incluso che gli ultimi tot anni di carcere vengono trascorsi in semilibertà vigilata, però comunque credo che per una persona come Pietro Maso sia ancora presto, perché 17 anni su 30 non sono due terzi della pena Da giovani si crede di potersi permettere di fare tutto quello che si vuole di Serena G., 3 a A Scuola media Mameli-Falconetto Non so se essere d accordo o contro la semilibertà per Pietro Maso. Perché da una parte tutti dovrebbero avere una possibilità, anche quelli che hanno commesso un omicidio, e magari sono cambiati. Però allo stesso tempo non ci si può fidare di persone come lui che forse è solo un attore e vuole solo uscire dal carcere per ritornare a compiere reati. Infatti la semilibertà mi sembra abbastanza ragionevole: è comunque vigilato e pratica un lavoro in modo che quando uscirà del tutto dal carcere avrà già esperienza nel lavoro. Bisogna anche pensare che quando ha commesso l omicidio aveva solo diciannove anni, quindi era ancora molto giovane e ora è cresciuto e ne ha trentasette. Forse con la distanza di diciassette anni è cambiato, forse non lo rifarebbe più. Quando si è giovani alcune volte si crede di permettersi di fare tutto quello che si vuole senza correre rischi, ma non è così. Prima di fare qualcosa bisogna sempre rifletterci su. Lui ha provato più volte ad uccidere i genitori e quindi di tempo per pensarci ne aveva molto. Comunque credo che Pietro Maso abbia capito di aver fatto un errore, ma non si sa mai. Trovo però ingiusto il fatto che se uno si è comportato bene in carcere può essere liberato prima e avere la semilibertà. Perché può benissimo fingere, quindi, quando i giudici decidono qualcosa, questa regola deve essere rispettata, senza eccezioni. Pietro Maso si sarà pure pentito ed avrà fatto una buona condotta, ma comunque ha commesso un reato grave e non bisogna dimenticarlo. I trent anni li avrebbe dovuti scontare tutti perché nessuno sa veramente cosa pensa lui e quali sono le sue vere intenzioni. Non può tornare indietro nel tempo, ha fatto quello che ha fatto e ne deve scontare tutta la pena 20
24 Credo che 17 anni di carcere siano abbastanza per un ragazzo così giovane di F., 3 a A Scuola media Mameli-Falconetto Io credo che Pietro Maso per uccidere in quel modo violento i suoi genitori li dovesse odiare molto, anzi moltissimo. Aveva anche già tentato altre due volte di farli fuori, ma non era riuscito. Lui e i suoi amici non hanno avuto nessuna pietà, volevano impadronirsi dei loro soldi per fare la bella vita senza lavorare e faticare. I giudici hanno dato a Pietro Maso 30 anni di carcere, ma per buona condotta ne ha scontati solo 17 ed era in semilibertà. Questo omicidio lo aveva fatto quando aveva 19 anni e sicuramente il suo cervello non funzionava per niente bene. Io credo che 17 anni di carcere siano abbastanza per un ragazzo cosi giovane. Trovo giusto che vada a lavorare soprattutto per capire quanto sacrificio è il lavoro, che conosca un po di persone nuove al di fuori del carcere, che cominci a rifarsi una vita. Mi sembra che ha conosciuto anche una ragazza che ora è la sua fidanzata e che ogni tanto incontra. Mi sembra giusto che venga continuamente messo sotto controllo e che tante cose gli siano vietate. Penso che sia giusto dare una speranza di vita anche a chi ha sbagliato di Chiara D., 3 a A Scuola media Mameli-Falconetto Semilibertà non perché si trascorre mezza giornata in carcere e mezza fuori, ma perché le ore fuori si vivono a metà. Questa frase mi ha colpito molto e mi ha fatto capire come quello che appare come una grande concessione sia invece un altra prova da affrontare per il detenuto, dato che tutti i suoi movimenti e comportamenti sono legati a regole ben precise, che se non vengono pienamente rispettate possono portare alla revoca del beneficio. Chi vive l esperienza del carcere ha senza dubbio commesso qualcosa di molto grave, ma che cosa può aiutare di più un uomo a riconquistare la libertà: l essere condannato per sempre o aver la speranza di poter un giorno, grazie a comportamenti irreprensibili, riconquistare momenti di libertà e una vita normale? Io penso che sia giusto dare una speranza di vita anche a chi ha molto sbagliato, che affronta un percorso di riabilitazione comprendendo i propri errori. Trovo che un regime di semilibertà sia utile al carcerato ma anche alla società. Il carcerato che lavora ha modo di dimostrare le sue capacità, il suo desiderio di riscatto e può allacciare i rapporti con i colleghi che sono cosi in grado di valutare i suoi comportamenti ed accettarlo nella comunità del mondo del lavoro. È un primo passo verso il reinserimento nella società. Io penso che il carcere sia una giusta punizione, ma che debba avere una funzione rieducativa, e il regime di semilibertà mi sembra uno strumento valido. Non posso fare a meno di considerare le parole di alcuni detenuti, da cui emerge il dolore, l amarezza e un disperato desiderio di tornare indietro per non compiere più atti di follia per sé e per i famigliari, mogli e figli da cui sono stati allontanati. Gli avrei concesso la semilibertà solo quattro anni prima della liberazione di Enrico S., 3 a A Scuola media Mameli-Falconetto Pietro Maso, attualmente 36enne e in semilibertà, il 17 aprile 1991 ha ucciso i suoi genitori. Quindi giungiamo fino all anno corrente, anno in cui Maso riceve la semilibertà. Diciamo che questo traguardo può essere visto sia in modo positivo, sia in modo negativo in base all ottica da cui lo si guarda. Infatti si può pensare che que- 21
25 sta libertà provvisoria possa essere sbagliata in quanto Maso ha scontato 17 anni in un totale di 30 anni, e ciò potrebbe dimostrare l infedeltà della giustizia italiana rispetto alle condanne inflitte. È anche vero, però, che Maso lascia il carcere di Opera alle 7,30 del mattino per poi tornarci alle 21,00 quindi non è proprio libero. Inoltre questa semilibertà lo obbliga a non fare praticamente nulla, come utilizzare l auto e lasciare il paese per andare a trovare le sorelle, e dobbiamo ricordare che comunque continua a scontare la sua pena, non gli vengono detratti quei 13 anni restanti. A mio parere, concedere la semilibertà a Pietro Maso è giusto e doveroso se si vuole integrare l assassino nella società, ma io non gliela avrei concessa dopo aver scontato appena la metà della condanna, ma cinque o quattro anni prima della sua liberazione. Se i miei tredici anni mi sembrano un eternità, figuriamoci diciassette di Laura P., 3 a A Scuola media Mameli-Falconetto Secondo me, gli elementi a favore di questa questione sulla semilibertà di Pietro Maso sono in netta minoranza con quelli sfavorevoli. Bisogna dire che, in diciassette anni uno può cambiare, se lo vuole, e almeno in carcere Maso ha dimostrato un comportamento eccellente, e anche lui dichiara di essere cambiato. Anche secondo me è cambiato. Quando ha commesso il reato era un adolescente di 18 anni. Ora ne ha 36. In diciassette anni molte cose possono cambiare. Persino una persona. Io diciassette anni fa non ero neppure nata, e se già i miei tredici anni vissuti molto intensamente mi sembrano un eternità, figuriamoci diciassette. Io sono dell idea che bisogna sempre dare una seconda possibilità alle persone che nella vita sbagliano. E a volte sbagliando si rovinano la vita, come è successo a Maso. Secondo me lui ha diritto ad avere un altra chance, in quanto è una persona come me, e come tutti, che può pentirsi dei fatti commessi. I punti sfavorevoli a questa semilibertà invece possono essere molti. Il più importante è, ovviamente, il suo reato. Lui ha commesso un crimine molto grave, uccidendo i suoi genitori, che fanno di tutto per la felicità del figlio e poi vengono ripagati così. Tutto il loro amore e il loro affetto, hanno portato a questo spregevole gesto da parte del figlio. Mi sono chiesta molte volte da dove ha tirato fuori Maso il coraggio per compiere quest atto. Dove hanno sbagliato i suoi genitori? Io non ho idea di che rapporto avesse questo ragazzo con i famigliari, ma se è arrivato a uccidere per i soldi mi vengono grossi dubbi. Capisco uccidere perché si viene maltrattati, ma uccidere per i soldi e per l eredita mi fa rabbrividire. È forse anche per questo che alcuni giudici non hanno voluto dargli la semilibertà e non ci hanno pensato neanche un secondo prima di negare la concessione, ma un essere umano può sbagliare, e tante volte supera i limiti, ma una seconda passibilità per cambiare ci dev essere per tutti. Almeno 20 anni penso che li debba trascorrere in carcere di Anonimo, 3 a A Scuola media Mameli-Falconetto Sulla cronaca ufficiale dei fatti avvenuti nel caso di Pietro Maso, al di là della freddezza dei dati è importante analizzare il comportamento tenuto dal ragazzo durante questi anni di carcere. Molti testimoni affermano che il suo comportamento è cambiato 22
26 e che è una persona diversa. In questi anni Maso non ha mai sgarrato, ha ricostruito il rapporto con le sorelle, si è diplomato in ragioneria, ha lavorato come magazziniere e ha seguito un percorso di fede. Ritengo che una giusta valutazione sull atteggiamento di Pietro Maso sia necessaria per farsi un idea adeguata dei presupposti che hanno portato i giudici a decidere per la semilibertà. Capisco il parere del sindaco di Montecchia, secondo il quale la condanna dovrebbe essere scontata fino in fondo, ma sono rimasta molto colpita dalle testimonianze che alcuni carcerati hanno dato della loro esperienza. Il primo spunto di riflessione mi è stato dato dal chiarimento sul termine di semilibertà, che prevede che il condannato, che comunque deve sottostare a innumerevoli regole, pena revoca del beneficio, usufruisce di qualche possibilità di riprendere i contatti con il mondo esterno, come lavorare fuori e rientrare in carcere la sera. Tale misura mira non solo a dare una possibilità di rieducazione al detenuto, ma anche a promuovere un inserimento graduale nella società, per evitare che torni a commettere reati. I carcerati sono unanimi nell affermare che 17 anni di carcere sono eterni e che la semilibertà rappresenta una semivita, senza provare mai la sensazione di essere indipendenti. Inoltre i detenuti sostengono che la punizione più dolorosa che esiste è dover fare i conti continuamente con i propri fantasmi. Personalmente trovo molto difficile schierarmi a favore o contro la decisione del tribunale, ma dovendo esprimere il mio parere ritengo che sia ancora troppo presto per concedere a Pietro Maso la semilibertà. Sono convinta che si sia pentito del reato che ha commesso, ma era consapevole di quello che faceva, quindi almeno 20 anni penso che li debba trascorrere in carcere. Successivamente potrà cominciare a passare l intera giornata fuori, tornando la sera, per un futuro reinserimento nella società. 23
27 È IMPORTANTE CHE PIETRO MASO SAPPIA RITROVARE NON SOLO IL SENSO DELLA LEGALITÀ, MA ANCHE LA MISURA DI CIÒ CHE È POSITIVAMENTE UMANO Dopo che ha liberato in sé la bestia che, nell incarnazione che l uomo ne dà, a volte è la più feroce, ora può mostrare, a se stesso e alla società che parzialmente lo riaccoglie, chi sia infine diventato, quale cammino abbia percorso di Gianfranco Bettin, sociologo e scrittore La polemica sulla semilibertà concessa a Pietro Maso, il ragazzo che anni fa con altri tre coetanei ha ucciso il padre e la madre per avere l eredità, è probabilmente inevitabile. La sua storia è talmente estrema, la sua colpa così al limite del comprensibile stesso, l eco che ha suscitato ancora non spenta malgrado i diciassette anni trascorsi dal delitto, che era prevedibile che una notizia del genere colpisse l opinione pubblica e provocasse reazioni critiche. Eppure, se c è una storia che mette alla prova ciò che la nostra Costituzione prevede, e cioè che il carcere, la pena, siano finalizzati al recupero del condannato, questa è proprio la storia di Maso. Entrato in carcere giovanissimo, per quindici anni Pietro non ha avuto neanche mezza giornata di permesso, e le pochissime godute dopo di allora le ha trascorse in una comunità di recupero. Seguito da vicino da persone sensibili e accorte e da operatori capaci, ha trascorso tutti questi anni conservando sempre un atteggiamento sobrio e riservato. Non ha giocato a fare il personaggio, come avrebbe potuto e come gli è stato spesso proposto (anche in cambio di lauti guadagni, oltre che di una visibilità che sempre, infine, paga comunque, in un paese volgare, pettegolo e morboso come spesso è il nostro). Al contrario, è sembrato, sia pure faticosamente e, probabilmente, con sofferenza interiore, guadagnare una sorta di equilibrio, di maturità. Ora, appunto, dopo molti anni, si prospetta per lui quella finestra di opportunità, quella mezza libertà se può esistere una libertà dimezzata in cui mettere alla prova se stesso, in cui mostrare a se stesso e alla società che parzialmente lo riaccoglie chi sia infine diventato, quale cammino abbia percorso. È alla luce di quanto prescrive la Costituzione, ma anche di quanto è opportuno concretamente fare, che le polemiche non hanno in realtà gran senso. Se, infatti, la reazione emotiva di molta gente è appunto comprensibile, non lo sono affatto le strumentali polemiche sollevate da chi dovrebbe avere ben chiaro quanto prescrive la nostra Carta fondamentale e cosa è davvero utile fare per preparare il ritorno alla vita comune di chi, comunque, fra non molti anni (avendo ormai scontato la gran parte della pena) uscirà dal carcere. La semilibertà è, dunque, anche un mezzo per far riprendere una strada normale a un reo che ha scontato in gran parte la condanna e che non dovrebbe essere rigettato fuori senza una preparazione adeguata, che riguarda in primo luogo lui, ovviamente, ma che non può essere elusa dalla stessa realtà esterna. In poche parole, è meglio che ci si riabitui tutti all idea che Pietro Maso prima o poi ormai abbastanza prima che poi tornerà libero ed è meglio per tutti che ciò avvenga con gradualità e come 24
28 compimento di un percorso evolutivo, di maturazione, piuttosto che al mero termine di un tempo di reclusione trascorso senza cambiamenti e concluso senza prospettive. Il minimo che ci si possa attendere da questa prova è che Maso sappia ritrovare non solo il senso della legalità ma anche la misura di ciò che è positivamente umano, dopo che ha sperimentato in sé, anzi, dopo che ha liberato in sé la bestia che, come sappiamo, nell incarnazione che l uomo ne dà a volte è la più feroce. Se, poi, la storia sarà anche una bella e importante storia di redenzione, ebbene, ancor meno avranno avuto senso le polemiche e i timori e saremmo di fronte a ciò che, davvero, di più felicemente umano, e di più coerente con le leggi supreme della nostra civiltà, può accadere. Eredi Da Pietro Maso a Erika e Omar di Gianfranco Bettin Io ho pubblicato un libro che riguarda Pietro Maso, ma anche altri giovani protagonisti di reati gravissimi: Erika e Omar che hanno ucciso la madre e il fratellino di Erika, per rabbia probabilmente. Sono delitti molto diversi, tremendi entrambi, molto diversi perché Pietro Maso uccideva per avere delle cose, Erika e Omar hanno ucciso per essere liberi, non riuscivano ad immaginarsi un altro modo per essere liberi e per vivere da soli autonomamente, e hanno finito per commettere questo delitto tremendo. Ma se noi li inchiodassimo per sempre a questa storia, in qualche modo inchioderemmo anche una parte della nostra società per sempre, quindi abbiamo un doppio problema, capire che cosa è successo, e capire cosa succede dopo, e per esempio la scrittura, l arte hanno il compito di raccontarlo. Diciamo allora che la nostra parte emotiva è colpita violentemente, la nostra parte intellettuale, che ragiona, ha invece il compito di dire: bene, cerchiamo di capire cosa è successo, e cerchiamo di vedere cosa succede adesso, a loro, alle vittime, che se sono sopravvissute hanno bisogno di essere risarcite, riaccompagnate a superare le paure che rischiano di restare per sempre, ma anche cosa succede alla nostra società, alla nostra comunità. Quindi il compito di chi racconta questi episodi, di chi si interroga su cosa succede dopo questi episodi è molto importante, per cui è molto importante capire quali risorse una società mette a disposizione per fare questo ragionamento, per ragionare su queste esperienze, ma anche poi per agire concretamente. Questo poi è il ruolo degli Enti locali, di chi amministra la giustizia, dei volontari, ma è anche un compito che abbiamo in qualche modo tutti. Eredi Da Pietro Maso a Erika e Omar Feltrinelli edizioni, Milano
29 COME ORGANIZZARE UN PICCOLO LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA TEMA SCELTO: LA SICUREZZA VISTA DAI GIOVANI La prescrittura Quando si scrive un pezzo giornalistico, occorre prima di tutto avere qualcosa da comunicare agli altri. Affermarlo sembra banale, ma non è così. Molti si mettono a scrivere sentendo che hanno tante cose da dire, poi però dopo qualche riga si impiantano. Il consiglio da dare è piccolo ma tassativo: prima di scrivere buttate giù, nero su bianco, le idee. Per idee qui intendiamo le cose da dire. Queste cose le dovete appuntare su un foglio in forma breve riservandovi di svilupparle in un secondo momento, quando davvero vi metterete a scrivere. Non fatevi fregare dall ispirazione o dalla spontaneità e libertà del pensiero. Organizzatevi un piano prima di partire. Però: non prendete alla lettera il termine idee. Possono essere concetti, fatti, informazioni, esempi, citazioni. È importante però che voi ne abbiate una piccola scorta prima di cominciare a scrivere. Magari non le userete tutte, ma è meglio averne messo da parte un bel mucchietto. Perciò, non state a valutarle troppo: appena un idea vi frulla per la testa, acchiappatela, etichettatela e appuntatevela. Chiameremo questa prima fase la RACCOLTA DELLE IDEE. Ora, ci sono due modi fondamentali per raccogliere le idee. Il primo è quello che chiameremo della LISTA DISORDINATA. Vale a dire che in un primo momento butteremo giù le idee così come si presentano, alla rinfusa. Senza preoccuparci dei legami tra queste, delle eventuali ripetizioni, della loro consistenza, validità, pertinenza, di quale sia più importante e di quale meno, ecc. Per capirci prendiamo un tema, questo: La sicurezza, e in particolare, la sicurezza vista dai giovani. Bene, cominciamo a buttare giù le idee come vengono vengono. Per esempio così: Confrontare i motivi di insicurezza dei giovani e degli adulti Situazioni di insicurezza sperimentate direttamente o raccontate da altri (l amico che ha subito un furto) Situazioni in cui i giovani si sentono a disagio, hanno paura, si sentono in ansia Comportamenti nel gruppo, tra gli amici, che provocano una sensazione di insicurezza Le notizie date dalla televisione pesano su questa sensazione di insicurezza? Un buon modo per stimolare l afflusso delle idee è quello che consiste nel porsi una serie di domande. Così: Si sentono più insicure le ragazze o non c è differenza? Ci sono dei luoghi vissuti come più insicuri di altri? 26
30 E si ricordi: si tratta di domande aperte, non è importane che voi abbiate la risposta già pronta, è importante che voi stabiliate alcune grandi questioni su cui magari poi indagherete. Questo lo diciamo perché spesso accade che la raccolta delle idee avvenga collettivamente, che sia un lavoro della redazione. Può capitare allora che ogni idea susciti un dibattito, magari interessante ma poco produttivo. Ripetiamo: non si tratta di stabilire se l idea sia giusta o sbagliata, non si tratta nemmeno di svilupparla, si tratta solo di buttarla giù, per riprenderla dopo. Un altra modalità utile è quella del FLUSSO DI SCRITTURA. In questo caso, diversamente che con la lista disordinata (che si avvale di formulazioni brevi, secche, quasi di etichette), si inizia subito a buttare giù pezzi di testo, costruendo frasi e periodi completi. Per esempio: Ci sono delle situazioni nelle quali mi sento insicura e non protetta. Accade quando percorro, in qualsiasi momento della giornata (o a piedi, o in bici) le strade del mio quartiere, soprattutto nei pressi della stazione dei treni. Evito sempre di trovarmi da sola quando comincia a fare buio. Questo modo d iniziare viene consigliato soprattutto a chi ha bisogno di sbloccarsi nella scrittura, a chi ha paura del foglio bianco. Però bisogna ricordarsi che le frasi buttate giù non saranno utilizzabili tali e quali nella stesura finale. Sono comunque appunti, buttati giù alla buona, non vanno corretti, vanno tenuti come sono, come promemoria, pensieri-stimolo. Si ricordi infine: che questi pezzi non devono mai essere troppo lunghi, altrimenti perdono il loro carattere di appunti. Un altro modo utile per sviluppare certi temi è quello di affrontarli individuando degli argomenti pro o contro. Per esempio: 1. Si dice spesso che una delle cause dell insicurezza sono gli immigrati. 2. Però non si può appiattire una situazione così complessa, a creare insicurezza sono anche comportamenti diffusi, come l uso di sostanze, che accomunano italiani e stranieri. È possibile, variando appena un po sulla modalità sopra esposta, analizzare una questione da due punti di vista contrapposti. Così tutta la questione della sicurezza andrà esaminata contrapponendo per esempio il punto di vista delle ragazze e quello dei ragazzi: le ragazze si lamentano che una donna non può girare per strada da sola né di giorno né di notte; i ragazzi sostengono che non cambia niente, sono insicuri tutti allo stesso modo. È comunque importante in questa fase di raccolta delle idee: buttare giù tutto ciò che passa per la testa senza rimandare a dopo; non preoccuparsi della giustezza o meno delle idee che ci sono venute in mente; inserire nella lista anche problemi aperti, intuizioni da verificare, idee preliminari; usare fogli grandi e lasciare spazi bianchi a lato e tra le righe in modo da poter inserire nuovi elementi vicino o in mezzo a quelli riportati; ogni tanto rileggere quanto s è già scritto (l esame di informazioni già raccolte è di stimolo alla generazione di nuove idee). 27
31 Farsi venire nuove idee Adesso diamo alcuni consigli circa il modo di farsi venire nuove idee. A scuola spesso si sente dire dagli studenti: non ho idee, non mi vengono idee. Ebbene ecco qui di seguito qualche piccolo trucco per farsi venire idee. Tutti i meccanismi sotto esposti si basano sulla tecnica della libera associazione. Il gioco è il seguente: a partire da un idea te ne può venire in mente un altra per via analogica, causale, oppositiva; stabilendo conseguenze, precedenze, successioni, generalizzazioni, esemplificazioni, classificazioni, tipologie; riportando casi personali, esperienze d autorità. Ecco qualche esempio: Analogia. Confrontando un fenomeno con un altro fenomeno, trovando le somiglianze e le differenze lo comprendo meglio. Partendo da un idea, da un fatto, da un fenomeno se ne trovano altri che somigliano ai primi (le due idee, i due fenomeni possono poi essere messi a confronto e analizzati approfonditamente). Per esempio: si possono analizzare i fenomeni confrontandoli nel tempo e nello spazio. Nel tempo: una volta la società era più sicura, la gente aveva meno paura (qualcuno sostiene però che questo succedeva solo nei periodi di pace, ma poi c erano le guerre e la società diventava più insicura che mai). Nello spazio: che tipi di soluzioni hanno adottato negli altri Stati (per esempio: avete sentito parlare di Paesi più sicuri perché fanno politiche sulla sicurezza più efficaci?). Contrapposizione. Data un idea se ne costruisce una opposta. Per esempio: i ragazzi non hanno paura di uscire di notte. INVECE: gli adulti preferiscono chiudersi in casa. Causa. Un certo fenomeno, già individuato, viene messo in relazione con un altro che lo spiega, che ne costituisce la causa: Le ragazze hanno più paura dei ragazzi. Ciò si spiega così: 1. Ci sono in giro molti maschi soli, per esempio tra gli immigrati. 2. Le donne subiscono molte violenze, anche in famiglia. Conseguenza. I ragazzi sono molto più liberi e tornano a casa molto più tardi. Conseguenza: ciò li rende spesso più esposti a situazioni di rischio. Generalizzazione: Partendo da informazioni specifiche, si arriva a una conclusione che le presenta in modo generale. Per esempio: Ci sono stati ultimamente alcuni episodi di stupri di ragazze giovani. Generalizzazione: Sono moltissime le donne che ogni anno subiscono violenze (cercare il dato). Esperienza personale. Si riportano fatti di cui si è stati diretti protagonisti o testimoni (questo serve per rendere più concreta e convincente l idea di partenza e aiuta a essere originali, evitando di ricorrere a luoghi comuni). Ecco un esempio raccontato da una studentessa in carcere: Io sono sempre stata una persona coraggiosa, uscivo di casa da sola anche di sera, in bicicletta. Poi una sera sono tornata a casa e ho trovato dentro i ladri. Non mi interessa quello che mi hanno rubato, so però che da quel giorno ho paura di tutto e la qualità della mia vita è radicalmente cambiata. 28
32 Come scrivere un articolo: raccolte le idee, è ora della scaletta Se il tema scelto, su cui scrivere un articolo, è La sicurezza, e in particolare, la sicurezza vista dai giovani, dopo aver raccolto le idee, si potrebbe anche passare alla scaletta. Ma qualche volta è consigliabile passare attraverso una fase intermedia. Si individua un numero limitato di IDEE PRINCIPALI (idee-guida, idee-matrice) e in base a queste i vari spunti raccolti vengono divisi in GRUPPI. Solo se avrò fatto questo lavoro il mio scritto non diventerà un mucchio di informazioni, concetti, esempi slegati tra loro. Si tratta sostanzialmente di una attività di distinzione e classificazione utilissima, che però richiede concentrazione e capacità di astrazione. Prendiamo il nostro tema e proviamo a suddividerlo per categorie. Va da sé che a seconda di chi scrive i modi di classificare il tema saranno diversi. Eccone uno possibile. Definizione di sicurezza/insicurezza: Che cos è secondo i giovani la sicurezza (si può arrivarci partendo dalla definizione dell insicurezza) Altre forme di insicurezza, come quella legata al futuro (la precarietà del lavoro, la vita in famiglia sempre più protratta nel tempo) Generazioni a confronto: Confrontare i motivi di insicurezza dei giovani e degli adulti Erano più sicuri i giovani dieci o venti anni fa? I giovani e l insicurezza: Situazioni in cui i giovani si sentono a disagio, hanno paura, si sentono in ansia Situazioni di insicurezza sperimentate direttamente o raccontate da altri (l amico che ha subito un furto) Comportamenti nel gruppo, tra gli amici, che provocano una sensazione di insicurezza Donne e uomini a confronto: Si sentono più insicure le ragazze? Ci sono dati attendibili che dimostrano che le donne sono più a rischio? Insicurezza e informazione: Le notizie date dalla televisione pesano su questa sensazione di insicurezza? Passiamo adesso all ultima fase che precede la scrittura vera e propria: LA SCALETTA. Fino a ora abbiamo raccolto le idee, poi abbiamo provato a disporle a gruppi, adesso proviamo a costruire uno schema. La scaletta infatti presenta le idee secondo un ordine e una gerarchia (in linea di massima questo ordine si ritroverà poi nel testo). Come a dire che il testo prevede una introduzione generale e una conclusione. Poi alcuni grandi blocchi concettuali, a loro volta suddivisi in sottoblocchi, e così via. Va da sé che prima di passare da un argomento all altro devo esaurire il primo. Il difetto di molti scritti è che gli argomenti si accavallano. Con una buona scaletta ciò non accade. Gli accorgimenti grafici possono naturalmente variare, però è importante che la scaletta renda evidente la distinzione dei piani e l ordine d importanza delle idee. È perciò molto utile 29
33 procedere con queste suddivisioni. Per dare un idea di una scaletta standard prendiamo la scaletta prestabilita per la recensione di un film: 1. Trama 2. Attori 3. Ambientazione 4. Significato della storia 5. Regista 6. Fotografia 7. Colore e aspetti tecnici particolari 8. Catalogazione del film in un genere 9. Commento su ognuno degli aspetti particolari Ecco invece una scaletta standard per scrivere un PEZZO PROBLEMATICO su una questione qualsiasi. Si parte dalla DEFINIZIONE del problema, con la sua delimitazione. Poi si passa a descriverne le MANIFESTAZIONI. Poi si passa a descrivere le CAUSE del problema. A questo punto si possono tirare in ballo le INTERPRETA- ZIONI (secondo alcuni le cause del fenomeno sono le seguenti, secondo altri sono le seguenti ). Sempre a questa altezza puoi esprimere una tua TESI che magari accoglie alcune interpretazioni, oppure ne propone di nuove. Vengono successivamente gli EFFETTI o le CONSEGUENZE immediate. Devi distinguere dagli effetti i cosiddetti SCENARI o le PROSPETTIVE che implicano le proiezioni del fenomeno in un futuro vicino e lontano. In questo caso puoi evocare OPINIONI divergenti e eventualmente avanzarne di personali. Infine puoi prospettare le SOLUZIONI POSSIBILI (quelle proposte dagli altri e eventualmente da te). Molti obiettano che le scalette sono troppo costrittive, che cammin facendo ti possono venire nuove idee Certo le scalette possono essere cambiate in corso d opera, ma ciò non toglie che sono utili. È come quando voi organizzate un viaggio: prevedete certe tappe e certe visite a questo o a quel monumento. Magari poi salterete una tappa o visiterete un monumento al posto di un altro, ciò non toglie che è utile avere un programma e degli obiettivi, altrimenti rischiereste di perdere tempo andando di qua e di là senza costrutto, o addirittura di girare intorno, di perdervi È proprio quello che accade con certi articoli: girano intorno, si ripetono, si perdono. Il buono delle scalette predefinite che vi abbiamo appena presentato è che esse sono già predisposte, che in un certo senso le troviamo già belle e pronte. Nel caso di un articolo pensato e realizzato liberamente da noi, non esistono scalette prestabilite. Siamo noi che dobbiamo architettarle. Proviamo a farne una immaginando di dover scrivere un articolo su questo tema della sicurezza, vista dai giovani, e di avere, sulla base della raccolta delle idee fatta inizialmente, messo insieme una serie di materiali utili (dati, interviste, risultati di inchieste). Insicurezza e percezione dell insicurezza Interviste ad adulti Testimonianze di ragazzi Distinzione fra chi ha davvero subito reati e chi ha paura pur non avendo avuto espe- 30
34 rienze negative Evitare semplificazioni e generalizzazioni ( gli immigrati sono fonte di insicurezza) L insicurezza vista dalle ragazze Raccolta di testimonianze di ragazze Statistiche sulle violenze che subiscono le donne (per molte donne la famiglia diventa a sua volta luogo insicuro) Analisi delle cause di questa insicurezza, reali e mediate dai mezzi di informazione Tesi di fondo È importante smontare l idea che la sicurezza sia una questione di più forze di polizia e più controlli (una società ultrasicura difficilmente è una società libera) Ragionare su una idea di sicurezza sociale Proposte, soluzioni, scenari possibili Una città più sicura è una città con più luoghi di aggregazione (interviste a ragazzi di diverse età, fatte in luoghi diversi, scuole, università, piazza) La vicinanza diminuisce la paura: il progetto di confronto fra scuola e carcere ne è un esempio, invece di escludere è fondamentale conoscere le persone che hanno causato insicurezza e danni agli altri, cercare di capire come si arriva all illegalità. Siamo così arrivati alla fine del nostro lavoro di prescrittura. (Questi appunti riprendono le indicazioni di un corso di scrittura tenuto nella redazione di Ristretti Orizzonti da Stefano Brugnolo, autore, con lo scrittore Giulio Mozzi, del Ricettario di scrittura creativa, Zanichelli, 2000) 31
35 È VERO CHE C È CHI CAVALCA LA PAURA SEMPLICEMENTE A FINI POLITICI, MA NON VA TACIUTO CHE COMUNQUE LA PAURA C È La redazione di Ristretti intervista il direttore del Mattino di Padova, Omar Monestier A cura della Redazione Il Mattino di Padova da alcuni anni dà la possibilità alla redazione di Ristretti Orizzonti di gestire uno spazio importante, mezza pagina ogni lunedì. Uno spazio che noi dedichiamo per lo più ai temi della sicurezza, delle pene, alle testimonianze dal carcere. Volevamo, su questi stessi temi, intervistare proprio il direttore del Mattino, che ha accettato il nostro invito in redazione. Ornella Favero (direttore di Ristretti Orizzonti): Naturalmente qui in carcere, e anche fuori per chi si occupa di temi sociali, pesa moltissimo il clima che c è nel Paese, e su questo secondo noi i mezzi di informazione giocano un ruolo importante, dando spesso messaggi che insistono molto su questo clima di paura. Del resto ho letto di recente proprio sul Mattino un articolo che diceva che la paura fa guadagnare voti, per cui evidentemente anche voi siete consapevoli che potete giocare un ruolo importante in questo ambito. Ecco, noi vorremmo partire da questa considerazione, ossia quanto pesano davvero i media nell accentuazione di alcuni problemi, come appunto l insicurezza, che nel nostro Paese sono vissuti sempre come emergenze? Omar Monestier: Ci sono criminalità e paure diverse. L Italia si trova di fronte ad un ondata migratoria senza precedenti che non è stata gestita, soprattutto all inizio, quando sono cominciati ad arrivare in massa migliaia di cittadini che cercavano una condizione lavorativa e di vita più dignitosa, e adesso il Paese ha paura perché si accorge degli effetti che questa ondata ha provocato. Poi c è l altra criminalità, quella che c è sempre stata (intendo dire che il ladro di polli e la rapina in banca sono sempre esistiti) e per la quale è subentrata una sorta di assuefazione, per cui la si considera un po come la normalità del nostro vivere civile. Si sa che in una società così complessa avvengono degli atti criminosi che non sono giustificati naturalmente, ma vengono tollerati, perché non sono completamente cancellabili dal nostro contesto sociale. Per quanto riguarda l aspetto legato all ondata migratoria, con gli anni è montato un sentimento dì grandissima insofferenza, di grande ribellione, di astio, certamente non di odio etnico e nemmeno di xenofobia, secondo me, ma comunque una grande intolleranza nei confronti di tutti gli eventi malavitosi che hanno come protagonisti i cittadini stranieri. L abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quando eravamo noi i cittadini stranieri che andavamo in America, trattati peggio delle bestie, abbiamo verificato sulla nostra pelle che cosa significhi essere i protagonisti di questo fenomeno, adesso sta succedendo il contrario. Adesso siamo noi quelli onesti e benestanti, che subiscono un ondata migratoria senza precedenti. Ora è vero che c è chi cavalca la paura semplicemente a fini politici, ma non va taciuto che comunque la paura c è, soprattutto da parte di alcune fasce deboli, non parlo di bambini e anziani, per non citare luoghi comuni, ma sicuramente quelle fasce a reddito più basso, 32
36 quelle più indifese socialmente, che magari hanno difficoltà a mantenere il posto di lavoro in periodi di crisi come questo. Allora, mentre una volta una cittadina di Padova di 60 anni poteva camminare tranquilla con la sua borsa al braccio, e non si spaventava se dall altra parte della strada vedeva una persona con la pelle di un altro colore, ora la prima reazione che ha è quella di stringere a sé la borsa perché ha paura, e questa non è una paura indotta dai giornali. I giornali danno conto di quello che sta capitando, siamo in un momento storico che viene vissuto dai miei lettori, ma credo anche da molti miei concittadini, come un momento di grande tensione. Poi è vero o no che i reati sono in aumento? Ed è vero o non è vero che la maggior parte dei reati sono commessi da cittadini di nazionalità diversa da quella italiana? Secondo le statistiche i reati gravi nel nostro Paese sono in diminuzione, per reati gravi si intendono in primo luogo gli omicidi, mentre sono in crescita i piccoli reati, quelli di piccolissimo cabotaggio che a volte neanche si denunciano più. Allora è vero che le biciclette a Padova, essendo una città studentesca, le rubavano 20 anni fa come oggi, con una piccola differenza, cioè che oggi non puoi lasciar fuori non solo la bicicletta, ma nemmeno il lucchetto o la catena che tiene legata la bicicletta, perché immediatamente te li portano via. Quindi è in aumento il reato di bassissimo livello, che proprio per questo ha a che fare con la nostra quotidianità. Quando c era la banda di Maniero che faceva delle rapine straordinarie (sotto il profilo scenografico) nel Veneto, e in tutto il nord, il cittadino medio non aveva una sensazione di insicurezza, nonostante la banda avesse assalito il ristorante dell ippodromo con i Kalashnikov, perché la percezione era che questi reati riguardassero una cerchia ristretta di persone, cioè i ricchi, quelli che potevano frequentare quei luoghi. Adesso il ladro di biciclette colpisce chiunque, e non è solo un fenomeno circoscritto come una volta. Vi do un esempio molto semplice derivante dalla mia esperienza: interi quartieri di questa città finiscono sul giornale, perché i garage vengono razziati settimanalmente, cioè ci sono, presumo, dei poveracci che vanno a svuotare il garage di altri poveracci per portar via non gioielli o denaro, ma semplicemente un trapano, un attrezzo, a volte una bicicletta che nessuno usa più da anni. Ecco, questo tipo di reato molto piccolo crea paradossalmente un enorme allarme sociale. Io racconto quello che succede, è vero che quello che succede si può raccontare in tanti modi, si possono esacerbare gli animi, oppure raccontare senza troppa partecipazione emotiva. Credo che innanzitutto vada raccontato il fatto, e questo noi cerchiamo di fare, e non mi pare che lo raccontiamo esaltandone i toni drammatici. Io non mi sento questa responsabilità, e vi assicuro, e lo giudico dalla quantità di lettere che ricevo, che il livello di esasperazione è molto alto. Ornella Favero: Tu hai usato due termini i giornali danno conto e raccontano quello che succede. Ti faccio allora un esempio: quando l altro giorno è successo che un mendicante è stato denunciato perché ha aggredito una donna ferma al semaforo in macchina, sul Mattino c era un articolo su questo fatto e poi un altro a fianco, con un titolo in grande rilievo: Sono ancora terrorizzato. Padova ormai è una giungla. Solo che queste dichiarazioni sono di uno che ha subito una violenza analoga nel Voglio dire, per trovare un fatto analogo cosi grave bisogna risalire al 1995, solo che dal titolo non te ne accorgi e 33
37 pensi che Padova sia ormai una giungla perché di storie simili ne succedono di continuo. Certo, noi non sottovalutiamo lo shock di una persona che subisce un reato, abbiamo fatto anche un convegno molto franco sul rapporto tra vittime e autori di reato. Altra cosa però è caricare con toni allarmistici i titoli: io abito a Padova, ma non mi sento di abitare in una giungla, mi sento di vivere in una città come tante, con dei problemi, oggi certamente più complessi, dovuti anche a questa presenza molto forte di immigrati, però, con titoli messi così, fai qualcosa di più che dar conto di una situazione, calchi la mano pesantemente. Omar Monestier: Certo, però è una affermazione della persona intervistata, non è un affermazione del giornale, io non ho fatto un editoriale dicendo: Padova è una giungla, ho sentito una persona che ha subito uno shock che dice: Per me Padova è una giungla, e costui lo dice da quando ad un semaforo è stato pestato selvaggiamente. Ora, stiamo parlando di una persona che ha subito una violenza, e che ha ancora per questo delle pesanti conseguenze, anche sotto il profilo fisico. Il caso del mendicante raccontato prima è un caso emblematico della nostra inettitudine a governare i fenomeni, per questo ha avuto tanto spazio, cioè si tratta di un cittadino indesiderato nel nostro Paese, e peraltro anche nel suo, condannato più volte, accompagnato al confine, più volte sottoposto a tutte le misure previste dalla nostra legislazione. Però non è stato messo nelle condizioni di non nuocere, e, solamente dopo che c è stato questo ulteriore episodio, sottolineato con forza dal giornale, è stato preso, impacchettato e rispedito al suo Paese. Tra l altro avrebbe avuto più bisogno dei servizi sociali, dei servizi psichiatrici che di quelli delle forze di polizia. Ora io ritengo che una persona pericolosa non può continuare a molestare la gente. Mi sono messo nei panni di questa donna, che lavora, che, come tante altre, torna a casa la sera, e io non posso accettare, da Direttore di un giornale, ma anche, che ne so, da fratello, padre, marito, che una persona sia ferma ad un semaforo e perché dice di no a un tale che le chiede la carità, costui le strappi un lobo dell orecchio, e scappi. Per questa ragione, questa storia ha avuto un così grande spazio, perché è un caso emblematico, ripeto, non solo di un fatto di microcriminalità, ma anche della nostra incapacità di applicare le leggi. Questo è il senso della grande esposizione mediatica che ha avuto questa notizia, di per sé forse non cosi grave. Ma se la tesi è che con queste notizie noi fomentiamo l odio, la paura, la xenofobia, io non sono d accordo. Noi siamo lo stesso giornale che racconta delle scoperte dell università, di come si fanno bene i marciapiedi, di tantissime altre cose, ma adesso stiamo parlando della criminalità, della sicurezza. Questo tipo di eventi non si può raccontare che così, non puoi raccontare che la donna è stata aggredita, però poverino quello che l ha aggredita forse ha una storia, un vissuto personale di sfiga alle spalle. Non esiste, non si può farlo perché chi subisce e chi vede il fatto non si pone nell atteggiamento di chi ha commesso il reato, si mette nella posizione di chi lo ha subito, e questa è naturalmente, ma non sempre, anche la nostra posizione. Sandro Calderoni: Non sarebbe sufficiente raccontare il fatto in sé, e cioè semplicemente che una donna è stata aggredita? Omar Monestier: Io posso anche accettare che nella nostra società così complessa una donna possa essere aggredita per strada, ma ci sono contesti e contesti, qui ci sono stati 34
38 una serie di eventi particolarmente drammatici e violenti che vanno raccontati, anche se lei non è stata ferita gravemente; cioè è la normalità dentro cui accadono queste piccole scene di violenza che le rende straordinarie! In altre parole, il fatto che due si sparino fra di loro avviene in un contesto diverso, magari un contesto socialmente orientato, per cui fa meno paura a chi non c è dentro; se invece tu sei una massaia e stai per strada, e un tipo ti strappa un lobo perché tu gli hai detto che non vuoi dargli un euro di carità, questo fatto ha socialmente una rilevanza molto maggiore perfino dell omicidio. Ornella Favero: Sì certo, ma va inserito in un contesto che spieghi con che frequenza questo avviene. Omar Monestier: Beh, non è che lo trovi tutti i giorni, se succedesse tutti i giorni probabilmente non saprei neanche come fare. Sandro Calderoni: Ma uno può appunto pensare che questa sia la normalità di tutti i giorni, se si scrive Padova è diventata una giungla. Elton Kalica: Vorrei aggiungere una cosa: questo articolo non è che raccontasse il fatto, ma riferiva che questa persona era già libera, perché il titolo era: Già libero di chiedere i soldi, quindi non è un articolo che si riferisce al racconto dell accaduto, ma solleva una critica, a mio avviso, verso il sistema giudiziario che ha permesso a questa persona di essere ancora in libertà. Omar Monestier: È così, è deliberatamente così. Il clandestino che ha scatenato una rissa con i carabinieri questo fine settimana, ed era sul giornale di domenica, è stato preso, ed è stato mollato poche ore dopo, cosa volete che pensi? Ornella Favero: Un momento, guardiamo bene come sono andate le cose: è stato processato per direttissima, condannato a 4 mesi (cosa gli si vuol dare di più per una rissa?) dopo di che, siccome c è la sospensione condizionale per tutti perché in tutti i Paesi civili, se sei al primo reato, funziona così, lo metti fuori sperando che non venga reiterato il reato. Però abbiamo letto l articolo, perché qui ci leggiamo ogni virgola, e dire è già fuori non spiega affatto che è stato condannato con sospensione della pena, e che se commetterà altri reati alla prossima condanna si dovrà fare tutta la galera! Omar Monestier: Presumibilmente. Ornella Favero: Presumibilmente, ma guarda che qui la gente se la fa la galera, eccome! Anche questa è una cosa di cui vorremmo parlare, questa idea di impunità. I giornali e la televisione contribuiscono molto a montare questa idea: Già fuori?, ma ci sono tanti modi di essere fuori! I telefilm americani li vedono i giornalisti italiani? noi li vediamo tutti. Là la gente paga una cauzione ed è messa fuori, ma poi, se la condannano, va in carcere. Però qui nessuno si sogna di spiegare che anche da noi succede lo stesso, solo che i tempi sono lunghi, io vedo gente che viene a scontare una pena dieci anni dopo aver commesso il reato. Ci sono delle donne alla Giudecca detenute per reati fatti quando erano tossicodipendenti e spacciavano, e magari hanno aspettato otto-dieci anni fuori, ma quando è arrivata la condanna definitiva, sono entrate in carcere a scontare la loro pena. Omar Monestier: Ed è anche questo uno scandalo, non è che questo non lo sia. 35
39 Ornella Favero: Certamente, questo è uno scandalo, ma è diverso dal dire è già fuori e far credere così che ci sia una sorta di impunità, infatti tanti stranieri qui sono finiti dentro convinti dell impunità, perché magari commettevano piccoli reati, erano fuori in attesa di giudizio e, pensando di averla fatta franca, alla fine si sono ritrovati qui. Maher Gdoura: Poi magari nel frattempo tu ti rifai una vita, ti crei una famiglia e riesci a capire da solo che quello che avevi commesso era tutto sbagliato, ma naturalmente te la fanno scontare lo stesso la pena. Io ho commesso i miei reati nel 1995 e sono stato condannato nel 2003, in contumacia, per vari episodi di spaccio, e adesso mi sto facendo 16 anni di galera. Leggendo i giornali, sembra che vengano tutti sempre scarcerati, ma poi il conto arriva da pagare, e a volte è salatissimo! Omar Monestier: Guardate però, non è possibile che conciliamo in qualche modo il mio punto di vista con il vostro, perché stiamo su fronti veramente opposti, voi vivete una situazione particolare, e siete dentro una realtà che non è la realtà di tutto l universo che sta fuori. Cioè voi vivete in un angolo di visuale molto particolare e siete molto attenti a quello, è inverosimile che noi e voi, cioè io e voi, si trovi un punto di contatto su come si raccontano questi fatti attraverso un giornale Elton Kalica: È vero, noi guardiamo la scena da una prospettiva un po diversa, se si parla in termini di cittadini regolari e di detenuti, però questo lavoro nella nostra redazione non viene svolto soltanto da detenuti, ma il giornale viene fatto da detenuti e volontari che hanno una vita anche fuori e vivono gli stessi problemi di tutti gli altri cittadini, inoltre hanno anche il senso critico di affrontare le cose senza identificarsi nella nostra stessa condizione di detenuti. Anzi, per precisare, qui facciamo delle discussioni feroci con i volontari, perché loro cercano di farci capire molto di quello che ci ha detto lei, com è il pensiero comune della gente fuori, com è la realtà nella società. Ci raccontano che adesso fuori i problemi di sicurezza esistono, che c è una grande parte di stranieri che girano e che commettono reati, perciò queste cose le sappiamo, e cerchiamo di tenerle sempre in considerazione anche qui, quando ragioniamo su questi problemi. Quindi credo che, se si vuole, si possono trovare terreni in comune su cui riflettere. Omar Monestier: Il fatto è che c è un Paese reale che vive nell insicurezza, al di là degli slogan, e al di là dei proclami di chi va al potere di volta in volta, e questo, come dire, è un dato di fatto che non ha colore né appartenenza politica, poi ci sono i toni della campagna elettorale, che ovviamente sono un altra cosa Il governo Prodi era un governo debole, con un partito che era tentato di fare alcune riforme, comprese quelle dei flussi di immigrazione, e anche della giustizia, e una minoranza che mandava messaggi molto contraddittori e molto diversi e che poi alla fine ha contribuito a farlo cadere. Di conseguenza è successo che in questo contesto è subentrata una forza politica che ha preso le debolezze del vecchio governo e le ha esaltate, facendone cavalli di battaglia per la propria campagna elettorale: ogni volta che c era uno sbarco, un delitto a Roma piuttosto che a Treviso, e ce ne sono stati due violentissimi, hanno avuto un forte impatto sull opinione pubblica ed un carico significativo nei confronti della campagna elettorale. Però chi oggi ci governa ha preso quegli elementi casuali, e li ha trasformati in elementi strutturali del malgoverno precedente, dicendo: Avete visto? Non c è sicurezza. Quindi il tema della sicurezza è stato cavalcato dalla forza che poi ha vinto le 36
40 elezioni, ma va poi anche detto, al di là della appartenenza politica di ciascuno di noi, che questo governo di centrodestra sta facendo delle politiche securitarie, sulle quali si può discutere, ma che comunque mantengono quello che aveva promesso di fare. Ornella Favero: Io però non capisco quando dici che non possiamo avere un punto di vista comune, perché non è che noi neghiamo il fatto che esista un problema di sicurezza nel nostro Paese, noi contestiamo, e su questo secondo me i giornali hanno un ruolo enorme, che tutto questo sia fatto passare come emergenza e che si facciano leggi sempre sotto la spinta dell emergenza. Perché, vedi, quando io citavo l articolo di prima dove si diceva: Padova è ormai una giungla, non è che io contesto che poniate il problema se questa persona poi pagherà o no, non è questo il punto, ma il punto è che, calcando i toni, questa diventa una perenne emergenza. Ora noi le leggi emergenziali che ci sono state in questo Paese le conosciamo e sono tante, adesso si invoca il carcere per qualsiasi cosa, e su questo secondo me i media hanno grosse responsabilità, non tanto, ripeto, sui temi della sicurezza, quanto sul farne perennemente un emergenza. Faccio un altro esempio: l altro giorno è uscito dal carcere quel pensionato, mi pare di 77 anni, che aveva commesso un omicidio, il titolo era: Omicida già libero dopo solo 2 anni. Uno crede che, commettendo un omicidio, un feroce assassino dopo due anni è già libero, poi vai a leggere, e scopri che la persona era anziana, seminferma di mente Omar Monestier: Sì ma è uscito dopo due anni, tu puoi dire quello che vuoi, ma vallo a dire ai figli della donna che lui ha ammazzato che due anni sono un tempo ragionevole perché è anziano o seminfermo. Ornella Favero: Tu però non stai parlando solo alle figlie, ma a tutta la società o ad una parte di questa che legge il tuo giornale. Omar Monestier: È stato fatto un titolo oggettivo. Ornella Favero: Secondo me no, perché quella persona era inferma di mente, mentre, se una persona normale avesse ucciso qualcuno, se ne starebbe in galera per anni come ci stanno loro qui. Capisci che è molto diverso, lo sai bene che la gente si crea l idea che con l omicidio stai dentro pochissimo. Marino Occhipinti: Tra l altro questa persona è agli arresti domiciliari, credo che abbia preso 8 anni, forse poco, però quando avrà la sentenza definitiva rischia di rientrare in carcere. Faccio un esempio da un altro giornale: nel Gazzettino, parlando di Naim Stafa, uno degli albanesi della rapina con omicidio di Gorgo al Monticano, scrivono Già nel 2017 l albanese potrà godere dei permessi e la valutazione del giudice sarà in realtà solo una mera presa di conoscenza del fatto che si sia comportato bene, se lo avrà fatto, i permessi non si potranno negare. Allora con queste affermazioni sì spaventano le persone, non è vero che fra 9 anni sarà solo una mera presa di conoscenza quella del giudice nel dire: se ti sei comportato bene, puoi uscire. La realtà è che quello dei termini temporali è il requisito minimo per accedere ai permessi, ma ne potremmo aggiungere un altra decina; insomma c è gente che non arriva mai ad ottenere i permessi. Vuol dire che questa giornalista evidentemente non conosce l Ordinamento penitenziario. Questo significa terrorizzare la gente, e terroriz- 37
41 zando le persone crei insicurezza, ed è questo che a noi dà un po fastidio, perché vediamo che ci sono persone che hanno l ergastolo, sono 20 o 30 anni che sono in carcere, ed in permesso non sono mai andate, e quindi perché fuori si deve dire che fra 9 anni Naim Stafa sarà libero di circolare, perché i permessi non potranno essergli negati? Elton Kalica: Noi conosciamo la materia, ma qualsiasi persona di buon senso che apra un codice si accorgerebbe che non c è niente di automatico, quindi il problema più grosso è che ci sono giornalisti che fanno degli errori grossolani, e non sono neppure sicuro che siano fatti in buona fede. Però anche se fossero fatti in buona fede, il punto è che, se un giornalista economico del Sole 24 ore prende delle cantonate su problemi economici, il giorno dopo lo cacciano, mentre se un giornalista parla di giustizia e fa errori grossolani di terminologia o anche più sostanziali, nessuno si prende la briga di andare a controllare se quell articolo corrisponda alla realtà. Poiché oggi stiamo cercando di trovare un terreno su cui confrontarci, si potrebbe pensare ad un maggior controllo su questa materia, magari offrendoci noi di segnalarle eventuali errori. Omar Monestier: Lo stavo dicendo io, che un sistema per combattere la cattiva informazione è quello di essere molto puntuali nella segnalazione degli errori. Io ho avuto negli anni passati lo stesso tipo di problema con la sanità, ve lo racconto perché secondo me può esservi di aiuto. Allora, fino a dieci anni fa la sanità veniva raccontata solo per i grandi fatti, come il trapianto di cuori artificiali, le scoperte, le nuove cure. Poi con il crescere dell insoddisfazione verso alcuni servizi da parte degli utenti, tipo la lunghezza dell attesa delle visite, oppure con le forti contestazioni nei confronti degli errori dei medici, e dei chirurghi in particolare, le notizie sulla sanità stavano molto più spesso sui giornali, e noi ci siamo resi conto che i giornalisti non avevano una conoscenza neanche elementare per trattare con competenza questo genere di informazioni. Allora siamo andati direttamente all azienda ospedaliera di Padova e abbiamo detto: Guardate, voi avete il problema di vedervi correttamente rappresentati sul giornale, noi abbiamo il problema di voler rappresentare correttamente voi per i nostri lettori, quindi, dopo una serie di incontri e seminari, in cui i giornalisti hanno capito dove sbagliavano, hanno imparato dove cercare le informazioni, si è costruito un rapporto che adesso funziona molto bene. Perché anche dall altra parte c erano delle difficoltà da superare, cioè le aziende sanitarie erano abituate al fatto che davanti all errore si taceva sempre, o si negava anche quello che era lapalissiano. Allora, visto che siete una redazione che passa ì giornali al setaccio, sugli errori clamorosi, marchiani, vale la pena di tentare di avere degli incontri con i giornalisti che se ne occupano. Una forma potrebbe essere anche quella di mandare delle garbate lettere ai direttori, in cui si dice: Caro direttore, abbiamo letto l articolo di cronaca giudiziaria uscito il, ci permettiamo di dire che non è vero che dopo 6, 7, 9 anni quello è uno che può uscire. Guardate, questa cosa che magari all inizio può essere vissuta con qualche fastidio, se ha una sua regolarità, una sua cadenza, e se non la fate su ogni stupidaggine naturalmente, ma solo su grandi questioni, può essere una forma di miglioramento che vi riguarda. Ornella Favero: Noi infatti volevamo proporre di fare un seminario con i giornalisti di giudiziaria e di cronaca nera qui dentro, per ragionare su come alcune questioni vengono trattate dalla stampa. 38
42 Omar Monestier: Mettere insieme tutti i giornalisti del Veneto diventa dura, bisognerebbe farlo allora per piccole aree, fare un giornale alla volta. Però è una bella iniziativa, perché obbligherebbe loro a misurarsi con le vostre facce, e non con i nomi scritti su un pezzo di carta, e com è ovvio c è una grande differenza tra trovarsi davanti uno che ti dice Io sono quello di cui tu hai scritto una cosa sbagliata, e vedere solo una riga su un pezzo di carta! Questo forse aiuterebbe anche voi a capire un po meglio i vostri processi, tenete presente che quando vedete riportato un documento su un giornale, quelle notizie escono da due posti, o dagli uffici legali, oppure dai palazzi di giustizia, questa è la verità, dopo di che è anche bene che qualche carta finisca ai giornali, perché altrimenti certi scandali non sarebbero mai scoppiati se non avessimo intercettato noi le carte prima che arrivassero in aula. Comunque fra noi e voi che state in carcere ci sono molti soggetti, noi non parliamo con voi, anche perché se voi state qui dentro è ovvio che non ci sia una possibilità di comunicazione diretta, e chi racconta le cose che vi riguardano spesso lo fa distrattamente al telefono, o ce le sussurra in un corridoio mentre va da un udienza all altra. Questo giustifica parzialmente, anche se non del tutto, una certa incapacità da parte dei giornalisti di essere precisissimi sulle cronache giudiziarie. In ogni caso la lunghezza dei processi e la struttura delle indagini che ha posto in capo al Pubblico Ministero tutta una serie di funzioni investigative, in questi anni ha reso la stampa necessariamente più orientata verso il PM, perché è l unica parte che parla subito dopo il fatto e che molto spesso ha interesse a rendere visibile il suo lavoro, mentre l altra di solito rimane coperta fino all udienza. Quindi è vero che la stampa normalmente è più colpevolista che innocentista. Daniele Barosco: Io voglio rimanere sempre sul tema informazione e sicurezza. Lei prima ha detto che riceve molte lettere su questi reati minori, furti nei garage e simili, difatti sul Mattino ci sono spesso notizie di questo tipo. E poi immagino che riceverà anche molte lettere di chi ha subito i crac, come Parmalat, i bond argentini e simili, e, se le riceve, come mai queste notizie non vengono pubblicizzate e finiscono nelle pagine interne? Omar Monestier: Cominciamo dalle lettere: allora io ricevo anche lettere di persone che ritengono di essere vittime di crac, che dicono di avere perso tutti i loro risparmi, ed è anche capitato di averne pubblicata qualcuna. La differenza è, e qui c è anche un certo disagio da parte del giornale, che quando uno manda una lettera per segnalare un fatto specifico come Mi hanno rubato la bicicletta, lo racconta e basta; quando invece mandano delle lettere contro i crac finanziari, siccome questa è gente che ha perso veramente dei soldi, si arrivano a lanciare accuse piuttosto pesanti, del tipo Sono stato truffato dal direttore della filiale della banca dove mi rivolgo, la tal banca mi ha rubato tutti i miei risparmi. Fate attenzione, non è mica così facile pubblicare queste cose, io ho una responsabilità penale di cui rispondo in prima persona, oltre che in termini economici. Daniele Barosco: Allora, se lei deve pubblicare una notizia su un disgraziato che ha rubato un motorino, le tutele giuridiche personali e individuali non servono, se invece la notizia riguarda il direttore di banca, le tutele subentrano tutte, e non si pubblica quella notizia. Omar Monestier: Da tutte le lettere che ricevo, dal povero cristo al direttore di banca, io tolgo, perché impubblicabili, gli insulti e le offese, e poi le pubblico, perché, ripeto, ne 39
43 rispondo io penalmente. Però nella sua domanda sottotraccia c era questa idea: Voi siete forti con i deboli e deboli con i forti, no non è proprio così, ci sono giornali che hanno fatto molto per informare sui reati finanziari, pensate al crac, al golpe sventato su AntonVeneta, che di fatto è stato svelato dai giornalisti, e anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte. Ornella Favero: Ma nel nostro Paese i reati di allarme sociale sono più quelli della zingara che fa tanti piccoli furti, che non, appunto, quei reati finanziari che mettono veramente sul lastrico migliaia di famiglie. Omar Monestier: Ma arrestano anche quelli, quelli della Lehman Brothers li hanno arrestati, Tanzi è stato arrestato. Ornella Favero: Sì certo è stato arrestato, ma quanti come lui non sono stati dentro neanche un giorno o comunque pochissimo? Omar Monestier: Lo hanno messo agli arresti domiciliari. Ornella Favero: Nello stesso modo in cui adesso dici che lo hanno messo agli arresti domiciliari, allora io dico che era già libero, come fanno sempre i giornali. Comunque viviamo in un Paese in cui se venisse applicata davvero la tolleranza zero finirebbe in galera l 80 per cento degli italiani, perché di gente che viola le regole in tutti i campi ce n è un infinità. Cos è allora l allarme sociale? Comunque un furtarello non lo puoi definire un reato di allarme sociale, lo puoi catalogare nel fastidio sociale semmai. Omar Monestier: Diciamo che, se tu sei un pensionato, a 800 euro al mese, e la zingara ti porta via questi 800 euro, non si può dire che è un furtarello, almeno per quel pensionato. Ornella Favero: Guarda, siamo i primi a dirlo che non si può minimizzare mai il reato, però oggettivamente ci sono due pesi e due misure nei confronti di chi commette reati contro il patrimonio. Daniele Barosco: Basta vedere che, nei vari pacchetti sicurezza, i provvedimenti presi d impeto colpiscono sempre una certa categoria di persone, però se poi ci si accorge che queste persone ci fanno comodo, allora non si può fare. Le faccio un esempio: volevano introdurre il reato di clandestinità, quando si sono accorti che avevamo badanti che andavano espulse il giorno dopo hanno cambiato idea, per cui la legislazione di emergenza subisce deroghe, allora lì viene trovata una soluzione. Volevo poi fare una domanda sui dati. Le statistiche e i dati non dovrebbero essere né di destra né di sinistra, anche se certo sono interpretabili. Il Mattino ha interpretato che qui a Padova ci sono circa persone che vanno a prostitute, e che un padovano su tre rischia l arresto, se passa la legge che prevede il carcere anche per i clienti delle prostitute. Io volevo sapere: allora come vengono elaborati questi dati. La questione dei dati è per noi scottante, perché per esempio ci sono statistiche sulle pene e sul tempo medio di permanenza in carcere elaborate dal Ministero dove si dice che per rapina si fanno mediamente 3 mesi di carcere, per omicidio 2 anni, per sequestro 6 anni, non si spiega però che in quei dati rientrano anche gli arresti non convalidati dai 40
44 GIP, o le persone poi assolte, che abbassano sensibilmente la media. Ma tutti questi dati come vengono trattati sui giornali nazionali e locali? I giornali hanno scritto Emergenza criminalità a Padova, il giorno dopo però il generale dei carabinieri, e il capo della polizia dicono che c è un calo di reati nella regione. Da certi titoli qualcuno qui dentro pensava che fuori ci fosse la guerra civile, allora noi vorremmo capire questi dati come vengono elaborati e diffusi, perché anche noi qui da un anno e mezzo tentiamo di elaborarli, ma ancora non siamo riusciti a capirli. Elton Kalica: I dati di partenza provengono da una fonte cosiddetta ufficiale, che può essere il Ministero degli Interni, o agenzie di statistiche; quello che noi contestiamo è l interpretazione o l uso che ne viene fatto quando arrivano sui giornali. Questo dato delle prostitute è un caso, diciamo così, eclatante. Io penso che abbiano calcolato un certo numero di prestazioni per prostituta a sera, hanno preso poi il numero approssimativo delle prostitute a Padova e fatto un totale, diviso poi per il numero dei maschi adulti, allora uno su tre va a prostitute. Ma questa non è una statistica, è una media che ha fatto il giornalista. Omar Monestier: Sì, credo che il dato sia stato calcolato così. Io comunque vedo che negli ultimi due anni, mentre cresce la sensazione di insicurezza, le statistiche dicono sempre che molti reati sono in calo. Tenete presente che dipende anche da che ministro c è al Viminale, e da chi c è alla Difesa, perché spesso passa una linea in cui si dice che i reati sono in calo, ma c è una lettura politica a monte dei reati che vengono raccolti a valle. Il fatto è che i grandi reati, soprattutto per quanto riguarda Padova, sono oggettivamente in calo, ma c è questo stillicidio di piccoli episodi sul territorio. Ornella Favero: È davvero difficile capire se effettivamente i reati sono o non sono diminuiti. Allora noi organizziamo questo progetto con le scuole, e quindi all inizio facciamo, con centinaia di studenti, una piccola indagine dove chiediamo se si sentono insicuri dove vivono, e poi da dove nasce questa percezione di insicurezza, se gli è successo qualcosa, e non troviamo quasi nessuno che dica: sì sono stato derubato, o conosco qualcuno che ha subito un reato, vivo in un quartiere pericoloso e a parte il furto di un telefonino o quelle cose minime che non sono certo da collocare come allarme sociale, tutti quanti ci dicono: Sì, però i giornali dicono che Sì però i telegiornali dicono che. Io non voglio dire che non esista il problema, sto solo distinguendo tra realtà e percezione indotta dai media. Omar Monestier: Ma la sicurezza, o l insicurezza sono un fattore di complessità che fa del nostro tempo non proprio un momento felicissimo, non siamo in una fase di rinascimento, in cui tutti si sentono di far parte di un grande progetto, viviamo in una fase molto convulsa che crea, insieme alla grande difficoltà economica di tutto il pianeta, una situazione di instabilità. Probabilmente i liceali che voi andate a sentire, o gli studenti degli Istituti Tecnici, che sono nel fiore della loro vita, e per i quali tutte le speranze sono aperte, non hanno mai provato un esperienza così fortemente negativa da poter dire che questo ha creato in loro insicurezza. Ma vivono dentro una famiglia in cui magari il papà che ha perso i soldi in borsa, la mamma che perde il lavoro part-time, li inducono a credere che viviamo in un momento di grande insicurezza. Ornella Favero: Ma allora il problema che dobbiamo tirare fuori è appunto un idea molto più ampia dell insicurezza, e non il vizio di scaricare tutto sullo straniero e sulla cri- 41
45 minalità, e basta, perché secondo me queste sono anche le fasi in cui è facile trovare i capri espiatori. Omar Monestier: Io non mi ricordo bene i numeri, ma c era uno studio di qualche settimana fa in cui le domande erano due: Posto che x è il numero di reati che avvengono ogni giorno, ogni mese in Italia, quale percentuale è fatta da stranieri, e quale è fatta da cittadini italiani?. E veniva fuori che la maggior parte di questi reati era compiuta da cittadini stranieri, dopo di che la seconda domanda era: Fra le nazionalità degli autori di reati, qual è quella che ne commette di più?. E veniva fuori che erano i rumeni per il 58 per cento. Allora questo non è razzismo, non è semplificare o dire che fanno tutto gli extracomunitari, c è un dato statistico chiaro. Questo non vuol dire che lanciamo una campagna xenofoba, non sto mica dicendo Allora i rumeni cacciamoli tutti via, ci mancherebbe, ma prendiamo atto di quello che accade. Ornella Favero: Ma se pensiamo a tutta l illegalità sommersa che c è nel nostro paese, forse la realtà è più complessa, basta vedere che tutti gli immigrati che sono qui dentro hanno lavorato in nero con datori di lavoro italiani, invece i giornali tendono a ridurre la complessità, semplificando al massimo. Omar Monestier: Ma è la funzione dei giornali! Ci sono le riviste e i convegni per complicare le cose! Ornella Favero: Io non credo che vedere la complessità significhi complicare i problemi, se sono complicati li analizziamo nella loro complessità. Marino Occhipinti: Io sono convinto che bisognerebbe essere più chiari nel distinguere il tasso di criminalità degli stranieri irregolari da quello dei di stranieri che lavorano regolarmente in Italia, ossia se gli stranieri vengono messi nelle condizioni di lavorare, comunque delinquono molto meno, spesso anche meno degli italiani, quindi forse bisognerebbe valutare anche questo. Maher Gdoura: Io sono tunisino, ho 35 anni, dall età di 17 sono in giro per l Europa ed ho visto in diverse città europee come si comportano con gli stranieri, però in questa fase della mia vita è la prima volta che vedo un attacco così forte contro gli immigrati. Per quanto riguarda quelli che commettono reati, non penso che loro vengano qui per commetterli, però uno che arriva qui con delle aspettative e non trova lavoro, non riesce a inserirsi perché il clima è pessimo, e magari il lavoro c è, ma solo in nero, come fa a sopravvivere, come fa a mangiare? Certo questa non è, né può diventare una giustificazione per delinquere, ma è un problema che sta a monte, e che dovrebbe essere valutato. Omar Monestier: Noi siamo in ritardo come Paese nelle politiche di accoglienza degli immigrati, e questo bisogna dirlo, gli altri Paesi sono molto più avanti, ma non è solo un demerito dell Italia, nel caso della Francia deriva anche dalla sua storia coloniale, così dell Inghilterra, nel caso della Germania l ondata migratoria c è stata molto prima e quindi i Turchi e gli Italiani, per esempio, sono già di terza, quarta generazione, perciò sono molto più integrati. Qui stiamo parlando di alcuni aspetti che non funzionano, ma non sono affatto pessimista per quanto riguarda l integrazione. Nel Veneto, pur essendoci una politica che parla poco di integrazione, e spesso a sproposito, non ci sono storie di xenofobia gravi o pesanti, 42
46 il punto è che noi siamo arrivati molto tardi, ripeto, e quando ormai il fenomeno migratorio aveva assunto dimensioni imponenti, se avessimo cioè pochi cittadini stranieri da aiutare, da inserire, non avremmo il problema che abbiamo oggi. È che ci siamo trovati improvvisamente davanti ad una marea di gente affamata, che aveva bisogno di lavorare, e che non sapevamo come inserire. Lucia Faggion (volontaria): Vorrei spostare il discorso dai contenuti degli articoli ai titoli. Molto spesso il titolo di un articolo viene smentito, comunque chiarito o modificato poi dall articolo stesso. Allora mi chiedo: come vengono fatti i titoli degli articoli? in che misura un titolo può far vendere più copie rispetto ad un altro? Omar Monestier: Che il titolo smentisca il contenuto di un articolo mi pare grave, il titolo ha un effetto di sintesi rispetto al contenuto dell articolo, e se è un titolo fatto bene cerca anche di catturare l attenzione, senza ovviamente cambiare il senso dell articolo che va a sintetizzare. Molto spesso no, questo non posso accettarlo, può capitare qualche volta, ma se fosse molto spesso sarebbe grave; quindi respingo il molto spesso. Per quanto riguarda le cose che fanno vendere di più, dipende dai giornali. Il giornale locale naturalmente è molto diverso da quello nazionale, un giornale nazionale può vendere molto in questi giorni anche per la crisi delle borse, mentre un giornale locale è assolutamente indifferente a questo tipo di notizia. Nella media, cioè in assenza di eventi eccezionali, le notizie che fanno vendere sui giornali locali sono sostanzialmente due, quelle di nera, morti, incidenti, rapine, non però fatti sgradevoli, tipo stupro, violenza, la nera quella classica, diciamo da sangue, sparatorie Oppure le notizie di servizio. Sono sostanzialmente questi i due filoni. Milan Grigic: Fra le notizie di nera ci sono, per esempio, gli omicidi in famiglia, che vengono commessi per lo più da gente con problemi psichiatrici, insomma io sono un padre di famiglia e se dovessi arrivare ad ammazzare i miei figli vorrebbe dire che qualcosa non va. Ma nessuno si preoccupa di guardare qual è la causa di questa pazzia, perché se magari una persona ha lavorato tutta la vita per costruire qualcosa per i propri cari e poi, arrivato ad un certo punto della sua vita, stermina la famiglia, forse c è qualcosa che non va anche all interno della società. Omar Monestier: Sì, ma non è proprio il mio mestiere, io racconto cos è successo, e poi se riesco trovo anche una spiegazione, ma trovare una spiegazione non è principalmente il mio mestiere, è un lavoro che lascio fare ad altri, agli investigatori, piuttosto che agli psicologi. Io racconto quello che vedo, cioè un uomo che uccide la moglie e i figli, e dico come si è svolto, dopo di che posso trovare qualcuno che mi aiuta a spiegare il fenomeno, magari la figlia che mi dice come è successo o il carabiniere che ha trovato il biglietto con scritte delle spiegazioni, ma è difficile che sia io, sia il mio giornale insomma, a spiegare o a dire come stanno le cose, non è proprio il mio mestiere. Lucia Faggion: Sempre a proposito di cronaca nera, la compagna di classe di mia figlia più piccola ha il papà che è un medico e che, in un momento di depressione, ha perso la testa e con una mazza da baseball ha cercato di aggredire la moglie. Ora di questa persona sono stati dati generalità e foto dell abitazione, però c è di mezzo una moglie che ha 43
47 subito il fatto, un figlio, i compagni di classe, molti dei quali hanno letto i fatti raccontati con tutti questi dettagli, quando invece gli insegnanti, gli psicologi, gli educatori, avevano comunque raccomandato che il fatto non fosse presentato nella sua crudezza. Quindi io mi chiedo fino a che punto il dovere di informare tiene conto del diritto di ogni persona, fino a che punto possa essere utile fornire dati che consentano di identificare quella persona, e anche i suoi famigliari. Omar Monestier: Il diritto di cronaca è preminente rispetto a qualsiasi forma di tutela di privacy o di intimità, tranne che per i minori, l unico fatto sacro è il diritto dei minori a non essere citati, né ad essere riconoscibili, tutto il resto è diritto di cronaca. Trasformo questa mia spiegazione in un esempio, se io scrivessi sul giornale che un noto medico padovano imbracciando una mazza in una abitazione di una non meglio precisata strada nel centro di Padova ha tentato di uccidere la moglie, lei se lo leggerebbe? Io dico di no. Io non posso, come giornale della città, raccontare un fatto senza tirare fuori gli elementi di identificazione, questa è la differenza tra fare cronaca, o non farla. La legge ci impone di non pubblicare il nome dei figli, non posso non pubblicare il nome del padre che è riconoscibile, è figura nota. Queste sono questioni che vengono sempre poste, ma sono irrisolvibili, e davanti a questo io sono molto chiaro: il mio diritto di cronaca è prevalente, e preminente a tutto il resto. 44
48 Capitolo 3 ALTRE SCRITTURE Il racconto autobiografico è al centro di questo progetto, perché è solo attraverso il racconto di sé che le persone detenute riescono a stabilire un contatto vero con gli studenti. Parlare di carcere e di pene ha un senso del tutto diverso infatti, se a farlo è chi in galera ci vive, e ha il coraggio di mettere a disposizione dei ragazzi la sua storia, e di dare così un significato nuovo anche alle esperienze più negative. Da questa centralità della narrazione, in particolare di quella autobiografica scritta e orale, è nata l idea di approfondire il tema della scrittura in contesti come il carcere e la scuola. E lo facciamo con il racconto di come organizzare un laboratorio, due ipotesi diverse, la prima proposta da Adriana Lorenzi, che è davvero una specialista in questa materia, che insegna all Università, ma sperimenta anche dal vivo, nelle carceri con le persone detenute, e poi fuori, con donne e uomini immigrati, con persone anziane; la seconda proposta da Luciana Scarcia, insegnante, che conduce da anni laboratori di scrittura nel carcere di Rebibbia, con persone detenute che hanno comunque voglia di ripensare la propria vita anche attraverso la scrittura. I suggerimenti, le proposte, le riflessioni che troverete possono essere usati per organizzare, anche con gli studenti, dei piccoli laboratori sperimentali di scrittura autobiografica, su temi attinenti il progetto, come hanno fatto, per esempio, in una scuola, dove hanno lavorato con i ragazzi sul lato oscuro che c è in ognuno di noi. 45
49 46
50 LA CARTOGRAFIA DELL ESPERIENZA Laboratori di scrittura autobiografica e memoriale Le parole significano. Le parole indicano. Sono frecce. Frecce conficcate nella ruvida pelle della realtà. Susan Sontag di Adriana Lorenzi, scrittrice, formatrice, conduce laboratori di scrittura autobiografica Premessa Ho sperimentato prima di tutto su di me la forza trasformativa e strutturante della scrittura. Fin da ragazzina, ho sempre tenuto diari segreti che iniziavo quando qualcosa mi turbava e, avvertendo di non potermi confidare con nessuno, cercavo il sollievo della pagina bianca. Il bisogno di scrivere durava per qualche giorno poi, superato il disagio, il diario smetteva di essere rifugio e niente mi pareva più degno di essere trascritto. Dimenticavo il diario e le sue pagine, come quando si abbandona un gioco per quello nuovo che viene a destare un altro interesse, per ricordarsene però all occasione successiva. Tra le pagine fitte di parole, tante pagine vuote, molti giorni non registrati, scorsi via, scomparsi alla consapevolezza eppure non completamente perduti come anelli nella sabbia. Scrissi il mio primo racconto quando l angoscia per una morte improvvisa non mi faceva chiudere occhio la notte e mi costringeva a sopravvivere alle settimane, il cuore e il corpo stracciati irrimediabilmente: niente accendeva il mio sorriso e due rughe a virgola avevano definitivamente inciso la pelle ai lati della mia bocca. Una persona a me cara era stata spezzata prima del tempo e non perdonavo: Dio, la vita, il destino, lei stessa che si era lasciata morire sfinita dal vivere. Sulla mia pagina sgocciolava il dolore a chiazze diluite d inchiostro, mentre prendeva forma quell interrogativo sulla morte prima di un compimento, o forse sul senso del vivere per morire. Ritornavo su quella pagina a combattere la mia battaglia di sempre tra la disperazione e la speranza; tra il pessimismo e l entusiasmo strappato ad ogni nuovo stupore, ad ogni ri-nascita. Da allora scrivo, partendo dal presupposto che spetta a me trovare parole adeguate per trascrivere l accaduto con la coloritura dell emozione provata, individuare le risposte alle domande che guidano la scrittura. Domande cruciali sulla vita e la morte, sulle regole utili al costituirsi di buone relazioni, sul modo di migliorare me stessa e il mondo nel quale sono stata lanciata come un sasso nel mare. Scrivo per capire come è davvero andato il tempo più remoto o più recente. Scrivo contro la morte degli attimi. E misurandomi con questo strumento espressivo e narrativo insieme, ho cominciato a pensare che se la scrittura era servita a me quale meccanismo trasformativo del dolore da pungolo che ferisce a stimolo capace di innescare processi di riflessione e strategie di resistenza poteva servire anche ad altri, come una sorta di solvente degli inciampi della quotidianità esistenziale, professionale, familiare, civile. 47
51 Partecipare a un laboratorio di scrittura autobiografica e memoriale Chi decide di iscriversi ai miei laboratori di scrittura, in genere, sta vivendo un momento particolarmente delicato della sua esistenza, di grandi cambiamenti; di insoddisfazione sul piano affettivo e lavorativo. Qualcuno sta invecchiando (anziani ed anziane); qualcun altro è costretto a saldare i propri debiti con la giustizia e a vivere ristretto tra le mura carcerarie (detenuti e detenute); qualcun altro ancora ha vissuto una profonda lacerazione determinata dalla perdita del proprio Paese d origine, lingua, abitudini, odori e sapori (immigrati e immigrate); oppure c è anche chi, più semplicemente, sogna ciò che non ha e non è (le vittime del burn-out professionale, gli operatori dei servizi socio-assistenziali ed educatori, gli affaticati dalle dinamiche familiari); o chi ha la necessità di ripensare alla propria vita poiché qualcosa è intervenuto a stravolgerla o a dirottarla almeno un po : una nascita, una morte, un trasloco, un abbandono. Nei laboratori di scrittura non miro all insegnamento di abilità scrittorie ai partecipanti, piuttosto alla formazione di soggetti attenti alla propria storia di vita, al suo ripensamento, alla sua ri-significazione grazie ad esercizi di nominazione e costruzione narrativa di alcuni episodi cruciali. Scrivere dunque per aumentare equilibri interiori, sviluppare capacità di riflessione e di lavoro di gruppo. Affinare le tecniche espressive e comunicative attraverso la scrittura vuol dire lavorare al consolidamento del proprio senso di sé e delle relazioni con il mondo. La vita accade e pare sbatterci a destra e sinistra, dal mattino alla sera come stracci, lasciandoci inebetiti, frastornati, spesso insoddisfatti per la sensazione di essere stati giocati dagli eventi, piuttosto che di averli giocati. Costruire un racconto a partire da quegli stessi eventi, diventa un modo per aumentare il proprio grado di autoconsapevolezza, coltivare nel contempo la propria autonomia, la capacità di giudizio e un proprio pensiero critico. Forse si può smettere di considerare la vita come una serie di colpi inferti da nemici invisibili, piuttosto come una trama fitta di fili da intrecciare, per riassumere il passato, decantare il presente e progettare il futuro. Raccontando per scritto le nostre avventure, scontorniamo le situazioni e diamo forma alle nostre responsabilità, evitando di attribuire ogni colpa alla Storia, alla società, agli altri, per non cercare alibi nelle circostanze che si abbattono contro di noi come vento sulle bandiere sui pennoni. Per questo propongo laboratori incentrati soprattutto sulla costruzione dell esperienza che dipende dal movimento di descrizione e valutazione dei fatti compiuti dai soggetti, coinvolti sia sul piano cognitivo che emozionale. Vivendo, si agisce e ci si concentra sull azione, riducendo, per rispondere ad impegni ed urgenze, lo spazio del pensiero; scrivendo, invece, si riduce quello dell azione, promuovendo l attività del pensiero. Come scrive Luigina Mortari: L esperienza è la vita saputa, compresa: è il tempo patito e agito. L esperienza è presa di coscienza. È come se l esperienza fosse vita di secondo grado 1. L esperienza è il risultato di un percorso narrativo che ha bisogno di individuare per ogni evento il chi, cosa, dove, quando e perché utili alla costruzione di unità di significato da parte di soggetti sempre più responsabili della loro esistenza e anche del mondo circostante. I partecipanti attraverso la scrittura, imparando a metter giù qualche parola, attraverso la lettura, iniziando ad amare la letteratura, attraverso la creatività dell ascolto reciproco, incominciano a capire un po meglio il mondo e a rendere il mondo migliore 2 (G. Paley). 1 Luigina Mortari, Un metodo a-metodico, Liguori, Napoli, 2007, pag Grace Paley, L importanza di non capire tutto, Einaudi, Torino, 2007, pag
52 Tutto sta nell applicarsi a trovare un nuovo vocabolario per questa esperienza in tutte le sue singolarità e differenze, contrastando l informità della realtà. Come afferma Iris Murdoch, si tratta di Dare forma all informe, per evitare che la realtà appaia solo un ammasso di detriti senza senso. Con la conquista di un senso che va comunque ricercato, negoziato, prefigurato e verificato, noi finiamo per adagiarci in una culla di tranquillità, stiamo bene nel nostro presente che fila liscio come un automobile su un autostrada senza traffico. Il senso può essere definito a partire dai frammenti di racconto della nostra vita che vengono via via aggiunti gli uni agli altri. Nominando e descrivendo, delineiamo anche le nostre cornici di riferimento, quelle che guidano i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti e anche le nostre parole e smascherano le più avvilenti semplificazioni. Nella sua autobiografia, Edgar Morin racconta un aneddoto capitatogli in una lavanderia dove aveva portato un vestito in cotone leggero. Al momento del ritiro si trovano soltanto i pantaloni e non la giacca che viene cercata invano dalla commessa tra quelle appese. Il giorno successivo, in tintoria si ripete la stessa scena, ma la commessa questa volta controlla anche tra le camicie e riconosce la giacca grazie al numero. Era finita lì, perché senza pantaloni assomigliava più a una camicia che a una giacca. E Morin commenta: Nessuno aveva il concetto di giacchiccia (vestise) o camiacca (chemeste) con cui la si sarebbe potuta indicare Ecco che ne è di noi: privi di un nome che ci definisca, siamo degli ibridi, dei bastardi, dei meticci che non sono neppure riconosciuti come tali. Ci si vuole incasellare a forza in una delle due categorie delle quali facciamo, e al tempo stesso non facciamo, parte 3. Imparare ad essere precisi nella scelta delle parole e nella loro combinazione all interno di un discorso, significa coltivare forme autentiche di rispetto per sé e per i propri interlocutori. Il racconto nasce dal bisogno di assemblare i pezzi eterogenei in un insieme omogeneo per guardare se stessi e il mondo e vedere più di se stessi e del mondo. È un modo privilegiato di autoformazione nella misura in cui costruire il proprio racconto è costruire anche la propria vita. Uso il verbo costruire per sottolineare la necessità di affiancare un racconto a un altro esattamente come, in un romanzo, si susseguono i paragrafi e i capitoli. Costruire, affiancare sono i verbi all infinito che promuovono la responsabilità di un disegno complessivo che dipende dalla giustapposizione dei tanti tasselli. Solo costruendo un insieme complesso, si impara che una parte trae forza da un altra, esattamente come accade per un capolavoro artistico. Il laboratorio diventa un percorso di formazione, uno spazio privilegiato dove ci si prende del tempo per riflettere sulla costruzione di una storia che dipende: sul piano formale dalla capacità di selezionare e combinare alcune parole in frasi e brani - Scrivere per raccontare in maniera efficace; sul piano contenutistico dalla capacità di attingere alla propria storia personale, familiare, professionale, ma anche a quella immaginifica del desiderio e del sogno che affondano comunque le loro radici nella propria biografia - Scrivere per raggiungere un equilibrio interiore; 3 Edgar Morin, I miei demoni, Meltemi, Roma, pag
53 sul piano metodologico dalla capacità di lavorare individualmente sul proprio brano di scrittura e in gruppo quando si legge ad alta voce il proprio scritto Scrivere per saper lavorare in equipe. Incontro dopo incontro ogni partecipante impara il valore della grammatica, dello scandaglio interiore e dello scambio di storie. Impara inoltre che se le parole possono determinare un senso, una nuova esperienza sa rinnovare le parole: da una parte si tratta di distillare la vita vissuta perché resti il sapere su/di quella stessa vita e dall altra di aprire scenari insospettati e insospettabili. Non c è niente di dato una volta per tutte perché l esistenza non smette di rinnovarsi. L organizzazione del laboratorio di scrittura Il laboratorio vuole far ricordare attraverso esercizi di scrittura e ogni incontro a cadenza settimanale per periodi variabili a seconda del tipo di gruppo si suddivide in tre momenti: TEMPO DELLA PREPARAZIONE: propongo di volta in volta un argomento capace di avviare le domande cruciali di una narrazione memoriale: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? L intento non è quello di esaurire l argomento, neppure di affrontarlo nella sola chiave psicologica, sociologica o antropologica, piuttosto quello di offrire suggestioni usando esempi letterari racconti, stralci di romanzi, poesie capaci di aggiungere alle parole già scritte quelle ancora da scrivere, di mischiare le proprie parole a quelle di autori ed autrici. In questa fase bisogna vincere i meccanismi difensivi che ciascuno mette in atto per la paura di non essere all altezza del compito, di non avere gli strumenti opportuni per farlo. I brani letterari facilitano la discussione di gruppo, la socializzazione e costituiscono una sorta di pifferaio magico dell immaginazione. TEMPO DELLA SCRITTURA: il tempo della scrittura varia a seconda del tipo di consegna offerta, da un minimo di 7 minuti per esercizi ad elenco di parole fino a un massimo di 20 per quelli che implicano la stesura di un intero brano. La consegna o induttore può essere interpretata a propria discrezione: si può scegliere di raccontare qualcosa che è capitato a se stessi oppure ad altri; di dire l accaduto oppure il sognato; di usare la prima oppure la terza persona: ciò che conta è che la scrittura si muova sull onda di un qualcosa che si ha la voglia, la forza e, finalmente, il tempo di scrivere. Non è facile per nessuno esporsi per la prima volta, in alcune situazioni può essere addirittura avvertito come pericoloso, come accade per esempio in carcere. La rivelazione di pezzi della propria vita dentro lo spazio e il tempo del solo laboratorio di scrittura valevole una sola volta per settimana, è meno compromettente di quella che accade tra detenuti che si vedono tutti i giorni, in alcuni casi 24 ore su 24 in cella, nell ora d aria o nelle diverse attività riabilitative. Quello che si racconta di se stessi, potrebbe essere usato dal pubblico uditore maldestramente e, magari, come arma di provocazione o sbeffeggiamento, se non si è prima conquistata una reciproca fiducia e anche la certezza che ciò che viene scritto e letto in aula, vi rimanga all interno. Nel tempo della scrittura, è obbligatorio il silenzio perché ciascuno possa raccogliersi senza essere disturbato da voci chiacchieranti. 50
54 TEMPO DELLA LETTURA: al termine della scrittura individuale, si leggono ad alta voce i testi scritti anche in questo caso in un clima di attenzione silenziosa. Sono inevitabili i sorrisi, le risatine più o meno sonore a seconda dei passaggi, oppure le lacrime di commozione poiché chi legge può smuovere ricordi assopiti in chi ascolta, addirittura proprio quelli che dovevano rimanere sprofondati nell angolo più buio del dimenticatoio. I testi vengono letti uno dopo l altro. Solo a lettura ultimata, chiedo di dare una restituzione rispetto al tanto ascoltato seguendo una regola precisa: non sono ammesse osservazioni di tipo stilistico o contenutistico, nessuna sottolineatura di eventuali errori sintattici, grammaticali, neppure di cose che avrebbero dovuto essere trattate in modo diverso. Sono invece ben accolte tutte le osservazioni relative, da parte di chi ha letto, alla scelta dell episodio narrato e da parte di chi ha ascoltato alle risonanze suscitate dal racconto. Non si tratta quindi di valutare i testi, piuttosto di condividere quello che hanno saputo risvegliare in ciascuno. Questo confronto sui testi è un momento delicato, ma necessario che alimenta uno spirito di complicità, di affidamento reciproco lungo il percorso che si sta tracciando insieme. TEMPO DELLA CHIUSURA: nella parte conclusiva riprendo gli argomenti trattati all inizio per confrontarli con quanto emerso dai testi: parole-chiave ricorrenti, discrepanze, similitudini. È il momento in cui si riflette su cosa ciascuno ha appreso da quanto è avvenuto durante l incontro, soffermandosi sia sulla fatica di scrivere selezionare il materiale e combinarlo sia su quella di leggere ad alta voce il pudore, il timore, la vergogna; sia sulla necessità di dare un senso alla propria ricerca memoriale. La scrittura e la lettura ad alta voce della propria vita conducono progressivamente ogni partecipante a costruirsi delle meta-competenze, dei riferimenti utili a rielaborare gli accadimenti, a individuare un proprio percorso, unico e insostituibile. Le attività di scrivere di sé e parlare ad altri possono consolidarsi e diventare consuetudine per uomini e donne che non vogliono farsi sorprendere dai vortici del tempo e dalla realtà. L apporto della letteratura Nel laboratorio una parte importante soprattutto nei primi incontri è giocata dall utilizzo della letteratura. Raccontare le trame dei racconti e dei romanzi, leggere delle poesie è cruciale nell attività formativa, perché fornisce esempi concreti, situazioni ben strutturate, minuziose indagini psicologiche e scrupolose dissertazioni speculative, facilmente accessibili a qualsiasi lettore che abbia voglia di confrontarsi e imparare a comprendere le situazioni vissute. Non mi stanco mai di ripetere che per me i libri sono la colazione dell immaginazione come il caffelatte e la brioche lo sono del corpo. I libri raccontano storie in cui ogni protagonista vive un incidente che sconvolge la sua vita e lo costringe a misurarsi con i limiti e le contraddizioni della sua condizione di figlio, marito, genero, padre oppure di figlia, moglie, nuora e madre in un determinato contesto epocale e sociale 4. 4 Adriana Lorenzi, Il gioco degli specchi: intreccio di letture e storie personali, Figure della complessità a cura di Liana Borghi e Clotilde Barbarulli, CUEC, Cagliari, 2004, pagg
55 Queste storie inducono la rilettura della propria vita alla luce di quella libresca: Azar Nafisi costretta a lasciare l Università di Teheran dove insegnava letteratura perché in contrasto con le rigide imposizioni dell ayatollah Khomeini, riunisce a casa sua alcune brillanti studentesse del suo corso per continuare a lavorare sulla letteratura americana e afferma avremmo scoperto come il banale ciottolo della vita quotidiana, se guardato attraverso l occhio magico della letteratura possa trasformarsi in pietra preziosa 5. Confrontare la condizione umana con quella di avvincenti personaggi di carta, dei quali si seguono le avventure, significa accedere ai misteri dell esistenza, alle domande importanti della vita che hanno generato risposte in termini di percorsi esistenziali. I libri offrono possibilità, strade percorribili affinché si esca dall autoflagellazione del capitano tutte a me. La paura e la felicità coabitano in ogni vita sia di carta sia di carne, solo che quella di carta ha un inizio e una fine, ha uno svolgimento che segue cause ed effetti, torti e ragioni. È il suo ordine che aiuta il caos del lettore, è il distacco della lettura di un altra vita che contagia il possibile distacco nei confronti di ciò che accade nella realtà. I libri ci aiutano quindi ad entrare in altri mondi dai quali sarà possibile contemplare il nostro da una visuale insospettata e quindi foriera di nuove, impreviste e imprevedibili, percezioni e comprensioni. Ci spingono a creare realtà alternative rispetto a quelle ben note e magari avviluppanti. La letteratura non è l equivalente di un sonnifero o di una sostanza stupefacente, è piuttosto uno strumento critico per soppesare e capire meglio la vita reale e anche quella dei nostri sogni. È un approdo più puro al fatto e al senso, ossia all accadimento accompagnato dalle percezioni ed emozioni del soggetto che l ha vissuto. Un distillato di sapienza che si dà sempre più raramente negli incontri mondani o lavorativi, familiari o professionali. Le vicende dei personaggi attivano processi di auto-conoscenza e meta-riflessione, poiché insegnano che ogni storia ha una logica stringente: se compare un dettaglio ad apertura della vicenda, ritornerà di nuovo prima della fine. Non esistono elementi casuali, fortuiti. Non è ammessa disattenzione e pressappochismo perché la trama non tollera fili pendenti. La letteratura offre utili attrezzi per una buona ginnastica della mente affinché osservi le situazioni da diversi punti di vista, mentre guida l immaginazione dei partecipanti verso la ricerca di episodi significativi e la loro stesura in uno scritto. Scrivere per raccontare in modo efficace L atmosfera del primo incontro laboratoriale è normalmente molto tesa e chi ha aderito alla proposta si intimorisce nel momento in cui verifica che sarà costretto non soltanto a scrivere in aula, senza rimandare tale operazione allo spazio protetto della propria casa e in una condizione di solitudine, ma anche a leggere ad alta voce il proprio pezzo. L attività di scrittura viene di solito collegata alla dimensione scolastica che per quasi tutti è un lontano ricordo, per alcuni sinonimo di dolorose sconfitte. La condivisa sensazione pruriginosa è che sia più facile parlare che scrivere, o forse, semplicemente, meno 5 Azar Nafisi, Leggendo Lolita a Teheran, Adelphi, Milano, 2004, pag
56 impegnativo e impegnante. In realtà, le parole sia parlate sia scritte chiedono di essere trattate con cautela e rispetto. Le parole danno vita ai racconti che ciascuno fa a se stesso e ad altri per aderire alla realtà, per saggiare l immaginazione: non si racconta soltanto quello che è accaduto, ma quello che si può fantasticare, per esempio guardando un uomo affacciato alla finestra, una donna alla guida di una moto, studenti con i libri aperti sul banco e lo sguardo perso nel vuoto o anche un cane a pancia all aria in attesa di qualche coccola. È la selezione delle parole, la loro combinazione in frasi concatenate le une alle altre a determinare la configurazione o la trama generale del racconto e a produrre un significato. Per facilitare il processo di conoscenza del gruppo, chiedo prima di tutto a ciascuno di raccontare, oralmente, la storia del suo nome, a dimostrazione che anche in poche lettere si stratificano innumerevoli aneddoti. La storia del nome facilita la reciproca conoscenza e stimola anche la reciproca curiosità per cui ciascuno vorrebbe saperne di più dell altro, mentre ci si stupisce dei tanti riferimenti dentro poche sillabe: la tradizione, la religione di appartenenza, l epoca storica e i diversi livelli di accettazione del nome toccato in sorte. Dimostra inoltre quanto le parole offerte, scambiate si facciano impegno a prendersi cura di sé all interno del gruppo e anche degli altri componenti. Se all inizio dell intero percorso laboratoriale la mia parola parlata e i contenuti che propongo, occupano molto spazio, progressivamente questi diminuiscono e aumentano le parole parlate e scritte, i contenuti dei partecipanti. Gli esercizi che sciolgono le giunture rispetto alla scrittura sono quelli ad elenco di parole che mostrano la necessità di selezionare alcune parole e di combinarle in tempi brevi: Ciò che mi piace e ciò che non mi piace Preferisco Le cose belle. Gli esercizi ad elenco, che richiedono per la stesura sette oppure dieci minuti al massimo, riducono l ansia da prestazione, la paura del giudizio degli altri ascoltatori e anche il disagio di non essere all altezza della consegna ricevuta o di incorrere nella stesura della tanto temuta banalità. I successivi esercizi di osservazione e nominazione la descrizione minuziosa di un luogo, di una persona, di un gesto, ma anche delle emozioni provate in situazioni particolari, come per esempio di fronte a una pagina bianca da riempire si propongono invece di aumentare la capacità di osservazione, di attenzione dei dettagli e della scelta accurata delle parole. Scrivere per raggiungere un equilibrio interiore È il passato che traghetta nel presente e anche nel futuro ed è il passato che deve essere indagato per comprendere le leggi, i meccanismi che lo hanno regolato senza rimanerne stritolati, intrappolati: non strapazzati dalla Storia e dalla Geografia, ma dentro la Storia e la Geografia con orecchi ed occhi bene aperti. Non si tratta di un nostalgico amore per il passato, e neppure di una rigorosa operazione archeologica, non è una questione affettiva e neppure scientifica, piuttosto una passione per il restauro, il rammendo, la ristrutturazione, perché i mobili ammaccati possano servire di nuovo, perché i tessuti lacerati o consunti possano offrire nuove fogge e le case diroccate essere abitate in modo ancora confortevole. È il presente che vuole strap- 53
57 pare al passato le sue rivelazioni, quelle pietre che garantiscono al futuro di non essere un castello di carte. Bisogna allora fidarsi del sapere per esperienza che, se viene - si sa - viene dopo, ma va costruito perché non è sempre dato né detto: è necessaria infatti un operazione di distillazione dell esperienza dall evento vissuto, del sapere dalla spirale dei fatti. Il sapere per esperienza è il risultato di una ricerca di comprensione di sé e del mondo. Non è utile ad alcuno rinchiudersi nei sogni di un tempo ormai andato, di vecchie abitudini che sembrano belle solo perché viste da lontano, attraverso la lente appannata del ricordo. Può invece servire il riutilizzo di quello che è stato per comprendere quello che ci sta accadendo oggi e, magari, potrà accaderci nel futuro. La scrittura memoriale è un esplorazione a piccoli passi, poi sempre più lunghi, finché non si acquisisce abbastanza forza per proiettarsi verso nuovi scenari. Duccio Demetrio scrive: C è un momento nella vita in cui si sente il bisogno di raccontarsi in modo diverso dal solito Da quando forse la scrittura si è assunta il compito di raccontare in prima persona quanto si è vissuto e di resistere all oblio della memoria. È una sensazione più ancora che un progetto è ciò che prende il nome di: pensiero autobiografico quell insieme di ricordi della propria vita trascorsa, di ciò che si è stati e si è fatto, è quindi una presenza che da un certo momento in poi accompagna il resto della nostra vita. È una compagnia segreta, meditativa, comunicata agli altri soltanto attraverso sparsi ricordi, a meno che non diventi uno scopo di vita. Soltanto in questo caso, oltre a mutarsi in un progetto narrativo compiuto, a diventare diario retrospettivo, storia di vita e suo romanzo, ridà senso alla vita stessa. Consente a colei o a colui che quasi si sente invadere da questo pensiero, così spiccato e particolare, di sentire che ha vissuto e sta ancora vivendo. Anzi, che la passione avvertita per il proprio passato si trasforma in passione di vita ulteriore 6. Paul Ricoeur, invece, distingue: Fra la memoria come mira e il ricordo come cosa presa di mira. Si dicono la memoria e i ricordi. La memoria è al singolare come capacità e come effettuazione; i ricordi sono al plurale: si hanno dei ricordi. I ricordi possono essere trattati come forme discrete dalle frange più o meno precise, che si stagliano su quello che potrebbe essere chiamato un fondo memoriale, nel quale ci si può cullare negli stati di vaga fantasticheria 7. Gli eventi accadono, hanno luogo e poi passano, la memoria li recupera dopo che sono passati e li rende presenti attraverso la rappresentazione che si avvale dell immaginazione. La ricerca del ricordo è una delle finalità primarie dell atto di memoria e cioè quella di lottare contro l oblio, di strappare alcune briciole di ricordo alla rapacità del tempo, alla sepoltura nell oblio. Per libere associazioni, per collegamenti muti si può richiamare qualcosa alla memoria (Reminding); si può invece conversare e confrontarsi con qualcuno affinché i propri ricordi aiutino l insorgere di quelli altrui, e viceversa, nella ben nota formula del Ti ricordi la volta in cui? (Reminiscing); e infine si può avviare il riconoscimento (Recognizing), ossia la facoltà di riconoscere la presenza di ciò che è assente nello spazio e nel tempo 8. E questo per Ricoeur è una sorta di miracolo, di atto magico: grazie al ricono- 6 Duccio Demetrio, Raccontarsi - L autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995, pagg Paul Ricoeur, La memoria, la storia, l oblio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003, pag Ibidem, pagg
58 scimento si rende presente qualcosa che è assente e anche distante e se ne prende possesso. I ricordi sono personali, ma anche collettivi: La memoria individuale prende possesso di se stessa a partire da una sottile analisi dell esperienza individuale di appartenenza a un gruppo, e sulla base dell insegnamento ricevuto da altri 9. Abbiamo ricordi in quanto membri di un gruppo familiare, professionale, sportivo, amicale, paesano, cittadino. Gli uomini e le donne, che usano le parole per dirsi e per dire la vita, muovono il pensiero e rendono la vita più viva. Ossia i soggetti si risvegliano al loro tempo. Dopo avere presentato il valore di un lavoro memoriale ai partecipanti e quindi conquistare i partecipanti alle ragioni del laboratorio, arriva il momento di far loro sperimentare i risucchi e i piaceri di tale attività. Chiedo allora ai presenti di nominare, oralmente, il primo odore che si affaccia alla loro mente. L odore può essere buono o cattivo: l odore dell erba appena tagliata, della legna che brucia nella stufa, di cagiara (latte acido), di terra bagnata, di Svizzera, di asilo, di bucato, di pane appena cotto, di lasagne, di sugo, di polenta e coniglio, di mandarini a Natale. Il puzzo di benzina, di naftalina, di fognatura. Ancora una volta per ogni odore sarebbe possibile dispiegare una storia come un lenzuolo al sole del tempo più lontano, quando il mondo sembrava arrivare soprattutto attraverso le narici e ci si disponeva ad annusarlo come la punta umida del naso dei cani da caccia. Gli esercizi di scrittura che ruotano attorno alla memoria, cercano di agganciare frammenti del tempo trascorso: ricordi familiari, scolastici, amicali, ricorrenze, luoghi del cuore. Mentre la memoria si disegna sul foglio, chi scrive sperimenta i trabocchetti della memoria, le braccia tentacolari della nostalgia, le cicatrici del dolore, ma anche la piacevolezza, magari un po velata di malinconia, del saltabeccare tra gli episodi per rianimarli, rispolverarli al fine di rimetterli al loro posto nella teca della memoria, oppure di eliminarli e fare spazio. Piano piano ciascuno comprende che la memoria è fatta di cassetti suddivisi per categorie: positività e negatività: ricordi felici oppure tristi individuale e collettivo: ricordi circoscritti al sé oppure a un gruppo allargato antico e recente: ricordi più e meno lontani e più o meno sfumati. Diventa a questo punto necessario introdurre una nuova riflessione: la memoria trattiene ciò che è stato più significativo, ciò che l ha incisa maggiormente. Ed è su questo che il sapere per esperienza viene costruito. Chi ha voglia di lasciare traccia scritta dei suoi ricordi, si lascia spesso scoraggiare dalla mole di lavoro che questo comporta e dal senso di responsabilità di operare la giusta scelta tra quello che è assolutamente da trattenere e ciò che non lo è. Eppure noi non ricordiamo tutto, ma soltanto qualcosa che ha inciso particolarmente la nostra mente, la nostra pelle, il nostro cuore. I fatti si fanno rammemorabili quando rimangono incastonati nella nostra mente, incorniciati come quadri sulle pareti delle nostre stanze interiori. I ricordi più intensi sono per Virginia Woolf momenti di essere 10 che chiedono di essere interpretati e anche capiti attraverso la loro continua ri-narrazione. 9 Ibidem, pag Virginia Woolf, Momenti di essere, La Tartaruga, Milano,
59 Raccontare l evento stra-ordinario significa ripercorrerlo per renderlo, per quanto e per come possibile, domestico, per riparare il colpo che ha inferto alla quotidianità dei giorni. Per momenti di essere, svolte, fratture si intendono tutte quelle situazioni che urtano contro la propria abituale e consolidata percezione, slabbrano i meccanismi di difesa del soggetto e avviano dei cambiamenti. Recuperare questi momenti, riportarli alla luce significa ricostruire per punti la propria autobiografia, individuare lo scheletro della nostra esistenza. Gli esercizi di scrittura, che recuperano alcuni momenti di essere, sviluppano una maggiore autoconsapevolezza e capacità critica: Il ricordo più lontano La volta in cui ho visto/assaggiato/odorato/udito/toccato Una sorpresa Scrivendo, si finisce per scoprire quali eventi sono stati davvero punti nodali nella costruzione della propria vita. Quali possono essere dispiegati e quindi approfonditi, quelli che, invece, possono soltanto essere sfiorati e, infine, quelli da ignorare per non farsi troppo male. Si racconta per stare bene e far stare bene, non per violare segreti. Quando chiedo di individuare alcuni momenti di essere della propria esistenza, di ordinarli in un elenco secondo un criterio peculiare e di dare infine un titolo all elenco, faccio sperimentare concretamente quanto il chi si è dipenda da che cosa è accaduto; quanto il senso della propria esistenza sia strettamente connesso alla trama dei fatti vissuti, ma anche al loro ordinamento. Al termine dell elenco, a ciascuno appare chiaro di avere vergato un indice di una possibile autobiografia. L ordine attribuito agli eventi risponde ai seguenti criteri: cronologico: dall episodio più lontano al più vicino o viceversa kairologico: dal meno intenso a quello più intenso o viceversa tematico: per argomento. Il titolo dato a questo elenco di momenti cruciali non è che il frutto di un operazione di sintesi che potremmo anche chiamare esperienza, l essenza della vita finalmente compresa e decantata grazie alla riflessione e alla riorganizzazione degli episodi. È il senso raggiunto che può essere: 1. esistenziale: Una parte di me La mia vita come cambia, come è cambiata Dove sto andando? In questo caso il soggetto rivela il bisogno di porsi proprio al centro della sua indagine. 2. ermeneutico: Frammenti di vita Così è la vita Risalire dall inferno Niente succede per caso In questo caso, il soggetto è sempre ovviamente in causa, ma in primo piano viene posta l attività interpretativa. Un esercizio di questo tipo educa a disfare la forma già precostituita della propria esistenza. Scovare alcuni ricordi, tralasciandone altri significa ridisegnare in modo diverso ciò che sembra granitico. Per costruire è necessario prima di tutto disfare come facevano un tempo le nonne con i vecchi cappotti o abiti per farne di nuovi, tagliando, aggiustando, ricucendo. Non solo, i partecipanti vengono anche educati a lavorare sulle conseguenze delle proprie azioni e dei propri comportamenti, poiché dare ordine significa comprendere che qualcosa determina altro, che il prima condiziona il dopo e che tutto contribuisce a comporre il disegno della vita. Sono convinta che l attività della scrittura conduca alla formazione di soggetti etici, 56
60 ossia di soggetti che si preoccupano del bene degli altri distanti e diversi. Infatti, chi scrive contempla sempre un destinatario al quale indirizza in maniera più o meno esplicita il proprio prodotto. Scrivere è un utile esercizio non solo per pensare e scendere in profondità negli argomenti affrontati, ma anche per contemplare eventuali lettori e lettrici, comunque altri da sé che fanno uscire dai facili meccanismi di auto-centratura. Si scrive per esprimersi, ma anche per comunicare. Il lavoro di gruppo abitua a rispettare i tempi della propria e altrui scrittura; i tempi della propria e altrui lettura. Ciascuno scrive, legge e ascolta e grazie all attenzione prestata ai racconti condivisi, si impara a variare e migliorare la propria scrittura, per contagio. I partecipanti ascoltano i testi degli altri, attivando un processo di raffronto, ristrutturazione, nonché di assunzione di responsabilità in relazione al proprio vissuto. La scoperta di sé dentro le proprie parole e la visione di orizzonti imprevisti grazie allo scambio collettivo è ciò che contribuisce a creare quella che qualcuno ha chiamato la magia di un laboratorio di scrittura autobiografica e memoriale. Io intendo per magia quel travaso di fiducia nei soggetti capace di attivare trasformazioni e sviluppo di potenzialità. Una volta una partecipante, Sonia, ha definito le donne sedute in cerchio incontro dopo incontro delle cantaoras colombiane: Mi sento ricca ed emozionata perché questo incontro al femminile lo desideravo da tanto tempo e non voglio perderlo più. Stamattina mentre venivo da casa pensavo alle cantaoras de bullerengue 11. Quelle donne della costa atlantica della Colombia che ancora oggi si ritrovano qualche pomeriggio, mentre gli uomini lavorano, e raccontano storie e cantano i dolori e le gioie battendo le mani al ritmo del bullerengue 12, come tramandando nel tempo un ritmo africano 13. Sono i partecipanti che si danno appuntamento settimana dopo settimana per raccontare e raccontarsi a fare la differenza, a dare una forma diversa al tempo per sé e insieme agli altri. La somma delle storie rende preziosi gli incontri laboratoriali dove a ciascuno resta appiccicato addosso qualcosa di tutti. Al termine del laboratorio c è sempre chi scrive un brano che contempla la presenza dei componenti del gruppo. Come ha scritto Virginia: Ho assaporato la meraviglia di iniziare questo stimolante percorso senza sapere come sarei stata alla fine, chi sarei stata e scopro oggi di essermi trasformata, di avere l aura più luminescente e più espansa nell atmosfera, alone impalpabile del quale sono orgogliosamente consapevole. In continua evoluzione rielaboro parole ascoltate, racconti ricevuti dalle altre doni preziosi come oro, incenso e mirra, parole scritte, parole come input, parole solo pensate immaginate, mai nate perché troppo dolorose, incompiute, dimezzate troppo astratte a volte, come gli oracoli, come le profezie. La parola scritta è silenziosa, ma testimone dello scambio fra culture differenti direi elegantemente differenti, si è trasmutata come pietra filosofale in pezzi di storia orale, fatica d esposizione, insicurezza dovuta al fatto di non sapere se effettivamente non si sarebbe state 11 Cantaoras de bullerengue: donne che cantano accompagnandosi con il battito delle mani. 12 Ritmo della costa atlantica della Colombia 13 Amo i ricordi. Laboratorio di scrittura per immigrate e non, a cura di Adriana Lorenzi, Centro Documentazione Donna di Ferrara,
61 giudicate mi hanno inizialmente creato qualche chiusura, mi ha aiutata profondamente l insostituibile vivacità e voglia di donare e ricevere da parte di tutte le amiche del laboratorio, così porterò sempre con me: la magnifica verve ed esuberanza di Christiana, la dolcezza delle parole e degli occhi di Sonia, la travolgente simpatia ed esperienza di Maria Grazia, l estrema forza e sensibilità di Silvia, la chiarezza e giocosità dello sguardo di Anita, la profondità e naturalezza di Maria Elisa, l affascinante ironia e i colori di Samira, l iniziale timidezza poi sbocciata in ricco significato di Simona, la voce evocativa e le parole decise di Barbara, l incantevole, sapiente e magico pensiero di Alessandra, la bontà d animo e gentilezza di Anna e la sua Polonia. 14 Tutte le donne sono ricordate, sono presenti, ciascuna con il suo nome, con la sua unicità, con il tanto offerto, non mischiate, piuttosto accostate l una all altra. All interno di un laboratorio di scrittura si impara a rompere la superficie delle cose, ad esprimersi bene, parlando di sé insieme ad altri. Scrivendo non ci si limita a disseppellire il tempo trascorso, ma si azzardano ipotesi; non si radiografa il passato, piuttosto se ne traccia la sua anamnesi che, come sottolinea Iris Murdoch, non è che la memoria di quello che non sapevamo di sapere 15. Ciascuno scrive e scopre, testimonia e stupisce con i collegamenti raggiunti, mentre non fa che cartografare la sua esperienza laddove la vita era stata scompaginata dalle irruzioni del destino o della piccola e grande Storia. 14 Ibidem, pp Iris Murdoch, Esistenzialisti e mistici, Il Saggiatore, Milano,
62 NARRARE L ESPERIENZA NEI CONTESTI FORMATIVI Il Laboratorio di scrittura nel carcere di Rebibbia: una esperienza esportabile anche nelle scuole? di Luciana Scarcia, insegnante, conduce laboratori di scrittura a Rebibbia Il fondamento narrativo della didattica Il modello culturale che negli ultimi decenni ha influenzato le migliori pratiche didattiche nelle nostre scuole attinge a una concezione costruzionista dell apprendimento: questo non può restringersi a procedure formalizzate e standardizzate in quanto è un processo di costruzione di senso, che richiede di essere riconosciuto attraverso la parola; il luogo in cui tale processo si sviluppa è uno spazio in cui i soggetti si confrontano e agiscono per dare significato a eventi, dati e concetti che necessitano di un elaborazione collettiva. Da questo modello derivano le cosiddette metodologie qualitative, tra cui si situa il paradigma narrativo: attraverso le pratiche discorsive, la scrittura, il racconto, il soggetto è in grado di trasformare l esperienza dell apprendimento, per lo più tacita, preriflessiva, localizzata nel contesto in cui si sviluppa, in conoscenza esplicita; e attraverso l interazione con gli altri mediata dalle narrazioni si promuove l autoriflessività e la capacità di trasformazione. L attenzione all esperienza obbliga il formatore a confrontarsi con il soggetto, con i suoi valori, le sue motivazioni, quindi con la sua storia. Per questi motivi la narrazione è da considerare non una modalità particolare usata in un campo specifico dell insegnamento (un settore del programma d italiano), bensì una componente fondamentale dell azione didattica. Anche quando l insegnante trasmette conoscenze riferite alla matematica, non tratta solo formule e procedimenti, ma accompagna la spiegazione con esemplificazioni, aneddoti, storie delle persone (di scienziati e matematici) e di come sono state compiute le scoperte, fa ricorso a metafore e figure non appartenenti ai confini della disciplina. Sa, inoltre, che anche la più oggettiva delle conoscenze, a scuola, viene legittimata come sapere dotato di senso ed elaborata in maniera personale dall alunno solo se la qualità della relazione educativa e le attitudini di buon narratore aiutano quella conoscenza ad affermarsi come tale e a farsi accettare. Invece fa notare Bruner 1 se riflettiamo sull usuale funzionamento della scuola, ci rendiamo conto che privilegiamo l insegnamento del metodo logico-sequenziale (ad esempio ci occupiamo molto di verifiche standardizzate), mentre viviamo la maggior parte della nostra vita in un mondo costruito secondo le regole della narrativa. Insomma, una maggiore consapevolezza di ciò e del fondamento narrativo della didattica 1 J. Bruner, La cultura dell educazione, Feltrinelli, Milano, p
63 può essere utile per migliorare l insegnamento, anche quello del metodo scientifico, perché esalta la soggettività dell insegnante e dell allievo nel contesto dell esperienza dell insegnamento-apprendimento. Le funzioni della narrazione Fattore di costruzione dell identità La narrazione è lo strumento principale di cui ci serviamo nelle relazioni quotidiane con i nostri simili per definire e costruire la nostra identità. Scrive Hannah Arendt: Possiamo sapere chi qualcuno è o fu solo conoscendo la storia di cui egli stesso è l eroe la sua biografia, in altre parole; qualsiasi altra cosa sappiamo di lui, compresa l opera che può aver lasciato o prodotto, ci dice solo che cosa egli è o fu. E ancora, in un altra opera: Ulisse (che dopo il naufragio viene accolto, non nella sua vera identità, nella reggia del re Alcinoo dove un aedo canta i fatti della guerra che lo avevano visto protagonista) non aveva mai pianto prima, certo non quando i fatti che ora sente narrare erano realmente accaduti. Soltanto ascoltando il racconto egli acquista piena nozione del loro significato (e solo dopo aver ascoltato il racconto dell aedo svela a Nausicaa la sua identità). 2 Dunque la propria identità (il chi si è, cosa diversa dal che cosa si è ) e il significato della nostra vita possono essere compresi non nel momento dell azione ma solo dopo, attraverso la narrazione e, ancor di più, attraverso la narrazione di un altro. La nostra vita è fatta di storie potenziali che, una volta raccontate, ci restituiscono un pezzo della nostra identità personale e ce ne rendono responsabili; cioè nel momento in cui la storia potenziale diventa effettiva siamo indotti ad assumerci la responsabilità di ciò che siamo e che si palesa nel racconto. Dimensione etica della narrazione I racconti hanno un valore educativo perché, nell interpretare l esperienza vissuta, offrono elementi di riflessione, assegnano un primato alla ricerca di un significato per la vita e dell attenzione verso gli altri, illustrano nuove possibilità per le azioni e i sentimenti dell uomo. Poiché presuppongono l assunzione di una posizione morale, in quanto si occupano di come i protagonisti interpretano le cose e del significato che vi attribuiscono, essi hanno uno statuto morale. Raccontare l esperienza e farne una storia implica la scelta di ciò che è più importante e il giudizio su ciò che è giusto o sbagliato; per questo è anche un esercizio di preparazione alla vita. Questa funzione educativa della scrittura viene messa a fuoco da Susan Sontag, che individua nella narrativa un modello di completezza e finitezza e di illuminazione del senso delle cose: 2 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, 2005, pag. 136 (prima citazione) e La vita della mente, Il Mulino, Bologna, 1978, pag. 221 (seconda citazione) 60
64 Raccontare una storia vuol dire: è questa la storia importante. Vuol dire ridurre l estensione e la simultaneità del tutto a qualcosa di lineare, a un tragitto. Essere un tipo morale significa prestare, essere obbligato a prestare, un certo tipo di attenzione. Quando esprimiamo giudizi morali, non stiamo semplicemente affermando che una cosa è migliore di un altra. Stiamo affermando che una cosa è più importante di un altra. Ordiniamo la vertiginosa estensione e simultaneità del tutto. [ ] forse il primo passo verso la saggezza e l umiltà sta nel rassegnarsi all idea, la devastante idea, della simultaneità di ogni cosa, e della incapacità della nostra comprensione morale che è anche del romanziere di assimilarla. I romanzieri, dunque, assolvono a un necessario compito etico sulla base di un diritto a un pattuito restringimento del mondo reale sia in termini di spazio che di tempo. 3 Nell antica Grecia prima della nascita della filosofia l idea di giustizia non era ancora formulata in norme, ma era espressa nel contenuto dei racconti offerti dal teatro tragico. Antigone, che rifiuta di obbedire alla legge relativa di Creonte in nome di un senso della giustizia assoluto (che prevedeva il rispetto dei morti), continua ancora oggi a dirci qualcosa di importante perché il genio di Sofocle ne ha saputo fare una combinazione di bellezza e giustizia. Per i Greci estetica e etica non potevano essere separate: il bello e il buono erano due diverse facce della stessa qualità (la kalokagathìa), cioè dello stesso bisogno di elevarsi. Oltre ai racconti più antichi (miti, Bibbia, epica, tragedie greche), tutta la grande letteratura, quella che resta nel tempo Dante, Shakespeare, Cervantes contiene una visione etica del mondo e può insegnare qualcosa proprio perché è bella, ci emoziona. Chi racconta rappresenta le azioni umane con il loro carico di ambiguità e perplessità che deve essere risolto, perciò gli è impossibile una neutralità etica. Chi insegna quando non voglia restringere la sua azione alle tecniche dell istruzione deve fare delle scelte, che rimandano a una dimensione etica non necessariamente esplicita, ma che accompagna un idea di creatività intesa come attitudine a ricercare le forme espressive personali e originali per rappresentare situazioni insolite, con conflitti da sciogliere. Dispositivo per strutturare l esperienza Mentre il metodo scientifico si occupa di trovare la verità e spiegare leggi, le storie sono mezzi di comprensione della realtà; come è impossibile scrive Bruner 4 distinguere tra il danzatore e la danza, così l esperienza delle cose umane tende ad assumere la forma delle narrazioni che usiamo per parlarne. Esiste una sorta di attitudine o predisposizione a organizzare l esperienza in forma narrativa, in strutture di intrecci, attraverso i quali si costruiscono i significati degli eventi. Ma nel raccontare noi ci serviamo degli strumenti e prodotti culturali a disposizione delle nostre società. Le culture mettono in moto dei meccanismi-protesi che ci rendono possibile trascendere i limiti biologici; sono esse a plasmare la vita e la mente dell uomo, a dare significato e indirizzo all azione inserendo gli stati intenzionali profondi in un sistema interpretativo. La narrativa apre ai dilemmi e alla vasta gamma di mondi possibili, mette al congiuntivo, cioè fa sì che l ovvio sia 3 S. Sontag, Nello stesso tempo. Saggi di letteratura e politica, Mondadori, Milano, 2007, pp Cfr. J Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp ; J. B., La mente a più dimensioni, Laterza, Bari, 1988, pp ; J. B., La cultura dell educazione, Feltrinelli, Milano, 1997, pp e pp
65 meno ovvio, l inconoscibile meno inconoscibile e i problemi di valore più accessibili alla ragione e all intuizione. I copioni e le trame della narrativa offrono gli schemi con cui interpretare le azioni, rintracciandovi intenzioni, motivazioni, sentimenti (quante volte ci capita di dire: sembrava di stare in un film ). Ciò che fa scattare l esigenza del racconto è il discostamento degli eventi dalla loro canonicità, dalla loro ordinarietà: cioè, quando ci si presenta qualcosa di inatteso siamo indotti a valutarlo alla luce di un punto di vista per attribuirgli un significato. È in quel momento che avvertiamo l esigenza di strumenti interpretativi e attingiamo al patrimonio culturale. La scrittura di sé nei percorsi formativi Riprendendo il filo di ragionamento esposto sopra, si è detto che l apprendimento è concepito come esperienza basata su un processo di costruzione di significati e la narrazione è la forma per dar senso all esperienza; quindi l uso di pratiche discorsive e racconti, che responsabilizzino il soggetto nel corso dell esperienza, diventa un metodo formativo che può davvero rendere più efficace ogni percorso educativo (a scuola, in carcere e altrove). Va da sé che la scrittura è la tecnologia privilegiata di tale metodo, da usare come pratica continua di riflessione ed elaborazione dell esperienza. L esperienza è come un iceberg: dietro la realtà visibile di azioni e comportamenti c è una realtà invisibile molto più ampia, fatta di bisogni, desideri, paure, affetti, ambivalenze, dinamiche di relazione, che determina le motivazioni, ed è questa realtà che va esplorata per capire quella visibile, attraverso la forma della narrazione e la pratica della scrittura. La scrittura narrativa diventa così lo strumento di un percorso di ricerca, di un processo di conquista di consapevolezza che nel suo farsi individuale si avvale del confronto con altri punti di vista. In questa ottica la scrittura di sé è autoformazione, sia per degli individui in crescita che per gli adulti. In particolare, per soggetti svantaggiati come coloro che si trovano in carcere o adolescenti a rischio essa è opportunità di empowerment perché, essendo un modo per riappropriarsi dell esperienza, ricostruisce, rimembra una materia smembrata, fa riflettere sui gesti del quotidiano, sulla loro normalità ed eccezionalità e, per questa via, fa individuare tracce di trasformazioni avvenute e indizi di trasformazione in divenire, offre cioè la possibilità di una migliore capacità di interpretazione del vissuto e (per chi vuole e può) di una rinnovata progettualità 5. Il Laboratorio di scrittura nel carcere di Rebibbia: un esperienza esportabile? L esperienza del Laboratorio di scrittura che da 6 anni tengo nel carcere di Rebibbia (prima come insegnante di un CTP e poi come volontaria) è un tentativo di uso della narrazione, in particolare della narrazione autobiografica, a scopo formativo. (Per un informazione sui temi trattati in questi anni si vedano le schede qui di seguito riportate). Ovviamente si tratta di un esperienza particolare con adulti particolari, eppure penso che 5 D. Fabbri, Narrare il conoscere. Appunti per una epistemologia della formazione, in Kaneklin, Scaratti, Formazione e narrazione, Cortina, Milano 1998, pag
66 il tipo di impostazione data e il lavoro svolto, al di là della qualità dei risultati, possano interessare anche degli insegnanti di scuola secondaria (le due istituzioni: scuola e carcere, non hanno forse entrambe una comune vocazione educativa prevista dalla Costituzione?). Cercherò quindi di riportare il metodo seguito nel Laboratorio, su cui mi piacerebbe un confronto con i docenti delle scuole. 1. Scelta del tema Ogni corso segue un filo tematico. La scelta del tema richiede del tempo perché deve trattarsi di un argomento che possa tenere l interesse (loro e mio) per un periodo abbastanza lungo (volendo anche 8 mesi) e si possa articolare in una struttura modulare (3 o più moduli, legati dal comune filo tematico, ma con una relativa autonomia). È un tema sufficientemente ampio da offrire piste di riflessione e ricerca varie e ricche, da scegliere in corso d opera? È capace di stimolare delle riflessioni sulle questioni importanti della vita? Una volta fatta la scelta del campo tematico, cerco di individuare due o più titoli e immagino come organizzare il lavoro; ne discuto con loro, fino a quando non si arriva a una formulazione definita del tema. 2. Come nascono i racconti Si cominciano a leggere i testi letterari (possibilmente racconti, e, se si tratta di romanzi, ne leggo delle parti selezionate riassumendo via via la trama), si vedono film o parti salienti di essi. Oltre ad analizzare trame e strutture della narrazione (come vengono presentati azioni, eventi, personaggi, i perché delle scelte dell autore, voce narrante, prospettiva ), si discute sugli spunti di riflessione che il materiale scelto offre. In questa prima fase di ricerca chiedo ai corsisti di scrivere su un taccuino degli appunti: annotazioni, intuizioni, associazioni, immagini Il momento in cui cominciare a scrivere lo decide ognuno liberamente; io posso dare tracce, spunti, ma non è detto che quelli si trasformino in racconti. Ognuno si affida alla sua ispirazione, sceglie la sua trama, qualcuno ne discute prima con me. Quando mi viene consegnata una prima stesura la leggo limitando le osservazioni alla correttezza linguistica e alla segnalazione di eventuali punti non chiari; quindi restituisco il testo al suo autore che provvederà alla revisione. Quando egli ritiene che il suo testo sia pronto per la discussione, ne viene data una copia a ciascun corsista perché lo legga e possa farsene un idea; quindi si dedica l incontro successivo alla sua analisi (non più di uno a incontro). 3. Il procedimento di analisi e la discussione Volendo collocare il nostro modo di lavorare in una cornice teorica definirei decostruzionista l approccio scelto: nessuna storia è ideologicamente neutrale, ogni storia presuppone e legittima una particolare visione del mondo, un punto di vista, un interpretazione alla luce di valori e credenze: sono tali sguardi soggettivi che è utile far emergere attraverso ciò che si racconta, dando voce a ciò che viene detto tra le righe e a volte smascherando quanto viene presentato come autoevidente, ovvio e che invece merita una traduzione consapevole in parola. Per esempio, in un testo in cui si raccontava una rissa 63
67 conclusasi con una morte c era un punto in cui l autore la sintetizzava con l espressione una cazzata giovanile ; tale espressione, a cui l autore non aveva dato peso, rivelava invece un atteggiamento troppo disinvolto verso un fatto così grave e richiedeva l esplicitazione di un giudizio morale. Oppure capita di cogliere un certo compiacimento nella descrizione di comportamenti illeciti, che, certo, non è coerente con la dichiarazione che si sono prese le distanze dal vecchio modello di vita, e anche su questo vale la pena di riflettere. Va da sé che tale tipo di analisi non può limitarsi agli aspetti di contenuto e testuali che cosa (azioni/eventi, nessi causali) il testo racconta e come (struttura testuale e linguaggio) lo racconta, ma deve concentrarsi anche sul contesto, inteso come complesso di relazioni e situazioni da cui la storia ha luogo perché (elementi extra-testuali) il narratore sviluppa la storia in quel determinato modo. Occuparsi di contesto significa assumere un orientamento ermeneutico, volto a indagare proprio le relazioni tra ciò che viene detto e ciò che non viene detto (contesto). Lo schema implicito che seguo nell analizzare un racconto e nel discuterlo nel gruppo è il seguente: Impressione globale sul testo Voce narrante. Prospettiva Divisione in sequenze, indicazione sintetica del contenuto; idea o emozione prevalente e confronto con l intenzione dell autore. Eventualmente indicazione di carenze nella composizione della sequenza Lessico: parole significative Segnalazione di frasi che mi sembra nascondano altro da dire; di omissioni e del loro significato. Per guidare a una valutazione, orientare ai fini di una riscrittura e sollecitare la discussione tengo presenti le seguenti domande guida 6 : Il testo dà conto di ciò che l autore vuole dire? Le parole nominano la realtà in modo significativo? Il testo somiglia a chi lo ha prodotto: ha sufficienti tracce della sua individualità, unicità e dell unicità della sua esperienza? (domanda delicata, che evito di fare in modo diretto). Questo tipo di lavoro viene condotto collettivamente e, quando si è imboccata la strada giusta dell ascolto reciproco, i contributi di analisi che vengono dal gruppo a volte sorprendono per la lucidità; attraverso la discussione del testo preso in esame si arrivano a toccare temi profondi riguardanti la vita e l uomo. In quei momenti si è tutti in gioco, scompaiono i ruoli di docente, educatore, detenuto, per lasciare spazio alle persone con le loro contraddizioni, dubbi e bisogni. Il mio ruolo è quello di riportare la discussione nel binario centrale dell attività, puntualizzando, riprendendo e coordinando le diverse 6 Per queste domande ho fatto riferimento a un saggio di Loretta Merenda, La relazione di gruppo nel Laboratorio di Scrittura, sul lavoro svolto in alcuni Laboratori di Scrittura frequentati da utenti adulti e attivati dal gruppo Centotrencentoscritture, (con cui lavora anche Adriana Lorenzi), istituito dalla Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna, che segue la metodologia di E. Bing. Il saggio si trova in: D. Demetrio (a cura di), Per una pedagogia e didattica della scrittura, Unicopli, Milano, 2007, pp
68 osservazioni, in modo che ciascuno rispetti tempi e tema. E quando le cose funzionano l effetto sulla capacità di revisione o riscrittura dell autore di turno è molto positivo. 4. La stesura definitiva Dopo la discussione l autore ritorna sul suo testo e, a quel punto, è lui che decide la stesura definitiva; può capitare che io faccia ancora qualche osservazione, ma il lavoro è sostanzialmente finito, anche se capita spesso che ci sia qualche ripensamento successivo. Alla fine di tutto il lavoro, faccio una proposta di organizzazione dei loro testi in un indice, e ovviamente se ne discute. Volendo individuare dei criteri metodologici generalizzabili, direi che la prima cosa è trattare le storie scritte dai detenuti come prodotti narrativi, sganciati dal loro autore presente in carne e ossa, con una loro struttura, una trama, dei personaggi con precisi ruoli e un senso generale; rintracciando in quella storia personale gli elementi universali e aiutando, per quanto possibile, il narratore a cercare significati via via più profondi. Il secondo elemento riguarda la valutazione di tali testi: il criterio principale che seguo non è tanto il rispetto della verità storica nel narrare l esperienza si assume necessariamente un punto di vista, le vicende che raccontiamo sono intrise di valori, esprimono delle scelte, e per mettere a fuoco un aspetto problematico o doloroso si può anche ricorrere all invenzione, ma piuttosto l autenticità nel raccontare, vale a dire quanto una storia è degna di fiducia 7, quanto cioè chi scrive riesce ad accettare il proprio sguardo critico e quello degli altri anche sui propri vissuti più tormentosi. Un indicatore fondamentale è, quindi, la coerenza interna, che segnala quel senso di sequenzialità e direzionalità che dovrebbe emergere dal modo in cui si mettono in connessione le vicende della vita attribuendo loro un significato. Per questo l incongruenza o l omissione possono diventare degli indizi di una più profonda incoerenza nella vita psichica. Un altro indicatore della qualità della scrittura è la persuasione: il racconto è convincente e persuasivo? fa vibrare una corda in chi legge? è stimolante, intrigante? Questo indicatore è meno importante del primo, perché riguarda la sensibilità del lettore allo stile o ai fatti narrati e perché nella narrazione in carcere come nella narrazione autobiografica in generale la regola fondamentale è che l ultima parola spetta al narratore: è lui che decide il senso del testo, come le sue parti si integrano e se è una storia valida. In ogni caso, per quanto la qualità della scrittura sia un obiettivo da tenere sempre presente, quello che mi sembra abbia un valore di per sé, in quanto altamente formativo per tutti, è l attività di discussione e analisi che si sviluppa a partire dalle storie narrate. SCHEDE: ITINERARI DI LETTURA E SCRITTURA Con l idea di offrire un materiale di lavoro utile ai docenti che lavorano sulla scrittura nelle scuole, ho sintetizzato nelle schede che seguono i percorsi tematici svolti nel Laboratorio di lettura e scrittura di Rebibbia N. C. nel corso degli ultimi 6 anni. 7 R. Atkinson, L intervista narrativa. Raccontare la storia di sé nella ricerca formativa, organizzativa e sociale, R. Cortina, Milano, 2002, pp
69 FILO TEMATICO: L attesa Sull uso del tempo si gioca la partita della vita, una partita a cui tutti partecipiamo e, anche se a volte (come in carcere) viene momentaneamente sospesa, non cessa mai; dunque vale la pena di giocarla stabilendo almeno in parte le regole. Riflettere sulle regole del gioco, magari scrivendo, è un modo per riappropriarsi del tempo e della vita. Percorso culturale: Attesa di futuro, sospensione della vita, distacco, riflessione: modi diversi di pensare all esistenza. Breve racconto di D. Buzzati, Conigli sotto la neve Film di V. Zurlini, Il deserto dei tartari (tratto dall omonimo romanzo di Buzzati) Racconto di J. L. Borges, L attesa Racconto di F. Kafka, Davanti alla legge Brani dal romanzo di Th. Mann, La montagna incantata Brani dal testo autobiografico di O. Wilde, De Profundis Poesia di J. Prévert, L attesa Film di D. Leconte, L amore che non muore Racconto di H. James, La belva nella giungla Brani dal testo di V. Hugo, L ultimo giorno di un condannato a morte FILO TEMATICO: Il viaggio Il tema del viaggio si presta a ricordare che la vita è mutamento continuo e che anche nelle situazioni più chiuse vale la pena di cercare un altro punto di vista dal quale guardare alla realtà. Metafora della vita dei suoi limiti di inizio e di fine, della sua aspirazione a superare quei limiti, il viaggio è anche un serbatoio di simboli cui attingere per darle espressione. Il metodo seguito è stato quello di servirsi delle lettere dell alfabeto per costruire una sorta di dizionario ragionato dell immaginario sul viaggio; a partire dall Alfabeto del viaggio sono stati scritti testi di diversa tipologia: racconti autobiografici, descrizioni del carcere, lettere, scherzi Percorso culturale: Il mito di Ulisse: Odissea / Canto XXVI de La Divina Commedia. Inferno / Poesia di C. Kavafis, Itaca / Poesia di G. Pascoli, L ultimo viaggio (Poemi conviviali) / Racconto di A. Tabucchi, Lettera di Calipso / Film di S. Kubrick, 2001: Odissea nello spazio Viaggio come liberazione: La figura di Don Chisciotte: brani dall opera di M. Cervantes / Poesia di N. Hikmet / Canzone di F. Guccini. Come esempio problematico di un viaggio di liberazione il film di L. von Trier, Dogville. Viaggio tra affermazione dell individuo ed evasione: La figura di Robinson Crusoe: brani dall opera di D. Defoe e il racconto di C. Tournier, La fine di Robinson / Poesia di C. Baudelaire, Il viaggio / Novella di L. Pirandello, Il treno ha fischiato. 66
70 Inquietudine e isolamento: il viaggio senza carica positiva: Brani dal romanzo di J. Conrad, Cuore di tenebra / Brani dal romanzo di F. Céline, Il viaggio al termine della notte / Brani dal romanzo di J. Kerouac, Sulla strada. FILO TEMATICO: Luoghi e identità Originari o scelti o incontrati per caso, i luoghi aiutano a capirci e definirci. In virtù della loro concretezza e fisicità, impongono alla memoria lo sforzo di ancorare il ricordo, quello che è restato nella mente di un pezzo di vita, all oggettività del luogo reale. I luoghi hanno un anima, una loro interiorità, che viene restituita da chi ricorda. Ma attraverso i luoghi e i loro cambiamenti si possono cogliere i segni dei tempi e le ragioni e gli effetti dei nostri cambiamenti. Percorso culturale (biennale) Luoghi, radici, cambiamenti: Ginzburg, Ritratto di un amico (da Le piccole virtù) / Incipit del romanzo di F. Süsskind, Profumo / Racconto di P. Lanzetta, Sotto il sole di Torregaveta (da Una vita postdatata) / Brani dal romanzo di P. P. Pasolini, Una vita violenta / P. P. Pasolini, La prima lezione me l ha data una tenda (da Lettere luterane) / Racconto di A. Kristof, La casa / Film di E. Scola, La famiglia / Film di E. Scola, Ballando ballando / Canzoni: P. Conte, Genova per noi; P. Daniele, Napule è; A. Celentano, Il ragazzo della via Gluck. Luoghi, destini, scelte: Racconto di K. Blixen, Il campo del dolore / Racconto di J. L. Borges, Biografia di T. Isidoro Cruz / Brani dal romanzo di G. Bufalino, Le menzogne della notte / Film di P. Haggins, Crash / Canzoni: L. Dalla, Caruso; C. Baglioni, Poster. Luoghi che negano. Luoghi che rivelano: Racconto di V. Cerami, Il tempo perduto / Racconto di J. Joyce, Eveline / Racconto di A. M. Ortese, Interno familiare (da Il mare non bagna Napoli) / Film di F. Fellini, Amarcord / Film di G. Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso / Brani dal romanzo di E. Morante, Aracoeli / Canzone di F. De Andrè, Via del Campo. Chi o che cosa siamo? Il mito di Edipo / Brani dal romanzo di J. Saramago, Cecità / Brani dal romanzo di A. Camus, La peste / Brani dal romanzo di L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal / Selezione da I. Calvino, Le città invisibili. (Per il docente: H. Arendt, Vita activa. La condizione umana / Z. Bauman, Intervista sull identità / J. Hilman, Il codice dell anima) FILO TEMATICO: Percorsi al bivio Un attimo e ti cambia la vita Riflettere su quell intreccio di scelta e casualità, di condizionamento e cambiamento che caratterizza l esistenza di tutti consente di ripensare alla propria vita. Tutto cambia continuamente, spesso in modo imprevedibile per effetto di eventi inattesi che ci colgono impreparati e ci rivelano quanto la vita sia instabile. Ma è proprio vero che ci si trova 67
71 in situazioni tanto inaspettate che non si può far altro che subire? Ci si può attrezzare al cambiamento? In che rapporto sono il caso e la responsabilità? Percorso culturale: Il mito di Edipo Conversione di Paolo, Nuovo Testamento Brani dal romanzo di J. Marìas, Domani nella battaglia pensa a me Brani dal romanzo di I. Calvino, Se una notte d inverno un viaggiatore Film di F. G. Iñarritu, Babel Film di T. Tykwer, Lola corre Brani dal romanzo di N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via Brani dal romanzo di P. Auster, Il libro delle illusioni Brani dal romanzo di S. Veronesi, Caos calmo Canzoni: V. Rossi, Sally; Manà, En el muelle de San Blas; I. Grandi, Prima di partire per un lungo viaggio. FILO TEMATICO: Umano Disumano È un percorso di ricerca sull essere umano e il male. Cosa significa umano? Quando si diventa disumani? Che cosa regola il nostro esercizio di umanità: la legge? un sentimento etico innato? i principi religiosi? Un azione disumana è irrimediabile? La frase del drammaturgo latino Publio Terenzio Afro Sono un uomo e nulla di ciò che è umano io trovo mi sia estraneo fa riflettere sul miscuglio di bene e male, di grandezza e meschinità che è l uomo. L umanità come i diritti umani non è innata ma una dignità da conquistare. Dignità dolorosa, che si conquista al prezzo di molte lacrime (Vercors). Percorso culturale: Colpa ed espiazione per il male compiuto Miti greci: Edipo; Prometeo; Sisifo (visto da A. Camus) / Dall Antico Testamento: La cacciata di Adamo ed Eva; Caino e Abele / Film di R. Polansky, Machbeth / Brani dal romanzo di F. Dostoevskij, Delitto e castigo / Brani dal romanzo di O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Il fine giustifica i mezzi? Brani dal romanzo di J. Littell, Le benevole / Brani dal romanzo di E. Bunker, Animal factory / Film di S. Kubrick, Arancia meccanica / Racconto di F. Kafka, La tana / Brani dal romanzo di J. Saramago, Cecità / Brani dal romanzo di C. McCarthy, La strada. Rancore, vendetta, perdono Brani dal romanzo di M. Carlotto, L oscura immensità della notte / Brani dal romanzo di J. M. Coetzee, Aspettando i barbari / Testo di Thich Nhat Hanh (monaco buddista), Libero ovunque tu sia / Film di R. Plà, La zona. (Per il docente: H. Arendt, La banalità del male; K. Jaspers, La questione della colpa; F. Stella, La giustizia e le ingiustizie) 68
72 Un curioso esempio di scrittura autobiografica LA GALERA RACCONTATA ATTRAVERSO UN DENTE di Elton Kalica Ieri ero andato ai passeggi, ma ci sono rimasto poco perché mi ha chiamato il dentista, finalmente, e mi ha rimesso apposto l otturazione. È strano ma, mentre il dentista stava lavorando (devo confessare che ha fatto il suo lavoro con professionalità: forse li merita, i duecento euro che mi ha chiesto) mi è ritornata in mente la prima volta che sono andato da un dentista, e ho ripassato mentalmente tutta la storia di questo dente, ho rivissuto tutti i momenti in cui ha attirato la mia attenzione, spesso con terribile violenza, a volte soltanto con un continuo, leggero fastidio. E allora voglio raccontare tutti i problemi che questo dente mi ha dato. Nella mia scuola, a Tirana, c era un ambulatorio dentistico. In realtà, era stata divisa un aula in due parti ricavando uno spazio per il dentista e un altro per il magazzino dove si tenevano le stoffe, le forbici, la cucitrice, i ferri da stiro e tutto ciò che serviva per l ora dell educazione domestica. Tutte le scuole medie avevano l ambulatorio odontoiatrico, ma vi era una sola dottoressa che faceva il giro da una scuola all altra. La scuola in cui andavo io teneva insieme elementari e medie, e aveva circa 450 alunni. La visita odontoiatrica era obbligatoria, nel senso che la dottoressa monitorava continuamente gli alunni chiamandoli periodicamente. L idea che qualcuno mi infilasse le mani in bocca mi aveva sempre spaventato, e non gradivo per nulla queste visite: una volta sono anche scappato, ma poi mio padre mi aveva ricordato che senza denti non avrei più potuto mangiare le frittelle di mia nonna, e questo era stato sufficiente per convincermi che, a prendersi cura dei propri denti, si fa un buon affare. In una di queste visite di routine avevamo appena ripreso le lezioni dopo il ponte del primo maggio, era il 1990 e io stavo finendo ormai la terza media la dottoressa interruppe di colpo il suo controllo guardando in alto a sinistra della mia cavità orale, al terzo molare, e mi disse: Ecco una piccola carie! Ah! Ah! sei andato a dormire senza lavarti i denti!. Volevo risponderle che non era assolutamente vero, ma avevo la bocca spalancata e le sue dita che continuavano a curiosare dentro. Quando lei fece funzionare il trapano, pensai di morire, e ricordo di aver stretto il bracciolo della poltroncina con tutta la mia forza, e chiuso gli occhi. In quei momenti però forse il morale alto che avevo dopo aver respirato per una settimana l aria libera dei giorni di festa mi aveva ubriacato ho pensato che comunque quello era un buon allenamento per un giovane pioniere e, se fossi stato preso da qualche nemico invasore e torturato, avrei potuto utilizzare la stessa tecnica per resistere: ma dopo appena sette anni, in Italia, avrei scoperto che quando, per esempio, ti arrestano e ti capita magari di essere ammanettato, portato nel cesso della caserma e appeso per i polsi al tubo della doccia come un prosciutto, non hai niente da stringere se non i tuoi pugni. Poi la dottoressa finì presto per trapanare il dente e, riempiendolo di un impasto bianco, disse: Ora è salvo! L abbiamo preso giusto in tempo. 69
73 Nell aprile del 1998, mentre venivo trasferito dal carcere di Monza a quello di Opera in seguito ad una protesta a cui avevo preso attivamente parte, fui colpito da un tremendo dolore a quello stesso dente curato otto anni prima in terza media. Una volta sistemato in una cella del nuovo carcere comunicai al personale medico il mio problema, e mi misero in lista di attesa. Fui chiamato dopo un mese. Il dolore ormai era svanito, anche se mi era rimasto un leggero ma costante disturbo, come se volesse ricordarmi il posto esatto da dove proveniva ogni tanto tutto quel dolore. Il dentista guardò accuratamente tutti i denti e mi disse che era tutto a posto e che non vi erano carie in giro. Io insistei indicando meglio il dente, ma niente, il medico ribadì il suo precedente responso. Nell agosto del 1999 fui trasferito nel carcere di Padova, e mentre scendevo dal furgone blindato il mal di denti ritornò con la stessa violenza dell anno precedente. Fu inevitabile cominciare a sospettare che ci fosse un qualche legame tra i viaggi di trasferimento in quelle celle buie, strette, dalla puzza e dal caldo soffocante, dei furgoni blindati e il mal di denti. Mi domandavo anzi se il dente stesso non avesse memoria e mi volesse mettere alla prova per vedere se ero in grado di stringere di nuovo i pugni e resistere come da ragazzino, ma poi decisi che era meglio rimanere immune dalle superstizioni e chiesi di nuovo ai medici di essere visto da un dentista. Presto però mi fu spiegato che in questo carcere il dentista era una risorsa piuttosto scarsa, e difficile da avere a disposizione. Dopo due settimane il dolore si dissolse di nuovo, lasciando la stessa scia di fastidio che palpitava la sera, dandomi la buona notte. Un dolore che accompagnava la vita di galera Era Natale del 2000 quando un agente si presentò al cancello della mia cella. Vieni qui!, mi ordinò, e io obbedìi avvicinandomi al cancello. Ascoltami bene! C è un nuovo giunto ed è nigeriano. Siccome nessuno lo vuole in cella e qui l unico altro nigeriano è il tuo compagno di cella, abbiamo deciso di mettere il nuovo arrivato qui, e tu vai da un altra parte! Scegli tu con chi vuoi andare, disse, usando un tono che viaggiava in bilico tra l ordine perentorio e la richiesta di un favore. Il mio compagno di cella ebbe da protestare sulla sua provenienza, sostenendo di essere originario del Ghana, però accettò volentieri di dividere la cella con un nigeriano, mentre io scelsi di andare in cella con Mustafa, un marocchino che finiva di scontare la pena due settimane dopo. Cominciai a traslocare. Spostai per primi il materasso con le coperte, poi svuotai gli armadietti infilando la roba nei sacchi neri, ed ecco che fui invaso di nuovo dal mal di denti. Era come se dal secondo molare in alto a sinistra, partisse un chiodo arrugginito e bucasse prima la gengiva, poi l osso mascellare e infine sbattesse all interno della calotta cranica, rimanendo incastrato nel cervello. Caddi malato, e mi prenotai per la visita medica. La notte avevo caldo e tremavo sudando freddo. Avevo la febbre. Alla mattina riuscii a prendere sonno, ma verso le undici l agente mi aprì la cella: era arrivato il medico. La faccia si era gonfiata come se avessi infilato in bocca una pallina da ping-pong e avessi deciso di tenerla tra i denti e la guancia. Il dente, vero?, mi domandò il medico, fermo sulla soglia, appoggiato su un gomito, espressione rilassata, piccoli accorgimenti da professionista. Va bene, ti prescrivo dieci giorni di antibiotici e ti rinnovo la richiesta per la visita odontoiatrica. Arrivederci. Avrei potuto avere 40 di febbre, avere anche una polmonite, o la pressione bassa, ma non 70
74 avevo voglia di parlare, di litigare, volevo solo ritornare a letto e dormire. Però prima di prendere sonno giurai che non mi sarei mai più spostato da quella cella. Il dentista arrivò dopo una settimana, guardò il gonfiore che ormai si era esteso allo zigomo abbracciando l occhio, e mi disse che con una infezione in corso non poteva fare niente, ma che dovevo finire la cura, e poi ritornare. Io però stavo in galera, e certo non potevo mai avere la libertà di ritornare a piacimento, ma comunque prima di Natale l ascesso si calmò. Passai le feste a letto, con i postumi della cura antibiotica, e dovetti aspettare fino ad aprile per rivedere il dentista. Strano!, esclamò dopo aver visitato l intera bocca. Il dente è sano. Non rimane altro che vedere se c è qualcosa sotto. E dopo un paio di punture sulla gengiva, mentre io disperato mi accorgevo che non vi erano braccioli da stringere, lui attivò il trapano, bucò il molare fino alla gengiva e sparse del veleno nel nervo per ucciderlo, annerendo così il dente. Forse c era un granuloma, o forse un brufolo. Chissà perché c è stato quell ascesso!, disse, sollevando le spalle. Riempì la cavità provvisoriamente e aggiunse che mi avrebbe chiamato la settimana successiva. Il tempo passò in fretta, e mi ritrovai di nuovo steso sul lettino dell ambulatorio del carcere, dove il dentista in meno di dieci minuti riempi il dente trapanato di piombo, e mi salutò con una stretta di mano. Il dolore era sparito, e ciò era abbastanza per farmi sentire più leggero, felice. Adesso che il dente era stato devitalizzato potevo anche essere trasferito, il mio vecchio giuramento non mi avrebbe più costretto a dare alcuna prova di resistenza. Finalmente la speranza, e un dente rimesso a nuovo Ma in galera le felicità durano pochissimo, e a differenza della vita fuori, in libertà, quando la felicità sparisce ci si ritrova immancabilmente a sprofondare in dolori e sofferenze. Dopo appena una settimana cominciai a perdere i pezzi del piombo che riempiva il dente, e nel giro di un mese, l otturazione si era spaccata in due, i chicchi di riso si incastravano dentro solleticandomi la gengiva, e la mia frustrazione rimbombava sui muri della cella senza possibilità di fuga, crescendo continuamente. Avevo paura che la gengiva si infettasse, che il molare marcisse e diventasse contagioso per gli altri denti vicini, che mi si ammalasse tutta la bocca. Immaginavo scenari terribili, e non volevo perdere i denti, né in galera e né dopo la galera. Chiesi al medico di turno di poter rivedere il dentista, scrissi lettere di reclamo al comandante degli agenti, al direttore del carcere, al dirigente dei medici, ma nessuna precedenza, il mio nome stava in fondo ad una fila che doveva essere smaltita con molta tranquillità. Dovetti aspettare fino alla primavera del 2002 per rivedere un dentista, che non era più quello di prima. Il medico infilò i suoi strumenti nella mia bocca, e dopo aver vibrato dei piccoli colpi dentro e intorno al dente bucato disse: Ma è un buco enorme! non me la sento di scavare di nuovo perché rischia di spezzarsi. E io che cosa faccio?, gli domandai appena tirò fuori le mani dalla mia bocca. Ti consiglio di tenerlo così com è, tanto non fa male, visto che è stato devitalizzato, proclamò avviandosi verso la porta, un chiaro invito a liberare il posto della mia presenza. La fortuna volle che, passati quattro anni di inutile attesa, e arrivati al 2006, un mio compagno di cella mi informasse dell esistenza del servizio odontoiatrico privato, e cioè 71
75 che in carcere c è anche un dentista che visita, interviene e cura a pagamento. Allora ho chiesto di essere visitato da quel dentista. Dopo un attesa di tre mesi fui visitato. Il medico guardò il dente, e mi fece subito un preventivo che firmai senza esitazioni: durante questi anni di carcerazione mia nonna è morta, insieme al nonno, ma le frittelle le voglio mangiare comunque quando uscirò di qui, quindi, in tutta sincerità avrei firmato qualsiasi cifra ci fosse da pagare per sistemare il dente. Lui allora aggiunse il mio nome ad una fila di nomi conosciuti, tutte persone con pene lunghe che, passato il mio stesso calvario dal dentista della mutua, hanno deciso di rivolgersi a quello privato. Alla fine, primavera inoltrata del 2007, arrivò il mio turno. Steso sul lettino dell ambulatorio, fui preso dalla paura che alla fine anche lui rinunciasse a toccare un dente che rischiava di frantumarsi per lo scavo eccessivo del trapano, oppure che facesse una cosa in fretta, rozza, senza passione come aveva fatto il medico precedente. Invece il dottore aveva gesti gentili, un modo di comunicare che trasudava umanità, e lavorò con professionalità, dedicandomi il tempo necessario. Si consultò con me per scegliere persino il tipo di materiale da usare per l otturazione. Fino ad ora il dente sembra robusto, ma soprattutto l idea che adesso ci sono maggiori chance che io esca da qui con una buona salute dei denti, mi fa vivere meglio la galera. 72
76 Capitolo 4 UN PERCORSO SULLA MEDIAZIONE In un percorso che si occupa di legalità e devianza come questo progetto, è importante riflettere sulla mediazione, che è uno strumento che si preoccupa di provare a riparare una relazione che si è rotta. Prima che intervengano gli strumenti del processo e della pena, è possibile infatti affrontare il conflitto prodotto da un reato, costruendo un confronto tra chi questo reato l ha commesso e chi l ha subito, lavorando insieme per uscire dalla spirale dell odio che spesso si crea quando si rompe una relazione. La mediazione viene qui raccontata da una mediatrice penale che opera soprattutto con i minori nell ambito penale, ma anche per conflitti che non sempre sfociano in reati, e che ha accettato di intervenire in alcune scuole nell ambito del nostro progetto. È capitato poi che questo stesso progetto sia diventato uno strumento di mediazione, mettendo di fronte vittime e autori di reato, che hanno poi raccontato questa esperienza perché possa essere utile a tutti. 73
77 74
78 UNO STRUMENTO CHE SI PREOCCUPA DI PROVARE A RIPARARE UNA RELAZIONE CHE SI È ROTTA Questa è la mediazione, raccontata da Federica Brunelli, mediatrice dell Ufficio per la mediazione penale di Milano La mediazione è uno strumento che può essere usato anche per conflitti che non sempre sfociano in reati. Proprio a scuola lavoriamo spesso per insegnare la pratica della mediazione, con l idea che si possano formare ragazzi e professori, capaci di intervenire con questo ruolo quando a scuola nascono dei conflitti. Professori e studenti formati possono prendere parte a incontri di mediazione, anche con l aiuto di mediatori esperti, e possono provare a lavorare sulle parole ricucire, riparare, parole che mi sembrano importanti. Vorrei raccontare un caso di mediazione che riguarda la scuola, così forse, partendo da questo esempio, che non riguarda il contesto penale, possiamo poi anche ragionare sui reati. Infatti, in una scuola in cui insegniamo ai ragazzi a formarsi come mediatori, ci è capitato di partecipare ad alcuni incontri di mediazione. Un giorno, il dirigente scolastico ci ha chiamato e ci ha detto che si era creato un conflitto pesante, perché un insegnante era stata aggredita fisicamente con uno schiaffo da uno studente sulla porta della classe. Lo studente era stato sospeso ma secondo il dirigente scolastico non era sufficiente il mero intervento degli strumenti che la scuola normalmente utilizza (la nota, la sospensione, nei casi più gravi l espulsione), occorreva provare a realizzare un percorso di mediazione, soprattutto per gestire le conseguenze di quel conflitto. In effetti, a seguito dell episodio e della punizione data al ragazzo, si era creato un effetto distruttivo: vale a dire, agli occhi dei compagni questo ragazzo era diventato una specie di martire, perché tutta la colpa di quanto accaduto era della professoressa. I ragazzi della classe avevano messo in atto una vera e propria azione di ostruzionismo nei confronti della professoressa: lei entrava in aula e la classe la ignorava, facendo finta che non esistesse, e questa era una cosa molto complicata da gestire. La classe aveva assunto questo atteggiamento perché riteneva, al di là del gesto di aggressione, che il loro compagno avesse ragione, e che in realtà fosse la professoressa a mettere in atto degli atteggiamenti vessatori contro di lui e contro tutti loro. C era fondamentalmente un conflitto. Abbiamo provato a lavorare, con non poche difficoltà perché l insegnante stava molto male, voleva lasciare la scuola, non se la sentiva più di tornare in classe, era impaurita dal ragazzo che l aveva aggredita ed era delusa da tutti gli altri. È stato difficile convincerla a partecipare all incontro di mediazione perché fortissime erano le sue perplessità. Vi dico questo perché una regola importante è che ogni mediazione è un incontro che non può essere imposto: si propone di fare una mediazione, ma le persone devono essere libere di decidere se se la sentono oppure no, questo è importante. Con un po di fatica siamo arrivati ad organizzare l incontro diretto fra loro due, lo studente e la professoressa. Poi è stato proposto un incontro con tutti i ragazzi e i professori della classe, perché il conflitto aveva coinvolto molte altre persone oltre ai due protagonisti, e questo accade spesso quando c è un conflitto: un fatto accaduto fra due sole 75
79 persone può produrre effetti anche su altre persone, per esempio se i protagonisti abitano in un piccolo paese, dove tutti si conoscono e dove tutti prendono le parti dell uno o dell altro. Se penso alla mediazione reo/vittima abbiamo incontrato delle situazioni nelle quelli il reato aveva creato una vera e propria spaccatura di un paese a metà, per cui c erano luoghi infrequentabili per un gruppo di persone e frequentabili per un altro, con conseguenze sugli amici, sugli abitanti, su quelle persone che noi definiamo vittime secondarie, non direttamente coinvolte nel reato, ma che ne subiscono gli effetti. Nella nostra mediazione a scuola, le vittime secondarie erano i compagni di classe e gli altri professori, ma anche i genitori del ragazzo, e la famiglia della professoressa, tutte persone che in qualche modo pativano gli effetti negativi del conflitto. Qual è stato l obiettivo della mediazione? In generale possiamo dire che la mediazione permette di considerare come certi comportamenti non siano unicamente la violazione di una norma o di una regola, ma rappresentino la rottura di una relazione. Quando a rompersi è il patto di cittadinanza Facciamo un esempio, considerando un fatto di reato: cos è una rapina? Cosa succede se a Padova, mentre scendo dalla macchina, arriva un ragazzo che mi rapina? Questo è un fatto che la legge guarda dal punto di vista della legalità, come violazione di una norma del Codice penale, l articolo 628. Se io questo fatto lo guardo con gli occhi della giustizia tradizionale, vedo che questo ragazzo ha violato una norma; però posso guardarlo da un altro punto di vista e posso pensare che questo fatto non ha semplicemente violato una norma, ma ha rotto una relazione fra lui e me. Che si rompa una relazione sarebbe abbastanza evidente se io e questo ragazzo ci conoscessimo già da prima, come il ragazzo e la professoressa; più difficile è riuscire a capire in che senso si rompa una relazione quando il reato avviene tra due persone che non si conoscono, come per esempio fra me e un ragazzo di Padova (non lo conoscevo prima, molto probabilmente non ci vedremo più, non abitiamo lo stesso territorio, che relazione c è?). Pensiamo che una relazione importante ci sia ugualmente, ed è quella che ha a che vedere con ciò che chiamiamo patto di cittadinanza (così lo definisce il nostro coordinatore, il prof. Adolfo Ceretti). Il patto di cittadinanza fa sì che se io vengo a Padova, ho l aspettativa di arrivare qui a scuola, dove devo fare una lezione, sana e salva, così come se uno va al supermercato, pensa che non gli accadrà niente di male. Ogni tanto però questa aspettativa viene tradita, perché succedono degli episodi che ci violano, che ci umiliano, che tradiscono le nostre aspettative sugli altri. Dico questo perché la mediazione è uno strumento che si preoccupa di provare a riparare la relazione che si è rotta, si chiama giustizia riparativa, quindi è la proposta di una forma di giustizia che ripara: non una forma di giustizia che punisce, ma una forma di giustizia che mette a confronto i protagonisti di una relazione rotta per vedere se questa relazione può essere in qualche modo riparata, quindi la domanda importante per un mediatore è: Che cosa si può fare per riparare?. Quando parliamo di riparazione, di provare a riparare ciò che si è rotto non intendiamo dire che le cose possano tornare come erano prima. Ascoltando le vittime spesso si sente dire: Io avevo la mia vita tranquilla, stavo bene, era tutto positivo, poi un giorno è successa questa cosa, indietro non si torna più ma io rivoglio la mia vita, come era 76
80 prima. Ma questa condizione è irrecuperabile sempre, perché comunque essere vittime di un reato mette le persone dentro ad una vita che non è più quella di prima. Pensate alle conseguenze - per una vittima di omicidio è molto evidente - ma prendiamo anche la vittima di un reato meno grave, pensiamo lo scippo della borsa, in una situazione nella quale non c è l arma, non c è aggressione fisica, insomma semplicemente la sottrazione del bene. Questo fatto, seppur non gravissimo, può condizionarmi molto: io non uscirò più da sola, oppure non farò più la strada di prima. È un esempio semplice, però fa capire come essere vittima di un reato genera delle trasformazioni della vita, le cose non sono davvero più come erano prima. Avere uno spazio per incontrare l altro significa avere innanzitutto la possibilità attraverso l incontro con l altro, di provare a trasformare parte del mio vissuto rispetto a quello che è successo, sapendo che le cose non torneranno come prima, ma forse c è la possibilità che cambi un poco ciò che io vivo rispetto a quel fatto. Se mi dici la verità, posso anche rinunciare a punirti Voglio citarvi un esempio eclatante. In Sudafrica, dopo il lungo periodo di apartheid, nel 94 con la salita al potere di Nelson Mandela c è stato un rovesciamento totale del sistema politico. Ebbero fine le leggi razziali e finirono le violenze sui neri. Rimaneva però il problema di capire come poteva essere ricostruita la pace senza che si perpetrasse la vendetta dei neri sui bianchi. Come fare in modo che da quel momento in poi i bianchi potessero vivere accanto ai neri senza subire vendette? Il grosso problema era di avere alle spalle delle azioni irreparabili. Che cosa ha fatto il popolo sudafricano? Ha pensato non in termini di giustizia tradizionale, quindi ha rinunciato a punire tutti i colpevoli con pene pesanti o con detenzioni lunghissime, ma ha scelto di avviare un processo di giustizia riparativa. A parere dei sudafricani il paese aveva bisogno di cambiare direzione: il vettore della violenza era andato così, e da quel momento in poi le cose dovevano cominciare ad andare in un altro modo. Desmond Tutu disse che c era proprio bisogno di girare il vettore della storia, e per farlo hanno usato non il male contro il male, ma la giustizia riparativa. Allora hanno costituito una Commissione per la verità e la riconciliazione, composta da persone degne di rispetto e riconosciute, rappresentative dei bianchi e dei neri, che si sono occupate delle vittime, degli autori di reati e della riparazione. I componenti della Commissione hanno innanzitutto ascoltato le storie delle vittime, sono andati nei villaggi di tutto il Sudafrica, hanno dato uno spazio alle vittime in pubbliche udienze, così che l intera comunità potesse partecipare all ascolto. Allo stesso modo, hanno chiesto alle persone che si erano macchiate dei crimini dell apartheid di dire la verità, di raccontarla davanti a tutti, anche alle vittime. Nel caso che avessero detto la verità, non sarebbero stati puniti, quindi: la verità in cambio della punizione. Hanno fatto questa scommessa, e hanno dato l opportunità agli autori di reato e alle vittime di incontrarsi per narrare quello che era accaduto e confrontarsi. Questa non è una vera e propria mediazione, ma un attività di giustizia riparativa, che ha cercato di aprire percorsi di pacificazione e di riconoscimento. Si trattava di azioni irreparabili: nessuno poteva portare indietro le persone morte, ma quelle che restano hanno potuto trovare delle modalità per avere una vita decente, una vita che necessariamente 77
81 doveva fare i conti con la presenza dell altro, in una convivenza che avrebbe rischiato di diventare di nuovo esplosiva sullo stesso vettore di violenza. Fare questo lavoro è stato complicatissimo: noi siamo andati in Sudafrica l anno scorso per la celebrazione, dieci anni dopo, della Commissione e abbiamo ascoltato un sacco di testimoni che avevano partecipato ai lavori della Commissione. Non tutto è stato chiarito, ci sono persone che sostengono che non tutta la verità è stata detta, che non tutte le riparazioni sono state accordate, ci sono molte contraddizioni (se pensiamo che lo Stato sudafricano si era fatto carico di risarcire tutte le vittime, versando somme di denaro, garantendo studi gratuiti ai figli delle vittime e cure mediche per quelli che erano stati feriti e resi invalidi, ma poi non è stato in grado di portare a termine queste forme di riparazione per mancanza di fondi, in un contesto che rimane ancora molto complicato). Ho fatto questo esempio proprio perché trovo estremamente significativo metterci di fronte a una modalità innovativa per riattivare una comunicazione, a una forma di riparazione anche quando sembra che sia impossibile intervenire. Ed è vero, le vittime del Sudafrica sono consapevoli che nessuno ridarà mai la vita ai loro cari, ma sanno anche molto bene che hanno bisogno di ricominciare a vivere, di non essere vittime per sempre. Certo in Sudafrica i problemi sociali non sono per nulla risolti, nonostante il lavoro della Commissione, però sicuramente in quel momento storico proprio con la Commissione hanno evitato che scoppiasse una guerra civile, ed hanno usato una modalità nuova, cioè l idea che io posso rinunciare alla punizione, e che invece posso usare uno strumento di ricucitura dei legami. C è stato anche un film girato su questo argomento, In My Country, dove viene mostrato molto bene il lavoro della Commissione, di villaggio in villaggio, e il racconto delle vittime. Pensate che gli incontri della commissione hanno permesso a molti parenti di vittime di sapere che cosa fosse successo ai propri cari, perché durante l apartheid le persone sparivano da un giorno all altro e nessuno ne sapeva più niente. Così, attraverso i racconti di chi aveva commesso i crimini le vittime hanno potuto trovare i corpi dei loro cari, hanno potuto seppellirli, sapere come erano morti, insomma hanno potuto conoscere la verità, e per una vittima è molto importante poter avere restituita la verità. La possibilità di riconoscersi come persone Ci sembra importante provare a capire se è possibile trasformare un po i vissuti e il futuro delle persone rispetto a quello che è accaduto, soprattutto nei casi in cui le persone sono destinate a incontrarsi di nuovo, come la prof. e lo studente, o due persone che si conoscono o che sono compagni di classe e si vedono tutti i giorni, allora io posso dire anche che si può applicare la giustizia tradizionale, e va bene, però questo non risolve tutto. Non sempre la Giustizia che noi conosciamo e che applica la punizione è capace per davvero di rispondere al bisogno di giustizia che le persone sentono di avere. È per questo che ci sono anche gli spazi di mediazione, perché in uno spazio di mediazione io posso lavorare su quello che è successo, prendendo un altro pezzo di quello che è accaduto, che non riguarda la dimensione delle regole, delle norme, ma le relazioni fra le persone, e lavorare su quello. 78
82 Per riprendere ancora un discorso generale e i principi della mediazione in relazione ai fatti di reato possiamo dire che quando io commetto un reato, normalmente mi imbatto in una Giustizia che come simbolo ha la spada, un simbolo che dice tutto: la spada significa tagliare esattamente, tagliare il conflitto, separare le parti; la giustizia della spada è sancita da un terzo che è il giudice, che tagliando nel mezzo interrompe il conflitto e dice la parola che decide, perché dice dove sta il torto e dove la ragione, applica una sanzione. È una giustizia che ha la benda sugli occhi, ovviamente, perché non guarda in faccia nessuno, oppure perché, se guardasse negli occhi una persona, non potrebbe punirla, e forse è proprio perché non guarda in faccia nessuno che è equa. È una giustizia verticale che dice che quel reato non doveva e non dovrà succedere mai più, e ristabilisce l ordine, nel nome del popolo italiano, applicando una sanzione. Questa è una dimensione della Giustizia senza cui probabilmente non potremmo vivere, però il reato non è soltanto questa cosa, spesso c è molto di più, c è tutta quella parte che riguarda la relazione che si è rotta di cui nessuno si prende mai cura, ed ecco perché, oltre alla spada, da dieci anni a questa parte si è pensato di introdurre la giustizia riparativa, ed ecco perché delle persone provano a lavorare sugli effetti negativi che ha provocato la rottura di questa relazione. Perciò è fondamentale avere degli spazi in cui autori e vittime di reato possano andare e parlarsi guardandosi in volto alla presenza di terzi, che non siano giudici e che quindi non abbiano il compito di stabilire il torto e la ragione, né dei poliziotti che fanno delle indagini, ma dei facilitatori della comunicazione e del riconoscimento, per vedere se le persone da questo confronto possono costruire qualcosa in positivo per il futuro, e quindi non essere passive come avviene quando si attende la parola del giudice. Il fatto di parlare di quello che mi è successo, ed anche il fatto che io possa decidere qualcosa con l altro rispetto a quello che ci è successo, mi rende attivo. La mediazione in questo modo si intreccia con il processo penale. Nel processo penale minorile accade che il magistrato possa decidere di sospendere il processo e mandare il caso ai mediatori, proponendo alle due persone coinvolte di incontrarsi. La mediazione è volontaria, per cui gli interessati possono decidere se accettare o meno. Se accettano avviene l incontro, che è di solito molto lungo, parecchie ore. Come mediatori cerchiamo di lavorare intorno a una parola per noi fondamentale vale a dire riconoscimento, la possibilità di riconoscersi come persone, e, se c è questo riconoscimento, la possibilità di riparare, e quindi uscire con l idea che il vettore innescato con il reato per il futuro può anche girare in un altro senso. UNA CLASSE INTERROGA FEDERICA BRUNELLI SULLA MEDIAZIONE La mediazione può essere applicata o richiesta per ogni tipo di reato? Astrattamente sì, non dovete avere l idea che questa cosa possa andar bene per alcuni tipi di reato e per altri no. Proviamo a non avere degli schemi, ma più un attenzione anche al tipo di persone coinvolte e caso per caso; perché le mediazioni ci arrivano sia su reati semplici e poco gravi sia su reati gravissimi, rapine, rapine con le armi, lesioni personali anche permanenti, violenze sessuali, omicidi colposi. Abbiamo quindi una gamma 79
83 di reati che va dal più grave, a quello minore; la cosa più importante è capire quando la mediazione ha senso, e se per esempio può aver senso tutte quelle volte che questa dimensione relazionale è molto significativa dentro al reato, indipendentemente dall oggettiva gravità. Per esempio non farò mediazione su tutte le violenze sessuali, ma magari il giudice si accorge che quella violenza sessuale è accaduta fra due ragazzi che sono vicini di casa, piuttosto che fra due compagni di scuola, e allora prende quel caso e lo manda in mediazione, perché capisce che, al di là della spada che lui userà per decidere, c è molto di più, c è il fatto che queste due persone si rincontreranno tutti i giorni, e che di questo nessuno si prende cura. Non pensate che un reato vada meglio di un altro, tutti i reati possono arrivare in mediazione, più gravi o meno gravi, l importante è guardare questa dimensione relazionale. Non sempre infatti è più facile mediare un reato un po meno grave rispetto a quello molto grave, e questa è una cosa che ho capito con l esperienza, prima ero convinta del contrario, però poi ho capito che in realtà, quando nei centri di mediazione arrivano dei casi fra vicini di casa che litigano perché il cane fa la pipì sullo zerbino, quel conflitto può essere molto più difficile da mediare di un reato di violenza sessuale, perché paradossalmente capita che ci siano dei sentimenti di odio più radicati e nascosti. Per cui è molto più difficile arrivare a lavorare su quei sentimenti di odio, piuttosto che per fatti gravissimi dove l odio è in qualche modo giustificato e ha una potenza che si manifesta immediatamente, mentre, quando ti arriva il vicino di casa che è arrabbiato per colpa del cane, può essere che ci sia un livello di odio così profondo che diventa poi difficile fare la mediazione, per cui ogni tanto fra i vicini di casa non ci riusciamo, anche se ci mettiamo molta energia. In Italia è possibile fare mediazione di questo tipo a tutti livelli o, dal punto di vista istituzionale, riguarda solo alcune categorie di reati? Cioè il ruolo del mediatore è un ruolo riconosciuto dalla giurisprudenza italiana e a quale livello? In Italia, a parte la mediazione famigliare che esiste fin dagli anni 70, la mediazione penale non c era fino al 98, mentre all estero si faceva dagli anni 80. Nel nostro Paese, su indicazioni del Ministero di Giustizia che aveva inviato una lettera ai Tribunali per i minori chiedendo di sperimentare questa modalità, si è cominciato a farla dal 95, quando si formarono dei gruppi per imparare a fare la mediazione e provare a sperimentarla. Oggi tutti questi gruppi sono stati in qualche modo riconosciuti dal Ministero, anche se non esiste la professione di mediatore e non esiste una legge sulla mediazione penale, per cui non abbiamo delle indicazione legislative precise che ci dicano come dobbiamo fare, chi la deve fare, con quali caratteristiche; però abbiamo delle norme internazionali dell O.N.U. e del Consiglio d Europa, che indicano tutto ciò, e normalmente gli uffici in Italia sono strutturati nel rispetto di queste norme. Si spera che presto venga fatta una legge, raccogliendo i frutti della sperimentazione di questi ultimi dieci anni. Noi mediatori non lavoriamo da soli, negli incontri con le due parti, lavoriamo in tre, e l equipe di mediazione viene formata a seconda di chi dobbiamo incontrare, quindi per un conflitto fra gruppi di maschi, che si sono picchiati all uscita di una discoteca, non vengono chiamate tre mediatrici donne, ma un equipe dove la presenza maschile sia significativa. Se, per esempio, abbiamo persone anziane (pen- 80
84 sate a una donna anziana che è stata scippata) non possiamo comporre un equipe di mediatori troppo giovani. Che qualifica, che competenze hanno i mediatori? Noi mediatori abbiamo delle competenze molto diversificate, anche di appartenenza: ci sono persone che hanno studiato legge, chi ha studiato sociologia, filosofia, criminologia, assistenti sociali, educatori, persone con varie specificità, tutti comunque devono aver seguito un corso di formazione. All ufficio siamo però solo mediatori, non facciamo gli avvocati, gli psicologi, gli assistenti sociali. Il mediatore è una figura imparziale, neutra forse no perché è una parola troppo forte, neutro può essere il giudice, perché è nec utrum, cioè né l uno né l altro, e quindi è distante da tutti e due. Quello che invece il mediatore nella sua formazione deve imparare è essere sia l uno che l altro. Noi diciamo che è equiprossimo, usiamo questa strana parola, cioè vicino a tutti e due allo stesso modo, e bisogna imparare ad esserlo perché non è semplice: come non è semplice essere neutro, non è neppure semplice essere vicini all uno e all altro, perché questo è un lavoro di vicinanza, non di giudizio, né di indicazione di cosa dover fare, cioè di consiglio, ma dì riconoscimento. Io comincio a usare una parola che riconosce, comincio a riconoscere per esempio i vissuti tuoi, quelli dell altro, e lo faccio perché voi possiate arrivare a comunicarveli. È il mediatore che decide se la mediazione non è andata bene? Si decide insieme alla fine: quando si arriva al momento in cui ci sembra che sia cambiato il clima, che le parti abbiano espresso tutto quello che desideravano dire, che sia avvenuto fra loro un riconoscimento (per esempio Io ho capito delle cose di te che non avevo capito prima, questo è un darsi riconoscimento), e magari che si arrivi a decidere delle cose concrete per il futuro ( cosa possiamo fare da oggi in poi, perché il rispetto sia tutelato? ). Allora alla fine ci confrontiamo sull esito da sottoporre al giudice, perché noi non riferiamo mai quello che si sono dette le persone in mediazione, ma solo se, secondo noi, la mediazione è andata bene o male. È molto importante, perché davvero la mediazione appartiene alle parti che vengono a farla più che al mediatore, è veramente un luogo diverso dal tribunale perché non c è giudizio, e questa è una cosa che colpisce molto. Quindi l idea è che, davanti all autore di reato e a una vittima, quello che io devo essere capace di fare è far parlare queste due persone che hanno due nomi, che non si chiamano vittima e autore di reato, ma che sono anche altro rispetto a quello che hanno fatto. Può spiegare come si è svolta la soluzione del conflitto fra lo studente e la professoressa, e quanto tempo ci è voluto? Abbiamo fatto due incontri solo fra loro, studente, insegnante e noi tre, e abbiamo lavorato molto sulla questione dello schiaffo: che cosa aveva significato anche rispetto a tutti gli altri, che cosa c era dietro, quindi il fatto che questo ragazzo si sentiva sempre incolpato solo lui quando c era casino in classe e la nota arrivava sempre a lui, e come si fosse arrivati a questo gesto di violenza. Dopo di che in quella sede loro si sono scambiati delle scuse, quindi la riparazione tra loro due è avvenuta. Spesso però capita che, negli incontri di mediazione, l autore di reato arriva, si siede, e senza neanche far pas- 81
85 sare il tempo di introdurre il discorso, già si scusa; dice che ha sbagliato, che adesso vuole chiudere, che è finita. Non è questa la mediazione, perché ovviamente la vittima non se ne fa niente di queste scuse. In questo caso c è stato un grosso scambio fra loro due, e poi alla fine ci sono state le scuse, che entrambi hanno percepito come sincere. Dopo di che rimaneva il problema della classe dove, fra l altro, c era una spaccatura assurda perché si erano divisi su due file di banchi, da un lato stavano seduti tutti gli agitati e dall altro tutti i bravi, e questo aveva ancor di più spezzato la classe, e tutti erano stati puniti, era stata negata loro la gita scolastica. Dopo questo incontro con l insegnante e lo studente, abbiamo proposto di fare un incontro libero con la classe ed i professori che avessero voluto; abbiamo detto che se volevano avrebbero potuto riunirsi un sabato mattina nel nostro ufficio, per fare un lavoro di riparazione (avevamo preparato tutta una serie di cose da fare insieme); quel sabato si sono presentati solo i c.d. agitati, di quelli bravi non è venuto nessuno, sono venuti invece i professori. Abbiamo lavorato con loro per circa quattro ore in un incontro bellissimo, è stato uno scambio profondo fra i professori e loro. Sono stati bravissimi davvero e hanno preso delle decisioni tra cui quella di scrivere insieme l esito della mediazione e di quella giornata per lasciare una traccia, come una sorta di regolamento interno, e di farlo insieme alla professoressa che era stata aggredita, aiutandola, e poi i ragazzi hanno chiesto di essere portati in gita e i professori presenti in mediazione hanno accettato. È andata bene, poi abbiamo fatto anche un ulteriore incontro in classe con tutti gli altri, come una restituzione, anche se devo dire che in quest ultima fase non ci siamo sentiti di forzare a ulteriori passi, perché una parte di classe non aveva voluto fare la mediazione e andavano rispettati, per cui l abbiamo chiusa lì. Quindi il conflitto con gli altri non è stato proprio gestito compiutamente, però c è stata comunque una condivisione generale sul fatto che la questione era chiusa, che questa era stata la riparazione decisa e che quindi sarebbero andati in gita. Non è mai capitato in una mediazione qualche litigio? I mediatori litigano un sacco, perché è importante poter anche partecipare al conflitto. Ogni tanto quindi anche i mediatori hanno conflitti fra di loro: bisogna imparare a lavorare insieme, anche se siamo molto diversi sia come visione del mondo che negli atteggiamenti verso gli altri. Se tutto il gruppo fosse omogeneo, riusciremmo ad essere anche meno vicini alle persone che incontriamo. Così invece rappresentiamo un po la diversità delle persone e siamo risusciti a lavorare insieme. È stata dura, perché abbiamo dovuto fare una formazione molto lunga che ha creato anche in noi conflitti, quindi, prima di andare a lavorare su quelli degli altri, abbiamo lavorato sui nostri, che erano davvero molti. Per effettuare una mediazione ci sono dei tempi che vanno rispettati o è sempre possibile farla, magari anche dopo molto tempo? No, non ci sono tempi da rispettare. Nel processo minorile normalmente i casi ci vengono mandati durante la fase delle indagini preliminari, dopo l interrogatorio, perché sentiamo l esigenza di non far passare troppo tempo da quando è successo il fatto. Un grosso problema è invece quello di fare la mediazione nell ambito dell esecuzione penale, quando le persone sono in carcere da tanto tempo, e magari sono passati dieci anni dalla 82
86 commissione del reato. Il fatto che tu vada comunque a disturbare delle vittime può essere molto violento, perché dopo dieci anni non è detto che la vittima abbia ancora il desiderio di fare questa cosa, e perciò è tutto molto più complicato. Normalmente quindi si cerca di farla abbastanza presto, nelle indagini preliminari vi dicevo, preferibilmente dopo l interrogatorio. Se per esempio arriva in mediazione un ragazzino che dice che non è lui il responsabile di una rapina, perché quel giorno era in piscina con gli amici, che non era nemmeno andato a scuola e che noi ci sbagliamo, allora non possiamo fare il nostro lavoro, perché questo ci pone in un ruolo di investigazione, quindi noi chiediamo almeno che il magistrato lo abbia già sentito, che perlomeno ci sia un assunzione di paternità di quel gesto. Se invece il ragazzo dice: Sì, ero io, però non è vero che è stata una rapina perché io gli ho chiesto il portafoglio, ma glielo volevo ridare subito, solo che è arrivato un carabiniere, questo sì che è un caso che riguarda la mediazione, perché attiene alla complessità del conflitto, posto che poi noi non andremo a lavorare per capire se lo possiamo qualificare come rapinatore o no, lavoreremo sul piano del vissuto, sul piano esistenziale. Quando ci arriva dal giudice la richiesta di mediazione, noi contattiamo telefonicamente la vittima e l autore del reato e li invitiamo ad un colloquio individuale, separatamente; se poi accettano, si decide per l incontro, normalmente uno, altre volte di più, però sempre con l idea chiara, che non è un lavoro di terapia e quindi non dura a lungo, ma un lavoro puntuale sulla relazione che si è rotta, per provare a trovare dei modi per ripararla, quindi non è neppure un lavoro di presa in carico, come quello di un terapeuta, molto più profondo, e molto più impegnativo. Ma la mediazione cosa fa? Evita poi il procedimento penale? Alla fine si scrive insieme un esito, si manda al giudice, e da lì il processo riprende e il giudice può tener conto della mediazione. Non ci sono comunque degli automatismi, quindi anche se la mediazione è andata bene, non è detto che per forza non ci sarà un processo, o magari anche una punizione. Oppure il giudice può dire che secondo lui la mediazione è significativa, e fermarsi, e chiudere il processo; o ancora, nei casi della querela di parte, la vittima può dire che non le interessa più andare davanti al giudice, che ritira la querela. In altri casi, quelli oggettivamente e giuridicamente più complessi, il giudice tiene conto che l incontro è andato bene, nonostante il fatto che, a fronte della gravità del reato, ritenga che ci sia bisogno di una messa alla prova. Che prospettive apre la mediazione nell ambito della Giustizia? Sapete che in Italia abbiamo un Codice penale che risale al 1930 (a parte la normativa sui minori che è dell 88 e segue tutta un altra filosofia) in cui la dimensione retributiva della pena è considerata centrale. I discorsi sulla mediazione quindi sicuramente aprono delle prospettive inedite, e fanno anche capire come si possano costruire delle risposte di giustizia capaci di guardare all offesa giuridica in un modo nuovo. L impatto che questi nuovi strumenti avranno su tutto il sistema delle pene, in questo momento non siamo ancora in grado di valutarlo; sicuramente, a mio modo di vedere, queste politiche dovrebbero avere molto più riconoscimento di quello che non hanno, e quindi magari arrivare ad una modifica del Codice penale dove la giustizia riparativa abbia un posto importante, riconosciuto. 83
87 C è una domanda che ci viene fatta spesso, anche da persone che appartengono al mondo giuridico, ed è: Ma questa cosa serve per la recidiva? Cioè, se uno fa la mediazione poi non delinque più?. Questo dato in Italia statisticamente non esiste perché queste ricerche non sono state fatte, però a mio modo di vedere, anche se non è detto che la mediazione sia risolutiva, potrebbe comunque essere un esperienza significativa e in alcuni caso lo è per davvero. Piccoli esempi di mediazione Voglio farvi due esempi diversi: avevamo fatto una mediazione in un piccolo centro vicino a Milano, tra un gruppo di vittime e autori di reato, quelli che vengono definiti Baby Gang ; le vittime erano tre fratelli, che non potevano più passare per la piazza del paese perché venivano sbeffeggiati, gli prendevano il motorino per fare un giro, senza poi restituirlo, finché alla fine vennero anche pestati molto pesantemente; scattò la denuncia che arrivò al tribunale per i minorenni ed il giudice ci mandò il caso in mediazione. Ci fu la mediazione veramente faticosissima, che però andò a buon fine. I ragazzi si parlarono profondamente, si dissero delle cose significative, addirittura decisero di dover fare qualcosa nei confronti degli altri (i leader di questi due gruppi decisero di andare nel bar del paese a bere una birra insieme con i tre fratelli perché, secondo loro, questa azione fatta davanti a tutti, sarebbe stata un messaggio unificante). Ebbene: lo fanno, va tutto bene, addirittura avevamo organizzato con questi ragazzi delle attività di utilità sociale che vengono svolte con grande impegno, proprio un percorso lineare, tutto a posto. Dopo tre mesi dalla chiusura della mediazione, uno dei ragazzi del gruppo si presenta al comando dei vigili urbani con una mazza da baseball, perché gli avevano notificato una multa, e distrugge tutto. Questa cosa ti fa capire come, nonostante l incontro di mediazione sia stato bellissimo, e questo ragazzo l abbia fatto non strumentalmente mettendoci tutto se stesso, poi però non ha trasformato tutto il resto. È stata una conclusione che mi ha fatto male. Un giorno, invece, ero all università, in mensa e ad un certo punto mi si avvicina un ragazzo che mi dice: Ah, tu sei Federica, quella della mediazione?. Lo guardo bene e scopro che era uno degli autori di un reato con cui avevo fatto una mediazione anni prima, che ora frequentava la facoltà di economia; abbiamo parlato un po, abbiamo mangiato insieme e lui mi ha detto che quella mediazione gli aveva cambiato la vita. Secondo me esagerava anche un po, cambiare la vita è una cosa troppo grossa, però ha detto che per lui quell incontro era stato importantissimo per capire tutta una serie di cose. Questo mi ha fatto anche molto piacere: in alcuni casi la mediazione può anche essere decisiva, non perché si incontra un mediatore, ma proprio perché incontri l altro, perché magari incontri la tua vittima e capisci che cosa c è dentro la regola che hai violato. Mi ricordo un altro caso nel quale un ragazzo era stato rapinato fuori dalla scuola, e nel colloquio preliminare disse che avrebbe fatto la mediazione perché per gli autori del fatto lui era stato solo un portafoglio: Loro non mi hanno neanche guardato in faccia, guardavano solo le mie mani ed il portafoglio. Per i due giorni successivi sull autobus gli autori del reato erano a fianco della vittima e non se ne erano neanche accorti, lui invece li riconobbe e fece denuncia. La vittima venne in mediazione, per- 84
88 ché per lui il fatto di non esistere era insopportabile, una prova di inciviltà. L incontro fu l occasione di guardarsi in viso, di capire che dietro quei soldi c era tutta una storia, non solo di soldi, ma una storia di una persona che chiedeva di essere riconosciuta e rispettata. C è più successo in una situazione dove c è una persona contro una, o in una situazione di una contro un gruppo? Sicuramente bisognerebbe pensarci un po per fare una mediazione di uno contro un gruppo, bisognerebbe chiedere alla vittima o all autore se se la sentono di incontrare tanti autori di reato o tante vittime. Secondo me la difficoltà sta nel fare in modo che la mediazione non sia un altra occasione di vittimizzazione, che il gruppo possa riesercitare la violenza anche in mediazione. Lo sappiamo, la violenza non può essere quella fisica, ma può essere anche violenza verbale, quindi in mediazione su questo bisogna essere molto bravi, molto attenti per fare in modo che questo non accada, altrimenti l incontro non va, non funziona. Ha mai fatto una mediazione su un caso di omicidio? Ci sono capitati dei casi di omicidio colposo, e un caso di omicidio preterintenzionale, dopo una lite fuori da una discoteca. I genitori della vittima in quest ultimo caso non hanno voluto assolutamente incontrare gli autori del fatto (erano tre i ragazzi e chiedevano in tutti i modi di poter fare un incontro, perché loro non volevano la morte di questo ragazzo, avevano questo peso davvero fortissimo, e sentivano il bisogno di incontrare soprattutto la mamma). Alla fine quello che noi siamo riusciti a fare come ufficio di mediazione non è stato un incontro diretto, perché non c era la disponibilità, però questa signora non ha opposto alcuna obiezione a che i ragazzi le scrivessero. Abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere quello che desideravano, hanno portato all ufficio le loro lettere, noi le abbiamo sigillate dentro una busta, quindi tre buste chiuse dentro una busta chiusa, in modo che la madre potesse decidere se leggerle o no. Lei ha accettato l invito, però poi ha ritenuto di non doverci chiamare per una risposta. Non è stata una mediazione ovviamente, solo far accadere questo scambio. 85
89 UN NUOVO MODO DI INTENDERE LA PENA I ragazzi del Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato raccontano l incontro con una mediatrice penale Un modo per ricucire i legami spezzati riparando il male fatto di Roberta Zancopè, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato L incontro con la mediatrice penale mi è piaciuto particolarmente perché non è stato noioso; la mediatrice, infatti, era allegra e sapeva catturare l attenzione dei ragazzi. L incontro, che riguardava la mediazione penale, mi è servito per conoscere meglio questo sistema riparativo del legame tra vittima e reo. In questo modo il rapporto si ricuce e si evita di allontanare maggiormente le due parti, e sotto questo punto di vista ritengo che la mediazione sia uno strumento valido, soprattutto perché non si colpevolizzano le persone devianti. Il limite della mediazione è, secondo me, il rischio di far rivivere alla vittima il torto subito, non tutti probabilmente sarebbero in grado di incontrare il reo. Credo quindi che la mediazione risulti più o meno efficace, a seconda della personalità che ha un soggetto. Una pena che non sia solo punitiva di Jessica Graffigni, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato L incontro con la mediatrice penale è stato importante per chiarire il significato della mediazione e della giustizia riparativa. Si può dire che è un nuovo modo di intendere la pena, non si tratta più di una visione puramente punitiva di quest ultima, ma si cerca invece, attraverso l incontro faccia a faccia tipico della mediazione, di riparare ad un danno. Dal momento in cui viene compiuto un reato si rompe un patto sociale tra l autore di reato e la vittima, e un incontro tra questi due soggetti può aiutare da un lato la vittima a superare il trauma causato dal crimine subito, e dall altra parte il reo si assume la completa responsabilità dei fatti arrivando, a volte, a scusarsi con la vittima. La mediazione si basa sostanzialmente sul colloquio, e avviene in genere sui minori ed è utilizzabile solo per certi tipi di reati. Il limite di questo tipo di giustizia è il fatto di non essere considerato sempre sufficiente per non scontare una pena, difatti, comunque non si sostituisce alla giustizia penale. Ma può aiutare nel percorso di risocializzazione. Ritengo che la mediazione sia molto utile, ma non nei casi di omicidio di Francesca Donolato, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato L incontro svoltosi con la mediatrice è stato molto produttivo, in quanto ho potuto imparare che la giustizia punta anche ad un fine restitutivo, cercando di far tornare alla normalità la vittima, e questa normalità può essere raggiunta attraverso una mediazione fra essa e il reo. Ritengo che la mediazione sia molto utile, ma non in tutti i casi, come ad esempio l omicidio Credo infatti che rapportarsi con il reo possa essere inutile ad esempio per una madre a cui è stato ucciso il figlio Nulla potrà mai restituirglielo! Però in caso di reato minore può rivelarsi efficace Per esempio in caso di scippo, attraverso la mediazione il reo può spiegare i motivi che l hanno portato a deviare e la vittima può riuscire a superare lo shock, capendo anche le motivazioni dell altra parte. 86
90 Una figura professionale con grandi responsabilità di Chiara Baldan, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato Abbiamo avuto un incontro con una mediatrice dell Ufficio per la mediazione penale di Milano. Ho trovato molto interessante questo incontro, perché ho potuto conoscere una figura professionale non molto nota, ma con grandi responsabilità. Nel raccontarci la sua professione, la mediatrice ci ha resi partecipi della lezione e ha messo in atto una specie di mediazione tra noi e lei. Ho capito che il mediatore è un lavoro molto utile e importante, aiuta in modo concreto le persone e si occupa della parte sociale più che giuridica. Non avrei mai pensato che ci sono metodi alternativi alla pura pena di Adriana Zacchinato, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato L incontro con la mediatrice penale è stata un esperienza che mi ha colpita molto. Prima di partecipare al progetto carcere non avrei mai pensato che ci sono metodi alternativi alla pura pena. Da ciò che ho appreso con la mediatrice, ho capito che essa svolge un compito molto importante, perché quando avviene un reato si pensa sempre ad una vittima e a un reo, ma non a due persone. La mediazione è appunto un tentativo di riagganciare quel patto di fiducia che lega due individui. Inoltre la mediazione pone al centro la vittima, cosa che la giustizia penale non fa. La mediazione riabilita, riporta alla normalità la vita delle vittime di Francesca Paviola, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato Della mediazione penale, prima dell incontro, avevo già un idea, perché la stiamo studiando in Scienze sociali. Penso però che sia stato molto importante aver incontrato la mediatrice, perché ha saputo portarci un esperienza concreta, la sua, e così abbiamo potuto presentarle tutti i nostri dubbi. La mediazione è un processo molto complicato e delicato, però ha un fine molto importante. Importante per tutti, per risolvere dal piccolo (che potrebbe diventare grande) problema a quello che invece è più grave, più grande. La mediazione riabilita, riporta alla normalità la vita delle vittime. Infatti è proprio per la vittima che è nato questo metodo nuovo che viene utilizzato quando un giudice durante un processo lo decide, oppure può avvenire per richiesta di una delle due parti (reo-vittima). Credo sia uno strumento utile per risolvere disagi provocati da reati minori di Davide D Avenia, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato Dopo l incontro con la mediatrice ho potuto consolidare la mia idea rispetto a questo nuovo metodo di giustizia riparativa che, in primo luogo, ritiene essenziale appunto la riparazione del danno causato, attraverso il dialogo tra le parti coinvolte, anziché limitarsi all attribuire colpe. Ritengo che sia certamente uno strumento utile per risolvere disagi provocati da reati minori, specialmente nell ambito minorile, ma ritengo sia impensabile, tramite questo mezzo, la risoluzione di reati più gravi come l omicidio, o peggio, il genocidio. Di certo anche in questi casi tra vittima e reo potrebbe avvenire un dialogo regolato dal mediatore, ma ciò non placherebbe comunque il desiderio di vendetta sorto nella vittima indirettamente colpita. 87
91 L importanza di far rincontrare la vittima e il reo di Federico Tessari, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato Grazie ad un incontro svolto durante il progetto carcere ho potuto conoscere un po meglio una persona che svolge un lavoro-servizio particolare, questa è la mediatrice penale. Tale figura mi è sembrata molto utile perché, da quanto raccontato dalla stessa, grazie a lei è possibile tentare di far rincontrare la vittima e il reo per una maggior comprensione dell avvenuto, con scontro di opinioni ed emozioni. L incontro, però, è possibile solo se entrambi i disputanti sono favorevoli e consapevoli di ciò che stanno per fare, inoltre il reo deve essere convinto della gravità del suo gesto ed intenzionato a porre rimedio al danno morale, fisico e finanziario creato alla propria vittima. Sostengo che la mediazione penale sia utile, perché come detto anche dalla mediatrice in questione, circa il 99 per cento delle persone che vi hanno preso parte ne sono rimaste soddisfatte, e poi anche perché, per il mio modo di vedere, è meglio capire il perché delle azioni e delle conseguenze di queste, piuttosto che rimanere nell ignoranza del dolore. Penso che questa modalità sia utile se c è pentimento da parte del deviante di Sofia Pertile, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato Grazie all incontro che abbiamo avuto con la mediatrice penale mi sono chiarita molte idee e ho scoperto anche molte cose interessanti di cui non ero a conoscenza. Questo argomento non mi era nuovo, perché grazie a delle spiegazioni avvenute in classe, mi ero potuta avvicinare a questa tecnica apparentemente semplice ma molto efficace. Ho capito, per esempio, che si può ottenere la mediazione con qualsiasi tipo di reato, anche quando si parla di omicidio. Ovviamente l incontro avverrà tra i genitori della vittima ed il reo, sempre se acconsentono e se sono disposti ad affrontare un colloquio faccia a faccia. Penso che questa modalità sia molto utile se viene eseguita correttamente e se c è un effettivo pentimento da parte del deviante. Molte volte le vittime preferiscono un rimborso economico piuttosto che un dialogo con la persona dalla quale hanno subito un danno, certo, in un primo momento penso sia comprensibile, anche perché i sentimenti della vittima non sono uguali a nessun altro e incontrarsi con il reo potrebbe suscitare reazioni particolari, però la vittima può cercare di capire le motivazioni che hanno spinto il criminale a compiere un torto nei suoi confronti. Ci ha permesso di conoscere una nuova faccia della giustizia di Elisa Giacomini, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato L incontro avvenuto con la mediatrice penale è stato una tappa molto significativa del progetto carcere, in quanto ci ha permesso di conoscere una nuova faccia della giustizia italiana. Il mediatore, che non ha il compito di giudicare e non è tenuto ad esprimere giudizi, facendo da tramite tra vittima e detenuto permette di alleviare gli stati d animo (pesanti) di entrambe le parti e permette una riconciliazione. Attraverso questo incontro abbiamo capito l importanza di questa figura, non molto conosciuta o pubblicizzata. 88
92 Quel difficile faccia a faccia tra vittima e reo di Lara Zavanella, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato La mediazione è un meccanismo della giustizia riparativa, finalizzato alla regolazione dei rapporti fra attori sociali. Anche fra due persone che non si conoscono c è un rapporto: il rapporto di cittadinanza. Questo consiste, per esempio, nell essere sicuri di poter uscire e rientrare a casa sani e salvi. Quando questo rapporto viene rotto, nella vittima si creano problemi psicologici che non le permettono più di tornare a vivere, alla normalità. La mediazione penale consiste nell incontro faccia a faccia tra vittima e reo. Si dà la possibilità alla vittima di ritornare alla normalità, perché in qualche modo supera l accaduto, può conoscere il punto di vista del detenuto e chiedere spiegazioni del perché. Il reo ha la possibilità di guardare la vittima in faccia, riconoscere i propri errori, capire che ha portato danni psicologici con il gesto fatto, ha la possibilità di riparare in qualche modo al male fatto. La cosa molto importante è che i due protagonisti si vedono in primis come due persone e non come reo e vittima. La mediazione è attuata quando lo richiede la vittima o quando il magistrato si accorge dell importanza di questa giustizia e chiede l intervento dei mediatori. La domanda può avvenire da chiunque. Per ora solo il Belgio l ha attuata completamente. È possibile per tutti i reati, ma in Italia è difficile da attuare su tutti. Sono stata colpita dalla storia raccontata del Sudafrica, dove per evitare ulteriori conflitti il governo ha deciso di attuare la mediazione. A mio giudizio è un ottima soluzione, spero che nel futuro si applichi maggiormente, perché diminuisce la recidiva e aiuta la vittima nel recupero della normalità, cosa molto cara a quest ultima. Il colloquio di mediazione può aiutare la vittima a superare il trauma del reato di Eva Luisetto, 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato In collaborazione con il progetto carcere, abbiamo avuto la possibilità di incontrare una mediatrice penale. La mediazione penale è ancora un percorso relativamente nuovo, anche se la persona che ci ha parlato ha detto che è stata utilizzata diverse volte. Questo metodo del colloquio è molto utile e soprattutto efficace. Utile per il reo, che può capire maggiormente il suo sbaglio e può pentirsi in modo più autentico e consapevole. Efficace per la vittima, perché questo dialogo può aiutarla a superare il trauma dato dal reato subito, e quando è possibile può anche permetterle di riappacificarsi con il suo aggressore. La mediatrice penale ha detto che è più difficile portare a termine con successo un incontro fra due persone che si conoscono (ad esempio due vicini di casa) piuttosto che tra due individui che non si sono mai visti. Questo forse perché i conoscenti possono provare rancore uno contro l altro da molto tempo ed è più complicato riallacciare i rapporti. Questo nuovo incontro è stato estremamente interessante dal mio punto di vista, perché io sapevo molto poco sulla mediazione penale, ed ora che conosco ed ho potuto approfondire meglio questo metodo, lo trovo molto proficuo ed intelligente da adottare in campo penale. 89
93 Cosa passa nella testa di chi afferra una persona e le punta una pistola QUANDO CHI HA SUBITO UN REATO E CHI LO HA COMMESSO SONO DI FRONTE Se ripenso al rapinatore che mi ha usata come ostaggio per una rapina in banca di Elena Baccarin, insegnante del Liceo scientifico Rogazionisti È una mattina come le altre, qui a scuola. Solita routine tranne per uno scambio d orario per il progetto La Scuola entra in Carcere. Sono in Quinta con i colleghi che si occupano del progetto. Stiamo aspettando che arrivino i detenuti che ci presenteranno la loro esperienza. Gli studenti sono un po emozionati, un po curiosi e mi chiedono qualche consiglio sulle domande che possono fare. Io sono molto tranquilla, non come la prima volta che ho affrontato questo incontro. Mi sento di potere rassicurare i ragazzi con l esperienza di chi ha già potuto appurare di persona che i detenuti sono persone normali e sapendo che dalla porta della classe non entrerà nessun alieno. E infatti così è: entrano le persone che conosco e mi metto ad ascoltare i loro discorsi. I ragazzi a volte fanno domande a bruciapelo e mi allarmano perché sembrano mancare di sensibilità, costringendo a rievocare solo per curiosità personale frangenti di vita che credo dolorosi. Mi spaventa il fatto che siano così fermamente convinti che a loro non accadrà mai di commettere un reato. Ma poi riflettendo penso che, forse, alla loro età la pensavo anche io così perché a 18 anni, in genere, non si sono ancora vissute quelle esperienze che ci portano al fondo di noi stessi e che, in un attimo, potrebbero farci compiere qualcosa di drammatico. Durante il racconto di G. a tratti sono un po assente, penso alle mille cose da fare. I ragazzi cominciano a chiedere sottovoce se conosco il motivo per cui quei signori sono finiti in carcere ed ecco che uno di loro dice di essere stato un rapinatore. Qualcosa inizia ad agitarsi dentro di me, un ricordo non troppo lontano ma che credevo oramai messo da parte. Invece, non è così. Una forte tensione mi assale, mi manca quasi il respiro e vorrei uscire dalla stanza mentre sento il racconto di quello che succedeva durante una rapina tipo ad una banca. Non ci vedo quasi, poi, capisco che l unico modo per riprendermi è proprio approfittare di questa occasione che la vita mi ha posto di fronte in modo così inatteso, proprio quando mi sembrava che non ce ne fosse più bisogno. Sono sempre stata convinta che la vita sia una spirale meravigliosa che attraverso i suoi incomprensibili giri ci pone sempre di fronte a quello che non abbiamo superato, a quello che ci fa paura ma che, con ostinazione, cerchiamo di mettere a lato, rimandando ad un altro momento. Ecco il momento è arrivato. Chi ha subito un reato e chi lo ha commesso sono di fronte, ma più che vittima e colpevole ci sono due persone qualsiasi: io e Nicola. Se ripenso al rapinatore che mi ha usata come ostaggio per una rapina in banca, non riesco a ricordare molto di lui, forse solamente gli strattoni che mi ha dato, le sue imprecazioni urlate al cassiere, il piccolo cerchio gelido della sua pistola puntata sulla mia nuca. Questa, di tutte, è la sensazione di cui ho fatto più fatica a liberarmi. Non mi rie- 90
94 sce di vedere Nicola sotto quella veste, non riesco a immaginare nella veste del rapinatore l uomo che appare qui, davanti a me, così mite. È un momento intenso, fatto di rabbia repressa e di forte emozione. Posso finalmente chiedere alcune cose, per cercare di capire cosa passa nella testa di chi, in quei momenti, a sangue freddo, afferra la prima persona che gli capita davanti e le punta una pistola addosso. Nella mia testa, in quei momenti si alternavano due pensieri a ritmo intermittente: Adesso mi spara se non gli aprono e Non si sente mai che nelle rapine uccidano gli ostaggi. Una consolazione, forse anche se in quei momenti non c è il tempo di riflettere: il tempo si dilata e sembra tutto un sogno e si vorrebbe credere che non sta capitando proprio a noi. Il confronto con Nicola è rincuorante, mi conferma la validità della mia seconda supposizione. Forse è stata solo una mia impressione, ma anche Nicola mi sembrava stupito ed emozionato da questo scambio inaspettato. Succede a tutti i detenuti di cambiare la propria vita? Di voler rimediare? Alla fine dell incontro c è stato un momento molto emozionante perché nell abbraccio che Nicola mi ha dato mi sembrava di avvertire il desiderio quasi di scusarsi, lui per qualcun altro, per quello che mi era successo. È stato l incontro di due estranei che, senza saperlo, avevano in comune qualcosa. Avrei voluto chiedergli molto altro ma non me la sentivo davanti agli studenti e, in seguito, non me la sono sentita di riaprire il discorso. Non mi pareva di avere il diritto di tirare fuori ricordi di un passato che forse bisogna anche lasciare andare prima o poi. E mi chiedo se sia più utile continuare a parlare di un vissuto sbagliato e lontano o se faccia male riportarlo alla luce spesso. In fondo, non è lui che mi ha fatto del male. Chissà cosa ne è stato del vero rapinatore che ha preso me: se ci penso non riesco ad immaginare che possa essere come Nicola mi appare. Continuo a vederlo aggressivo e violento, freddo e implacabile. Senza cuore. Mi chiedo: forse non sono in grado di perdonare? Di dare una seconda possibilità a chi ha sbagliato? Non so se potrei fidarmi di lui. Lo sto scoprendo ora, da persona coinvolta. Succede a tutti i detenuti di cambiare la propria vita? Di voler rimediare? Ho creduto molto nell importanza di questa esperienza tra il carcere e la scuola per il mio desiderio di conoscere, di sapere quello che c è oltre al meccanismo della perfetta vita quotidiana che non trova spazio per reati, vittime e colpevoli. Di solito queste cosa riguardano sempre qualcun altro e ne sentiamo parlare alla tv e sui giornali. Andare in visita in carcere è un esperienza forte che molti dovrebbero fare. Il mio ricordo è fissato sul rumore delle porte che si chiudono man mano che si procede all interno. È la sensazione più intensa che mi è rimasta. E ora, quando mi capita di passare in auto nei pressi del carcere di Padova, mi soffermo sempre a pensare che dentro a quel blocco ci sono tante persone che vivono. Anche in altri momenti, mentre sto per uscire o per fare altre cose mi capita di pensare alla routine del carcere. Prima, non l avrei fatto. E le persone che ho incontrato lì dentro sono solo persone come le altre che vedo all esterno: è molto facile guardare negli occhi di questi uomini e trovarci l umanità, la fragilità, la stessa pasta di cui siamo fatti tutti. Ma, mi chiedo, riuscirei a trovare queste stesse cose negli occhi di quel rapinatore? In certi occhi c è anche qualcosa di sfuggente che inquieta. 91
95 Un tentativo di risposta a una persona che ha subito una rapina UN CONFRONTO CHE MI PUÒ FARE SOLO DEL BENE, ANCHE DENTRO LA SOFFERENZA Conosco bene la parte del carnefice e, ripercorrendo con la memoria alcuni fatti del mio passato, mi rendo conto di quanto male posso aver procurato di Maurizio Bertani Ho avuto modo, frequentando la redazione di Ristretti Orizzonti nel carcere di Padova, di affrontare anche temi delicati e complessi nel corso delle discussioni. Negli ultimi mesi la nostra attenzione si è rivolta ad esaminare in modo più approfondito la sofferenza provocata, con gesti a volte sottovalutati da chi li compie, alle vittime di ogni tipo di reato. Ho avuto modo inoltre di leggere la lettera di una insegnante di una scuola che partecipa al progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere, che si è trovata nella condizione di vittima, essendo stata sequestrata durante una rapina in banca con un arma puntata alla testa e usata dai rapinatori come scudo e deterrente nei confronti degli impiegati. Ho potuto così capire tutta la sua sofferenza e la paura che ha provato. Devo ammettere che come rapinatore questa storia mi ha molto colpito, personalmente non ho mai pensato di collocare fra le vittime anche persone che di fatto sono state coinvolte nell esecuzione di un reato per un caso fortuito, o meglio sfortunato, e invece, sbagliando, ho sempre considerato come vittime solo tutte quelle collegate a reati di sangue Questo scritto mi ha costretto a ragionare e a valutare criticamente il mio modo superficiale di pensare, che mi obbligava a cercare giustificazioni che mitigassero le mie responsabilità. Ma non ne ho trovate, non si può infatti affermare che esista il caso fortuito, almeno nella situazione descritta dalla professoressa. È logico che la rapina riguarda due attori principali, il rapinatore e la banca, ma di fatto dobbiamo riconoscere che esistono molteplici figure che vi prendono parte e sicuramente la loro non è una parte secondaria, pensiamo a tutti gli impiegati, che si trovano all interno dell istituto bancario, ai clienti, che al momento della rapina si trovano in banca, infine a tutti coloro, che vengono coinvolti come vittime di reati collaterali, pensiamo a quelle persone a cui viene rubata l auto per commettere la rapina. Insomma, le figure coinvolte sono tante e tutte subiscono violenza fisica o psicologica, e volere sdrammatizzare non solo è stupido, ma diventa offensivo verso quelle vittime che si sono viste, anche solo per poco tempo, defraudate della propria vita e della propria tranquillità esistenziale. Conosco molto bene la parte del carnefice Personalmente non mi sono mai trovato dalla parte della vittima, conosco molto bene la parte del carnefice e ripercorrendo con la memoria alcuni fatti, mi rendo conto di quanto male posso avere procurato ad una persona tranquilla che esce al mattino da casa salutando magari i suoi cari, e poi verso la fine della mattinata si trova di fronte un individuo armato, 92
96 che per quanto autocontrollo possa avere, sicuramente urla, è agitato, punta un arma e prende in ostaggio, seppur momentaneamente, tutti i presenti. Ho rivissuto attraverso la lettera di questa insegnante i mille volti e le mille paure che ho incontrato nel corso della mia dissennata vita, e che superficialmente giustificavo a me stesso come paure momentanee e da relegare esclusivamente allo spazio e al tempo del reato, non rendendomi conto dell impatto psicologico che chi subisce tali violenze si porta dentro nel tempo. Una rapina può porre la persona che l ha subita in uno stato di timore e paura di fronte a qualsiasi situazione, anche la più banale come un eccessivo trambusto o un alzar di voci, insomma credo si finisca per essere estremamente condizionati nei rapporti sociali, e provare un angoscia che diviene allo stesso tempo un mal di vivere, e tutto questo per una violenza subita. Allora mi chiedo: valgono oggi le mie scuse a tutte quelle persone che ho trasformato in vittime? sicuramente sì, se non fosse per la paura che vengano travisate come frutto di una scelta opportunistica, che è poi il senso di malessere che mi impedisce di porle. Sicuramente posso dire che l imparare a parlare, o meglio a dialogare, anche dentro un contesto particolare come la redazione di Ristretti, mi ha aiutato a rapportarmi e a confrontarmi con gli altri, siano essi detenuti, volontari, studenti, o la professoressa, che tramite il suo scritto ha dato l avvio a mille domande e ad altrettante risposte, aprendo con me un dialogo che mi ha portato a ragionare in modo meno leggero e superficiale. Ho imparato che le vittime di qualsiasi reato subiscono violenza, e che la violenza incrementa nell animo umano l odio. Che, per un autore di reati, sentire le vittime che parlano del loro odio per la violenza subita da una parte non è piacevole, e può essere un sentire pesante, ma se questo confronto mi consente di conoscere le loro sofferenze, se questo mi porta a ragionare, e a fare valutazioni fino ad oggi mai fatte, allora mi convinco sempre più che questo confronto può fare a me solo del bene, anche dentro la sofferenza. PER UNA VOLTA MI SONO TROVATO COL PENSIERO DALL ALTRA PARTE DI UN ARMA Non vi è ragionamento che possa compensare lo stato di malessere di una vittima, si può solo provare un totale smarrimento di fronte a lei. E non c è neppure nessuna scusante che giustifichi da parte dell autore il suo reato di Sandro Calderoni Sono un detenuto e svolgo attività di volontariato all interno di questa redazione da ormai parecchi anni. E tra le varie cose che di solito si fanno in un ambiente dove si produce e si riceve informazione, visto il contesto particolare in cui ci troviamo, cerchiamo anche di far conoscere come realmente è il carcere e chi ci sta dentro. Quattro anni fa è iniziato il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere, proprio perché si voleva dare ai giovani un idea del carcere come è visto da chi lo vive da dentro e inoltre fornire delle conoscenze che permettessero loro di valutare e considerare il carcere senza tutti quei luoghi comuni che media, film e altri tipi di informazione tendono a disegnare. 93
97 Man mano che il progetto andava avanti, mi rendevo conto che ha mutato molto anche il mio atteggiamento, perché la curiosità e la voglia di conoscere dei ragazzi è disarmante, al punto da portarmi spesso a confrontarmi con il mio passato. E mi sono accorto così che anch io avevo i miei luoghi comuni, le mie convinzioni e i miei falsi idoli, e, importante per me, mi sono reso conto che questa esperienza mi sta arricchendo molto, proprio grazie al fatto che nel confrontarmi con persone che vengono da fuori, come gli studenti e gli insegnanti, scopro dei punti di vista, dei ragionamenti e delle esperienze che mi pongono in una prospettiva che, sotto molti aspetti, oltrepassa il senso egoistico e opportunistico della propria visione della vita. Questo pensiero si è rafforzato quando ho letto l articolo di Elena Baccarin, un insegnante che ha raccontato la sua esperienza come vittima di una rapina in banca, ha descritto il suo stato d animo quando era in ostaggio del rapinatore, i pensieri che le passavano per la testa e il timore di morire per una volta mi sono trovato dall altra parte di un arma e sono stato davvero male. Mi sono reso conto che persone, che conducono la loro vita serenamente, si vengono a trovare a volte in situazioni totalmente al di fuori dai loro schemi, nelle quali senza colpa si ritrovano in balia di un altra persona, che per raggiungere un suo scopo non esita a rompere l armonia altrui. Non vi è ragionamento che possa compensare lo stato di malessere di una vittima, si può solo provare un totale smarrimento di fronte a lei. E non c è neppure nessuna scusante che giustifichi da parte dell autore il suo reato. Quello che c è invece quasi sempre é solo una leggerezza, un indifferenza al valore della persona che possono unicamente mortificare e deludere chi subisce reati. Prima non vedevo questo, ero un rapinatore, in particolare un rapinatore di banche, e nonostante la gravità del reato in sé, ero convinto che prelevando denaro, con un arma in mano per spaventare gli altri, in sostanza non recavo un particolare danno psicologico alle persone che assistevano al fatto, anche perché, con una certa presunzione, ero sicuro che non avrei mai fatto del male se non fossi stato in pericolo io stesso. Ora non sono più convinto di questo, ora capisco che solo per il fatto di avere un arma in mano vuol dire che mettevo in conto anche di doverla usare. Non so se questa mia consapevolezza, riassunta in queste poche righe, che mi è stata donata dal racconto della professoressa, possa ridare un po di serenità e tranquillità a lei, credo che non vi sia una ricetta per questo, ma so, comunque che grazie a lei forse ho cominciato a capire come si sente una vittima di un reato. 94
98 Capitolo 5 UN PERCORSO SULLA GIUSTIZIA In un progetto sperimentale come questo, che cerca strade nuove per affrontare problemi vecchissimi come quello della legalità e della devianza, è importante confrontarsi anche con la teoria, portandola fuori dai libri, per umanizzarla. Così, a parlare agli studenti di reati, processi e pene abbiamo chiamato degli addetti ai lavori : una docente universitaria, dei Magistrati di Sorveglianza, un Pubblico Ministero scrittore, il cappellano di un carcere minorile che è anche responsabile di una comunità per giovanissimi autori di reato, il Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura, dei trattamenti e delle pene inumane e degradanti. E abbiamo chiesto loro di abbandonare il linguaggio complicato della loro professione, e di provare a raccontare la Giustizia ai ragazzi. 95
99 96
100 LA GIUSTIZIA MINORILE Elisabetta Palermo, docente di Diritto penale dell Università di Padova, esperta di Diritto minorile, ha incontrato alcune classi per raccontare come funziona la Giustizia minorile Cercherò per prima cosa di delineare le norme del sistema penale che disciplinano in Italia le risposte alla commissione di un reato da parte di un soggetto minorenne. Precisando che si considera tale chi, al momento della commissione del reato, ha un età inferiore agli anni diciotto. In realtà io insegno anche diritto penale per i reati commessi dagli adulti, e quindi cercherò di evidenziare la differenza tra la disciplina prevista per l autore minorenne e quella per l adulto, spiegandovi però realisticamente quali sono le scelte che i giudici fanno attualmente di fronte alla commissione del reato. Questo incontro dovrebbe servire non certo ad aggiungere alla vostra conoscenza delle nozioni teoriche, quanto piuttosto a cercare di farvi riflettere su che cosa possa significare crearsi un progetto di esistenza, cioè fare delle scelte, soprattutto cercare di immaginare chi siete e che cosa volete per voi stessi, al di là delle scelte che riguardano il vostro quotidiano che fugge molto velocemente e quindi che cosa può capitare quando si infrange la legge penale. E soprattutto riflettere sulla vostra esistenza non nell immediato futuro, ma nella proiezione di quando diventerete adulti. Perché dico questo? Perché certamente la commissione di un reato, anche da parte di un soggetto che ha meno di 18 anni, è uno degli aspetti più drammatici dell esistenza di una persona. Il carcere è un posto di dolore terrificante, come l ospedale e come tutti i luoghi dove esiste la segregazione da sé e dalla propria vita: la sanzione prevista dal nostro ordinamento a fronte della commissione di un reato è, di norma, infatti, la pena detentiva che consiste nella privazione totale della libertà personale. Ma stare in carcere non significa solo dover rimanere dentro ad una cella con la polizia penitenziaria che vi controlla, è molto peggio, è molto di più. Il carcere significa perdere la propria identità di esseri umani, non avere desideri, sogni, perché tutto ciò che ci è permesso di fare viene deciso da un istituzione. Ecco perché dobbiamo chiederci che cosa significa commettere un reato e perché la realtà di chi lo commette è così grave. Voi sapete cos è un reato? Parliamo di commettere un fatto che è previsto da una norma penale. Qualcuno di voi ha idea di cosa sia una norma? Anche la legge morale che dice di non uccidere il proprio fratello è una norma, ma qual è la differenza tra la norma giuridica e una qualsiasi norma morale od etica? Anche nel vostro gruppo di amici avete delle norme non dette da rispettare, e se qualcuno non lo fa, ne subisce la conseguenza: viene espulso dal gruppo, viene meno all amicizia. Quando è possibile dire che il comportamento posto in essere ha violato una norma 97
101 giuridica? Quando ne paghiamo una conseguenza che ci può essere imposta con la forza riconosciuta giuridicamente, cioè la forza del diritto alla quale noi non ci possiamo opporre, e quindi quando per la sua realizzazione viene applicata una sanzione. Ebbene, quando tale comportamento realizza un fatto che la società dove viviamo considera di particolare gravità, in quanto offende beni essenziali di singoli individui e/o di tutta la collettività, tale fatto è previsto dalla legge come reato ed è punito per lo più con la più grave delle sanzioni, ossia la pena detentiva. Questo vale indifferentemente sia se questo reato venga commesso da un soggetto che ha meno di diciotto, che più di diciotto anni. Quando io violo la norma del testo unico sugli stupefacenti, e quindi commetto un azione che la legge prevede come criminosa, anche se di gravità diversa, come lo spaccio o la cessione di uno spinello, sono responsabile per la commissione di un reato. Si considera che la circolazione della droga sia dannosa non solo per chi la consuma, ma anche per l indotto di criminalità che poi genera insicurezza sociale. Il diritto penale per l autore di reato che ha meno di diciotto anni Passiamo ora a spiegare qual è la differente disciplina, contenuta nel nostro sistema penale, per l autore di reato che ha meno di diciotto anni e quello maggiorenne. Quando parliamo di diritto penale che riguarda i minori, parliamo di fatti commessi da chi ha un età inferiore agli anni diciotto, con differenti previsioni per chi ha meno di 14 anni e per chi ha un età compresa fra i 14 ed i 18 anni. Prima dei 14 anni c è una presunzione di non imputabilità, in quanto per il nostro sistema penale l infraquattordicenne non è sufficientemente maturo per comprendere appieno il significato negativo dei suoi comportamenti e per autodeterminarsi liberamente alla commissione del reato, di conseguenza il diritto penale non lo punisce. Per l autore di un fatto previsto come reato che ha un età compresa fra i 14 ed i 18 anni il giudizio di imputabilità viene fatto di volta in volta dal Giudice e solo qualora tale soggetto venga riconosciuto maturo al momento della commissione del fatto, venga cioè considerato capace di cogliere il significato negativo del suo comportamento e libero di deciderne la sua realizzazione con un sufficiente grado di autonomia, può essere considerato imputabile e, di conseguenza, responsabile. Anche al soggetto non imputabile per età in quanto ha meno di 14 anni o per immaturità quando ha un età fra i 14 ed i 18 è possibile tuttavia applicare una sanzione diversa dalla pena che talvolta é di discreta gravità; si tratta della misura di sicurezza che si applica anche ad un infraquattordicenne, se c è un giudizio di pericolosità sociale, e che dura finché dura la pericolosità del soggetto. È vero dunque che l infraquattordicenne non può essere punito con una sentenza di condanna ad una pena detentiva, però anche per lui possono scattare le misure di sicurezza se c è un giudizio di pericolo di ripetizione del reato. Le misure di sicurezza attualmente previste per i minorenni, sia che abbiano meno di 14 anni o un età compresa fra i 14 ed i 18 anni, sono due: la libertà vigilata, eseguita nelle forme delle prescrizione o della permanenza in casa, ed il riformatorio giudiziario, eseguito nella forma del collocamento in comunità. Poi vedremo cosa sono le comunità e l importanza fondamentale che hanno nel sistema penale minorile. 98
102 Chi giudica i ragazzi che hanno meno di diciotto anni? Chi giudica un soggetto che ha meno di 18 anni? Per i reati commessi dagli adulti la competenza a giudicare appartiene a organi giudiziari diversi, a seconda della gravità del reato. In primo grado la competenza è distribuita fra il Tribunale in composizione monocratica, composto da un giudice unico che è chiamato a giudicare i reati meno gravi; il Tribunale in composizione collegiale, composto da tre giudici (un presidente e due giudici a latere) ed è competente per i reati più gravi; la Corte di Assise, che giudica alcuni reati di particolare gravità ed è composta da sei giudici popolari, cioè comuni cittadini che vengono scelti all interno di elenchi compilati seguendo particolari procedure, e da due giudici togati, il presidente ed un giudice a latere. Vi è infine una competenza residuale, per alcuni reati considerati di minore gravità, ed appartiene al Giudice di Pace. In secondo grado la competenza è attribuita alla Corte d Appello ed alla Corte d Assise d Appello. Ebbene quando il reato è commesso da chi ha meno di 18 anni, c è un unico organo giudiziario che ha competenza esclusiva in primo grado ed è il Tribunale per i minorenni, mentre in secondo grado la competenza è attribuita alla sezione minorile della Corte d Appello. I Tribunali per i minorenni hanno una competenza territoriale che abbraccia orientativamente il territorio di una regione, essi sono infatti costituiti presso ogni sede di Corte d Appello o presso ogni sezione di Corte d Appello. La circoscrizione del Tribunale per i minorenni coincide, dunque, con quella della Corte di Appello, o della sezione di Corte d Appello presso cui è istituito; ciò significa che, di norma, la competenza copre l ampiezza di un territorio regionale; salvi i casi di alcune regioni che hanno più sedi o della Valle d Aosta dove non esiste una Sezione di Corte d Appello e quindi non vi è neppure il Tribunale per i minorenni e la competenza per quel territorio è attribuita al Tribunale per i minorenni del Piemonte. Va poi precisato che la competenza per territorio si determina tenendo conto del luogo dove il reato è stato commesso. Il che significa, per esempio, che qualsiasi reato commesso nel Veneto da un soggetto di età inferiore agli anni diciotto, verrà sempre giudicato dal Tribunale per i minorenni di Venezia, perché nel territorio del Veneto il capoluogo è Venezia, la Corte di Appello è Venezia e quindi anche il Tribunale per i minori è a Venezia. Dobbiamo chiederci ora le ragioni che sottendono la previsione di un giudice specializzato per gli autori di reato minorenni. Si tratta di una scelta antica che risale lontano nel tempo, al 1934 quando per la prima volta in Italia, come nel resto d Europa, si comincia a parlarne e ad elaborare e concepire una risposta al reato commesso da un soggetto minore. Non solo punire, ma anche prendesi carico dell autore di reato Che cos era successo alla fine dell 800 e ai primi del 900 da spingere tutti i legislatori europei e anche transcontinentali (perché nascono in America le prime corti giovanili) a decidere che il minorenne va trattato diversamente dall adulto? È successa una cosa molto semplice che ci aiuta a capire come il diritto non nasce dal nulla, ma dall elaborazione, dalla crescita della cultura e dalla comprensione e consapevolezza dei fenomeni umani: si era sviluppata una scienza che prima non esisteva, cioè la criminologia. Per la prima volta anziché concepire il reato come un fatto negativo, meritevole di una pena e basta, si comincia a pensare che il reato stesso possa essere anche l indicatore di un grave 99
103 disagio personale e/o sociale, in quanto chi lo commette probabilmente ha alle spalle dei problemi. Si ritiene dunque che quando viene commesso un reato non vi sia una persona cattiva da giudicare, bensì una persona che ha avuto dei percorsi di vita complessi, difficili, problematici e quindi il diritto penale, per essere un buon sistema, non può pensare solo a punire chi lo ha commesso, ma deve anche prendersi carico del suo autore sia per evitare che ricada nella commissione dell illecito penale (la c.d. recidiva), sia per consentirgli, una volta pagato il suo debito con la giustizia, di reintegrarsi completamente nel contesto sociale. Ebbene, nascendo la criminologia come scienza, nasce anche la distinzione fra varie tipologie di autori di reato. Si sviluppa lo studio dell autore delinquente, e fra queste tipologie ce ne sono due che particolarmente emergono e si impongono a tutti i legislatori: il minorenne, perché ci si rende conto che commettere un reato in età evolutiva è una scelta diversa che commetterlo in età adulta, e colui che commette il reato perché infermo di mente. C è un libro bellissimo di Foucault, un grande filosofo francese, che vi aiuta a capire cos era il sistema penale prima del diritto penale moderno, basato sul sorvegliare e punire; ebbene, se voi andate a leggere questo libro, che si intitola appunto Sorvegliare e punire, vi renderete conto che prima della nascita di un diritto penale che si apra all uomo e cerchi di recuperare l autore del reato e non semplicemente di distruggerlo e di espellerlo dal proprio contesto perché ritenuto dannoso, le carceri erano un contenitore. Chi era malato di mente finiva in carcere esattamente come una persona sana, e tutti gli autori di reato convivevano all interno di queste grandi strutture, nelle quali veniva sistematicamente violata la dignità umana dei soggetti reclusi. Ebbene, è chiaro che quando un sistema penale si apre all autore del reato e non soltanto al fatto dannoso, comincia a preoccuparsi di queste due tipologie di soggetti: colui che commette il reato perché infermo di mente, colui che commette il reato perché adolescente, e quindi ritiene necessaria una risposta diversificata. La necessità di un giudice specializzato A questo punto fermiamoci a capire che cosa succede per i minori: la prima decisione che emerge e si impone è proprio quella di creare un giudice specializzato, proprio per evitare che i minori vengano giudicati come se fossero degli adulti. Si prevedono le Corti giovanili che nascono alla fine dell 800 in America e subito dopo vengono istituite in tutta Europa. Da noi viene istituito il Tribunale per i minorenni. Si tratta di un organo giudiziario composto da quattro persone fisiche, due giudici di carriera, cioè magistrati che studiano diritto e devono superare un concorso molto difficile, quindi conoscono molto bene la legge; uno di questi due magistrati funge da Presidente. Accanto a questi due magistrati ci sono due giudici onorari che sono due cittadini, necessariamente un uomo ed una donna, scelti tra esperti delle problematiche dell età evolutiva, in psicologia, pedagogia, anche biologia e criminologia. Per la loro nomina c è una selezione molto rigorosa: devono avere più di trent anni, dimostrare di avere esperienza e buona conoscenza in questo settore, vengono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, organo composto prevalentemente da magistrati e da esperti di diritto che esprime una notevole competenza essendo l organo di autogoverno della Magistratura. 100
104 Il ruolo dei giudici onorari all interno del Tribunale per i minorenni è fondamentale: i giudici onorari devono aiutare i giudici cosiddetti togati a valutare la personalità dell adolescente, a capire perché quel ragazzo in un determinato momento abbia commesso un reato, quali erano i suoi problemi, i suoi bisogni, quale è stata la spinta a commettere il reato. Si tratta di una valutazione necessaria sia al fine di esprimere un giudizio sulla maturità del minore stesso - e quindi sulla sussistenza o meno dell imputabilità richiesta per procedere alla punibilità -, sia al fine di individuare una risposta da dare al reato commesso che sia atta a conciliare le esigenze del sistema penale con la preservazione degli interessi educativi del suo autore. I diritti dei ragazzi nella Convenzione O.N.U. L iter che ha portato all attuale assetto del Diritto Penale minorile inizia, come abbiamo già visto, nel 34, prosegue, con l arricchimento della componente onoraria, nel 56; però è solo nel 1988, quindi in tempi relativamente recenti, che si sviluppa e si esprime nella logica piena di dare sempre e comunque la prevalenza agli interessi educativi del minorenne. Prima di tale data erano percorribili solo due vie per evitare la pronuncia di una sentenza di condanna a carico del minorenne. Una possibilità era costituita dalla sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilità, che il giudice poteva pronunciare anche nei confronti di un soggetto maggiore di 14 anni al momento della commissione del fatto, purché lo considerasse non sufficientemente maturo nel momento in cui lo aveva commesso tuttavia alla sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilità si poteva accompagnare l applicazione di una misura amministrativa che per molti minori era peggiore del carcere, l altra possibilità era costituita dalla sentenza di estinzione del reato per concessione del perdono giudiziale. Il perdono giudiziale era l unico istituto, presente nel nostro codice, che permetteva ai giudici minorili di non applicare la pena, ma il perdono giudiziale, che è tuttora in vigore, riguarda per lo più un soggetto incensurato, che non ha commesso altri reati, ed il reato per il quale si procede non deve essere grave, in quanto si deve trattare di un reato passibile di una pena detentiva non superiore a due anni, il giudice si deve inoltre convincere che in futuro quel soggetto non commetterà nuovi reati, si deve trattare cioè di un autore occasionale, considerato come colpevole di un incidente di percorso, ma che nella realtà è un soggetto ben integrato. Al di fuori di queste previsioni non erano contemplate risposte diversificate per il reato commesso da un minore di età rispetto a quanto previsto per gli adulti, fatta salva comunque una possibile riduzione di pena fino ad un terzo di quella da infliggere (articolo 98 Codice penale) e l elevazione fino a tre anni della pena sospendibile condizionalmente. La svolta, che dà vita al moderno diritto penale minorile, si realizza a livello mondiale già nel 1985, grazie all emanazione, da parte dell Organizzazione delle Nazioni Unite, delle c. d. Regole di Pechino, ossia delle raccomandazioni in ordine alle regole minime per l amministrazione della giustizia penale minorile che tutti gli stati aderenti avrebbero dovuto rispettare. L Organizzazione delle Nazioni Unite, nata nel 1948, è fondata sulla Dichiarazione universale dei diritti dell uomo. Ora ragazzi, voi vivete in un momento storico in cui date per scontato che essendo degli esseri umani, delle persone, siete portatori di alcuni diritti fondamentali che vanno 101
105 rispettati, quei diritti voi li sentite come vostri e non volete che nessuno ve li tocchi. Diamo pure per scontato il diritto alla vita, il diritto alla vostra incolumità individuale, il diritto al vostro patrimonio, il diritto alla vostra libertà personale. Si tratta dei diritti cosiddetti di prima generazione, cioè quei diritti talmente ovvi, talmente radicati nella consapevolezza di ogni essere umano, che forse non c era neanche tanto bisogno di proclamarli a livello di dichiarazione universale dei diritti dell uomo. La novità sul piano internazionale è costituita dalla proclamazione dei cosiddetti diritti di seconda generazione, sui quali in passato non si è mai riflettuto abbastanza, e forse nemmeno si era arrivati a concepirli in tutta la loro importanza. Il primo diritto fondamentale che comincia ad emergere è quello che riguarda la dignità delle persone, il diritto al rispetto della loro personalità, alla loro libertà, non soltanto intesa come una libertà di movimento, ma soprattutto come libertà personale e morale, che si traduce nel diritto di ognuno di noi di realizzarsi come persona con parità di diritti, in una società in cui ciò che conta non deve essere la ricchezza economica, ma la persona con tutta la sua ricchezza, interiore, spirituale ed umana. Ecco che allora quando nascono le Nazioni Unite si comincia a lavorare a livello internazionale per elaborare leggi buone che siano effettiva espressione di questo rispetto dei diritti fondamentali. Le Nazioni Unite hanno lavorato molto anche per la tutela dei diritti dell infanzia e nel 1989, qualche anno dopo l emanazione delle Regole di Pechino, hanno prodotto una Convenzione rivolta più in generale alla enunciazione di tutti i diritti fondamentali dell infanzia, di tale portata da costituire attualmente una sorta di Costituzione fondamentale per qualsiasi soggetto in età evolutiva. Questa Convenzione tutela tutta la fascia non solo dell infanzia, ma di tutti i soggetti in età evolutiva, per cui si considera infante, ai fini della Convenzione, chi ha meno di 18 anni. All interno della stessa vi sono alcuni articoli (articoli 37 e 40), dedicati all autore di reato minorenne, dove vengono recepite le raccomandazioni contenute nelle Regole di Pechino, dando vita ad un radicale rinnovamento del diritto penale minorile in tutto il mondo. Qual è il principio che esprime la Convenzione O.N.U. in generale? Il principio è quello che deve esserci un maggiore interesse, per un soggetto che ha meno di 18 anni, alla sua educazione, alla formazione della sua personalità. Interesse che deve prevalere anche su altri interessi dello Stato, e allora come si cala tutto questo in termini di diritto penale minorile? Direi che si esprime con un principio fondamentale, che è quello poi che si travasa nella nostra riforma dell 88: di fronte all interesse del minore alla sua educazione, lo Stato talvolta può anche rinunciare all applicazione della pena. 1988: La riforma del sistema penale minorile I principi contenuti nei su enunciati documenti internazionali vengono recepiti nel nostro ordinamento da due importanti testi normativi e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dal decreto legislativo n. 272 del 1989, si tratta delle disposizioni relative al processo penale a carico di imputati minorenni e delle relative disposizioni di attuazione. Il sistema penale minorile nel 1988 viene modificato e viene costruito su alcuni principi fondamentali: il minore è un soggetto in età evolutiva e in quanto tale va trattato 102
106 anche quando ha commesso un reato, partendo dal presupposto che il più delle volte il reato stesso è espressione della difficoltà tipica della sua età; la risposta al reato deve essere sempre rivolta anche alla ripresa del suo percorso di sviluppo educativo, ma la comprensione non deve significare pura clemenza e perdono, bensì deve servire ad avviare un percorso educativo che, se arriva a buon termine, può portare anche alla rinuncia all applicazione della pena da parte dello Stato. Ma qual è il patto che viene siglato fra l adolescente autore del reato e lo Stato, e a quali condizioni? Lo Stato può e deve rinunciare all applicazione della pena nei confronti di un soggetto che ha commesso reati in età evolutiva, a condizione che questo soggetto si impegni in un percorso educativo in cui, con lealtà, rispetti gli impegni che ha preso e quindi collabori con chi lo deve affiancare nella ripresa del suo percorso, fino ad arrivare a quella condizione che lo Stato gli pone, perché come per gli adulti, anche per i minori nessuno vuole entrare nelle vostre coscienze e chiedervi di pensare con la testa di un altro. Questo sarebbe il tradimento di un vero progetto educativo, non è questo che vi viene chiesto all interno del diritto penale minorile, ma unicamente di interiorizzare la necessità del rispetto della legalità. Se noi viviamo in una società organizzata, e lo Stato lo è per eccellenza, che ci consente di vivere associati come esseri umani, dobbiamo rispettare le leggi che questa società si dà. Perché le dobbiamo rispettare, solo per la paura della sanzione, solo per la paura della pena? Questo è poco, non basta, dobbiamo rispettarle perché ci convinciamo che l unico modo per vivere veramente bene insieme, nel rispetto reciproco, è quello di rispettare le leggi che ci siamo dati. Qualcuno può dire che la legge non l ha fatta lui, ma se l è trovata calata dall alto, imposta da un legislatore che non conosce, noi però viviamo in un paese democratico, e quindi, una volta che queste regole sono state fatte, sono l espressione di coloro che abbiamo eletto per rappresentarci, e allora, anche se questa regola talvolta non ci piace, la dobbiamo rispettare. Qual è l unica cosa che possiamo e dobbiamo fare perché uno dei principi fondamentali della democrazia sia la libertà di pensiero? Noi possiamo, in maniera civile senza l uso della violenza, darci da fare perché la legge sia cambiata, promuovendo un opinione pubblica che esprima tale convinzione. La messa alla prova dell autore di reato minorenne Qual è questo istituto che permette di non applicare la pena a un soggetto in età evolutiva? È un istituto fondamentale, molto importante, di tradizioni anglosassoni che voi conoscete per sentito dire con il termine probation, che significa ti metto alla prova, io voglio darti una chance in più, anche se hai sbagliato e meriteresti la punizione la prima cosa che voglio fare è darti fiducia perché tu capisca che, pur avendo sbagliato, ti do la possibilità di rimediare ricominciando da capo. Questo istituto del sistema penale minorile si chiama sospensione del processo e messa alla prova. Il giudice del Tribunale per i minorenni sospende il processo, sulla base di un progetto educativo elaborato dai Servizi sociali minorili insieme ai Servizi sociali degli Enti locali, in collaborazione con lo stesso minore, perché nel progetto devono essere previsti gli impegni che il minore assume, impegni di studio se il ragazzo va a scuola, lavorativi se sta lavorando, ma anche di tutta la gestione del tempo libero. Il periodo di messa alla prova serve proprio per consentire al minore di confrontarsi con gli adulti di 103
107 riferimento, i Servizi sociali, ma anche gli insegnanti o i datori di lavoro, anche coloro che lavorano nel volontariato, se il tempo libero deve essere speso nelle associazioni di volontariato. In questo periodo di messa alla prova il minore è costretto a confrontarsi con se stesso e con gli adulti di riferimento per capire quale direzione vuole dare alla propria vita, perché se lui rispetta il progetto ed è leale, alla fine del periodo di messa alla prova nel corso dell udienza che deve essere fissata per valutare la personalità del minore all esito del periodo di prova, se il giudice si convince che c è stata un evoluzione positiva della personalità, il reato viene dichiarato estinto, significa che viene cancellato. Cosa succede però se l adolescente, che si è impegnato in un percorso di ripresa dei suoi processi educativi, tradisce la fiducia che gli è stata data, trasgredendo le prescrizioni o comportandosi comunque male, e non c è quindi la possibilità di quel giudizio di evoluzione positiva della sua personalità? Succede che si ritorna al processo e si arriva alla sentenza, per cui anche il soggetto adolescente molte volte, io direi attualmente il più delle volte, subisce la sentenza di condanna. Attenzione, che la condanna anche per l adolescente significa sempre comunque carcere. Abbiamo la sospensione condizionale della pena, che è un istituto che permette di non applicare la pena se è contenuta entro i tre anni trattandosi di autore di reato minorenne, ma la condanna con sospensione condizionale della pena costituisce un precedente, il che significa che rimane segnata nel casellario giudiziale. La fedina penale sporca è un precedente difficile da lavare Cosa succede se questo soggetto da adolescente, o da adulto commette un altro reato? Attualmente vi garantisco che succede una conseguenza pesantissima, prospettatevi questa evenienza: io subisco una sentenza di condanna per spaccio, la sentenza viene sospesa condizionalmente per cui in carcere non ci vado, ma rimane segnata nel casellario giudiziario. Divento adulto, comincio a lavorare, voglio rigare dritto, voglio avere una vita buona, ma mio malgrado (e può succedere), magari da piccolo imprenditore non mi accorgo che sto violando una qualche legge economica, e commetto un altro reato, il giudice che mi condannerà avrà a disposizione i miei documenti che certificano che non sono incensurato, che ho un precedente, e allora, probabilmente applicherà l aggravante della recidiva, che attualmente è diventata un aggravante pesantissima, perché automaticamente prevede un aumento di pena, e comporta la perdita di tanti benefici, compreso quello della sospensione condizionale della seconda pena. Quindi io, che ero convinto di aver cominciato un percorso di ripresa, mi ritrovo mio malgrado con questo fantasma della vecchia condanna che riemerge, non ho scontato il carcere, ma mi è rimasto come precedente e mi ha sporcato la fedina penale, e la fedina penale sporca diventa un precedente difficilissimo da lavare completamente. Ecco perché il sistema penale minorile ha cercato di concepire strumenti che evitino l applicazione della pena, nella consapevolezza che, se vogliamo far ripartire a bocce ferme un adolescente che ha commesso un reato, cioè con gli stessi diritti di qualsiasi altro soggetto, dobbiamo evitare anche il precedente penale della sentenza di condanna, perché altrimenti questi vedrà pregiudicato il suo futuro, non potendo avere pienamente tutti i diritti di chi in realtà un reato non l ha mai commesso. 104
108 Non sottovalutiamo mai le conseguenze delle nostre azioni! La messa alla prova comunque non ha limite, può essere applicata sempre, quale che sia la gravità del reato commesso. Ovviamente esistono alcune condizioni perché questo istituto sia applicato: ci vuole l impegno del minore, ma ci deve essere un contesto sociale di supporto familiare, che dia veramente al giudice garanzie che la messa alla prova venga fatta davvero bene. Ma se il giudice non ha queste garanzie, cosa fa? preferisce condannare e mandare in carcere. Ora, il carcere minorile è completamente diverso dal carcere per adulti, perché una delle importanti riforme successiva all 88 è stata proprio quella di prevedere istituti penitenziari separati da quelli degli adulti, con una capienza nettamente inferiore e con una presenza altissima di educatori, che hanno davvero la voglia di aiutare i minorenni ad uscire dal loro problema. In ogni caso, se si è commesso il reato prima dei 18 anni, si resta in un carcere per minori fino al 21esimo anno di età, perché ci si rende conto che la fascia più trascurata, quella che avrebbe bisogno di più considerazione, non è soltanto quella dei minorenni, ma anche quella dei cosiddetti giovani adulti, cioè dai 18 ai 21 anni, che sono ancora in una fase di transizione adolescenziale. Comunque nel giorno stesso del compimento dei 21 anni, vi è il trasferimento nel carcere per adulti. La messa alla prova è comunque un percorso di rinascita che, cancellando il reato, è interamente affidato alla voglia reale dell adolescente di uscire dalla devianza: chi vuole ce la fa e ce la può fare, perché con il progetto di messa alla prova io ho visto gente che aveva commesso omicidi, o rapine aggravate, ricominciare davvero riprendendosi la propria vita in mano. Questi progetti di messa alla prova il giudice li approva a condizione che l interlocutore sia un adolescente che abbia la voglia di fare, se invece l adolescente rifiuta di collaborare, morde la mano di chi lo vuole aiutare, il suo percorso inevitabile sarà quello del carcere. Noi oltretutto partiamo dal presupposto che la messa alla prova dovrebbe implicare una famiglia dove tornare, perché altrimenti come si fa a stare alla prova se non c è una casa dove vivere? Nel caso in cui non ci sia una famiglia di riferimento, c è la possibilità di un collocamento in comunità polivalenti dove si eseguono tutti i provvedimenti che riguardano i minori, quindi, oltre ai progetti di messa alla prova, le misure cautelari, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, le misure amministrative ed i provvedimenti civili a tutela del minore. La scommessa è che chiunque lo voglia ce la può fare, perché ogni vita è irripetibile ed ha un valore enorme, e quindi non può essere buttata via, perché, se noi non partiamo da questo presupposto, cioè che ogni essere umano ha diritto di avere una seconda possibilità e comunque quel poco di bene che può cogliere, non vedo perché devo fare differenza fra lo spacciatore o l omicida. In via conclusiva sento di dovervi ripetere che la scelta di fondo è quella di assumere i valori sui quali vogliamo costruire la nostra vita, sin da quando siamo adolescenti, di preservarci come persone, di prendere per buono ciò che la vita ci può dare, e quindi pagare quell unico prezzo che ci viene chiesto, cioè il rispetto della legalità. L alternativa è che, pur di fare ciò che ci passa per la testa sotto l impulso di sentimenti di onnipotenza, come spesso succede agli adolescenti, convincendoci di potere tutto, sottovalutiamo completamente le conseguenze delle nostre azioni, compromettendo un intero progetto di vita. 105
109 FARE CON I RAGAZZI UN OPERA DI CHIARIFICAZIONE RISPETTO AI MESSAGGI DEI MASS MEDIA Sarebbe interessante avviare un discorso sulle alternative al carcere, se queste alternative sono possibili, e quali, secondo le esperienze dei ragazzi, potrebbero essere di Paolo Canevelli, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia Credo che il tema che vada messo al centro di progetti, come quello avviato tra scuole e carcere a Padova e che si tenta di replicare a Roma, non sia soltanto il carcere: bisognerebbe più in generale parlare della pena. Sono convinto infatti che il tema centrale sia proprio quello della pena, perché parlando a degli adolescenti il carcere è una realtà che comunque non viene immediatamente in evidenza nei rapporti tra di loro. Tra adolescenti credo che occorra considerare quali sono i rapporti più frequenti, evidenziare e sottolineare ad esempio i rapporti di violenza e sopraffazione fra ragazzi, e come questi rapporti di sopraffazione e violenza vengono vissuti. Perché dico che bisogna partire dalla relazione che si costruisce fra adolescenti? Innanzitutto perché siamo più vicini ad un tema che i ragazzi vivono quotidianamente. Il tema del bullismo, della sopraffazione spicciola in classe, di quello che si frega la merenda del compagno che è una banalità solo perché ha un fisico più imponente, o perché l altro è più piccolino o vergognoso e non dice niente all insegnante, è già un tema che ci mette direttamente di fronte alla questione della delazione, della denuncia, della polizia. Sono argomenti che secondo me prendono molto gli adolescenti, e credo che gli adolescenti affrontino tali temi con grande imbarazzo, con grande difficoltà, nel senso che a mio avviso non ne parlano nemmeno fra di loro, perché la denuncia è una cosa brutta, perché la delazione è una cosa che non si fa, perché la polizia a volte è il nemico comune. Semplifico, ovviamente, perché non è per tutti così e non tutti la pensano allo stesso modo, però credo che l atteggiamento violento e la reazione agli atteggiamenti violenti e di sopraffazione che ci sono negli adolescenti, quindi l atteggiamento passivo di chi subisce e sta zitto, e l atteggiamento reattivo di chi invece risponde e magari forma un proprio gruppo di risposta e da qui credo che nascano poi i gruppi che si contrappongono anche in piccole classi di ragazzi ecco, ritengo che tutto questo possa rappresentare l inizio di un discorso su cosa è la sanzione, su cosa è la pena, e possa far discutere sui comportamenti ai quali la pena o la sanzione debba essere applicata. Quali potrebbero essere, secondo i ragazzi, le alternative al carcere? Non dobbiamo dimenticare che è solo nel nostro paese, o meglio nel paese così come è venuto a formarsi con la legislazione del Codice penale del 1930, che il carcere rappresenta l unica risposta che l ordinamento dà ai fenomeni di delinquenza, ai fenomeni di devianza. 106
110 Ma non è scontato che debba essere sempre così, e anzi mi piacerebbe che proprio fra gli adolescenti partisse un dibattito, che invece stenta a camminare a livello di opinione pubblica e a livello politico. Il tema dovrebbe essere: Quali sono oggi le alternative al carcere, se queste alternative sono possibili, e quali, secondo le esperienze dei ragazzi, potrebbero essere. I ragazzi cos hanno di fronte? Hanno ad esempio le sanzioni che può applicare il preside, o l insegnante, nel caso di comportamenti irregolari: la sospensione per qualche giorno, addirittura la sospensione o l esclusione dall attività didattica per un anno, la cacciata dalle scuole di tutto il Regno come avveniva anni fa: quindi non è che i ragazzi sono lontani dalle sanzioni, ma anzi le conoscono bene, e allora sarebbe interessante avviare un discorso proprio sul tipo di sanzione, sulla gradualità delle sanzioni, capire se la sanzione, quella esclusiva che priva le persone della libertà, sia una sanzione da spendere nei confronti di tutti i comportamenti o se invece non sia possibile immaginare quello che oggi, a livello politico, viene detto il carcere come extrema ratio. Secondo me questo è un tema che va rilanciato, proprio perché a livello culturale e politico nel nostro Paese non va avanti, e allora cominciamo dai bambini e dai ragazzi, forse potrebbe non essere sbagliato avviare questo tipo di discorso fra le giovanissime generazioni, per capire come si porrebbero loro di fronte a questo fatto. La domanda è: Di fronte al dilagare della delinquenza quale sistema penale e sanzionatorio?. Ossia, costruiamo più carceri, oppure pensiamo ad altro, pensiamo ad altri tipi di sanzioni? Io sono convinto che i giovani a cui ci rivolgiamo, che vedono Distretto di polizia, che vedono tutte queste fiction che parlano quasi sempre di giustizia, di delinquenza, di devianza, di processi, di procedimenti, in realtà si siano fatti un idea molto più forte di quello che noi crediamo. E forse si sono fatti un idea sbagliata, perché la comunicazione non è quella giusta, perché i mezzi di comunicazione danno un idea di un sistema giudiziario e di un sistema penale quasi come un orologio, nel senso che c è la denuncia, c è l indagine di polizia, c è la chiamata, la convocazione della persona, che confessa perché messa alle strette e va a finire in carcere. Ecco, questo è un sistema che non esiste nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, e riflettere anche su queste dinamiche, magari prendendo spunto da una puntata di Distretto di polizia, potrebbe essere un gioco, un gioco per mettere a nudo alcune presunte verità sul nostro sistema che non sono tali, e per capire cosa pensano i ragazzi di questo. La galera riesce in qualche modo a rieducare? Anche ragionare, ad esempio, per principi generali, tolleranza zero oppure no, credo che sia un argomento interessante: ossia è giusto che una persona al terzo sbaglio finisca la sua vita in carcere, come propone la legge americana, una legge che si vuole in qualche modo cercare di introdurre anche in Italia? Siamo convinti che questo è l obiettivo che ci può portare ad una società più giusta, più libera, più umana? Ecco, anche questa è una domanda sulla quale potremmo avere un fortissimo contributo da parte dei ragazzi. Un altra domanda che piacerebbe a me se fossi ragazzo, e alla quale vorrei una risposta, è questa: Ma qualcuna di queste persone che hanno commesso tanti reati, alla fine di questo percorso, alla fine di tanti anni di carcere, viene recuperata? Alla fine, la galera riesce in qualche modo a rieducare?. Vorrei sapere questo perché credo che la galera ab- 107
111 bia, per come può essere vissuta da parte di una persona che non la conosce, un fortissimo elemento di violenza. Oggi se penso ad un carcere, non conoscendolo, e se mi astraggo per un attimo dalla mia funzione, lo penso come ad un mondo di violenza, lo penso come un luogo in cui avrei paura ad andare, perché sicuramente sarei oggetto di violenze e di minacce, di tutte le cose più brutte che posso immaginare. Allora possiamo realisticamente pensare che questo luogo possa rieducare? Questa è un altra domanda che mi farei con i ragazzi, perché anche su questo dobbiamo cercare di fare chiarezza, dobbiamo cercare di stimolare una riflessione anche all interno del luogo chiuso carcere, per capire se è possibile, attraverso questo sistema che si basa esclusivamente sulla pena carceraria, recuperare qualcuno, perché se il sistema dovesse documentare che non si salva nessuno, allora è un sistema fallimentare. Quindi secondo me dobbiamo ragionare anche con la realtà, con dati alla mano, certo, ma soprattutto con storie vissute che raccontino pure il contrario, ovviamente dando anche esempi positivi di recupero delle persone, che a mio avviso è un elemento fondamentale. Sostanzialmente quindi una riflessione importante sulla pena, che è una pena che vuol dire anche sofferenza, perché non c è dubbio che la pena sia sofferenza. È la privazione di qualcosa, é come il ragazzo che non rispetta le regole e viene privato dell uscita del sabato sera, così il ragazzo un po più adulto che non rispetta le regole e va a rubare, probabilmente verrà privato di qualcosa di più importante, di ancora più forte. Poi bisognerebbe chiedere ai ragazzi, oltre a quale tipo di pena, quando eseguire la pena, e non è una cosa banale, se si pensa alle pene eseguite a distanza di 5-7 o 10 anni dal fatto, con un grosso punto interrogativo: Ha senso espiare una pena quando non si è più ventenni ma trentenni, con una storia in qualche modo diversa, superata, con una famiglia e un lavoro che prima non c erano?. Anche questa è una domanda alla quale i ragazzi dovrebbero dare una risposta. Non è vero che non paga nessuno, è vero che spesso pagano solo i più deboli C è poi una sensazione, molto diffusa fra i ragazzi, secondo la quale pare che non paghi nessuno, e anche questo è un punto che bisognerebbe chiarire. Non è vero che non paga nessuno, è vero invece che spesso pagano solo i più deboli, ed è una realtà che non possiamo nasconderci. È vero che spesso pagano soltanto le fasce più emarginate della società: perché non hanno saputo reagire, perché non hanno integrazione, perché non hanno avvocati, perché non hanno mille opportunità che invece sono date alle persone di ceti sociali privilegiati, quindi è vero che noi in carcere troviamo, all per cento, persone disagiate. È vero anche il contrario, e cioè che ci sono persone che appartengono a classi sociali di medio livello che avrebbero potuto fare scelte diverse, ma certo il mondo del carcere è popolato prevalentemente da situazioni di persone che, nella loro vita, hanno vissuto disagi, sofferenze, privazioni, e quindi riaffrontano questi disagi attraverso una ulteriore sofferenza che è quella del carcere. Paradossalmente posso dire, però, che proprio attraverso queste ulteriori sofferenze le persone riescono anche a migliorare, perché attraverso la pena, l isolamento, la deprivazione, spesso le persone, se sostenute positivamente dal mondo carcerario e quindi anche dal mondo che è fuori, riescono a trovare forme di uscita positive. Quindi penso che dovremmo fare anche un opera di chiarificazione rispetto ai messaggi che invece man- 108
112 dano i mass media, credo che dovrebbe essere quasi un opera di controinformazione su quello che ci viene proposto. Temi essenziali sono anche come affrontare la violenza, e il rapporto con le forze dell ordine, lo abbiamo visto recentemente con la vicenda del tifoso ucciso dal poliziotto e con tutto ciò che poi ne è nato. Il tema delle forze dell ordine è un tema caldissimo fra i ragazzi, perché le forze dell ordine rappresentano spesso il nemico, rappresentano lo Stato dalla faccia più brutta, rappresentano quelli che ti vogliono fregare a tutti i costi, quelli che ti sequestrano il motorino, che ti fanno la multa quando passi col rosso, e da lì deve secondo me partire un educazione alla legalità, anche attraverso la discussione e il confronto fra queste pratiche che possono essere banali il divieto di sosta, il rosso, in fin dei conti sono delle fesserie, tutti noi ci confrontiamo giornalmente con queste violazioni però credo che non partire da lì priverebbe il ragazzo anche di punti di riferimento, perché è frequente sentire giovani che dicono Tanto lo fanno tutti, rubano tutti, che vuoi che sia se ho truccato il motorino per andare a 70 anziché a 40? È un illecito? Mi vuoi mandare in galera perché ho truccato il motorino?. Vogliamo mandare in galera un ragazzo perché ha truccato il motorino? Eppure è un reato, così come se ruba lo specchietto da un motorino di un compagno perché il suo gliel hanno a loro volta rubato Ecco, credo che dovremmo innanzitutto cercare di avvicinarci al tema del reato, prima ancora che al tema della pena perché poi la pena è una conseguenza partendo proprio dall esperienza quotidiana dei rapporti fra ragazzi di questa età, soprattutto se vogliamo rivolgerci a ragazzi di anni, perché a livello di media superiore possiamo già dare per scontato qualche concetto in più. Ritengo infatti che un progetto del genere sia utilissimo anche per giovani delle scuole medie, non credo che sia presto, però penso che l approccio debba essere un po più soft, insomma non bisognerebbe cominciare proprio col carcere, ma al carcere bisognerebbe arrivarci pian piano, nel senso che il passaggio non è così lontano. Sarebbe però opportuno rileggere la storia dei rapporti personali, di violenza o non violenza, di tolleranza o di non tolleranza, proprio all interno di un gruppo classe per capire in realtà quali sono le riflessioni, cosa pensano i ragazzi del compagno che il sabato sera si fa gli spinelli, che si ubriaca di birra o che beve superalcolici. Ecco, io esplorerei tutto questo mondo prima di arrivare al tema della pena, che però, ripeto, è molto vicino, non è difficile arrivarci, ma ci arriverei con questa gradualità, per poi portare delle storie che mi sembrano molto significative: le storie di un detenuto, le storie di una persona che è riuscita a liberarsi dalla tossicodipendenza, le storie di persone che hanno fatto dei percorsi familiari e sociali di recupero importanti. Ed è importante chiamare dentro anche le famiglie, non c è dubbio, perché altrimenti rischiamo di perdere un elemento fondamentale del discorso che vogliamo fare. Infine, allargherei ai temi più generali della pena, del perché la pena, del come punire e quando punire, e credo che potrebbero uscire fuori cose molto più interessanti di quelle che invece, oggi, vediamo proposte a livello di opinione pubblica o a livello politico, proprio perché vissute da persone libere da schemi concettuali, libere da ideologie, libere da tatticismi politici o da altro. Credo che questa iniziativa potrebbe essere molto utile anche al mondo degli adulti. 109
113 VENT ANNI DI CARCERE POSSONO ESSERE VERAMENTE IL MASSIMO DELLA PENA A dirlo è Gianrico Carofiglio, scrittore e magistrato, che ritiene che la pena dovrebbe essere più coerente a criteri di umanità, più mite per l appunto. Bisognerebbe ridurre l uso del carcere per utilizzare altre pene. Un esempio? La detenzione nei fine settimana, per ragazzi colpevoli di violenze allo stadio a cura della Redazione di Ristretti Orizzonti Gianrico Carofiglio è uno scrittore, ma è anche un magistrato, talmente sdoppiato nel suo ruolo che ha scelto come protagonista dei suoi romanzi un avvocato, piuttosto che restare troppo legato, anche nel mondo della fantasia e della creazione letteraria, alla sua professione e alla sua esperienza lavorativa. L abbiamo intervistato nella sua veste di Pubblico Ministero. Alì Abidi (Ristretti Orizzonti): Nel suo ultimo libro, lei ha scritto che a volte i processi non viaggiano più nei loro binari precostituiti, e di questa circostanza si accorgono tutti. Cosa voleva dire? Che la giustizia cerca il colpevole ma non la verità, come ha scritto un altro magistrato sempre in un suo libro? Gianrico Carofiglio: Qualche volta succede che i processi deraglino, ed è una sensazione strana, perché si ha l impressione che da quella dimensione, che per qualche aspetto è comunque fuori dalla vita reale, che è il processo, ti avvicini al mondo reale, che è anche la ricerca di una verità più sostanziale di quella approssimativa che si cerca e che si trova nei processi. Io ho un paio di esperienze che possono essere raccontate: una la ricordo nitidamente, ed è quella di un testimone che venne chiaramente in aula per fare falsa testimonianza. Fu interrogato a lungo dalla difesa, che lo aveva portato, temo anche consapevole del fatto che dovesse fare una falsa testimonianza, e poi fu interrogato a lungo da me. Si vedeva che all inizio era molto teso, perché sapeva che io ero il Pubblico Ministero e che lui era venuto a dire delle cose non vere, e che per questo era esposto a dei rischi, ed io come mia abitudine lo interrogai in maniera molto tranquilla. Per inciso, interrogare in modo aggressivo è sempre una cosa stupida, non serve mai, sia che tu abbia davanti qualcuno che ha detto la verità sia che ti trovi davanti qualcuno che ha detto bugie. Perché se ha detto la verità è una cattiveria inutile, mentre se ha detto bugie, il modo migliore per farlo rinforzare nelle sue bugie è quello di aggredirlo. Quindi fu interrogato in modo tranquillo, come faccio di solito, e là qualcosa lo stupì: dopo un lungo percorso di domande, accadde che all improvviso questa persona cambiò idea, e raccontò i fatti come stavano. Ecco, lì fu una sensazione davvero surreale. É capitato altre volte, ma quella volta fu molto forte, perché chiaramente era stato portato lì sostanzialmente minacciato per dire certe cose, e disse la verità non perché pressato da domande aggressive, o da una situazione che sembrava diventasse drammatica per lui, ma come risultato di un percorso che aveva generato un qualcosa, forse una forma di co- 110
114 scienza diversa della situazione, un recupero della dignità. Quella fu una situazione in cui ebbi l impressione che dalla formalità della situazione processuale, che peraltro io conosco e conoscevo molto bene, perché ormai sono vent anni che faccio il Magistrato, si andasse su una dimensione diversa, quel deragliamento di cui si parla nel libro. Il processo a volte cerca una verità qualsiasi e non la verità, è vero, ma non bisogna credere che sia sempre così e non bisogna credere che tutti i protagonisti del processo si muovano in questo senso. Lo sforzo di molti, che facciano il Pubblico Ministero o altro, è quello, pur consapevoli del fatto che si tratta di un meccanismo imperfetto e che la verità vera, qualsiasi cosa significhi l espressione, non verrà trovata mai di cercare di avvicinarsi il più possibile alla verità. È necessario essere consapevoli del fatto che è un meccanismo imperfetto, e che tutti quelli che vengono coinvolti in un processo quasi sempre sono convinti che il processo abbia fallito nel suo compito, perché tutti quelli che sono coinvolti nel processo sono portatori di una propria personale verità, che è diversa da quella degli altri. Per il solo fatto di essere persone, che vedono il mondo in maniera diversa. Se io e lei dovessimo raccontare, fra tre giorni, quello che è successo qui oggi pomeriggio, lo racconteremmo in modo diverso: non perché vogliamo mentire, ma perché percepiamo le cose in maniera diversa, le rielaboriamo in maniera diversa. Per cultura, per storia personale e tutto il resto. È ovvio che chi dovesse ascoltare queste cose, sarebbe costretto a fare una mediazione di queste verità personali che non sono né vere né false per il fatto di essere diverse, ma appunto sono personali. Bisogna essere consapevoli, da parte di chi fa il mio lavoro, che laddove non si abbia una approssimazione accettabile di come i fatti sono andati veramente, bisogna assolvere l imputato che ci si trova di fronte. E poi bisogna avere anche la consapevolezza che il processo è un male necessario che implica a volte delle conseguenze e non devo dirlo certamente a voi che possono essere di notevolissimo peso sulla vita delle persone, ma anche quello che è successo prima a volte lo è stato. Alì Abidi: Sempre in uno dei suoi libri ha detto che nei processi e nei tribunali esistono delle regole non scritte, che però vengono rispettate con molta attenzione e cautela. Fra queste c è una regola che, più o meno, dice che un avvocato non difende un cliente buttando a mare un altro collega. Non si fa e basta. Chi viola queste regole solitamente la paga. Da dove deduce queste sue affermazioni e in che modo avviene il pagamento del torto fatto? Gianrico Carofiglio: Le rispondo come rispose un ispettore della squadra mobile quando una volta gli chiesero: Come ha fatto lei a capire che quel certo comportamento significava questa cosa?. L ispettore rispose: Vent anni di squadra mobile. Io invece le rispondo: vent anni di Procura della Repubblica, o poco meno. Lo capisci perfettamente, se ti trovi in certe situazioni, che alcune cose non si fanno perché sono vietate, perché fanno parte di un codice assolutamente inesistente che però viene applicato da quasi tutti. Quando uno le viola viene messo all indice, viene isolato. Ho presente alcuni avvocati che conosco, che alcune volte hanno violato queste regole, e gliel hanno fatta pagare. Non certo sparandogli, ovviamente, ma isolandoli e mettendoli all indice come degli infami, dei traditori della categoria, traditori di quel sistema di regole che è tanto più forte quanto meno esplicito. Questo capita anche in altre categorie professionali: l idea che non si butta 111
115 a mare il collega, che non si denuncia il collega anche se ha fatto una porcheria, è un idea forte. Anch io mi sono trovato ad avere una serie di non piccoli problemi, per avere violato, nel mio ambito, la regola che ci si fa i fatti propri. Scopri che il collega fa qualche porcheria, che di solito si tollera, ma io non ci sono stato ed hanno cercato di farmela pagare in tutti i modi; poi non ci sono riusciti, ma capisci che alcuni meccanismi rischiosi, tipici di ambienti dell illegalità, fanno parte anche di ambienti della cosiddetta legalità. Emilio Coen: Nell ambito del giudizio dei magistrati, o dei giudici, esiste veramente il ragionevole dubbio? Gianrico Carofiglio: Esiste assolutamente. Le posso assicurare che, salvo casi patologici che ci sono dappertutto, i magistrati che vanno in camera di consiglio e anche molti dei Pubblici Ministeri, ma più frequentemente è quasi fisiologico che il Pubblico Ministero, non dovendo poi fare la sentenza, a volte abbia un attenzione minore anche se alcuni ce l hanno accuratissima davvero si pongono tutte le questioni possibili quanto all esistenza del dubbio sulla responsabilità dell imputato. Quindi da questo punto di vista mi sento tranquillamente di rassicurarla. Questo non significa che siano infallibili e che non sbaglino come di fatto capita in tanti casi, ma la cultura dei magistrati, e soprattutto dei magistrati giudicanti, è una cultura impregnata della consapevolezza che se c è dubbio si assolve. Daniele Corradini: Perché è così osteggiata dai magistrati la separazione delle carriere? Gianrico Carofiglio: Ci sono due motivi, uno buono ed uno cattivo. Quello cattivo è di tipo corporativo, cioè la corporazione dei magistrati, Pubblici Ministeri e giudici, ritiene in qualche modo, inconsapevolmente anche, di perdere potere nella separazione delle carriere. Questo è il motivo sbagliato, negativo, che riguarda qualcuno e che c è come sottofondo, che andrebbe però escluso dall orizzonte concettuale. Il motivo buono, e che io sottoscrivo dicendo che non sono d accordo sulla separazione delle carriere anche se sono del tutto favorevole a delle più chiare distinzioni di funzioni per evitare che succedano cose di quel genere o altre è che con la separazione delle carriere il Pubblico Ministero acquisti sempre più una cultura di tipo poliziesco. Non c è nessuna espressione di disprezzo in questo senso, ma la cultura di tipo poliziesco è quella che essenzialmente mira a scoprire un colpevole, mentre la cultura di tipo giurisdizionale e giudiziario è quella che tendenzialmente dovrebbe mirare a scoprire la verità, ammesso che questo sia possibile. Se il Pubblico Ministero viene spostato dal quadro culturale del giudice, ed avvicinato più al quadro giudiziario della polizia ripeto, con tutto il rispetto per il lavoro delle forze di polizia, sono miei fratelli, ci campo assieme il rischio è quello che si perda sensibilità per la necessità di provare, per il dubbio ragionevole, quindi per le garanzie dell imputato. E in questo chi ha da perdere sono in generale i cittadini. Il Pubblico Ministero che ragioni da un lato come un investigatore, ma dall altro lato come un giudice naturalmente con un sistema migliore di quello che abbiamo adesso è una garanzia per tutti quanti. Io credo che chiunque preferirebbe avere davanti un Pubblico Ministero disposto in ogni momento a valutare le ragioni dell imputato, che è un atteggiamento del giudice, piuttosto che un Pubblico Ministero essenzialmente orientato a incastrare la per- 112
116 sona di cui si sta occupando. Questa è la buona ragione per cui molti di noi ritengono sbagliata la separazione delle carriere. Sandro Calderoni (Ristretti Orizzonti): Ma concettualmente la posizione dei Pubblici Ministeri è questa, cioè di trovare le prove per incastrare l accusato. Gianrico Carofiglio: Sì e no. In parte è così, ed è una situazione di fatto, ma tenga conto che un Pubblico Ministero, inserito nella carriera dei giudici, studia con e come i giudici, è costretto a ragionare più o meno come io sto ragionando con voi adesso. Sandro Calderoni: Infatti, secondo me, lei come Pubblico Ministero è un po anomalo Gianrico Carofiglio: Prendo atto di quello che lei dice. È vero che ci sono molti Pubblici Ministeri che ragionano nel modo in cui dice lei, ma molti altri che ragionano così come sto ragionando adesso io con voi. Allora, la professione del Pubblico Ministero è in bilico tra queste due possibilità: se il Pubblico Ministero viene risucchiato soltanto nell orbita culturale dell investigazione poliziesca, allontanato dall orbita culturale del processo, sempre di più saranno quelli che ragionano come dice lei, che certamente ci sono, e non va bene. Se invece il Pubblico Ministero viene mantenuto nell orbita culturale del giudice, anche se naturalmente molte cose vanno modificate per migliorare l attuale situazione, è probabile che ci siano sempre più persone che ragionano come ragiono io adesso. Marino Occhipinti: Per uscire un po dal tecnico ma rimanendo sempre nell ambito della sua professione, come vede lei come Magistrato il modo in cui vengono presentati all opinione pubblica, da parte degli organi di informazione, i processi, i fatti criminosi che accadono, e le pene? Mi spiego: recentemente in una trasmissione, Porta a porta, hanno detto che tra sette anni e mezzo i due autori della strage di Erba potranno andare in permesso premio. In via teorica potrebbe essere anche possibile, ma credo che con questa affermazione si disinformi e si terrorizzi, che si crei dell allarmismo inutile Gianrico Carofiglio: Qui parliamo del malcostume giornalistico. Vedete, noi ci troviamo in Italia ma in realtà è una tendenza non solo italiana, in cui la notizia brutta fa vendere i giornali, mentre quelle buone e ce ne sono, e la cosa insopportabile è che ce ne sono di tanti tipi non sono notizie, ma chi se ne frega. E quindi le brutte notizie fanno scandalo e piacciono, perché uno si può arrabbiare, si può indignare gratis, nel sentire sciocchezze di questo genere. Poi lei in realtà ha citato una trasmissione dove di sciocchezze se ne sentono un bel po, in cui la pratica di questo giornalismo discutibile è abbastanza intensa. Rispetto a questo, come rispetto ad altre cose, bisogna esercitare il senso critico, che poi non è una cosa complicata, e voi lo sapete meglio di me, e sta nella capacità di farsi delle domande. Marino Occhipinti: Ma io credo che il 90 per cento delle persone che assistono ad una trasmissione credano a ciò che ascoltano Gianrico Carofiglio: Proprio per questo è una ragione in più per discuterne, come stiamo facendo noi adesso, per esercitare il senso critico, che significa non accontentarsi 113
117 delle cose preordinate e belle pronte. Vi ricordate l aviaria? Uno scandalo di proporzioni colossali, e mentre se ne parlava ricordo che dissi che per me era una bufala gigantesca inventata dalle industrie farmaceutiche per obbligare, come di fatto è accaduto, gli Stati, l Italia per prima, a comprare centinaia e centinaia di milioni di vaccini inutili, pompando e manipolando gli organi di informazione. Era chiaro, era chiarissimo, eppure il paese, la comunità internazionale, è stata appesa a questa idiozia per tre mesi, poi letteralmente, da un giorno all altro, la questione è finita: quando gli acquisti erano stati effettuati e quindi non c era più bisogno dell allarmismo. Su questi e su altri temi bisogna usare l intelligenza, consapevoli del fatto che il giornalismo deteriore come questo può fare danni anche molto seri, e consapevoli anche del fatto che noi abbiamo comunque per guardarla da un altro punto di vista un sistema giudiziario e in generale un sistema di norme che funziona male, che per certi aspetti è spietato e per altri aspetti è eccessivamente lassista e incapace di far percepire la forza delle regole. Altin Demiri (Ristretti Orizzonti): Quando i detenuti entrano in carcere, hanno paura di perdere l amore, di perdere le relazioni con gli altri, di perdere i propri cari. Leggendo le storie dell avvocato Guerrieri abbiamo trovato che è una persona trasgressiva, alla quale piace la vita, le belle donne. Lei come uomo, prima che come Magistrato, cosa ne pensa della mancanza di relazioni fra uomo e donna in carcere e delle stanze dell affettività? Gianrico Carofiglio: Questo è un problema serio che in realtà si inserisce in un quadro più ampio: cos è la pena? Non è chiaro neanche agli addetti ai lavori, perché si oscilla fra interpretazioni diverse, e cioè se la pena sia uno strumento di rieducazione, se sia uno strumento di punizione, oppure uno strumento di prevenzione di altri reati. Fino a quando non c è totale chiarezza su questo punto, e in parte sarà impossibile che si arrivi a una totale chiarificazione perché probabilmente la pena ha tutte queste funzioni insieme sarà difficile risolvere una serie di questioni tipo quella che solleva lei. Io in generale, senza entrare nel dettaglio della specifica questione delle stanze dell affettività, o di soluzioni di questo genere, sono del parere che le pene dovrebbero essere più miti e più certe contemporaneamente. I Paesi in cui c è la pena di morte, non sono Paesi in cui i reati con la pena capitale calino, perché quello che spaventa, quello che inibisce dalla commissione di reati, non è il fatto che ci sia una pena spaventosa, ma invece e infatti nei Paesi in cui questo accade la riduzione dei reati esiste che ci sia una pena certa. È molto meglio una pena certa a 15 anni, che l ergastolo probabile o solo possibile. La pena dovrebbe essere più coerente a criteri di umanità, più mite per l appunto, riducendo l uso del carcere per utilizzare altre forme. Oggi ero in una scuola e parlavo di temi affini a questo, e facevo l esempio di una pena che da noi non esiste, che è la detenzione domiciliare del fine settimana: sarebbe uno straordinario strumento di inibizione di una serie di reati commessi soprattutto da giovani, senza nessun effetto criminogeno. Voi sapete meglio di me non certo in istituti come questo in cui c è gente che deve stare un po di tempo, e che quindi ha un elaborazione diversa da altri casi che spesso la detenzione, soprattutto nella forma della custodia cautelare, ha l effetto che una persona va lì, sta poco e impara cose che non dovrebbe, e in certi ambienti, il fatto di fare la prima detenzione è quasi una sorta di acquisizione di punteggio. Quindi io penso a pene miti come la detenzione nei fine settimana, che per un ra- 114
118 gazzo che ha fatto delle sciocchezze inerenti ad esempio l uso della violenza allo stadio o cose di questo genere, sarebbe una afflizione, una inibizione dal commettere reati senza quegli effetti criminogeni di produzione di ulteriore crimine, che determinano poi l inserimento nel circuito carcerario. Pene più miti possono essere previste assieme a un sistema giuridico più efficiente, e quindi è un discorso che si può fare se si parla di una rimodulazione di tutto il sistema della giustizia, in cui noi fossimo in grado di dare risposte più rapide, sia investigative che processuali. E naturalmente, in un quadro di questo genere, certo vedrei con molto favore tutte quelle misure che consentissero un effettiva e progressiva rieducazione e riadattamento di chi ha sbagliato e si trova a pagare per aver sbagliato. Elton Kalica: Il fatto è che sui temi della Giustizia sembra impossibile fare dei passi avanti, perché si trova sempre un muro causato dalle leggi emergenziali. Ad ogni richiesta, riguardante per esempio le telefonate e i colloqui, ci si sente rispondere che non si possono allargare le maglie perché altrimenti i mafiosi ne approfittano per mandare ordini all esterno. Siccome le leggi emergenziali sono state fatte in momenti di emergenza, quindi per affrontare uno stato eccezionale, dovrebbe esserci anche una fine, una conclusione. Però in Italia pare che le leggi emergenziali vadano avanti per decenni o per sempre. Lei crede che avranno un termine o si continuerà così? Gianrico Carofiglio: Intanto voglio darvi un informazione. Le nostre leggi emergenziali sono molto più miti di quelle di altri paesi. Per esempio in Gran Bretagna, quando processarono i terroristi dell Ira, cancellarono letteralmente tutte le regole del processo anglosassone, e per molto tempo. Questo per dire che le leggi emergenziali esistono pure negli altri Paesi, e anche se io non sono d accordo, i terroristi dell Ira furono processati senza giuria, con giudice singolo, giudice spesso mascherato, con regole di acquisizione della prova che significavano prova scritta e non in un dibattimento pubblico, con esame e controesame e tutto il resto. Ci sono Paesi europei civilissimi, ad esempio l Olanda, in cui è ammessa la prova anonima. Sembra allucinante ma è così: un testimone di cui non si conosce l identità, che quindi non vedi, del quale non si conoscono le generalità, un testimone incontrollabile, mentre voi sapete che in Italia il dibattimento pubblico prevede l esame e controesame, e il controesame serve proprio per controllare se il testimone è attendibile oppure no. È l arma più forte nelle mani della difesa correttamente praticata: se io voglio sapere se un teste è attendibile o no, devo sapere chi è. Un conto è se il teste si chiama Pinco Pallino, un altro conto è se si chiama Billy the Kid. Un conto è se uno ha cinque pagine di certificato penale, un altro conto è uno che ha fatto sempre il chierichetto. Se io non so chi è il testimone, mi viene tolto l 80 per cento delle possibilità per verificare se un testimone è attendibile, quindi viene tolta all imputato la possibilità di difendersi in maniera efficace. Perciò attenzione, non è l Italia il Paese della legislazione di emergenza, per lo meno non solo. Non c è dubbio che esista un problema di eccessiva durata delle norme emergenziali, in parte però legata al fatto che alcune emergenze non sono affatto finite. Una migliore modulazione dei meccanismi di applicazione dei regimi differenziati certamente è auspicabile. Quindi io sono del tutto d accordo sulla necessità di modulare meglio sia i meccanismi di regime differenziato, sia ancora ove possibile anche la distinzione fisica dei 115
119 luoghi di collocazione dei comuni e dei non comuni, tanto per intenderci. È una questione delicata di cui bisognerà occuparsi seriamente: io tra non molto andrò a fare il consulente della Commissione parlamentare antimafia, e questi sono temi di cui sicuramente ci occuperemo. Cercando di migliorare da un lato l efficienza, e dall altro le garanzie di chi non è coinvolto in quel circuito, ma ci viene trascinato da quei meccanismi repressivi. Ornella Favero: Noi conosciamo già il suo parere negativo sull indulto, ma molto ipocritamente volevamo porre la domanda al protagonista dei suoi romanzi, l avvocato Guerrieri, su cosa pensa dell indulto. Gianrico Carofiglio: Ne penserebbe male, perché credo che l indulto non sia una cosa rieducativa, così com è stato concepito. Non sopravvaluterei però il fatto che chi è tornato fuori è tornato a delinquere, anche perché la percentuale è relativamente fisiologica, ma penso che sia diseducativo in un sistema processuale poco funzionante come il nostro, in cui si arriva a sentenza definitiva con estrema fatica, con mille ostacoli, con meccanismi farraginosi, e poi senza una vera ragione che non fosse quella che è il riconoscimento di un incapacità dello Stato, che è dire che le carceri sono piene fare un provvedimento di clemenza è qualcosa di poco comprensibile per i cittadini, poco comprensibile anche per gli addetti ai lavori. Io concordo in pieno sul fatto che in presenza di alcuni problemi, nel caso di specie il sovraffollamento penitenziario, forse potesse essere giusto assumere delle determinazioni. Allora io avrei fatto in modo che chi aveva ancora tre anni da scontare, andasse a farli in detenzione domiciliare, con anche la possibilità di andare a lavorare. Quindi dormiva a casa e andava a lavorare fuori, questo per chiarire come io non sia spietatamente contrario, anzi, perché non è che dico di stare in carcere e basta, ma quella sarebbe stata una misura utile per decongestionare le carceri, educativa perché avrebbe creato un diaframma fra detenzione carceraria e riacquisto completo della libertà, senza però comunicare agli altri cittadini che a chi ha sbagliato e sconta una pena gli si fa un regalo e si fa l indulto, che ci ha costretto a lavorare a macinare l acqua. Il mio discorso si inserisce in un idea mite della pena, e non vedo quali controindicazioni ci sarebbero state, se non quella di lavorare un po di più a scrivere una norma più completa. La mia idea è questa; mi rendo conto che non può essere condivisa, ma la sostengo e ne sono assolutamente convinto. Aggiungo che, dopo aver fatto l indulto, che è una tipica mezza misura, a quel punto il legislatore doveva almeno avere il coraggio di fare l amnistia, perché adesso c è anche la grottesca situazione per cui si fanno i processi per nulla, e cioè per applicare pene che verranno completamente condonate, il che significa buttare i soldi del contribuente e le energie degli organi investigativi e giudiziari, che invece potrebbero essere utilizzate meglio. Quindi, a questo punto, sono a favore di un provvedimento di amnistia, e ditemi cosa ci sarebbe di incoerente nella mia idea sull indulto, che per certi versi è stato deciso anche per sistemare alcuni conti personali. Marino Occhipinti: Io francamente non sono molto d accordo. Con l indulto sono uscite all inizio circa 15mila persone, che sono poi aumentate a 20-25mila nei mesi successivi. Lei parla di detenzione domiciliare con possibilità di andare a lavorare, ma non 116
120 crede che se queste persone avessero avuto una casa e un lavoro, sarebbero già state fuori? Il problema era proprio quello, che in carcere erano rimaste moltissime persone con pene sotto ai tre anni, definiamole le più sfigate: stranieri, tossicodipendenti, che nella maggioranza dei casi non avevano né un abitazione, né un lavoro. Sa cosa succede poi? Che ad esempio a Palermo, alcuni ex detenuti usciti con l indulto si sono dovuti incatenare in piazza per cercare di avere un lavoro. Io credo che ci siano anche persone che quando escono vorrebbero rimettersi a lavorare, a fare una vita onesta, magari non tutte, però si devono incatenare per cercare di ottenere un lavoro, e lei sa meglio di me che in certe realtà del paese è più facile poi rivolgersi agli amici di prima piuttosto che rimettersi sulla strada giusta, proprio per mancanza di opportunità. Gianrico Carofiglio: Proprio di fronte a quello che dice lei, che in buona parte corrisponde alla realtà dei fatti non del tutto ovviamente, perché non erano tutti sfigati o tossicodipendenti o stranieri, e per gli stranieri per esempio si poteva pensare ad ipotesi di provvedimenti di espulsione dico solo che l indulto, nel migliore dei casi è stato fatto in modo un po troppo semplicistico, è questa la mia opinione gravemente negativa sul provvedimento: che si è buttata improvvisamente gente per strada. Marino Occhipinti: Guardi che anche noi ci lamentiamo molto del fatto che l indulto poteva esser organizzato meglio, ma era un occasione storica da sfruttare in quel momento particolare, che altrimenti non ci sarebbe stato più, perché la situazione politica è questa: la maggioranza qualificata dei due terzi dei parlamentari della Camera e del Senato è praticamente irraggiungibile Gianrico Carofiglio: Infatti non è in discussione la clemenza in sé, la clemenza andava anche bene, però un conto è la clemenza intelligente calata in un progetto che abbia senso, un altro conto sono le cose che sfiorano la cialtroneria solo per agevolare qualcuno. Sono del tutto d accordo se mi si dice che c è un esigenza e che è necessario affrontare il problema, ma dico che quel modo di affrontare il problema, se non il peggiore, era uno dei peggiori. Alì Abidi: Lei ha detto che a causa dei suoi conflitti interni si è messo a scrivere. Secondo lei può succedere che, a causa di malumori, i giudici possano sbagliare? A lei è mai capitato di avere la giornata sbagliata e quindi di giudicare male? Gianrico Carofiglio: Sicuramente ho avuto la giornata sbagliata, e sicuramente ho giudicato male. Mi sento però di dire, con molta franchezza, di aver sempre cercato di mantenere la consapevolezza di avere di fronte delle persone, che è la chiave di tutto. Ho sempre cercato di dirlo anche agli uditori giudiziari, e cioè ai magistrati giovani che vengono affiancati ai magistrati più anziani per imparare il lavoro. Tra l altro in questi anni mi sono successe un sacco di cose strane, e cioè che si creassero rapporti strettissimi, delle simpatie, con persone che ho fatto arrestare e condannare. Ad esempio ricevo i saluti ma saluti veri, non minacce velate da persone che ho fatto condannare per reati di mafia; l ultimo è stato pochi giorni fa, ed era uno che aveva preso 26 anni e mezzo soltanto per associazione, un associazione abbastanza pericolosa della quale lui era il capo supremo. Mi ha mandato a dire, tramite i suoi avvocati, che ha letto i miei libri, che gli sono piaciuti, e che mi stima perché ho soltanto fatto il mio lavoro. 117
121 Queste sono cose che fanno piacere, e guardate che non sto parlando di collaboratori di giustizia, che sarebbe più facile, ma di casi di persone davvero pericolose, almeno all epoca. E con tante persone detenute, nel corso delle pause dei processi, mi sono trovato a scherzare e a chiacchierare in maniera quasi amichevole. Questo non ci può essere fermo restando il fatto che io faccio la mia parte e tu la tua se non c è un rapporto di rispetto reciproco. Elton Kalica: Ma lei non crede che 26 anni per un traffico di stupefacenti siano troppi? Gianrico Carofiglio: Sì, credo che siano troppi, sono d accordo. Sono delle condanne assurde, non c è dubbio che in certi casi ci sia il problema di rivedere le pene, e difatti riscriverei le leggi che prevedono pene così esagerate in materia di stupefacenti. Marino Occhipinti: Ad esempio, proprio fra di noi c è Elton, che ha fatto, quando aveva vent anni, un sequestro di persona e non lo faccio per banalizzare né per giustificare per il quale sarebbe stato più da prendere a schiaffi che da infliggergli 17 anni di carcere, anche perché per i sequestri di persona non è previsto alcun tipo di beneficio e quindi molto probabilmente se li dovrà fare tutti, mentre invece ci sono persone che magari hanno commesso degli omicidi, che non sono certamente meno gravi, e che però possono usufruire della legge Gozzini. Gianrico Carofiglio: Guardate, su questo argomento trovate una porta spalancata. Vi dico di più: secondo me, ad esempio, dovrebbe essere prevista la possibilità di patteggiare per qualsiasi reato, con limiti amplissimi come esiste nei sistemi angloamericani, dove per un sequestro di persona patteggi otto anni e vengono meno tutte le limitazioni ai benefici penitenziari. Altin Demiri: Cosa ne pensa dell ergastolo e quale sarebbe per lei la pena massima da infliggere, se si pensa davvero che una persona in carcere possa maturare e cambiare? Gianrico Carofiglio: Io sono favorevole che l ergastolo rimanga come sanzione prevista, anche perché, come voi sapete, i casi di ergastolo realmente scontati sono abbastanza rari. Come dicevo prima, la pena ha varie funzioni, tra cui anche la funzione simbolica: comunica con il mondo esterno, comunica con le vittime dei reati, e il fatto stesso che si dica che per un certo reato viene applicato l ergastolo è un idea giusta, anche se poi non verrà mai realmente eseguito, e in questo senso vanno rafforzati i meccanismi di semplificazione di esecuzione della pena, per far sì che sia veramente un ipotesi residuale. Però lei si immagini il caso di una madre che ha visto il proprio figlio torturato e ucciso da qualcuno: qualsiasi pena diversa prescindiamo dalla pena di morte dall ergastolo, è una pena offensiva rispetto ad un ipotesi di questo genere, fermo restando che anche chi ha commesso queste cose può cambiare, e si spera che cambi, e potrà essergli garantita la possibilità che non trascorra tutta la vita in carcere. Io sono favorevole che la pena dell ergastolo, anche solo come fatto simbolico, rimanga nell ordinamento. La pena massima da infliggere invece, dipende dai singoli casi. Ad esempio in Germania la pena massima prevista è di 15 anni, e pur con tutto il discorso che abbiamo fatto sulla mitezza, se mi immagino la mamma che ha visto il figlio stuprato e ucciso, e vede dare 15 anni all assassino, insomma mi vengono un po i brividi. Comunque credo 118
122 che anche per le situazioni più gravemente compromesse, vent anni di carcere possono essere veramente il termine massimo, perché sono davvero il cambiamento di un esistenza, però in astratto è difficile da stabilire. Tenete comunque presente che vi è una differenza tra civiltà delle pene e l esigenza di ripristinare in tutti i sensi, nei limiti del possibile ovviamente, il danno che il reato ha prodotto: voglio dire che è necessario che, anche dal punto di vista simbolico, alcuni significati vengano rispettati. Ornella Favero: A me però non piace molto questa idea che abbiamo bisogno di pene simboliche. Recentemente è stata qui in redazione Olga D Antona, che ha avuto il marito ucciso dalle Brigate rosse, e lei per esempio ha dato una lezione straordinaria, perché ha ammesso di essere una persona fortunata perché non è capace di odiare. Mi sembra più simbolica e anche più importante la capacità di non odiare, e l ergastolo è difficile non vederlo come un sistema di odio. Gianrico Carofiglio: Ma estremizzando questo discorso, allora qualsiasi pena detentiva può essere vista come un sistema di odio. La capacità di perdonare è una sana pratica da esercitare con noi stessi, ma non può essere una cosa da pretendersi da chi ha subito magari dei dolori straordinari. A tutti, me compreso, piace una donna come la D Antona che ha la forza morale, il coraggio e l integrità psicologica per dire queste cose, ma queste sono cose che uno costruisce dentro di sé, che non possono essere pretese dagli altri. E comunque, quando parlo della pena simbolica dell ergastolo, non alludo all esecuzione reale, ma al carattere appunto simbolico dell applicazione di quella pena, del significato di una parola che in qualche modo può creare un processo di cicatrizzazione di ferite profonde subite dalle vittime. Sono due cose un po diverse. Io non sto dicendo che una volta applicato l ergastolo una persona debba stare in carcere fino all ultimo dei suoi giorni, dico una cosa ben differente. Si potrebbe ad esempio abolire l ergastolo e stabilire trent anni come pena massima, ma sarebbe soltanto un gioco di parole e di prestigio, e allora confermo quello che ho detto prima, e cioè lasciare l ergastolo mantenendo fermo che una possibilità deve essere data a tutti. Oppure l alternativa sarebbe quella di adeguarsi al sistema tedesco, che prevede i 15 anni di pena massima, che magari si riducono a 10 con i benefici, e cosa si risponde ad una persona alla quale è stato violentato e ucciso il figlio, che dopo 10 anni si ritrova per strada il violentatore e assassino? 119
123 UN RAGAZZO CHE SBAGLIA INVECE CHE ESSERE UN RIFIUTO PUÒ DIVENTARE UNA RISORSA Con don Ettore Cannavera, cappellano del carcere minorile di Quartucciu e responsabile della comunità La Collina, abbiamo parlato della giustizia minorile, dei percorsi tra carcere e comunità e del profondo lavoro culturale necessario per dare ai ragazzi prospettive di vita nuove a cura della Redazione di Ristretti Orizzonti Don Ettore Cannavera è il cappellano del carcere minorile di Quartucciu vicino a Cagliari, ma è anche responsabile della comunità La Collina, dove vengono inseriti molti giovani adulti che hanno commesso reati, anche gravi. Lo abbiamo incontrato nella redazione di Ristretti Orizzonti e abbiamo parlato con lui di questa esperienza, di come i ragazzi scontano la loro pena tra il carcere e la comunità, della difficoltà di costruire dei percorsi di legalità condivisi, e non imposti. Marino Occhipinti: Vorremmo innanzitutto sapere se succede che facciate, sia come comunità, che come carcere minorile, esperienze nella mediazione penale, considerato che questo è previsto nel processo minorile. Magari ci potete spiegare se è il magistrato che ve la chiede oppure se è un vostro impegno occuparvi di mediazione e di giustizia riparativa. Don Ettore: Sì, si sta tentando, ma non è facile con i ragazzi, parlo di ragazzi che hanno commesso i reati nella minore età, quindi 15, 16, 17 anni, non è facile avere la disponibilità anche ad incontrare la vittima, però ci sono stati dei casi ben riusciti. Ne ricordo soprattutto uno che è stato proprio il magistrato ad indirizzarci ancora prima di fare il processo, con l ufficio di mediazione che è collegato al tribunale. É successo in un piccolo paese, dove dopo questo reato c era stata una divisione all interno della comunità, fra persone che erano più vicine alla famiglia di chi aveva commesso il reato, e altre più vicine alla famiglia della vittima. Questo fatto aveva spaccato in due questo paese di poco più di mille abitanti, e lì siamo riusciti gradualmente a fare un opera di riconciliazione, a farli incontrare, però partendo soprattutto dalle famiglie. Cioè si trova più disponibilità nell adulto a entrare in quest ottica di incontrarsi, che non da parte del ragazzo, il ragazzo tende più facilmente a dimenticare, a rimuovere il reato. Tenete conto che in comunità abbiamo avuto, su trentacinque ragazzi, sette casi di omicidio, avvenuti anche in piccoli paesi all interno della Sardegna, coinvolgendo per lo più vittime anziane: ragazzi che vanno in casa a fare una rapina, e vi trovano un anziano che reagisce, quindi lo bloccano, gli danno qualche colpo, e poi succede che non subito, ma dopo qualche giorno muore, e quindi gli autori di questi reati sono condannati per omicidio. Ecco questi ragazzi, quando cerchiamo di farli incontrare con i parenti della vittima, hanno una certa difficoltà, perché per me in loro ancora non è maturata l idea di riconoscere il male fatto, ma soprattutto perché non vogliono perdere quell immagine che si è creata nei confronti del paese, di essere stati persone dure, forti. É un po anche 120
124 la storia di Jimmy, raccontata poi da Massimo Carlotto nel romanzo Jimmy della Collina, da cui è stato tratto il film di Enrico Pau. I ragazzi che si trovano in carcere tendono più facilmente a mostrare un volto di durezza, di fermezza e anche di violenza rispetto a quello che forse, anzi sicuramente sentono più interiormente. Riconoscere il male fatto, la debolezza, la fragilità è difficile nel ragazzo, però è uno dei nostri compiti, nel progetto che mettiamo in atto nel chiedere la misura alternativa alla detenzione, pensare alla giustizia riparativa, vedere che cosa quel ragazzo può fare per riparare al dolore provocato. Un caso che abbiamo attualmente e che ci sembra positivo, riguarda un ragazzo e degli scherzi che faceva, che poi sono finiti drammaticamente perché è morto un vecchietto. Lui ha scelto di andare in un ospizio vicino al carcere, a suonare la chitarra, a passare qualche ora con questi anziani per intrattenerli, e ha detto proprio che voleva fare qualcosa per questi anziani, perché gli ricordano la vittima del reato che ha commesso. Però non è facile la mediazione, è un passo che si deve maturare, e questo avviene spesso dopo che le persone finiscono di espiare la pena, quindi si resta in contatto pensando di riprendere più tardi questo discorso. Ornella Favero: Noi pensiamo che un altro aspetto interessante della mediazione sia la mediazione sociale. Un ragazzo che ha commesso un reato in una piccola comunità, dovrà prima o poi rientrare in quella comunità, e scaraventarlo lì senza una preparazione mi sembra sbagliato. Esiste, da questo punto di vista, qualche esperienza di mediazione sociale, per andare a preparare l ambiente dove una persona deve rientrare dopo la pena? Don Ettore: Sì, si tenta di farlo, ci sono delle esperienze positive, altre meno, credo che il fattore principale di questa possibile mediazione dipenda dal servizio sociale di quel paese, dalla famiglia stessa del ragazzo che ha commesso il reato e da tutte le componenti di quella comunità, la chiesa, la parrocchia. Ricordo l esperienza di due minorenni di un paese vicino a Oristano, condannati per omicidio, uno dei due era ancora in comunità, però andava frequentemente al suo paese, perché la sua famiglia è una famiglia che ha collaborato con i servizi sociali, cioè si è resa disponibile a parlare del fatto, tanto che questo ragazzo è riuscito ad avviare una cooperativa dentro al suo paese, e presentare un progetto con altri ragazzi, pur avendo alle spalle la condanna per omicidio. È la storia di Antonio, che è riuscito tranquillamente a rientrare in paese e a mettere insieme i giovani, anche perché si è fidanzato con una ragazza di Serdiana dove sta la comunità, e lei l ha aiutato a rientrare in rapporto con il suo paese, mentre l altro ragazzo, il coautore del reato, ha avuto molte più difficoltà perché la sua famiglia non è accettata, è una famiglia con il padre alcolizzato, la madre un po sbandata, e lui ha deciso a fine pena di non rientrare nel suo paese e di tornarci solo occasionalmente, perché quando vado mi guardano storto, e se vado in un bar mi controllano. Quindi, pur essendo i due ragazzi coimputati, uno è stato accettato bene, e l altro no. Devo dire che più che dal ragazzo dipende dal contesto, quello che tendiamo a fare è cercare di andare a lavorare nel territorio, ed è anche un po l ottica di tutta la comunità fare molto lavoro culturale, tra l altro anche grazie alla vostra rivista tento di far capire che chi sbaglia può essere completamente recuperato, che ha delle potenzialità e può dare il suo contributo, e invece che essere considerato un rifiuto può diventare una risorsa per quella comunità, la sua stessa esperienza può 121
125 essere d esempio per altri ragazzi. Nel caso di Antonio, condannato per omicidio, parlando con i suoi compaesani di questo episodio, del carcere, di come nella vita si può sbagliare, ma c è anche la possibilità di recupero, Antonio ha scritto delle cose bellissime. Poi ha finito di espiare la pena e per due anni è rimasto a lavorare in comunità come economo, stava per sposarsi, e una notte un infarto ce l ha portato via, lui aveva solo 26 anni. Gabriella Brugliera (volontaria): Secondo lei l accettazione o meno, da parte del paese, del rientro al suo interno di una persona che ha commesso un reato così grave sarebbe la stessa cosa se si trattasse di una città? Io temo che forse in un ambito metropolitano sarebbe difficile un percorso di mediazione sociale tra l autore di un reato e la comunità coinvolta nel fatto. Don Ettore: Dipende, può essere che sia anche più facile, noi in Sardegna a parte le due città Cagliari e Sassari, abbiamo altri trecento piccoli Comuni, anche di abitanti, nel piccolo paese si conoscono tutti, c è quasi una forma di parentela, quindi un episodio del genere colpisce tutto il paese, mentre in una città non so, potrebbero rimanere colpiti quelli che abitano vicini o nello stesso condominio, c è più anonimato nella città, quindi non c è riconoscimento, né in positivo, né in negativo. Una persona ha commesso un reato e quando torna può darsi che la città non se ne renda neanche conto. Però ci sono anche altri problemi: a Cagliari c è un quartiere periferico, dove c è più illegalità, lì un ragazzo che rientra dal carcere è più facilmente accolto paradossalmente, perché è un quartiere dove, se uno ha fatto un esperienza di carcere, viene riconosciuto come una persona che conta, come una persona che bisogna rispettare. Io ricordo che ho accompagnato lì un ragazzo di 16 anni appena uscito dal carcere, quando è sceso dalla macchina tutti gli amici lo hanno circondato e lui ha subito detto: adesso lo sapete chi sono, lo sapete da dove vengo. Ed è stato trattato con un senso di reverenza, in quel quartiere chi esce dal carcere è come se avesse il suo ruolo e contasse di più, invece in certi ambienti della città continuerebbe ad essere emarginato, guardato con diffidenza: e tutte e due sono situazioni a rischio. Invece è diverso in un paese, se c è un lavoro precedente all uscita, e questo lo permette molto l esperienza in comunità. Di fatti il ragazzo va spesso in paese, va con altri amici, si reinserisce gradualmente, e non come con i permessi dal carcere di due o tre giorni, che uno va e viene, ma sanno tutti che è ancora in carcere, che ha ancora l etichetta di detenuto. Invece a stare in comunità comincia a venir meno lo stigma, l etichetta, e quindi i ragazzi vengono più facilmente accolti, perché ormai sono liberi, liberi anche se non del tutto, è chiaro: in comunità hai molte limitazioni della libertà, però non sei più in carcere, e se il magistrato ti ha fatto andare in comunità vuol dire che puoi cambiare vita. Insomma, dalla comunità in paese il ragazzo ci va con uno di noi, con un operatore, questo reinserimento avviene davvero in modo graduale, invece l uscita dal carcere dopo aver espiato la pena dentro è molto più difficile, molti ragazzi non tornano al loro paese se vengono dal carcere, se escono da una comunità sì, perché è possibile un reinserimento graduale, quindi nel paese l accettazione mi sembra più facile che nella città. Adnen El Barrak: Noi abbiamo un progetto con le scuole e incontriamo tanti studenti sia qui in carcere che nelle scuole. Mi piacerebbe sapere quali sono i disagi che ci sono 122
126 nei giovani, e che poi li portano magari anche a commettere dei reati, quali sono le motivazioni che hanno, le storie che più spesso capitano. Don Ettore: Per la mia esperienza il commettere un reato da parte di un minorenne è dato molto spesso da un bisogno che l adolescente ha, che è quello di presentare un immagine di sé agli altri, in una fase in cui si sta costruendo la sua identità, quindi ha dei valori dei significati dentro di sé anche acquisiti dalla famiglia o dalla scuola, però per lui è più importante presentare un immagine ai suoi coetanei per essere accettato. Quindi se il ragazzo frequenta certi contesti, dove per essere accettato tu devi essere bravo culturalmente, nello sport, nella musica, nel teatro, tutti comportamenti positivi, il ragazzo si realizza in quella direzione, se invece non ha l opportunità di fare queste cose, a scuola è fallimentare addirittura lo mandano via, penso alla cosiddetta dispersione scolastica, nelle associazioni non lo vogliono perché è un rompiscatole, piano piano viene messo fuori da tutti quei circuiti di socializzazione, di riconoscimento, per cui va a finire in certi settori che sono più per la trasgressione, e l illegalità. Io sostengo che la pedagogia criminale purtroppo è molto più efficace della pedagogia scolastica e famigliare, perché lì spesso riescono a cogliere di più il vero bisogno del ragazzo, che è quello di essere considerato, stimato, tutelato. Soprattutto certi adulti il ragazzo lo invitano e lo riconoscono per quelle capacità che ha, io ho seguito un ragazzo così, denominato motoretta perché girava, rubava e spacciava, ma era talmente veloce che non riuscivano mai a prenderlo, e quindi a scuola era fallimentare, nello sport non faceva niente di buono, però si sentiva apprezzato proprio per questa sua abilità e sempre di più continuava a fare queste cose, finché anche lui poi è stato preso. Quindi l immagine che un ragazzo deve dare di sé dipende da che immagine gli chiede il contesto dei suoi coetanei, se uno va a finire in un gruppo di ragazzi che gli chiedono invece un efficacia, un abilità in una cosa positiva, il ragazzo diventa così, tanto è vero che anche molti studiosi di devianza minorile dicono che l azione trasgressiva non conta tanto per l efficacia di raggiungere un oggetto, io rubo cioè per rubare, per avere quella cosa, ma è un azione comunicativa, cioè io faccio delle cose per comunicare, per dire agli altri che io sono capace di fare qualcosa. Vedete che ognuno di noi nella vita ha bisogno di essere dagli altri riconosciuto, essere riconosciuto in azioni positive, ma anche in azioni negative, non esistono vie di mezzo quindi per questi ragazzi di 15, 16, 17 anni, il problema è di riuscire a dare loro opportunità positive per riconoscersi e apprezzarsi. Anche la storia di Jimmy è così: Jimmy in carcere continua a fare reati per essere riconosciuto come un vero detenuto, come un duro, eppure dopo va in cella e piange, e si interroga e dice Ma io non sono così, però poi arriva il suo compagno di cella e lui deve subito dimostrargli che invece è un duro. I ragazzi sono condizionatissimi dall immagine che devono presentare agli altri, invece la libertà è essere se stessi, anche se gli altri poi non ti accettano, gli adulti dicono Io sono quello che sono, se mi accetti bene se no pazienza ; il ragazzo non ci riesce ancora, è in una fase di crescita in cui ha molto bisogno degli altri, e quindi è disposto a fare delle cose di cui magari non è convinto pur di avere il loro consenso, e questo lo fa anche per trasgressione. Se poi questo meccanismo continua, il lavoro della comunità è proprio di destrutturare questa identità negativa, che in carcere si è addirittura rafforzata e strutturata. Invece noi dobbiamo poter dire Io ti vedo un ragazzo come gli altri, non ti vedo malavitoso, non mi interessa, tu sei un ragazzo che ha delle capacità e delle po- 123
127 tenzialità come tutti gli altri, e ti voglio dare la possibilità di esprimere queste capacità, nel lavoro, nella musica, nel teatro. I nostri ragazzi hanno fatto gli attori in questo film Jimmy della collina, e Giovanni Cantarella, che viene dalla Sicilia anche con condanne pesanti per mafia, dopo questo film non è più tornato in Sicilia, si è fidanzato in Sardegna, la settimana scorsa si è sposato, quindi è un età in cui si può cambiare, se però trovi il contesto che ti aiuta a capire, dove puoi confrontarti davvero. Elton Kalica: Io vorrei sapere com è la realtà del carcere minorile, com è la vita lì dentro. Don Ettore: Tenete presente che l Ordinamento penitenziario del 75 è uguale per gli adulti e per i minori, tanto è vero che il capo dipartimento della Giustizia minorile, il presidente Melita Cavallo, ha formato un gruppo tecnico di cui anch io ho fatto parte con una decina di operatori, per rivedere e modificare alcuni articoli dell Ordinamento penitenziario degli adulti, per renderlo più vicino alle problematiche degli adolescenti. Quindi il carcere dei minori funziona come un carcere degli adulti in teoria, per fortuna c è da parte degli agenti, degli educatori, della direzione la possibilità di essere più tolleranti, ad esempio non ci sono le divise, e poi al minorile l agente con i ragazzi ci gioca a pallone, a carte, ci scherza. Abbiamo certi agenti che io considero dei padri di famiglia, quando il ragazzo è in crisi gli stanno vicino, gli parlano se lo portano con sé, è un rapporto umano diverso, molto più responsabilizzante anche per il ragazzo; ad esempio io domenica ero in carcere, perché alla domenica pranzo con i ragazzi, e un ragazzo marocchino con un siciliano ad un certo punto si sono accapigliati, e l agente li ha separati, li ha fatti ragionare e riconciliare, in modo molto attento e umano. Il problema del carcere minorile secondo me è questo aspetto del tempo vuoto, ci sono delle attività, ma molto poche rispetto alle necessità, c è ogni tanto qualche proposta che viene da fuori, attualmente c è la pelletteria, c è per due ore alla settimana la biblioteca aperta, però io vedo che i ragazzi spesso stanno lì senza far niente. Certo almeno c è un clima umano accettabile, per essere un carcere, poi cambia in Italia da carcere a carcere. Ci sono carceri molto più aperti, dove i ragazzi stanno fuori dalle celle anche ore al giorno, carceri dove stanno fuori solo 4 ore, il carcere lo creano gli operatori, gli agenti soprattutto che ci stanno 24 ore su 24, gli educatori e tutte le persone che entrano. Alla domenica noi abbiamo la possibilità di celebrare la messa tutti insieme, poi l ora d aria si sta ancora tutti insieme, nel campo si gioca tutti insieme, i ragazzi le ragazze i volontari, insomma abbiamo un direttore che ci ha permesso una vita molto aperta. Ci vorrebbero però a mio avviso più proposte formative di responsabilizzazione, ma il sistema non lo permette più di tanto. Un ragazzo, oltre a dei doveri, ha dei diritti che sono quelli che riguardano la crescita e la progettualità della sua vita, che avviene attraverso l istruzione e l educazione. L educazione è composta di due aspetti secondo me, quello che dicevano i latini, dal verbo educere, tirar fuori le tue potenzialità, tu potresti essere un artista, uno scienziato, un filosofo, io devo aiutarti a tirar fuori tutte le tue potenzialità, le tue attitudini, e nello stesso tempo l educazione è condurti ad accogliere il mondo che ti è attorno, attraverso la cultura conoscere studiare capire sempre di più, acquisire sempre più conoscenze. L intreccio di questi due aspetti avviene nella crescita di ognuno di noi, perché ciascuno tira fuori le sue idee, ma nello stesso tempo accoglie anche quelle degli altri e questo è un rapporto dialettico, questo bisogno fondamentale in 124
128 carcere viene riconosciuto a parole, ma di fatto no, perché è la struttura che condiziona, non è la buona volontà o la professionalità degli operatori penitenziari. Per esempio un ragazzo difficilmente può tirar fuori le potenzialità che ha, perché non ci sono le opportunità, metti che uno avesse la capacità musicale, l attitudine a suonare uno strumento, o lo sport, ci sono solo delle esperienze occasionali, una volta alla settimana si può fare una partita, può entrare una squadra di fuori e tutto finisce lì, ma non c è un allenatore che veda cosa tu puoi fare, non c è un orientamento. A chi in carcere è arrivato senza la terza media si propone di frequentare la scuola per acquisire il diploma, ma molti ragazzi non partecipano alle proposte positive che ci possono essere, perché è il contesto carcere che spesso non permette questa attivazione delle proprie capacità, quindi in carcere si passa molto tempo a non far niente. Ci sono delle mattine che vedo dei ragazzi seduti lì nella sezione, a giocare a bigliardino e niente più, quindi quello che si fa è spesso occasionale, non è un progetto che segna nel tempo, anche perché molti ragazzi sono in misura cautelare, oggi ci stanno domani non lo sai, alcuni hanno pene minime anche di un mese, quindi non puoi fare un progetto a lunga scadenza. Ma la comunità in che cosa si differenzia? Chi entra in comunità deve garantire una presenza almeno di due anni, due anni e mezzo, allora questo per esempio viene proposto a chi ha le pene più lunghe per reati di omicidio, o rapine. Serve un periodo più consistente per apprendere dei ritmi, andare al lavoro, come meccanico, giardiniere, manovale, fuori dalla comunità, perché da noi non si lavora in comunità se non in casi eccezionali, anche se in comunità c è l azienda agricola di 10 ettari, con l uliveto, le erbe officinali, l allevamento delle lumache, però ci serve per il primo mese, perché i ragazzi apprendano la costanza, l impegno, l alzarsi all ora giusta. In carcere questo non avviene, se il ragazzo si alza o non si alza si è molto più tolleranti, noi invece siamo più severi, alle sei e mezza tutti in piedi, dopo tutti a tavola a fare colazione, anch io sono a tavola con loro, e non si comincia se non ci sono tutti. Si inizia così ad insegnare un rispetto vicendevole, qui ci sono gli altri e ti stiamo aspettando, se tu ritardi fai aspettare gli altri. Poi tutti a lavorare, con il loro stipendio che oscilla dai 700 euro ai 1200, mettono 300 euro nella cassa comune gestita da un ragazzo, e così si pagano tutte le spese, il mangiare, luce gas, eccetto il telefono perché ognuno paga le telefonate che fa, e quando arriva la bolletta ognuno paga la sua. Questo è importante, sentire che loro vivono del loro lavoro mentre il carcere è assistenzialismo, in carcere un minorenne sta lì, gli spetta il pranzo, gli spetta tutto, può stare in cella tutto il giorno senza fare niente, e questo è diseducativo. In comunità poi c è chi rientra alle quattro del pomeriggio, chi alle cinque, subito dopo c è il servizio comunitario, che è una sorta di giustizia riparativa, ciascuno ha un compito, c è chi cura il giardino, chi cucina, chi pulisce le stanze, in modo che all ora di cena chiediamo conto di quanto è avvenuto. Finite le due ore di lavoro per la comunità, ciascuno ha del tempo libero: c è chi studia, chi deve prendere la patente, chi frequenta dei corsi scolastici serali, chi gioca al pallone nella squadra del paese vicino. Tutto quello che i ragazzi hanno come potenzialità personale va sviluppato fuori dalla comunità, questo è molto importante, e ci differenzia dalle comunità per tossicodipendenti dove fai tutto dentro, sport, cultura, proprio per tagliare i rapporti con il mondo esterno. Da noi invece invitiamo i ragazzi a uscire, ad affrontare i problemi della vita, perché sono fuori i problemi, tanto è vero che molti appena finito di scontare la pena mi 125
129 dicono: Ma io posso stare ancora in comunità!. Invece è possibile per un mese o due ma non di più, perché la comunità ti tutela, ti protegge, ma i problemi sono fuori e dobbiamo spingere ad affrontarli fuori. Allora la loro giornata è proprio piena, la comunità non ha momenti di ozio, quindi quando si arriva alla fine della giornata alle nove, nove e mezza dopo l ora di cena, e c è la possibilità di guardare la televisione, crollano tutti. Il sabato e la domenica pomeriggio si può uscire, i primi mesi accompagnati dall operatore perché la fiducia bisogna conquistarsela, quando poi vedo la maturazione e la responsabilità allora li facciamo uscire anche da soli, in ore ben delimitate secondo le disposizioni del Tribunale di Sorveglianza. Così finita la pena sono già fuori dalla comunità, cambia l alloggio, ma hanno gli stessi amici, lo stesso lavoro, le stesse relazioni, invece di vivere in comunità vivono nel paese, nella loro casetta, in questo modo avviene un passaggio graduale: la comunità permette quello che la Costituzione ci chiede, il reinserimento, che in carcere tu non puoi fare, cosa inserisci se il ragazzo sta dentro? Dritan Iberisha: Nel carcere minorile in Albania si studiava due ore al mattino e due ore al pomeriggio, ed era una scuola di rieducazione, i ragazzi imparavano un mestiere e quando uscivano erano i primi ad avere un lavoro se volevano, perché il tipo di scuola li faceva diventare dei professionisti, e tanti cambiavano, perché avevano un mestiere in mano. Non lo so se qui il carcere minorile funziona così. Don Ettore: In Italia ci sono 17 carceri minorili ma pochi che danno una formazione professionale, e ti dico anche il perché: è vero che l importante è apprendere una professione poi spendibile sul mercato del lavoro, mentre in carcere i lavori che si fanno sono lo scopino, il portavitto, ma fuori qual è il datore di lavoro a cui serve uno scopino o un portavitto? Il problema è che il carcere raramente dà una professionalità spendibile fuori, nel minorile poi non c è quasi nessuna formazione professionale, innanzi tutto perché i ragazzi per la maggior parte sono in misura cautelare, oggi ci sono domani non ci sono, e possono essere facilmente trasferiti. E poi i ragazzi, non essendo obbligati a frequentare i corsi, ci vanno un giorno sì e uno no, perché se non c è una motivazione forte ad essere presenti non li frequentano, da noi non sono obbligati per niente: c è la scuola, vuoi venire? No non ho voglia, allora non vengo oggi non vengo domani, e l insegnante ti dice che non può darti il diploma di scuola media. Gli adulti capiscono, acquisiscono una professione, se il carcere gli da un opportunità la colgono, per gli adolescenti è difficilissimo, il problema più grosso che noi abbiamo con ragazzi di 16, 17, 18 anni è di essere in quella fase che io chiamo preadolescenziale, dove non c è ancora un progetto di vita, dove si vive il carcere come un tempo da passare e finirlo e basta. Chi viene in comunità invece ha già maturato un idea diversa, perché quando facciamo i primi colloqui io dico spesso che se il ragazzo viene in comunità per scontare la pena, allora non lo posso accogliere, se viene in comunità per cogliere un opportunità per cambiare stile di vita, per acquisire una professione, allora può venire. La comunità ha tutto un altro progetto, che è quello appunto della professionalizzazione, dell andare a scuola, del riprendere gli studi. Due ragazzi con noi hanno ripreso gli studi e sono all università, perché hanno chi li aiuta economicamente e possono così fare qualcosa in più per la loro vita, ma se non c è un progetto di lavoro o di studio la comunità non serve a niente. 126
130 Chi viene in comunità è motivato a riprendere in mano la sua vita, e questo durante la detenzione invece è difficilissimo, sono rari i casi di un ragazzo che chieda di studiare, perché è proprio l età adolescenziale che non permette ancora di coltivare un progetto di vita a ragazzi che vengono da condizioni di disagio, sono abbandonati, non sono interessati a niente. Davor Kovac: Io le volevo chiedere se i ragazzi stranieri quando finiscono la condanna riescono in qualche modo ad avere il permesso di soggiorno, oppure a rinnovarlo se scaduto. Don Ettore: Io credo che i ragazzi stranieri non vengano in Italia per delinquere, ma per trovare un maggior benessere, per vivere un po meglio. C è un ragazzo attualmente da noi che è scappato dalla Romania in Austria che aveva dodici anni, l hanno preso e riportato a casa, è riscappato e lo avevano preso con loro dei Rom, per quattro anni andava a rubare, era bravissimo a rubare, poi a Bologna l hanno fermato, da Bologna lo hanno trasferito a Quartucciu, da Quartucciu è venuto in comunità ed è attualmente ancora in comunità, anche se ha già finito di scontare la pena. Ed è bravissimo, ha diciannove anni, sta lavorando in un impresa che ha a che fare con i computer, ed è un ragazzo di una grande onestà, che mette in riga gli altri italiani quanto ad affidabilità, che aiuta la famiglia mandando i soldi a casa. Cosa vuol dire tutto questo? Che anche lo straniero che viene in Italia, se gli dai l opportunità di avere un lavoro, di essere accolto, di avere degli amici, di essere stimato, lui la coglie al volo, ma chi non ha questa opportunità continuerà anche dopo avere scontato la pena a vivere nell illegalità. Invece abbiamo un ragazzo marocchino che è stato arrestato a Milano per una fesseria, poi è venuto a Quartucciu, poi da noi, ha compiuto il diciottesimo anno ed era senza permesso di soggiorno, siamo riusciti a farglielo avere, con il permesso di soggiorno è entrato a lavorare in un Mac Donald in part time, il resto lo fa da noi nella azienda agricola e vive in un paese vicino. Così si è messo da parte circa euro e con quei , e gli altri glieli ha dati la banca, si è comprato una casetta dove ha fatto arrivare anche altri due fratelli, con la richiesta di lavoro da parte nostra. Questo vuol dire che anche lo straniero, una volta che entra in un ritmo di legalità, difficilmente ne vuole uscire, e la questura se c è un rapporto di fiducia in quello che si fa riesce anche ad andare oltre, e dare il permesso di soggiorno, anche perché gli ho detto che ne rispondo io. Il ragazzo è veramente a posto, dopo tre anni che ha vissuto in comunità ho capito che lui era lontanissimo dall idea di commettere reati, certo c è sempre un po di rischio, però io penso di poter distinguere, tra quelli che vedo dove si indirizzano rispetto ad altri, quindi se vengono in Italia, se sbagliano e si scontano la loro pena, e poi vogliono vivere nella legalità, perché non accoglierli dandogli il permesso di soggiorno? Bruno De Matteis: Io sono stato nel carcere minorile, e mi ricordo che spesso si creavano dei gruppi, nel senso che c era chi aveva violato più volte la legge, e chi capitava lì per il primo reato, e in qualche modo spesso veniva emarginato dai soliti bulletti. Succede così anche oggi? Don Ettore: Noi cerchiamo oggi soprattutto di convincere quelli che ci sono da più tempo a rispettare i nuovi, e lo facciamo mischiando gli stranieri con gli italiani. Questa in comunità è una regola normale, ad esempio c era un ragazzo italiano che doveva 127
131 venire in comunità e mi aveva detto: sì, tutto a posto però non voglio andare a dormire con Mohamed. Io gli ho risposto che l alternativa era che se ne restava in carcere, poi è venuto in comunità e lui e il ragazzo marocchino sono diventati amicissimi. Anche in noi italiani c è questo pregiudizio nei confronti dello straniero, del marocchino, del rumeno, ma una volta che si incontrano e che si crea un rapporto di fiducia, poi le cose cambiano. È questo che noi dobbiamo tentare, se continuiamo a tenerli separati a guardarsi con diffidenza gli uni con gli altri, quelli continuano con un rapporto conflittuale, quindi il carcere è un opportunità di stare insieme fra diversi, anche se in carcere è più difficile. In comunità è più facile, perché dopo un po di tempo si vede che i ragazzi in fondo hanno tutti gli stessi bisogni, gli stessi desideri, e quindi riescono a stare insieme. La vera preoccupazione è quella del dopo, io dico sempre con i miei collaboratori che il giorno che il ragazzo entra in comunità bisogna già fare un progetto per l uscita. Bruno De Matteis: É una grande cosa che voi fate, quando vi preoccupate dei ragazzi minorenni che escono, perché se i ragazzi escono e non hanno nessuno, si trovano direttamente in strada e non fanno altro che tornare a delinquere. Don Ettore: La mia esperienza nasce proprio da quello: 11 anni fa io facevo il padre cappellano, e nel giro di due anni quanti ragazzi ho visto uscire dal carcere e rientrare! Uno dopo tre ore appena, è uscito a mezzogiorno alle tre era già lì, appena uscito è andato all ingresso di una scuola e ha scippato una ragazza, quando gli ho chiesto perché, mi ha detto che doveva mangiare. Allora ho capito che bisognava avere una struttura di passaggio fra il carcere e il rientro nella società, la comunità fa in modo che, finita la pena, tu hai il tuo lavoro, la tua casa, le tue amicizie, tanto è vero che la recidività è altissima quando si esce dal carcere, e dalla comunità è minima, perché è una questione graduale il reinserimento, devi farlo gradualmente in modo che finita l espiazione della pena tu sia già inserito, cambi la casa, ma il contesto di vita è lo stesso. Daniele Barosco: Vorrei parlare di un fatto avvenuto in Sardegna, di quei ragazzi che hanno violentato una donna, e poi tre di loro sono stati uccisi per vendetta, dai famigliari della vittima credo. Si può fare qualcosa perché in queste piccole comunità non si manifestino più questi fenomeni di odio e di vendetta? Ornella Favero: In redazione abbiamo discusso parecchio della vendetta, perché qui ci sono molti detenuti, in particolare albanesi, che spiegano anche ai ragazzi delle scuole che la vendetta nelle famiglie è ancora una pratica molto diffusa, e bisogna ragionare su come riuscire a spezzare la catena dell odio. Don Ettore: È successo a Dorgali, qualche anno fa, dove due minorenni e un maggiorenne hanno commesso una violenza sessuale nei confronti di una signora di una certa età. I due ragazzi sono stati, uno in primo grado assolto, l altro condannato a due anni e mezzo, quest ultimo è da me in comunità, il 21enne è in carcere. Quello assolto in primo grado, Sebastiano, è poi stato condannato in appello a 6 anni. Dopo questo episodio sono state uccise tre persone, durante tutta la fase processuale, l ultimo ad essere ucciso è stato Sebastiano, esattamente tre mesi fa in un bar gli hanno sparato, e questo naturalmente ha generato nell altro ragazzo che è in comunità grande paura che uccidano anche lui come oggetto di vendetta. Il rischio c è ma non da parte dei parenti della 128
132 signora, sembra che sia un altro gruppo che vuole quasi tutelare l onorabilità di questa donna. A questo ragazzo che è stato ucciso, Sebastiano, avevamo detto tante volte di non stare in paese, di andare a vivere fuori. Nella nostra cultura il reato sessuale è considerato un reato gravissimo, più dell omicidio. Di questo abbiamo parlato anche con i preti della zona, ci sono delle cose fortemente radicate, in chiesa io oso parlare di misericordia, di perdono, e credo che mi ascoltino, ma l idea della vendetta è talmente radicata che bisogna cominciare più che altro con i ragazzi a far capire che è sbagliata, tanto è vero che un mese fa abbiamo fatto degli incontri con dei ragazzi delle scuole medie ad Orgosolo per affrontare questo tema, con le persone adulte e gli anziani è più difficile. Daniele Barosco: Tra i minori si riscontra un livello elevato di reati? Don Ettore: Sono circa le denunce sui minori in Italia, ed è un dato che è abbastanza stabile da anni, per cui non c è e non si vede questa escalation, noi veniamo allarmati dai mass media quando succedono fatti eclatanti, come la storia di Erika e Omar, ma sono casi rari, di questi in carcere ne finiscono , molti sono stranieri, gli italiani sono pochissimi. Quindi non c è tutto questo allarme, poi nella procedura minorile in molti casi non entri neanche in carcere, il magistrato ha la possibilità di darti delle prescrizioni a casa, o il collocamento in comunità senza conoscere il carcere. Secondo me si crea allarme sociale per abbassare l età della punibilità a 12 anni. Lucia Faggion (volontaria): Ci piacerebbe sapere anche come è nata la vostra comunità. Don Ettore: Quando con il Tribunale di Sorveglianza io ho proposto questa comunità, mi hanno detto: leggi che diano aiuto finanziario non ce ne sono, ma se fai una struttura che ci dia garanzia di controllo noi te li mandiamo, i ragazzi. Io ho avuto la fortuna di avere un terreno, di costruire una casa, di avere un gruppo di volontari che ci hanno aiutato ad accogliere i primi ragazzi, i primi due condannati per omicidio, Antonio e Giancarlo, di un paese del nuorese. Quando questa comunità è diventata insufficiente perché eravamo otto e non ci stavamo più, la Regione ha finanziato la costruzione di un altra comunità, e con la nuova comunità naturalmente c era bisogno anche di operatori stabili e retribuiti. La Regione Sardegna allora nella legge finanziaria ha inserito lo stipendio di cinque operatori e questo ormai lo fa da dieci anni, unica in Italia con queste modalità. Un altra comunità di questa tipologia non esiste, soprattutto perche non ci sono risorse finanziarie, e non può essere fatta da volontari, i volontari possono esserci solo per dare una mano, ma non può la comunità strutturarsi solo sul volontariato, è troppo a rischio, ci vuole professionalità, sicurezza della presenza. Ornella Favero: Ma come funziona la vostra comunità? E voi non accogliete ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza? Don Ettore: Che i ragazzi che finiscono al minorile spesso abbiano usato spinelli o un po di cocaina è purtroppo scontato, l ultimo che è venuto ha usato per più di un anno cocaina, però l importante per entrare in comunità è che non ci sia quella dipendenza forte e strutturata che ha bisogno della comunità chiusa. Questo ragazzo che abbiamo preso fa il manovale in una ditta a Cagliari, con un controllo abbastanza rigido, cioè va 129
133 a lavorare e durante l ora di pausa non si può spostare da li, quando finisce rientra con la macchina, la sua dipendenza non era tale da richiedere una comunità terapeutica chiusa. La vita della comunità è basata innanzitutto sul lavoro, tutti devono lavorare e vivere del loro lavoro. Abbiamo la riunione con i ragazzi il giovedì sera dove si affrontano tutti i problemi della comunità. Il martedì mattina invece c è la riunione dell equipe con la collaborazione dei servizi sociali per parlare dei singoli ragazzi, in modo che, quando notiamo che c è bisogno di un altro tipo di intervento esterno, psicologico, psicoterapeutico, farmacologico, ci si serve dei servizi esterni. Tutti i ragazzi almeno una volta alla settimana vanno dallo psicologo. Se ancora non ci sentiamo di farlo andare da solo viene lo psicologo in comunità e fa il suo colloquio, quindi valutiamo da ragazzo a ragazzo di cosa hanno bisogno, può esserci bisogno anche di un lavoro più psicoterapeutico, come facciamo con questo ragazzo che ha avuto esperienza di cocaina, e sta andando al Ser.T., ogni settimana fa i colloqui e noi ci confrontiamo con chi lo segue per sapere su cosa dobbiamo stare attenti, che cosa il ragazzo sta vivendo, come dobbiamo seguirlo. Naturalmente la nostra non è una comunità terapeutica, noi la definiamo comunità educativa, quindi tendiamo a non usare farmaci se non in casi eccezionali. Io la nostra comunità la penso sempre così, è come una famiglia, l importante è il clima affettivo, questo noi cerchiamo di costruire, se poi c è il ragazzo che ha bisogno ci sono i servizi. Tutti i servizi sono fuori, dalla scuola, al lavoro, allo psicologo, al medico, tutto fuori, tu devi imparare a vivere utilizzando i servizi, tanto che abbiamo tanti amici medici che potrebbero aiutarci, ma i ragazzi devono seguire le procedure che seguono tutti i comuni mortali. Certo se poi c è una urgenza chiamo l amico medico e viene in comunità, altrimenti dobbiamo insegnargli ad affrontare le difficoltà della vita, cioè prima di uscire devono capire che il mondo fuori è duro, ma devono essere in grado di difendere i loro diritti, di farsi rispettare e rispettare gli altri. Dritan Iberisha: I ragazzi che entrano in carcere anche con reati molto gravi, come le violenze sessuali, stanno tutti assieme o vengono divisi, come succede nel carcere per adulti, e poi invece in comunità stanno insieme, e cosa fa la comunità per aiutarli? Don Ettore: Si mettono insieme, e devo dire che nel carcere minorile non c è quello che mi dicono del carcere degli adulti, dove gli autori di reati di tipo sessuale vengono guardati con molta diffidenza e messi in sezioni separate. Noi cerchiamo di lavorare in modo che anche chi ha fatto questo tipo di reato sia considerato sempre un ragazzo recuperabile. Io penso anche che la violenza fatta da ragazzi sia a volte un po il frutto di tutto quello che vediamo e sentiamo in televisione, pornografia sulla sessualità, tanto che i ragazzi sono sì autori di reati, ma sono anche vittime. Se penso a quei minorenni che hanno violentato di recente una ragazzina, e dopo l hanno uccisa, credo che forse dovremmo interrogarci anche noi adulti, genitori, insegnanti, mass media. A me a volte piace dire che gli adolescenti sono un po lo specchio della società degli adulti, non nascono violenti, non nascono stupratori, questa cultura l hanno presa dal contesto in cui vivono. Io poi uno di questi ragazzi ce l ho in comunità, ed è un ragazzo dolcissimo. Lui dice che ha sbagliato, ma che si è trovato coinvolto in qualcosa di più grosso di lui, però evidentemente c era già questa incapacità di cogliere la sofferenza, e 130
134 questa è una caratteristica propria dei bulli, non riescono a vedere la sofferenza dell altro che tu violenti, a cui fai del male, perché in te è stato annientato il sentimento dell altruismo, del sentire che l altro è anche lui come te e ha bisogno anche lui di essere rispettato come te. Ma questo è il frutto di una cultura in difetto, di un individualismo sfrenato. Io mi realizzo con l altro, la mia vita è una vita relazionale, solo se sono capace di rispetto degli altri sarò capace di rispettare me stesso. Invece oggi la cultura è quella che tu ti realizzi contro gli altri, li devi sfruttare, imbrogliare, fregare, violentare, questo è qualcosa che viene fuori da questa cultura dominante, che ci trasmettono i mass media, che ci trasmettono persone che hanno grandi responsabilità istituzionali purtroppo, perché mancanza di rispetto è anche quella di aggredire chi non la pensa come te. Questi ragazzini di 12, 13, 14 anni sono responsabili, non li voglio scusare, altrimenti sarebbe pericoloso, però chiediamoci anche la responsabilità degli altri. Per chi commette un reato da minorenne è responsabile anche la comunità, e così nel recupero deve entrare in gioco tutta la collettività, non serve emarginarli, chiuderli in un carcere o metterli da parte, è importante cercare di recuperarli, prospettandogli un tipo di vita diversa. Il lavoro principale è il lavoro culturale, quello che noi facciamo con i ragazzi, un numero piccolissimo, 35 ragazzi contro i denunciati, ma la nostra vuol essere una testimonianza che è possibile un percorso diverso. Ora addirittura in Sardegna vogliono fare 4 carceri, con i soldi di 4 carceri si possono fare 80 comunità come la nostra e accogliere lo stesso numero di ragazzi, cioè bisogna entrare nell ottica che la pena, la sanzione non deve essere per forza sempre detentiva, e questo non lo dico solo per i ragazzini, per i minorenni per i giovani, ma anche per gli adulti. Però questo passa solo attraverso un cambiamento culturale, perché la gente vuole il carcere, gli dà più sicurezza che tu sia chiuso in un carcere, a me qualcuno lo dice pure: quelli hanno commesso anche omicidi e tu li tieni in comunità, la galera devono fare! E io gli rispondo: ma guardate che la comunità è anche più dura della galera. In galera spesso non fanno niente, mangiano e dormono e basta, invece in comunità devono pagarsi il vivere, devono lavorare, allora bisogna potenziare queste strutture, e poi bisogna aprire la comunità a tutti, così i ragazzi si mischiano con le persone di fuori. L importante è far capire alle persone che vengono da fuori che questi ragazzi hanno sbagliato, però sono ragazzi che hanno delle potenzialità. La gente cambia opinione più che con le prediche nostre, vedendoli, i ragazzi, cioè quando Antonio si è fidanzato nel paese vicino, all inizio è stato un grosso problema, i genitori venivano da me preoccupati per la figlia, poi quando hanno visto Antonio, la sua bontà, le sue capacità di relazione, allora hanno capito che è possibile cambiare, quindi la comunità è l esempio che chi ha sbagliato può tornare sulla via della legalità e del rispetto come tutti gli altri. Prince Obayangbon: Questa attività che lei sta facendo adesso come la può conciliare con la sua fede? Don Ettore: È possibilissimo, basta pensare per esempio che quella che abbiamo in comunità è una cappella ecumenica, è un misto tra una moschea, una chiesa ortodossa e una cattolica, dove non facciamo nessuna pratica di culto cattolica. Io non faccio la messa, la messa la faccio in carcere dove sono il cappellano, ma in comunità no, perché ci sono i marocchini islamici, i rumeni ortodossi, e i cristiani. Cosa facciamo? Una let- 131
135 tura della Bibbia o del Corano. La mia motivazione è quella di riuscire a fare in modo che le persone che hanno professioni di religioni diverse si incontrino, perché fino ad oggi si sono combattute, invece è importante far capire una regola d oro di tutte le religioni, dallo scintoismo al buddismo, che rispettare se stessi e rispettare gli altri è la legge fondamentale di tutte le religioni, quindi insegnare ai ragazzi che il rispetto vicendevole vale per tutte le pratiche religiose. La mia fede mi spinge a guardare l uomo nella sua concretezza, perché prescindendo da che religione ha, che cultura, che visione politica, ha però gli stessi desideri di amare e di essere amato, di essere accettato e accettare. Walter Sponga: Quello che fate per i ragazzi mi sembra molto utile, ma per le famiglie di questi ragazzi fate qualcosa? Don Ettore: Io credo che ci siano ragazzi che hanno le radici del loro disagio, che poi è sfociato nella devianza, proprio in famiglia, ci sono ragazzi che invece hanno famiglie più positive, come nel caso di Antonio che ha iniziato ad abbandonare la scuola a 13 anni, anche per la morte del padre a cui lui era molto affezionato, ma la famiglia era molto sana, molto solida. Lui l omicidio lo ha commesso a 16 anni, è entrato in carcere e la famiglia lo ha sostenuto, e poi in comunità ha continuato a frequentare il fratello e la sorella. Io dico sempre ai famigliari: attenti, noi abbiamo un progetto educativo, insegniamo anche piccole cose come l uso del danaro, delle sigarette, parliamo delle sostanze, se voi collaborate siamo in sintonia altrimenti no, quindi con le famiglie facciamo un discorso iniziale di collaborazione, chi collabora avrà più possibilità di venire in comunità, di stare a cena con noi, e i ragazzi di andare con loro. Con chi invece è più in difficoltà stiamo più attenti, li segnaliamo ai servizi sociali, perché dovrebbero essere loro a fare da coordinamento e lavorare su quella famiglia, ma questo avviene anche quando un ragazzo esce dal carcere, perché se la famiglia non ha fatto un passo avanti di accoglienza di questo ragazzo, è chiaro che poi il ragazzo, trovandosi in quella famiglia, in quel contesto, se è anche un contesto trasgressivo di legalità, cadrà di nuovo. Io ho ragazzi di un quartiere di Cagliari dove i genitori sono grossi spacciatori e il ragazzino aiuta, quindi se, finito di espiare la pena, ritorna in quella famiglia rifarà le stesse cose. Però ci sono ragazzi che riescono ad essere consapevoli di questo, ricordo un ragazzo, una storia bellissima, che ci è stato affidato dal tribunale a 16 anni, per grossi conflitti con la famiglia, soprattutto con la mamma. L hanno mandato in comunità da noi e piano piano ha ripreso il cammino, a 18 anni è ritornato dalla madre, facendo lui in un certo senso il genitore della madre. Anche molti genitori vengono da esperienze negative di istituzionalizzazione, sono stati magari in orfanotrofio, quindi c è bisogno di aiutare le famiglie a riaccogliere il ragazzo, però anche esercitando un controllo, perché ad esempio non vogliamo che diano soldi ai ragazzi. I ragazzi devono vivere del proprio lavoro, se uno di loro deve fare un acquisto particolare e non gli bastano i soldi glieli presto io, e quando prende lo stipendio me li restituisce, altrimenti quando vanno fuori hanno bisogno di aiuti continui, e noi invece lavoriamo perché siano persone responsabili. 132
136 COME FUNZIONANO LE PENE A spiegarlo sono i Magistrati di Sorveglianza di Padova, Giovanni Maria Pavarin e Marcello Bortolato a cura della Redazione di Ristretti Orizzonti L incontro in redazione con i Magistrati di Sorveglianza di Padova, Giovanni Maria Pavarin e Marcello Bortolato, è stato in buona parte dedicato al tema dell informazione. Perché è un tema cruciale oggi: infatti ogni notizia data in maniera non corretta sulle pene e sulle misure alternative rischia di portare un altro mattone alla costruzione di leggi emergenziali, che poi si abbattono pesantemente sulla vita di chi sta in carcere, ma anche su quella dei cittadini liberi, perché un clima di sospetto, di intransigenza, di chiusura su ogni prospettiva di pene più umane alla lunga diventa pesante per tutti. Ornella Favero: Noi riteniamo che ci sia una informazione così superficiale sull esecuzione delle pene, che alcuni chiarimenti vorremmo darli ai nostri lettori proprio attraverso di voi. Una delle questioni fondamentali riguarda proprio i criteri con i quali i magistrati decidono se concedere o meno una misura alternativa al carcere. Basta pensare, ad esempio, alla vicenda di Pietro Maso, il ragazzo che 17 anni fa ha ucciso i genitori e ora è in semilibertà, addirittura trasmissioni televisive facevano i calcoli del suo fine pena mettendo in conto anche i cinque anni della liberazione condizionale, come se fosse una cosa automatica ottenerla. Il dato è invece che la percentuale di concessioni della liberazione condizionale è bassissimo, il 3 per cento. A noi più che altro interessa far capire fuori che i detenuti comuni che tornano a commettere reati, mentre stanno usufruendo di una misura alternativa al carcere, sono lo 0,45 per cento. E ci piacerebbe comunque ribadire quali sono i criteri che voi usate per formare il vostro giudizio, vorremmo spiegare alla gente che non c è nessun automatismo nella concessione delle misure alternative, ma una valutazione che tiene conto di moltissimi elementi. Giovanni Maria Pavarin: È evidente che il clima che stiamo vivendo adesso, dal punto di vista politico, è improntato ad una sostanziale disinformazione. È proprio di questi giorni una inchiesta sul senso di insicurezza, che viene trasmesso insistentemente dai mezzi di informazione ma che non corrisponde ad un aumento effettivo dei reati. Si è detto infatti che nel 2007 e nei primi mesi del 2008 si parlava sempre di più di criminalità in aumento dopo l indulto, e invece dal punto di vista statistico non si è avuto incremento dei fatti di reato, né si è tenuto conto della circostanza che nel medesimo periodo molti degli indultati sarebbero comunque usciti dal carcere. Quindi è ovvio che la disinformazione è un aspetto contro cui noi Magistrati ben poco abbiamo da contrastare se non altro per il fatto che raramente ci è data la possibilità di fornire dati reali, oltre al nostro punto di vista tecnico di cui ben pochi, mi sembra, tengano conto. Per quanto riguarda la questione dell errore umano dei magistrati, è evidente che l errore è una variabile di tutti gli uomini. Anche il magistrato, che è un uomo come tutti gli altri, purtroppo può sbagliare e nel caso della Magistratura di Sorveglianza si tratta 133
137 spesso di un errore di previsione. Del resto, la prognosi favorevole smentita dai fatti è un evenienza possibile nel nostro lavoro ed anche ineliminabile se si vuole, perché è nella realtà delle cose: la vita ha tante sfaccettature ed il Giudice di Sorveglianza si occupa più del futuro che del passato. Ciò accade anche in altri settori della giustizia: si pensi al Tribunale dei Minorenni dove ci si confronta quotidianamente con il futuro, la prognosi, la scommessa sul cammino di vita di un bambino da strappare ad una famiglia e da inserire in una nuova. Ma anche al Giudice della condanna quando concede o nega la sospensione condizionale della pena. Può capitare che le valutazioni di un giudice poi si scontrino con i dati della realtà i quali possono smentire un giudizio favorevole. Per quanto riguarda il percorso attraverso il quale noi arriviamo ad una decisione sulla concessione dei benefici, si tratta forse dell elemento più importante del nostro lavoro, perché noi decidiamo applicando delle leggi, alle quali abbiamo giurato fedeltà, e dobbiamo necessariamente applicarle. Poi c è ovviamente uno spazio lasciato all interpretazione che è variabile, e nel compiere la quale il magistrato deve comunque seguire delle norme ma in cui tuttavia ed inevitabilmente mette dentro anche quello che è lui personalmente, quindi la sua cultura, la sua cura nell ascoltare, ed anche le sue convinzioni. Ovviamente noi come Magistrati di Sorveglianza ci basiamo prevalentemente su degli scritti, quindi su dati di fatto riportati, relazioni, osservazioni degli educatori, dati che desumiamo anche dalla sentenza, che è il nostro punto di partenza, nel bene e nel male. Partiamo dunque da lì, dopo di che ovviamente nel fascicolo leggiamo quello che scrivono i condannati, gli educatori e le forze dell ordine, e poi ci mettiamo del nostro, attraverso il colloquio, che da quanto ho capito, perché è poco che sto facendo questo lavoro, è un elemento fondamentale per prendere qualunque decisione. Il colloquio che si fa all interno della Casa di reclusione direttamente fra magistrato e detenuto, e poi anche in udienza, è un momento fondamentale. Quindi per la valutazione del caso è fondamentale come il detenuto viene al colloquio o in udienza, come si presenta, quello che dice, quello che sa dire su quello che ha commesso, perché ad esempio davanti al Tribunale ci sono quattro magistrati, che lo vedono magari per la prima volta, mentre il Magistrato di Sorveglianza generalmente l ha già conosciuto, l ha già visto, quantomeno ha già studiato il suo fascicolo, ma gli altri è la prima volta che vengono in contatto con lui. Mi pare che questi siano gli elementi su cui si può fondare la decisione, che è comunque una decisione oggettiva, perché noi abbiamo fatto studi di diritto e dunque ci basiamo sull applicazione delle norme. Però il magistrato porta anche se stesso; qualsiasi uomo quando prende una decisione porta se stesso, e quindi necessariamente fa delle scelte anche in relazione alle sue opzioni ideali, prima fra tutte quella sul valore rieducativo della pena, a quanto creda o non creda in questa funzione. Noi siamo obbligati comunque a crederci, perché la Costituzione dice che la pena ha una funzione rieducativa. Ovviamente più uno ha una sensibilità in questa direzione e più è portato a prendere delle decisioni in un certo senso, questo è un dato inevitabile, ripeto: il magistrato è un uomo. Per fortuna il nostro sistema giudiziario è fatto in modo tale, che la decisione di un magistrato non è poi quella definitiva ed è soggetta ad ulteriori controlli e rivalutazioni. 134
138 Elton Kalica: Il fatto che ci sia una valutazione individuale così complessa sul soggetto lo sappiamo noi, ma fuori non lo sanno, anzi sempre di più i giornalisti, sui canali televisivi, ma anche sulla carta stampata, fanno dei conti incredibili sull esecuzione della pena, i più famosi sono i conti che ha fatto Travaglio dicendo che se uno uccide la moglie, fra la riduzione di pena di un terzo per il rito abbreviato, un terzo per l incensuratezza, tre anni in meno per l indulto, cinque anni di condizionale, tre anni di liberazione anticipata, dopo tre anni uno è fuori, quindi ha concluso che oggi in Italia conviene più uccidere la moglie che divorziare, che ti costa di più. Giovanni Maria Pavarin: Quello che stupisce e forse addolora, ma che soprattutto stupisce, è come anche le persone più acculturate hanno un atteggiamento un po cinico, con cui spesso si accostano a questi grandi temi, probabilmente non pensando che anche in carcere si vede la televisione e uno può sentirsi, non dico offeso, ma sconvolto dalle considerazioni che vengono fatte. E non è la prima volta che dei giornalisti irridono il sistema della pena, quasi non considerando che ci sono delle persone che fanno 10 anni, 20 anni in carcere. Io conosco una persona che ha fatto 44 anni di carcere, quando sentivo questi discorsi mi veniva voglia di dire al giornalista: vieni qui che ti presento tizio che è stato 44 anni chiuso. Queste persone credo che andrebbero invitate anche qui per provare a spiegare un po la cosa. E se devo giudicare te, Travaglio, con equilibrio, e se devo giudicare la tua serietà e la tua fondatezza, con l equilibrio delle cose che dici, e da come parli di me, di quelli come me, della pena e dell esecuzione penale, mi viene da dubitare che tante altre cose che tu dici siano fondate. Quindi per misurarti io ti invito e ti spiego, e ti faccio vedere il carcere, che non è proprio come tu pensi, ammesso e non concesso che le cose che tu dici corrispondano a quelle che pensi. Voi sapete meglio di me, perché ne avete un esperienza diretta, che cos è la pena, e cos è l esecuzione, e come tante cose che vengono dette non corrispondano al vero. Esistono certo dei casi in cui veramente la società è sbigottita, perché è vero che ci sono delle applicazioni della legge sui pentiti che riconsegnano quasi subito alla società delle persone, che si sono macchiate di gravissimi delitti, solo per la logica dello scambio, ma ripeto la cosa avviene sempre di meno, perché sempre di più i tribunali valorizzano quella discrezionalità, che la legge affida a loro. Questa discrezionalità, di cui ha parlato il mio collega, non è un arbitrio, non è un fare quello che voglio a seconda che mi sia simpatico l uno o l altro, è una discrezionalità tecnica, che si basa sull uso di certi parametri che sono logici, che sono giuridici, che sono di esperienza. Non è un arbitrio puro che non risponde a nessuna logica, è una discrezionalità che deve poggiare su degli strumenti di logica. Ma quali sono gli strumenti della logica che usiamo? Primo il buon senso, la considerazione delle cose che la legge non dice, ma che è giusto che il magistrato valuti, ad esempio, lo diciamo sempre, la posizione delle vittime, esistono ancora, non esistono più, quante sono, qual è il tuo atteggiamento nei confronti delle vittime, questo è un fattore che ha sempre un importanza maggiore, ma non è una importanza che diamo per ostacolare il cammino della riabilitazione. È un importanza maggiore che diamo per rendere più credibile il discorso delle misure alternative, che si legittimano in tanto, in quanto facciamo in modo che la società le accetti sempre più, nella misura in cui, sulla bilancia, diamo un posto e un peso 135
139 specifico anche ai danni che sono stati fatti. Quindi l uso della discrezionalità avviene tramite la motivazione del provvedimento che prendiamo, che è soggetto alla censura del giudice che controlla la nostra ipotesi, ed è la Corte di Cassazione. Se la motivazione non è coerente, sufficiente, logica, allora il provvedimento viene annullato. Elton Kalica: Io vorrei cominciare a fare un ragionamento prendendo tutte queste misure una ad una, ad esempio la liberazione anticipata, lo sconto di pena di 45 giorni a semestre, che l opinione pubblica e soprattutto i giornalisti pensano sia una cosa che viene data automaticamente. È vero che voi Magistrati di Sorveglianza la concedete a tutti, o no? Marino Occhipinti: Mi viene in mente un articolo su un quotidiano locale che parla dei due albanesi condannati per la rapina di Gorgo al Monticano, in cui hanno ucciso la coppia di custodi di una villa. La giornalista pone la domanda: Fra nove anni, uno per altro lo ha già scontato, Naim Stafa, condannato all ergastolo, potrà usufruire dei permessi? E lei stessa risponde: Certo, e la valutazione del giudice sarà in realtà solo una mera presa di conoscenza del fatto che si sia comportato bene, se lo avrà fatto i permessi non si potranno negare. Noi questa la riteniamo una affermazione offensiva, perché sappiamo che non è così, non è vero. Quindi vorremmo spiegare meglio queste questione proprio con le vostre parole, insomma utilizzando questo incontro, per spiegare che in fondo certe cose non le vogliamo dire noi perché ci fanno comodo, sono cose dette da magistrati ai quali devono credere. Marcello Bortolato: È evidente che non c è nulla di automatico, perché altrimenti a questo punto basterebbe un computer, o l amministrazione stessa, è ovvio che se ci sono i magistrati c è anche una decisione discrezionale. Come giustamente diceva il mio collega, l importante è che il magistrato espliciti il percorso motivazionale, ed è giusto che dica il perché ha negato un beneficio o perché lo ha concesso, sia in un caso come nell altro; è un controllo che non solo deve fare la Corte di Cassazione, ma che devono fare i cittadini, la Giustizia viene amministrata nel nome del popolo, e quindi anche i cittadini devono poter controllare il perché un beneficio è stato negato o concesso, oltre ai diretti interessati. Quella dell informazione è una battaglia difficilissima, perché se noi dovessimo ogni volta ribadire che le cose non stanno come dicono i giornali o la televisione, impiegheremmo gran parte del nostro tempo ad indicare a molti giornalisti e commentatori le inesattezze, le superficialità, le approssimazioni in materia di giustizia. Ecco, l unica cosa che si può dire in questo caso è che la liberazione anticipata non è assolutamente automatica, certo è un beneficio che viene concesso sulla base di un comportamento buono in carcere, quindi se non ci sono rilievi disciplinari, se il comportamento del detenuto è conforme ad un opera di risocializzazione, il beneficio è difficile negarlo. Però ciò non toglie che viene negato anche quando da un comportamento complessivo si possa desumere una totale chiusura rispetto all opera di rieducazione. Forse allora i giornalisti dovrebbero seguire qualche lezione di diritto penitenziario quando si occupano di carcere. Il discorso di Travaglio poi è grave, perché Travaglio è un giornalista molto intelligente, il suo forse è un paradosso, però lo sa lui stesso che non è cosi ma talvolta prevale l esigenza di andare incontro ad un certo uditorio, è ovvio però, e lo ribadiamo noi tecnici del settore, che sono assurdi questi calcoli, che non esistono questi automatismi. 136
140 Elton Kalica: Per quello che ho visto anche il buon comportamento e la partecipazione alle attività rieducative non determinano sempre la concessione del beneficio. A volte basta un semplice richiamo per infrazione al regolamento interno del carcere, o anche per aver otturato lo spioncino del bagno quando si va a fare i propri bisogni, e i 45 giorni si perdono. Anche perché dopo aver fatto 5, 10, 15 anni di carcere non è una cosa facile mantenere un comportamento lineare senza incappare mai anche in un semplice richiamo. Giovanni Maria Pavarin: Sulla liberazione anticipata dobbiamo ricordare quello che dice la legge, sono concessi 45 giorni per ogni semestre di pena espiata a chi abbia fatto due cose: punto primo, abbia tenuto regolare condotta, punto secondo, abbia dato prova di aver partecipato all opera di rieducazione, questi sono due pilastri logici sui quali il magistrato ha l obbligo di fondare le sue motivazioni di decisione, punto. Poi c è una norma che spiega che cosa significa partecipare all opera di rieducazione e cosa significa regolarità nel comportamento, anche qui c è la discrezionalità del magistrato, che deve spiegare il perché la dà o il perché la nega. Regolare condotta significa non essere incappati in sanzioni disciplinari, o meglio in rapporti, un rapporto può sfociare in una applicazione di una sanzione oppure no, si legge spesso di sanzioni che sembrano eccessive rispetto al fatto addebitato, come per converso si incontrano casi in cui sembra applicata una sanzione minore rispetto al disvalore e alla gravità dell illecito raccontato nel rapporto disciplinare. Aderire all opera di rieducazione significa non solo avere partecipato alle attività che il carcere organizza, quando le organizza, ma avere fatto sì che chi ti incontra possa desumere che tu un po alla volta ti sei allontanato dal male che hai fatto e hai intrapreso un cammino verso un momento della tua vita, in cui tu decidi di rompere definitivamente con quello che hai fatto, insomma è la trasformazione della persona che si allinea alla condotta di quelli che non delinquono. Che cosa è però successo, e qui dobbiamo dare ragione, se pure in parte, ai mezzi di informazione? È vero che noi in genere concediamo la liberazione anticipata basandoci di più sul primo pilastro, che non sul secondo, guardiamo di più la condotta regolare, che non l adesione all opera di rieducazione, ma perché capita questo? Perché nella stragrande maggioranza degli istituti si fa poca rieducazione, e non posso negare la liberazione anticipata se uno non ha lavorato, se è il carcere che non gli dà lavoro. Capita qualche volta che, se andiamo a leggere la storia delle detenzioni, abbiamo dato tre mesi all anno di sconto di pena a quelle stesse persone che dopo, uscite dal carcere, sono tornate a delinquere. Quindi io darei ragione in parte alla stampa, anche se il fenomeno va spiegato come vi ho detto, andando a leggere quello che hanno scritto i parlamentari quando hanno approvato questo articolo 54. Sostanzialmente cioè hanno detto che la liberazione anticipata è uno strumento di governo del carcere, purtroppo è cosi, se tutti i detenuti sanno che non hanno nulla da perdere, il carcere diventa ingestibile, di conseguenza c è un riconoscimento della funzione sostanziale di questa norma, che è quella di rendere governabile sotto il profilo dell ordine interno il carcere. Ornella Favero: Sul fatto della liberazione anticipata, forse bisognerebbe spiegare che comunque in tutti i Paesi ci sono dei sistemi analoghi. Rispetto alle persone incensurate, per esempio, ci sono Paesi come la Germania, in cui se hai un comportamento corretto in carcere devi scontare solo metà della pena, mentre nel nostro Paese c è un informa- 137
141 zione che fa credere che solo da noi succede. Ma voi non provate mai il desiderio di informare di più, vedendo che il vostro ruolo è completamente stravolto sui giornali e in certe trasmissioni televisive? Marcello Bortolato: Il magistrato dovrebbe parlare solo con i provvedimenti, ogni volta che qualcuno ha cercato di andare un po al di là, è stato accusato di uscire dai suoi ambiti, insomma il nostro mestiere è molto delicato, noi non possiamo sempre cercare di spiegare perché abbiamo preso una tal decisione né possiamo sempre correggere un informazione sbagliata o tendenziosa, informare sulle nostre decisioni spetta ad altri. Dobbiamo infine coniugare il nostro diritto ad esprimerci liberamente come qualunque cittadino al dovere di imparzialità che ci impone la legge. Ornella Favero: Per capire quanto pesa l informazione basta vedere un esperimento che abbiamo fatto con i ragazzi di una scuola, che sul caso di Pietro Maso hanno letto alcuni articoli dei grandi quotidiani, e poi alcuni articoli che hanno scritto i detenuti della nostra redazione per il Mattino di Padova. Allora una ragazza, che ha tredici anni, scrive in un suo testo di commento a questa notizia: Ma poi questa semilibertà, si può definire una vera libertà? secondo me no, secondo me vuol dire solo allargare i confini del carcere, perché uno non è poi così libero se deve stare attento a qualsiasi cosa faccia e in qualunque posto vada. Quindi questa ragazzina ha capito, leggendo degli articoli con punti di vista diversi, che la questione è più complessa di come la fanno tanti giornali. Marcello Bortolato: Ma i ragazzi sono molto più attenti e più intelligenti, di quanto a volte li si voglia dipingere e sicuramente hanno degli insegnanti altrettanto intelligenti che li possono guidare ad allargare le loro conoscenze. Silvia Giralucci (giornalista, volontaria in redazione): Nelle critiche che vengono spesso rivolte alla stampa, è insita l idea che i giornali debbano educare. A mio avviso i giornali sono lo specchio, non il lume della società. Hanno il dovere di informare correttamente, ma anche di interessare i loro lettori. Quando lavoravo in un quotidiano mi sono spesso trovata in difficoltà perché l esiguità dello spazio a disposizione rendeva impossibile dare conto dei diversi punti di vista, dei grigi, e in questi casi nel fare delle scelte si tende a privilegiare la storia che fa notizia, quella che si ritiene piacerà al lettore e farà vendere il giornale. Sulla questione dei permessi premio dei detenuti, quando anche un giornalista si renda conto di questa complessità, può, per esempio farci una scheda, se lavora in un giornale dove questo tema è sentito, ma un quotidiano non riesce assolutamente a entrare nel merito. Non c è il tempo, non c è lo spazio, perché si parte dal presupposto che probabilmente i lettori non sarebbero interessati. Travaglio con quella uscita ha centrato un problema, era sicuramente un paradosso e ha fatto notizia, ha dimostrato di essere un bravo giornalista perché è riuscito a catturare l attenzione. Certo, da una parte c è un po di malafede, e dall altra c è la necessita di costruire una notizia. Il problema della rappresentazione infedele della realtà non riguarda solo la realtà carceraria. Voglio dire, se guardiamo la sanità, anche i medici hanno la stessa difficoltà: basta un paziente che si lamenti, e la notizia è che in quell ospedale si muore e la sanità fa schifo. Quello che mi veniva in mente per cercare di far si che almeno i gior- 138
142 nalisti abbiano coscienza di quello che scrivono, è cercare di avere un rapporto con l Ordine nazionale dei giornalisti, per inserire questi tipi di studi nel programma per l esame di Stato di giornalista professionista. O di organizzare dei piccoli corsi di aggiornamento con gli Ordini regionali, da proporre ai giornalisti che fanno cronaca nera e giudiziaria. Ornella Favero: Sì è quello che vorremmo proporre, un seminario qui dentro sui temi della giustizia, per i giornalisti di giudiziaria e di cronaca nera. Anch io non credo che i giornali debbano educare, però informare, e non disinformare, questo sì. Perché poi secondo me la disinformazione passa non tanto sulla notizia falsa, quanto sulla mezza notizia, che diventa di fatto peggio della notizia falsa, nel senso che non è smentibile immediatamente. Il discorso di Travaglio, io non lo trovo serio, perché si è fatto pubblicità con una ricostruzione del sistema giocata proprio sulle mezze verità, sul paradosso del caso limite che non è mai successo e che mai succederà. Del resto, qualsiasi telefilm americano sulla giustizia spiega il loro sistema senza scandali meglio di quello che fanno tanti nostri giornalisti: lì c è la persona che esce su cauzione, qui direbbero è già libero. Senza spiegare che se quello però verrà condannato, poi entrerà in carcere. Silvia Giralucci: Questo dipende anche dalla preparazione e dalle fonti del giornalista. In casi come quelli della scarcerazione di pluriomicidi magari il cronista interpella l avvocato delle parti civili, che gli mette una pulce nell orecchio, e il giornalista che non ha né il tempo né gli strumenti per valutare la riporta, senza e questo sì colpevolmente citare la fonte. Marcello Bortolato: Oppure le fonti di polizia, perché spesso invece di chiedere al giudice o all ufficio giudiziario, chiedono alla questura, o ai carabinieri. Però, secondo me, il dato della preparazione professionale di un certo giornalismo che si occupa di giudiziaria è un dato oggettivo, purtroppo anche noi leggiamo delle notizie, che spesso sono delle mistificazioni, ecco è vero che il giornalista fa il suo lavoro, vende un prodotto, il prodotto va, ma se non rende un servizio buono per i cittadini, allora quello è un cattivo giornalista. Silvia Giralucci: Il giornalista parla con la polizia probabilmente perché è un interlocutore abbastanza informato e soprattutto disponibile. Il pezzo va scritto in giornata, contattare un magistrato con questi tempi potrebbe essere così difficile che il cronista preferisce scegliere una strada dove è più probabile trovare le informazioni che cerca. Marcello Bortolato: Sì, ma si può contattare il magistrato non sul caso specifico, è ovvio che il magistrato del caso Maso non dirà mai con che motivazioni gli ha dato la semilibertà, perché c è il provvedimento che parla per lui. Però quanto meno un magistrato vi spiega che cos è la semilibertà, che cos è la liberazione condizionale, vi può dire come stanno le cose oggettivamente. Per esempio di recente il dottor Tamburino, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e responsabile del Coordinamento nazionale dei Magistrati di Sorveglianza, è stato intervistato quando si parlava del braccialetto elettronico, e anche lì si andava dicendo le cose più impensate, per fortuna che lui ha potuto dire alcune cose oggettive. Secondo me, così si rende un servizio al lettore, che è messo in grado di capire di più. Giovanni Maria Pavarin: Prima Occhipinti ha parlato dell articolo di una giornalista, che è considerata esperta di cronaca giudiziaria, ma un conto è fare cronaca giudi- 139
143 ziaria, e un conto è essere a conoscenza dei temi dell esecuzione penale. Sono due mondi non dico contrapposti, ma molto distanti, quindi è difficile trovare un giornalista che faccia correttamente cronaca di esecuzione penale, non ne ho ancora conosciuto uno. Daniele Barosco: Io vorrei porre un altra domanda. Prima dell indulto in questo carcere c erano più o meno 700 persone, come ce ne sono adesso, allora è possibile sapere il motivo per cui le persone che andavano in permesso prima dell indulto erano moltissime (circa 200), e adesso sono una sessantina, e le persone ammesse alle misure sono molte di meno rispetto a prima? Cioè c è un motivo particolare, c è stato, come nel crac delle borse, anche il crac dell indulto che ha prodotto questo effetto secondario, oppure sono cambiati i criteri di valutazione? Lo chiedo perché si vive meglio nelle sezioni quando si vede che le persone che hanno pene brevi, con delle situazioni famigliari solide, con una offerta di lavoro, trovano la loro possibile collocazione fuori dal carcere, e vengono ammesse ai benefici. Giovanni Maria Pavarin: Personalmente non mi pare di aver cambiato il metro di giudizio, ma forse è aumentata l esperienza, forse sono aumentate le delusioni, non escludo che di benefici, invece di darne 10, ne do 9, non lo escludo. Però mi sembra più o meno di ragionare allo stesso modo, ho detto di no, per esempio, a tre persone che conosco da tantissimi anni, che hanno avuto due carcerazioni con me, che hanno avuto permessi con me, e alla fine gli ho risposto: guarda, è vero che tu finisci la pena fra poco, ma con me hai chiuso, mi hai pugnalato due volte, e con me hai chiuso. Spero che ti arrivi un altro magistrato che non ti conosce, però io ti ho dato fiducia due volte e l hai tradita tutte e due le volte, allora ti finisci la tua pena e siamo a posto così, chiunque di voi credo e spero ragionerebbe come me al mio posto. Marcello Bortolato: Se posso aggiungere qualcosa per quanto mi riguarda, la valutazione è sempre esclusivamente personale e individuale, voglio dire che noi non facciamo politica criminale, non diciamo che d ora in poi saremo più severi o d ora in poi più buoni, ogni volta un fascicolo è una storia a sé, un fascicolo è una persona, è un caso a sé. Quindi per quanto mi riguarda io continuerò a valutare i casi uno per uno indipendentemente dagli altri, perché se uno mi ha deluso, la delusione evidentemente deve ripercuotersi solo su di lui. 140
144 LADDOVE C È UN CARCERE CON PENE ALTISSIME, C È IN REALTÀ MAGGIORE CRIMINALITÀ Subire una pena molto dura non è di per sé un effettivo disincentivo alla commissione del reato, lo è invece l azione educativa continua di Mauro Palma, Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura e delle pene inumane e degradanti Vorrei spiegare innanzitutto cosa c è dietro alla denominazione piuttosto lunga del Comitato che presiedo: Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e delle pene inumane e degradanti. È l organismo europeo che ha il compito di controllare le condizioni della privazione della libertà e la sua denominazione riprende la formulazione dell articolo 3 della Convenzione Europea per la tutela delle libertà individuali e dei diritti umani, che stabilisce, appunto, che nessuno può essere soggetto a tortura o a trattamenti e pene inumani o degradanti. Un divieto assoluto per gli Stati membri della Convenzione perché tale articolo, a differenza di altri, non è derogabile, neppure in circostanze gravi per la sicurezza dello Stato. Ho usato la locuzione privazione della libertà e non il temine detenzione, perché il nostro controllo si estende a un ambito ben più ampio di quello della detenzione carceraria. Esso include certamente il carcere, ma anche le celle dei commissariati della Polizia di Stato e quelle delle altre polizie; e, ancora, i Centri di permanenza per immigrati irregolari e, infine, i trattamenti sanitari obbligatori. Dobbiamo monitorare e controllare tutte le situazioni in cui si è privati della libertà da parte di un autorità pubblica; e tale supervisione si estende ai 47 paesi membri del Consiglio d Europa. Un territorio, quindi, vasto che, lungo un parallelo, si estende da Lisbona alla costa del Pacifico, giacché fin là si estende la Federazione russa, e, lungo un meridiano, va da Malta fino all Islanda. Diverse sono in esso le tradizioni giuridiche, le prassi e le attenzioni culturali ai problemi oggetto della nostra azione, tra i diversi Paesi. Una seconda premessa che vorrei fare è sottolineare l importanza delle discussioni sul rapporto tra carcere e territorio, sul ruolo di responsabilità che la comunità locale esprime nel suo coinvolgimento nelle attività dei detenuti e sull espressione di appartenenza alla comunità stessa che i detenuti a loro volta manifestano nel rivolgersi all esterno con iniziative come il teatro, o i progetti con le scuole. Al di là della singola esperienza, l elemento più forte è il fatto stesso che una città senta che il carcere è un pezzo di se stessa, un luogo dove ci sono problemi, dove ci sono persone che hanno sbagliato, dove c è sofferenza e dove ci sono persone responsabili di sofferenze altrui, e che tuttavia non è altro rispetto alla città, è parte della sua complessa trama. Il ricorso allo strumento penale come unico criterio per risolvere conflitti Discutiamo ora di un aspetto specifico della vita detentiva: l istruzione, anche al di là delle mura. L istruzione è inclusa tra i diritti fondamentali di un individuo, e vorrei ricordare che anche la citata Convenzione Europea per i diritti dell uomo, con un suo pro- 141
145 tocollo specifico, ha inserito l istruzione all interno dei diritti umani, diritti quindi di tutti, siano essi liberi o reclusi. Trattandosi di un diritto fondamentale, i titolari di esso non sono soltanto i cittadini, cioè soggetti che hanno uno status giuridico definito e regolare, ma gli individui in quanto tali, indipendentemente dalla qualità della propria connotazione giuridica. Lo includiamo comunemente tra i cosiddetti diritti di cittadinanza, ma certamente andrebbe precisato che è un diritto per la cittadinanza, perché come detto non si riferisce a coloro che hanno già la connotazione di cittadini, ma a qualunque persona che si trova in un luogo e che ha il diritto di comprendere quel luogo, di sapersi muovere, saper interpretare, conoscere. È proprio l esercizio di tale diritto che favorisce l inclusione e la cittadinanza. I diritti umani del resto sono affermati erga omnes: qualunque persona, indipendentemente dall essere regolare o irregolare, indipendentemente da quale sia la sua posizione giuridica, ha diritto, per esempio, a essere curata, a essere accusata o trattenuta solo secondo procedure legali e ha anche il diritto di apprendere e comprendere la realtà in cui è collocata. C è però anche un altro aspetto che dobbiamo considerare in questo insieme di premesse. Riguarda il sistema penale o, meglio, il ruolo del diritto penale nel nostro convivere civile. Il ricorso allo strumento penale come unico criterio per risolvere conflitti o per affermare l importanza di alcuni beni giuridici, si è andato ampliando negli ultimi decenni. Da strumento sussidiario, costoso, a cui ricorrere quando non è possibile risolvere altrimenti una data situazione, il diritto penale è diventato strumento centrale e la legislazione penale è divenuta ipertrofica, rendendo il sistema complessivo spesso incoerente e soprattutto non totalmente conoscibile. C è la tendenza spesso visibile anche tra i giovani a ritenere il ricorso al sistema penale quale unica forma efficace di risoluzione dei conflitti che sorgono nel contesto sociale e quale unico modo per stigmatizzare il comportamento di chi aggredisce un bene ritenuto rilevante. Infatti per affermare che qualche cosa è un bene da tutelare opportunamente, si ricorre alla previsione di una pena particolarmente ampia per chi lo aggredisce. E la misura della pena sembra dare l indicazione dell importanza di quel bene. Una pena di solo pochi anni viene interpretata come un modo per sminuire la significatività di quel bene: l importanza dell ambiente, per esempio, è misurata sulla base delle pene previste per chi offende l ambiente stesso. In realtà la vera tutela sempre prendendo come esempio l ambiente risiede nella costruzione di una cultura condivisa della sua importanza, in un azione che parte sin dalla prima educazione e che rimane sempre viva e vigile; la pena per chi offende l ambiente dovrebbe essere soltanto l elemento residuale dei casi di insuccesso di tale strategia di fondo. Lo stesso vale per altri reati: tuteliamo la persona se creiamo la cultura della persona, non certo se affidiamo il tutto alle pene. Subire una pena molto dura non è di per sé un effettivo disincentivo alla commissione del reato, lo è invece l azione educativa continua. Nessuna aggressione, neppure quelle gravissime come lo stupro, sarà mai fermata dalla possibilità di pena di un certo numero di anni, anche altissimo, se non si agisce sulla cultura complessiva in cui tale atto è collocato. Questo concetto frettolosamente da me illustrato è sintetizzabile in un principio: il diritto penale è uno strumento sussidiario; esso deve agire, e agisce, laddove altri strumenti di regolazione sociale, che vanno dalla crescita culturale alla crescita di consape- 142
146 volezza, alla rimozione delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere, laddove tutti questi strumenti, anche se ampiamente praticati, non siano riusciti ad agire. La pena, la punizione, sono un elemento a valle, non a monte di un processo complesso, al contrario della tendenza attuale a porlo a monte, punto di inizio di un percorso che poi stentatamente cerca di tornare verso il sociale, attraverso la promessa di reinserimento. Nel carcere che dovrebbe livellare tutti, i soggetti sono profondamente dissimili Il diritto penale ha anche un altra connotazione fondante, che pure oggi si stenta a trovare: l equità. Per illustrare la perdita di equità sostanziale, posso citare il fatto che qualche anno fa, esattamente due legislature fa, nello stesso giorno in cui il Parlamento approvava la legge per la depenalizzazione del falso in bilancio, è stata approvata la legge che prevede la carcerazione per i responsabili di contraffazione dei CD. In questo caso il principio di equità sembra un po vacillare. Posso citare il fatto che tra i reati non molti per i quali l Italia ha accettato di applicare il mandato d arresto europeo c è proprio la contraffazione dei marchi, dei CD; una categoria di reati, che, se vogliamo fare la scala dell allarme sociale, non è tra quelle che occupano i posti più in alto. Quindi, vediamo che nell esercizio concreto del diritto penale, il principio di equità è sottoposto a prove e tensioni che sembrano farlo sfumare. Sembra molto più rilevante il criterio di essere forti o deboli sul piano sociale a determinare l inflessibilità della sua applicazione. Del resto basta fare una sommaria analisi sociologica dei soggetti che arrivano alle aule dei tribunali e considerare la loro collocazione nel sistema sociale. Se sono forti, hanno una difesa privata particolarmente incisiva e soprattutto un sistema di protezione di rapporti, conoscenze, capacità di difesa informale anche in proprio. Se al contrario sono deboli, non possono fare ricorso a tale rete e dovrebbe essere compito delle istituzioni garantire l equità affermata, e dunque l effettiva giustizia, attraverso il bilanciamento di questa differenza, portando a pari condizioni soggetti che partono impari. La scena sociale vede in realtà soggetti dissimili, con diverse esposizioni al rischio di commissione di reati e con possibilità diverse anche di difendersi, che diventano ancora più dissimili nel corso della rappresentazione penale, perché una difesa forte riesce a utilizzare tutti i meccanismi di garanzia offerti dall ordinamento, anche in modo a volte pretestuoso per ottenere rinvii del processo e possibilità di prescrizione, mentre la minorità sociale e la conseguente difesa debole rende tali strumenti pure enunciazioni. Quindi, anche il principio di equità è un principio traballante nell esercizio del sistema penale, si è dissimili alla partenza e ci si ritrova sempre più dissimili durante il percorso. Anche nell esecuzione della pena, nella realtà carceraria che teoricamente dovrebbe livellare tutti, i soggetti si ritrovano profondamente dissimili e chi lavora direttamente negli istituti può dare conferma di questa mia valutazione. Nel carcere italiano, per esempio, l accesso alle misure alternative è in realtà precluso ai soggetti deboli o debolissimi, in particolare agli stranieri, e quando non è tale è solo per l azione del volontariato che agisce all interno e che dà indirettamente forza sociale a chi ne è privo. Fa sorridere il gran parlare di molti di certezza della pena, come valore perduto e da recuperare: per alcune persone la pena è certissima, fissa; e lo è perché non hanno uno straccio di difesa, di supporto. Per loro la reclusione fino al termine dell esecuzione penale è più che certa: re- 143
147 steranno dentro, chiusi, al contrario di altri che, forti dei propri legami privati, o anche dei legami sociali, hanno altri strumenti per una esecuzione variegata e meno rigida. Quindi anche il secondo principio quello dell equità è un principio che va in qualche modo riscoperto e ridefinito nel sistema penale italiano. Vanno ridefiniti strumenti per rendere operativo ed effettivo per tutti quanto il nostro sistema prevede perché non possiamo essere soddisfatti delle enunciazioni, pur fondamentali, che troviamo nella nostra Carta Costituzionale se a esse non diamo possibilità di essere pienamente attuate. Sono in realtà le misure alternative a garantire l effettiva sicurezza Ho posto la questione della sussidiarietà e quella dell equità. A queste voglio aggiungere quella dell efficacia. L efficacia di un sistema detentivo si misura, ahimè, con un problema che è la recidiva, cioè quanto il soggetto ritorni a commettere reati. Naturalmente c è una inversa proporzionalità: tanto maggiore è la recidiva, tanto meno è stata efficace la detenzione. Il problema della recidiva in Italia è un problema estremamente grande, ma la sua dimensione dipende anche dalla mancata rimozione delle cause che hanno determinato la commissione del reato. Se un soggetto che ha commesso un reato è posto nuovamente nella stessa situazione in cui si trovava precedentemente, è forte la predisposizione a reiterare il reato stesso, soprattutto per quanto riguarda i reati verso la proprietà. Qui sorge la necessità di costruire, durante la detenzione, un percorso di attività e successivamente di misure alternative alla detenzione stessa, quale unica forma per garantire che il soggetto, una volta fuori dal carcere, non sia nella stessa situazione di quando vi è entrato, o in una situazione anche peggiore dato il tempo inutilmente trascorso, ma sia una persona che abbia dei legami di accompagnamento e di reinserimento, che rendano il quadro in cui si trova collocato diverso da quello precedente. Tutti coloro che, in nome della sicurezza, cercano di dire che le misure alternative dovrebbero diminuire, e che ci dovrebbe essere un carcere più certo e più fisso, in realtà non capiscono che stanno indicando una soluzione contraria a ciò che intendono ottenere. Sono in realtà le misure alternative, i loro contenuti e la loro significatività a garantire l effettiva sicurezza, perché solo un soggetto che ha compiuto un percorso nel tempo di detenzione, può uscire in modo diverso da come vi è entrato. Si è, quindi, più sicuri se si investe in intelligenza e risorse durante il periodo carcerario, poiché quanto più si offrono possibilità, opportunità, tanto più poi si può sperare di aver riannodato un legame sociale. Quanto più al contrario si tagliano queste possibilità e si propone una pena fissa e rigida, inutile, tanto più ci si espone al rischio di nuovi reati. Anche se la cosiddetta opinione pubblica sembra a volte non concordare, chi ha a cuore la sicurezza deve investire in non fissità della pena, anche perché ogni detenuto primo o poi lascerà il carcere ed è interesse collettivo che ciò avvenga in un quadro individuale mutato. Nella mia attuale funzione di monitoraggio dei vari sistemi detentivi, ho trovato delle similarità nei problemi che si pongono, ma ovunque ho riscontrato che laddove c è un sistema ricco di misure alternative, laddove si investe realmente in esse, la recidiva è minore, e quindi la sicurezza è maggiore. Laddove invece c è un carcere apparentemente rigido con pene altissime e dure, c è in realtà maggiore criminalità, maggiore possibilità di commissione di reati estremamente gravi, se non altro perché una persona, per esem- 144
148 pio, condannata all ergastolo a volte anche non rivedibile, mai riesaminabile non ha nulla da perdere e anche il suo comportamento detentivo risente di questa assenza di prospettiva in termini di maggiore propensione al crimine. Rieducazione non può significare rieducazione etica, bensì rieducazione sociale L ultimo punto che mi preme discutere riguarda la ratio che soggiace all enunciato del comma terzo dell articolo 27 della Costituzione italiana, molto citato e raramente applicato: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione del condannato. Chiariamo subito il significato del termine rieducazione : rieducazione non può significare rieducazione etica, perché questa non attiene ai compiti dello Stato, bensì rieducazione sociale; quindi, reinserimento quale forma per ricostruire quel legame con la società che con il reato si è in qualche modo scisso. Da dove nasce questa indicazione costituzionale? Succintamente, vorrei ripercorre la strada che questa formulazione ha avuto. Partiamo dal dato che negli ordinamenti moderni il diritto penale nasce in contrapposizione alla precedente pratica della vendetta, per contrastarla. Non nasce per continuare la pratica della vendetta in una modalità depurata, affidandola allo Stato, fuori dalla cruenza della vendetta individuale. Non nasce cioè per togliere all individuo il compito della vendetta e affidarla all autorità pubblica. Nasce in contrapposizione con tale pratica e per prevenirla. Ha così una doppia finalità: prevenire i reati e prevenire anche la vendetta privata. Un doppio aspetto che va sempre tenuto presente, perché anche nelle nostre attuali democrazie il rischio di una giustizia fatta in proprio o meramente vendicativa, persiste. Nelle teorie del diritto penale, si sono tuttavia sempre misurate due grandi aree di pensiero: una di tipo retributivo e l altra di tipo utilitarista. Per la prima la pena costituisce un male simmetrico a quello commesso, utile a ristabilire l ordine che il reato ha infranto: una visione kantiana, secondo cui il delitto ha in qualche modo determinato una lesione del sistema generale e solo attraverso una simmetria l equilibrio sociale può essere ritrovato. Questa visione attribuisce una funzione retributiva al diritto penale: la pena retribuisce per il male commesso. Da essa discendono elementi che connotano il tipo, la quantità e le modalità esecutive della pena; ne discende,per esempio, anche la previsione della pena di morte. L altra visione è invece quella utilitaristica: la pena è sempre un male che viene inflitto a chi ha commesso un reato, perché la privazione della libertà è sempre una sofferenza, ma è comunque rivolta a una qualche utilità; perché questo male è finalizzato a qualcosa rispetto alla persona e rispetto alla società. Deve avere una funzione utile e non di semplice retribuzione, deve essere educativa per il resto della società, così prevenendo altri reati, deve tendere al recupero del soggetto che ha commesso il reato, anche in ciò esercitando una funzione preventiva per il futuro. Questa visione utilitaristica della pena, assunta dagli ordinamenti europei, può essere tuttavia ancorata a due diversi aspetti: utile per la tutela della società, poiché intrinsecamente preventiva, oppure utile per il soggetto, in quanto preventiva di pene spropositate e non tendenti al suo reinserimento. Possiamo, quindi, vedere due polarità di riferimento della funzione utilitaristica della 145
149 pena: tutelare la società e prevenire la commissione di altri reati, oppure prevenire pene eccessive e tendere a un diverso ritorno di chi ha commesso un reato. La pena concreta che vediamo scontata nei nostri istituti penitenziari deve trovare un baricentro tra queste due polarità. Se la spostiamo eccessivamente verso la tutela della società, che, sulla spinta di campagne emotive, può sentirsi mai totalmente rassicurata e quindi chiedere sempre maggiore severità, rischiamo di tornare indirettamente a una visione retributiva della pena stessa. Se la spostiamo solo verso il destinatario, potremmo arrivare, come emerge in alcune ipotesi filosofico-giuridiche europee, a posizioni del tutto abolizioniste del carcere, affidando le persone alla mera cura dei servizi sociali. Il compito del legislatore utilitarista e progressista è proprio quello di trovare il punto di equilibrio tra le due polarità enunciate la prevenzione e il reinserimento e questo è stato il compito dei padri costituenti nel formulare quel prezioso articolo della Costituzione italiana. Un affermazione, quella dell articolo 27 della Costituzione, che non è stata facilmente accolta dall ordinamento italiano: nonostante la Costituzione sia entrata in vigore nel 1948, si è dovuto attendere fino al 1975 per avere una legge l Ordinamento penitenziario in linea con quanto la Costituzione prevedeva. Per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta il carcere ha continuato a essere quello normato dal vecchio regolamento fascista, riferito ad altre visioni, ad altre norme, a un altro tessuto sociale e ordinamentale, diverso dalla democrazia. E si è dovuto poi attendere altri quindici anni per avere una pronuncia chiara della Corte Costituzionale, nel 1990, che ha riconosciuto che il fine rieducativo della pena non è un elemento aggiuntivo alla pena stessa, ma un suo elemento costitutivo, fondante, secondo quanto la nostra Carta prevede. Possiamo, quindi, dire che dal 1990 noi abbiamo un riferimento stabile che ci dice, al di là di come siano le vicende carcerarie nella concretezza attuativa, che il fine del reinserimento sociale nel nostro Ordinamento è un fine costituente la pena. Questo è il quadro di riferimento che credo utile tenere sempre presente. A noi poi spetta capire e valutare quanto la realtà carceraria italiana odierna sia corrispondente a esso. Nella gran parte delle situazioni reali, la situazione carceraria italiana, purtroppo, è assolutamente non rispettosa del dettato costituzionale, per una serie di inadempienze, arretratezze e problemi, che in larga parte non dipendono da chi in carcere lavora, bensì da una grande disattenzione sociale e politica a un luogo che rimane lo specchio fastidioso, ma reale, delle nostre difficoltà. Rimane un pezzo di noi, come collettività, anche se spesso ce ne dimentichiamo e preferiamo non vederlo. Testo della relazione tenuta al convegno Diritto all apprendimento, un diritto per la libertà Volterra, 27 settembre
150 Capitolo 6 Un percorso su sicurezza, insicurezza, legalità, trasgressione, bullismo Nei piccoli laboratori di scrittura che abbiamo condotto in molte scuole, abbiamo lavorato partendo dalla raccolta delle idee e dalla prescrittura, proponendo sempre temi vicini al percorso sulla legalità che stavamo realizzando nelle classi: quindi il bullismo, l idea che hanno i giovani della sicurezza, la trasgressione. La raccolta delle idee è stata collettiva, abbiamo lavorato con tutta la classe per aiutare i ragazzi a sviluppare la fantasia e a superare le prime idee su un dato argomento, quasi sempre le più scontate. Abbiamo così stimolato tutti a trovare degli argomenti pro o contro, ad analizzare una questione da due punti di vista contrapposti, a porsi delle domande, e le idee si sono allargate a macchia d olio. Da lì siamo partiti per riordinare i materiali, provare a fare una scaletta, trovare un incipit stimolante. Abolendo, finalmente, i classici inizi dei temi, quelli sotto forma di noioso diario di un evento Il 7 novembre sono venuti in classe due detenuti, Il 3 dicembre in classe abbiamo parlato di trasgressione. 147
151 148
152 QUANTO SI SENTONO INSICURI I GIOVANI? Oggi si parla molto di sicurezza. Ci sono situazioni nelle quali ti senti insicuro? Che cosa pensi sarebbe utile per rendere la tua città più sicura e più vivibile? Questa è una traccia, sulla quale i ragazzi hanno scritto le loro riflessioni in libertà, prima di iniziare il percorso di conoscenza del carcere e di approfondimento sui temi della giustizia, della legalità, delle pene. A cura degli studenti delle scuole coinvolte nel progetto scuole-carcere Ho preso parte a un corso di difesa personale di Giulia C., 4 a D Itas P. Scalcerle Al momento posso dire che sono maggiori le situazioni in cui mi sento in pericolo, rispetto a quelle in cui mi sento al sicuro. Ormai la delinquenza è ovunque e talvolta non serve nemmeno uscire di casa per trovarla. Devo ammetterlo, ho paura anche di stare a casa se sono sola, soprattutto da pochi mesi a questa parte visto che delle persone, sembrerebbe extracomunitari, hanno recentemente svaligiato una casa vicino alla mia. Vivo in campagna e adoro andare a pattinare nelle strade circostanti, ma purtroppo non riesco più a farlo tranquillamente come una volta. Sempre più ragazze e ragazzine vengono violentate e questo mi fa paura più di tutto il resto, visti anche gli apprezzamenti talvolta pesanti che mi giungono anche solo mentre sono per strada che sto andando a scuola. Ed è per questa ragione che la scorsa primavera ho preso parte ad un corso di difesa personale, che più che dal punto di vista fisico, mi ha aiutato da quello psicologico. Per incrementare la sicurezza nella mia città credo siano necessari maggiori controlli da parte delle forze dell ordine. Devo però ammettere che negli ultimi due anni ho visto aumentare notevolmente il numero di poliziotti e carabinieri, soprattutto nella zona centrale della città, e questo mi fa sentire più sicura, anche se non del tutto. Inoltre ritengo che sia necessario operare un maggiore controllo sugli extracomunitari, spesso artefici di molti reati. Non voglio generalizzare o essere razzista, ma gli immigrati irregolari a mio avviso andrebbero immediatamente rimpatriati. Mi rendo conto che un affermazione del genere è fortemente ipocrita visto che noi italiani siamo un popolo di immigrati, ma troppe volte mi sono trovata a dover affrontare situazioni di forte disagio causate da extracomunitari che si dimostravano invadenti e volgari nei miei confronti (una volta sono stata sul punto di chiamare il 112!). 149
153 Bisogna unificare, piuttosto che separare le persone con allarmismo e paura di Kristie, 4 a D Itas P. Scalcerle Quando si parla di insicurezza ci si riferisce ad uno stato d animo che non ci fa sentire a nostro agio rispetto alla situazione che stiamo vivendo, o alle persone che ci circondano. Insicurezza mi fa pensare ad una strada buia senza illuminazione, che si è costretti ad attraversare impauriti dalla possibilità di essere aggrediti. Eppure non dovremmo provare timore, quella via è parte della nostra città, della nostra casa, del luogo più sicuro nel quale sentirsi protetti. Sinceramente non ho molta paura di aggirarmi da sola per strada, perché in me sento che non devo temere la mia città, tuttavia è necessario salvaguardarsi ed essere diffidenti anche in casa nostra perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Ho sempre pensato che la libertà fosse la cosa più bella di cui sono in possesso gli esseri umani, ma quando sento i crimini che ogni giorno vengono commessi, l intolleranza e la paura che ormai regnano sovrane, mi chiedo come possiamo definirci liberi se non siamo più padroni di fare una camminata notturna in solitudine, se dobbiamo utilizzare allarmi all avanguardia per salvaguardare la casa che con fatica ci siamo guadagnati, se dobbiamo temere di parlare con un estraneo. La verità è che non siamo liberi, ci sentiamo tutti insicuri e nella nostra inquietudine dubitiamo di tutto, anche di casa nostra. Molte sono le proposte per rendere la nostra città più sicura, o per lo meno più vivibile, ma a mio parere tutto sta nel rendere consapevoli i cittadini, promuovere una politica comunitaria per unificare, piuttosto che separare le persone con allarmismo e paura. Pene più severe e rigide potrebbero aiutare i cittadini a sentirsi più sicuri. Purtroppo fin troppe volte si sentono criminali che infrangono la legge e tuttavia ottengono uno sconto sulla pena. Troppe volte gli anni da scontare in carcere si dimezzano, le persone che hanno subito il danno hanno ragione a sentirsi insicure ed a reclamare giustizia. Penso che la situazione sia sfuggita di mano di Chiara B, 4 a D Itas P. Scalcerle Non mi sento sicura a camminare per strada da sola quando si fa sera. Ho paura, ad esempio, le tante volte che torno da scuola, magari d inverno quando il sole tramonta presto. A volte non mi sento sicura nemmeno a casa mia quando non c è nessuno a tenermi compagnia. Penso che, più di ogni legge o qualsiasi sorveglianza, la prima cosa che tutti dovremmo imparare sia la buona convivenza e il rispetto degli altri. Sarebbe stupido pensare che tutti seguissero questi principi ed è proprio per questo che lo Stato interviene. A mio parere la legge italiana, per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, è poco efficace e il governo dovrebbe impegnarsi in leggi più severe, cercare di farle rispettare e, soprattutto, far scontare gli anni che spettano a coloro che hanno commesso reati. In particolare, la città di Padova è molto pericolosa: la situazione che si è venuta a creare in questi anni è spaventosa. Penso che ormai il tempo in cui si doveva agire sia passato e ora la situazione sia sfuggita di mano o forse si è voluto lasciarla sfuggire di mano. 150
154 Non giustifico chi commette reati, ma almeno cerco di capire di Ilaria S., 5 a B Itas P. Scalcerle Come ci si può sentire al sicuro in un Paese dove i veri criminali girano liberi per le città e vengono condannate altre persone che magari hanno compiuto reati minori? Quando si sentono le notizie al telegiornale e si parla di extracomunitari viene sempre specificata e ripetuta la nazionalità più volte, ma perché quando è un italiano ad essere il colpevole si generalizza e si chiude in fretta la notizia? Forse c è la paura di scoprire che in realtà noi italiani siamo molto più criminali dei tanti stranieri che vivono in Italia anche senza permesso. Ci sono momenti in cui, girando per il paese da sola, mi sento a disagio, soprattutto la sera, perché dopo tutte le notizie di stupri e rapine che passano per la televisione, un attimo di panico ce l hai anche tu, ma tutto questo perché deve esserci? Se invece di punire i piccoli criminali si arrestassero i veri boss, forse poi anche gli altri capirebbero, ma resta un affermazione molto incerta. Una cosa che non ho mai capito è questa fobia per lo straniero; ogni volta che succede qualche cosa, se c è uno straniero tra i tanti nomi, lui è sempre il primo ad essere accusato. Ma perché? Forse perché è la via più semplice. E quelle volte che veramente lo straniero è colpevole, perché lo fa? Tutti dicono subito è colpevole, deve essere punito, ma nessuno si chiede il motivo delle sue azioni. Io credo che arrivare in un posto nuovo e sentirsi subito attaccati per qualsiasi cosa, non sia semplice; e se in più si deve mantenere una famiglia si fa di tutto pur di riuscire a sfamarla. Nel momento in cui ci si trova tutte le porte chiuse, qual è l unica via d uscita? Proprio la criminalità. Non giustifico chi lo fa, ma almeno cerco di capire. E se invece della sicurezza promuovessimo la cultura dell accettazione? di Laura P., 5 a I Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta Mi rendo conto che negli ultimi anni la criminalità è aumentata, sembra quasi che la gente stia impazzendo in questa società, forse senza rendersene conto, ma penso anche che tutto questo gran parlare di crimini da parte dei mass-media abbia la funzione di distogliere l attenzione dell opinione pubblica da altre questioni come la politica, le guerre, l impoverimento di molte persone a causa della precarietà del lavoro. E quindi vediamo che il criminale, a mio avviso, viene usato come possibilità di attribuire le colpe dei mali della società a qualcuno (capro espiatorio) e come valvola di sfogo dell aggressività. C è un altra questione molto importante, legata alla sensazione di insicurezza che infondono le continue notizie di assassinii, stupri, furti: la gente appunto si sente insicura, disorientata, sente bisogno di protezione e quindi si rafforza il potere dello Stato, delle forze dell ordine. E l industria degli antifurti e dei portoni blindati trae vantaggio dall insicurezza della gente. La mia proposta è quella di convertire le energie e il denaro usato per la sicurezza pubblica per progetti volti a promuovere la prevenzione del crimine, la cultura dell accettazione dell altro, la cultura della legalità, della pace e della non violenza. So che l uomo ha delle tendenze innate verso l aggressività, la paura dell altro, ma questi strumenti possono essere incanalati verso strade più sane come lo sport, la musica, l arte invece che verso la violenza, i pregiudizi e gli stereotipi. 151
155 Mi sento insicura a girare da sola quando è buio di Giorgia D., 5 a I Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta È proprio così, oggi più che mai si sente dappertutto parlare di sicurezza. I professori a scuola si raccomandano di leggere i giornali, di guardare alla televisione i vari tg Noi sinceramente siamo un po stanchi di sentire che per quanto la si cerchi, la sicurezza nei nostri paesi, nelle nostre città lascia molto a desiderare. Io abito in un paese di provincia e anche qui le situazioni di insicurezza non mancano. Personalmente mi sento insicura a girare da sola quando è buio, e per buio intendo anche quando cala il sole (quindi non necessariamente di sera tardi). Ma anche quando scendo dall autobus, per dirigermi verso casa ho un pezzetto di strada da fare a piedi e sono tante le volte che mi trovo a camminare più veloce, perché dietro di me c è qualche extracomunitario o qualche persona di cui non si sanno le intenzioni. L anno scorso, quando ogni mattina mi trovavo a piazza Boschetti, dove scende la maggior parte degli studenti, si è avvicinato un ragazzo che chiedeva soldi, minacciandomi. Sono tante le persone con queste intenzioni e si trovano proprio in luoghi così frequentati da noi ragazzi: ma di sicurezza neanche l ombra, nessun controllo, nessuna vigilanza, niente! Sono una persona che per andare a scuola gira parecchio per le vie della città di Padova, e personalmente mi sentirei più sicura se per strada incontrassi più forze dell ordine, invece che persone con cattive intenzioni. Evito di frequentare zone poco sicure e poco illuminate di Enrica Marzari, 5 a I Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta Una situazione in particolare, facendo riferimento all insicurezza, mi viene in mente: Padova di sera o di notte. Può capitare infatti, sia in estate, sia in inverno, di dover prendere l autobus in ore serali per tornare a casa e spesso succede di trovare, in particolar modo in zona stazione, persone che si drogano, tossicodipendenti, zingari, barboni, ubriachi, che magari, anche senza cattive intenzioni, vengono da te a chiedere l elemosina. Poi ci sono ragazzi che si avvicinano, per il semplice gusto di importunare e terrorizzare. In entrambi i casi devo dire che queste situazioni mi rendono molto insicura, tanto che evito in qualsiasi modo di rimanere sola, di dover prendere i mezzi pubblici nelle ore serali e di frequentare zone poco sicure e poco illuminate. Credo, almeno in questo caso, che la soluzione migliore e più fattibile sia quella di porre più sorveglianza e più controlli. Non deve essere bello girare per la città e trovare di tanto in tanto qualche poliziotto che controlla la situazione, ma forse potrebbe essere un modo per rendere le persone più tranquille e libere di svolgere i loro impegni senza doversi limitare per la paura dei continui inconvenienti che ci circondano quotidianamente. Mi sento insicura dove ci sono immigrati, insistenti e spudorati con le donne di Francesca G., 5 a G Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta Ci sono parecchie situazioni nelle quali mi sento insicura, ad esempio quando sono sola di sera, quando cammino per strada o in alcune zone di Padova, in particolare dove ci sono più immigrati, particolarmente insistenti e spudorati con le donne. Però non mi vengono in mente possibili soluzioni forse più polizia anche di notte. 152
156 Non penso sia giusto vivere con la paura di essere aggrediti di Elena F., 5 a I Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta È vero, oggi si parla molto di sicurezza, ma penso che se ne parli e basta, perché, quando esco di casa, proprio sicura non mi sento. Quando cammino per la strada mi guardo sempre intorno, ma anche questo non basta, visto il furto che ho subito qualche giorno fa non si può stare tranquilli. Non penso sia giusto che si debba vivere con la paura di essere aggrediti per qualche soldo o derubati dei propri averi. Secondo me il problema è il modo in cui ci si pone nei confronti di questi avvenimenti: ci si concentra magari su questioni meno importanti e si trascurano i problemi legati alla malavita; ad esempio ci preoccupiamo di evitare una coppia omosessuale, ma non ci preoccupiamo che ogni giorno arrivano non si sa quanti immigrati su dei gommoni. Persone illegali che, non avendo permesso di soggiorno, e non avendo possibilità economiche, finiscono per diventare delinquenti ma allora se già si sa la fine che faranno, perché dobbiamo continuare a permettere che ciò accada? Capisco che la loro realtà non sia delle migliori, ma perché per dare loro la possibilità di migliorarsi (che poi non accade quasi mai) dobbiamo vivere male noi? Detto questo, a mio parere per rendere la città più vivibile bisognerebbe che le forze dell ordine si comportassero in modo più serio, perché vedo casi in cui se un ragazzo in bicicletta circola su un area pedonale viene fermato e rimproverato, mentre quando i venditori illegali girano per le strade del centro con le loro merci, si vede il solito rito. Quando passa la polizia si nascondono dietro gli angoli delle case e i poliziotti passano senza dire niente sembra si prendano in giro La paura dei cittadini si traduce in diffidenza verso le minoranze di Elisa B., 5 a B Liceo delle Scienze Sociali Newton di Camposanpiero Si continua a sentire per i telegiornali e i giornali di persone rapite, uccise, di incidenti provocati da chi, sotto l effetto di sostanze stupefacenti o alcool, si mette alla guida delle auto, senza contare gli innumerevoli scippi, le rapine, gli stupri e tutto ciò che non viene riportato dai mass media. Queste situazioni causano nei cittadini scarso senso di sicurezza nel momento in cui si trovano nei luoghi pubblici o per le strade, di giorno ma soprattutto di sera. Il problema quadruplica quando si tratta della popolazione femminile, più indifesa nei confronti delle aggressioni fisiche e più esposta a rischi, soprattutto se si pensa a quant è diversa culturalmente la situazione delle donne da un paese all altro. La crescente paura dei cittadini si traduce in diffidenza nei confronti delle minoranze, primi fra tutti gli stranieri, indipendentemente dal fatto che questi risiedano legalmente o meno nel territorio. Questo perché essi sono abituati a leggi sia etiche che giuridiche molto diverse: l immigrazione non costituisce un grave problema in sé, sono le differenze culturali a rappresentare un ostacolo che deve essere superato con una maggior accettazione da parte della popolazione locale per quanto riguarda quelle discriminazioni che si possono considerare ingiuste. Ma lo sforzo più grande dovrebbe essere fatto dagli individui ospitati, che anche se non condividono le differenze culturali dovrebbero rispettarle e osservarle. 153
157 Il problema è cosa fare con le persone che minacciano la sicurezza di Mattia B., 4 a G Liceo scientifico E. Curiel Oggi la sicurezza è sicuramente la prima fonte di preoccupazione di ogni persona. Chi non ha paura ad attraversare, da solo, una strada buia o una zona malfamata? Chi non chiude la casa a chiave di notte o la riempie di allarmi per non ritrovarsi un ladro in casa? Chi non ha paura a Padova a passare per la famosa via Anelli (prima che venisse svuotata) senza incorrere nel rischio di essere avvicinato da gente malintenzionata? Certo, magari sono tutte paranoie o strani pensieri che ci vengono in mente (magari anche dopo essere stati coinvolti da un bel film thriller o horror), però i fatti che accadono tutti i giorni parlano chiaro: la gente ha paura, che sia del nero, del rumeno, del cinese o dell italiano, ma ha paura, nonostante le nostre efficienti capacità di difesa dell incolumità della persona. Efficienti tra virgolette, perché se questi fatti continuano ad accadere, vuol dire che qualche pecca nel garantire la sicurezza c è. Ma il problema non è tanto cosa fare per garantire la sicurezza, ma cosa fare con le persone che la minacciano. Per le persone che commettono reati, rubano, violentano è prevista la condanna del carcere, perché altre pene in Italia non esistono, ma si sa, nel nostro Paese siamo tanti, e le carceri più di tanti ingiusti non possono contenere. Cosa fare allora con tutta quella gente che, pur meritando sicuramente il carcere per gli atti compiuti, non può essere imprigionata? La mia opinione è che l Italia dovrebbe adottare altri provvedimenti, quali l espulsione per gli incriminati stranieri o la sistemazione in altre strutture statali per i carcerati italiani. Sicuramente le persone che sono in carcere non fanno parte di quella ricca borghesia (o raramente) ma appartengono al ceto umile e povero, ed i crimini che li indirizzano al carcere sono compiuti per questa necessità di vivere. Si propongono sempre provvedimenti emergenziali di Margherita Z., 5 a B Liceo delle Scienze Sociali Newton di Camposanpiero Ci sono situazioni della vita quotidiana in cui io stessa non riesco a sentirmi sicura e magari proprio nei luoghi a me più familiari, come l ambiente domestico e dopo aver vissuto ripetutamente l esperienza del furto in casa non posso non condividere i dubbi di chi si chiede se nel nostro Paese si possa ancora parlare di giustizia, se realmente i governanti si preoccupino del benessere della comunità o piuttosto si limitino ad intervenire quando inevitabile con soluzioni legislative estemporanee. Il clima di insicurezza ha generato episodi di associazionismo locali, che vedono privati cittadini organizzarsi autonomamente in pattuglie di sorveglianza comunali o di quartiere nell intento di garantire l incolumità delle proprie famiglie. Ciò che la classe politica ha saputo fare fino ad ora per rispondere all insoddisfazione delle masse è stato proporre ulteriori provvedimenti emergenziali, incentrati questa volta sull inasprimento delle pene e la riduzione delle possibilità di accesso ai trattamenti rieducativi per i detenuti, nella convinzione che l immagine di uno Stato forte e di un sistema carcerario rigido servano ad allargare le basi del consenso. 154
158 Per noi ragazze è peggio, perché siamo più deboli e incapaci di difenderci di Laura S., 5 a I Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta Mi sento molto insicura ogni volta che esco dal mio paese, soprattutto quando prendo i mezzi di trasporto come l autobus e il treno. Per noi ragazze è ancora peggio, perché siamo più deboli e molte volte incapaci di difenderci. Quando esco di casa cerco di non vestirmi in modo troppo appariscente per non attirare l attenzione, e cerco anche di restare in luoghi affollati senza isolarmi in quartieri con strade buie, oppure esco solo in compagnia di altre persone. Una soluzione per diminuire la delinquenza può essere quella di punire con il carcere chiunque compie dei reati, senza essere clementi e senza fare riduzioni di pena. Tuttavia in molti casi bisogna tener conto del perché è stato compiuto il reato, andando ad indagare sul vissuto del colpevole. Può aver reagito per legittima difesa o addirittura per disperazione. Siamo tutti potenziali criminali, e nemmeno a casa siamo al sicuro di Federica R., 5 a G Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta Ci sono situazioni in cui so di correre dei rischi, ad esempio nei parcheggi nelle ore notturne, ma anche quando apro il cancello di casa dopo il tramonto. In nessuna occasione però mi sento veramente minacciata, perché in me, come in tutti, è viva la convinzione che le cose spiacevoli capitino sempre agli altri. Penso che non sia così semplice rendere più vivibile la città, anche se illuminazioni più efficaci e controlli più frequenti sarebbero d aiuto; penso anche che siamo tutti potenziali criminali, e nemmeno all interno della propria casa, con la propria famiglia, siamo al sicuro. Il crimine deve diventare un tabù prima di tutto all interno della propria coscienza. Non sono solo le leggi a garantire agli individui maggior serenità di Jessica B., 5 a B Liceo delle Scienze Sociali Newton di Camposanpiero Il tema della sicurezza nella società odierna è molto sentito, basti pensare alle prime pagine dei quotidiani che propongono, quasi giornalmente, notizie tragiche di omicidi, furti, o scontri di varia natura tra individui. A mio parere non sono solo le leggi a garantire agli individui maggior serenità e tranquillità di vita, ma questo è possibile anche con sforzi per cambiare mentalità. È necessario infatti cominciare a pensare che chi commette un reato è una persona in difficoltà non solo dal punto di vista legale, ma anche personale. Eliminato il problema legale con una reclusione nelle carceri, persiste il problema legato alle ragioni di questo gesto, alle condizioni dalle quali è scaturito e guardando al futuro, a ciò che si potrà fare per evitare il reiterarsi di quella grave azione. È per questo che è importante parlare di rieducazione, che seppur faticosa, costituisce un duplice rimedio: per la società ma anche per la persona che uscita dal carcere sarà di nuovo come tutte le altre, pronta a ricominciare la sua vita. 155
159 Non è detto che le persone che mi fanno paura siano veramente cattive di Chiara Z., 4 a D Liceo scientifico E. Curiel Ci sono molte situazioni in cui mi sento insicura: ho paura quando vado in giro per Padova da sola, quando sono in stazione o di sera quando si va a passeggiare. Se non ci sono i miei amici con me, non esco nemmeno di casa! Mi impauriscono le persone che mi fissano quando cammino o aspetto l autobus da sola. Mi spaventano le notizie che parlano di stupri, anche fatti da compagni di scuola: non riesco proprio a spiegarmi come si possa arrivare a tanto. Non saprei come si possa rendere più sicura la città, queste persone dovrebbero capire che ciò che fanno non va bene, ma è molto difficile che accada, quindi dovrò uscire sempre accompagnata o evitare certe zone! Poi non è detto che le persone che mi fanno paura siano veramente cattive, magari è solo un impressione, quindi un problema mio, però non posso cambiare le mie sensazioni e ciò che provo. Ormai per una ragazza uscire da sola per strada è davvero un pericolo di Diletta S., 4 a D Liceo scientifico E. Curiel Ci sono molte situazioni in cui mi sento insicura, e come me la pensano molte ragazze, donne e bambine, anzi forse tutte, ormai per una ragazza uscire da sola per strada, soprattutto quando è buio ma non solo, è davvero un pericolo. Infatti tutti i giorni nei telegiornali si sente Ragazza stuprata, per non parlare poi di scippi o di gente che viene coinvolta tra risse di bande straniere. È difficile dire cosa si potrebbe fare per migliorare la sicurezza, bisognerebbe che girasse più polizia, e soprattutto che le leggi venissero applicate più seriamente: ritengo che uno che ha violentato una donna non possa essere rimesso in libertà dopo soli tre mesi di carcere Se fossi il ministro della sicurezza, l espulsione l applicherei a tutti gli stranieri di Michele B., 3 a EA Istituto Scolastico Enaip Veneto (U.O. di Padova) Dopo che la moglie di un generale è stata uccisa da un extracomunitario, il governo ha emanato una legge che riguarda l espulsione degli stranieri non in regola dall Italia. Sono molto favorevole: se fossi io il ministro della sicurezza, questa legge l avrei applicata a tutti gli stranieri, anche a quelli che sono in regola. Non voglio che questa frase sembri fascista o nazista, perché è vero che molti stranieri sono in regola, hanno un lavoro, una casa, ma tanti altri non sono dei santi. Mi è capitato di vedere in tv, o di leggere sui giornali, che queste persone commettono molti atti illegali, sono cattive e quindi abbiamo paura. Più della metà degli stranieri che sono in Italia sono venuti per rubare, spacciare o fare altro del genere, e pur di arrivare alla conclusione del loro piano usano tutti i mezzi a disposizione, compresa la violenza o anche uccidere la gente. Mi sento molto insicuro, e l unica soluzione per rendere la città più sicura e vivibile, oltre alla legge dell espulsione, è quella di aumentare la sorveglianza della polizia. 156
160 La maggioranza degli extracomunitari è qui per spogliare l Italia di Luca B., 3 a EA Istituto Scolastico Enaip Veneto (U.O. di Padova) Per rendere sicura la nostra città bisognerebbe mettere in carcere chi commette omicidi e reinserire la pena di morte, invece al giorno d oggi gli assassini stanno in carcere quattro giorni ed escono. Poi bisognerebbe mandare ai propri paesi gli extracomunitari, dal momento che la maggioranza di loro stanno qui solo per spogliare l Italia dei propri tesori e renderla insicura. Commettono gravi reati, uccidono, picchiano, stuprano, rubano alla persone indifese. Io, che non ho il fisico per difendermi, se alla sera esco da solo sono un po preoccupato, soprattutto se cammino nelle strade buie. Ho sempre paura che esca qualche extracomunitario per picchiarmi o uccidermi. Ci sono anche italiani che fanno reati, ma in percentuale minore. Ho molta paura del mondo di Silvia C., 4 a A Itas P. Scalcerle Ai giorni nostri è molto facile parlare d insicurezza, di paura del mondo esterno. Sentiamo tutti i giorni al tg di omicidi, rapine, violenze Secondo me nulla è più sicuro, nemmeno starsene in casa. Ho sempre avuto paura di tutto, e sentire di persone che uccidono, che stuprano, tra l altro anche sacerdoti professori pedofili, mi mette paura e anche insicurezza. Il mio parere è che ci si deve fidare poco delle persone che si trovano fuori. Ora è tutto pericoloso: esci di casa e trovi gente ubriaca, drogati Queste persone mi mettono molta paura. Quelli che odio di più sono i pedofili. Ho molta paura del mondo, di tutto ciò che c è nel mondo. Ho imparato a non dare troppa fiducia, sto sempre attenta a tutto e non mi butto mai se prima non sono sicura di ciò che può accadere. Il pericolo è ovunque, persino nei luoghi che tu consideri sicuri di Nicole M., 2 a SA Istituto Leonardo da Vinci Il pericolo è ovunque, dietro l angolo, in strada, persino nei luoghi che tu consideri sicuri. Io lo so, è successo anche a me. L 11 ottobre, ore 7.35, faceva freddo, c era quella brezza gelida che, alla sola esposizione della pelle, ti faceva salire un brivido lungo la schiena. Eravamo in Corso Milano. Io e delle mie compagne decidemmo di dirigerci verso piazza Insurrezione: calme, tranquille, ognuna con i propri pensieri in testa. Stavamo procedendo lungo il marciapiede a coppie; lo vidi, un uomo di mezza età, alto, capelli grigi e crespi, k-way verde, jeans chiari e bava alla bocca. Era a pochi metri. La mia compagna fece un commento ad alta voce, d un tratto lo vidi avanzare con passo felpato verso le altre e mi trovai di fianco quest uomo che dopo avermi strattonato mi spinse contro il muro e se ne andò insultandoci. Fino a quel momento ero sicura di me, dicevo sempre: Devono solo provare a toccarmi, e vedrai cosa gli faccio!. Invece, sono rimasta ferma, come paralizzata. Come è successo a me, poteva succedere a qualche altra. Sono insicura, ho paura di essere da sola quando potrà accadere di nuovo. Sarebbe utile aumentare la vigilanza nei luoghi più a rischio, per evitare che la paura che ho preso io, la possa prendere un altra persona. 157
161 Vivo nell insicurezza a causa del cambiamento della società di Serena F., 4 a ALS Liceo delle Scienze sociali Marchesi-Fusinato Penso che non ci sono situazioni in cui mi sento più o meno insicura. Ogni volta che esco da casa vivo una sensazione di insicurezza perché non so mai ciò che mi può succedere. Questo mio pensiero non è dovuto a qualche particolare fatto che mi è capitato ma molto semplicemente a causa del cambiamento della società, di questo umore di culture diverse, dai fatti di molestie e omicidi che sono aumentati verso le giovani ragazze e donne. A questo punto non credo che non si possa fare niente di più rispetto a quello che già i corpi della polizia e dei carabinieri fanno. Siamo in un epoca in cui stanno scomparendo i confini degli Stati per far posto ad unioni e federazioni in cui lo scambio culturale è alla base. Nonostante questo sia un aspetto positivo la criminalità è aumentata e anche se gli Stati mettessero di nuovo dogane e posti di blocco al confine, ciò non basterebbe a fermarla. Per me questo mondo fa veramente schifo di Serena S., 2 a SA Istituto Leonardo da Vinci Ci sono molte situazioni nelle quali mi sento insicura. Di questi tempi non si può neanche uscire di casa, soprattutto verso sera, per paura di essere aggredite, derubate, violentate da persone che aspettano soltanto il momento giusto per agire. Poi non parliamo di droga. Proprio ieri sera ho visto un filmato che parlava di Padova, la nostra città, invasa da tossicodipendenti che lasciano tracce ovunque. Ha parlato una mamma dicendo che il suo bambino non dovrebbe vivere lì, in un posto nauseabondo dove i muri sono completamente impregnati dal vomito di drogati o di persone alcolizzate, ubriache. E la prostituzione: ogni sera si vedono ragazze, spesso molto giovani, che si prostituiscono. Per me questo mondo fa veramente schifo. Non dovrebbero esistere questo tipo di cose; invece, purtroppo, la società sta subendo sempre più velocemente un degrado. Per me ciò che bisognerebbe fare per rendere la società più sicura e più vivibile è istituire delle leggi più severe e per certe persone anche la pena di morte. Cammino per strada con il timore della gente che incontro di Alessandra L., 2 a SA Istituto Leonardo da Vinci Ogni sera, grazie ai mass media, sappiamo in tempo reale cosa accade nel mondo e puntualmente vengono annunciati i problemi d oggigiorno: nuove violenze, omicidi e quant altro. Per quanto riguarda l Italia, gli abusi non mancano; le donne, in particolare le ragazzine, ne sono le vittime principali, viste forse come sesso debole, e i primi ad approfittare di questo sono gli uomini: pedofili (nel caso si tratti di bambini) e stupratori. Tutto ciò mi rende insicura, anche soltanto nell uscire nel vialetto di casa mia. Non ci sono più limiti al pericolo, cammino per strada con il timore della gente che incontro o che accidentalmente mi urta; sono, come si suol dire, sul chi va là?, perché ho la certezza, sostenuta dalle affermazioni dei telegiornali e giornali, che in giro ci sia della gente inaffidabile che non si fa alcun problema a procurarti del male. Per rendere tutto più vivibile, non so sinceramente cosa e chi ci serva, però mi piacerebbe pensare a una città con più forze di polizia che siano più severe e soprattutto che intervengano con durezza. 158
162 Mia madre e mio padre potevano andare in giro fino a notte fonda di Consuelo Z., 2 a SA Istituto Leonardo da Vinci Innanzitutto penso che la sicurezza nella mia città venga un po trascurata; ci sono tante persone che fanno quello che vogliono: partendo da noi italiani, arrivando agli stranieri che dovrebbero portare rispetto per il territorio che li ospita. C erano luoghi che fino a poco tempo fa erano tenuti con cura e ora, a causa di questi stranieri che portano droga, razzismo, discriminazioni tra i cittadini, si stanno rovinando. Per me queste persone che sono venute qui per trovare lavoro ma non ci sono riuscite, dovrebbero tornare nel proprio Paese natale, perché sono solo d intralcio per la società. Ai tempi di mio padre non c erano queste cose che impediscono la libertà del cittadino. Ad esempio, mia madre e mio padre ai loro tempi potevano andare in giro fino a notte fonda, invece ora io non posso nemmeno chiedere di stare fuori molto perché ci sono molti pericoli. Anch io certe volte mi sento insicura. 159
163 COS È QUESTO BULLISMO DI CUI TUTTI PARLANO? Un laboratorio di scrittura per uscire dai luoghi comuni I pulcini possono insegnare alle chiocce qualcosa sul bullismo di Giulia Z., 3 a A scuola media Mameli-Falconetto Indica i nomi di tre tuoi compagni che usano la violenza contro ragazzi più piccoli. Chi è soggetto a bullismo nella tua classe o nella tua scuola?. Ormai domande di questo tipo vengono proposte a noi, ragazzi con l unica colpa di frequentare la terza media, molto spesso, troppo spesso. Studenti universitari arrivano accompagnati da test e questionari riguardanti il bullismo o il cyber-bullismo, che poi dio solo sa cosa voglia dire. I mezzi di comunicazione di massa, i telegiornali, i giornali animano la salute mentale dei genitori e dei ragazzini che varcano la soglia delle scuole medie terrorizzati, pronti ad essere derubati e picchiati. Questo fenomeno si chiama paranoia. Non bullismo. Non violenza su compagni più giovani, solo paranoia. Vedere quei poveri undicenni che si fanno da parte per cederti il passo, perché sei grande, perché sei alto, è ridicolo, assurdo. I mass-media gonfiano alcuni gravosi episodi e ne fanno casi nazionali, solo per aumentare l audience. E questo è il risultato che portano: se c è un gruppetto di ragazzi grandi che parla e ride con un povero, piccolo e indifeso (ma quando mai?!) di prima, scorgi un finestrino che lentamente si abbassa e la voce minacciosa di un padre, eccessivamente preoccupato, che viene a riportare ordine: Tutto bene? Devo forse darti una mano? Calmi ragazzi, eh?!. Tuo figlio forse sta venendo picchiato? Ti sembra terrorizzato, pieno di lividi, in lacrime? Prova a rivalutare la situazione, a vederla oggettivamente, scopri ciò che realmente sta succedendo. Non fissarti su quello che vuoi vedere tu. Non c è bullismo, perlomeno a scuola nostra. Per meglio dire esiste, ma è bullismo al contrario: quei ragazzi che dovrebbero prendere la merenda con la forza, minacciare i più piccoli e quant altro, sono in realtà vittime di pregiudizi per il semplice fatto di essere più grandi. È questo che gli adulti non capiscono: loro sono convinti che i giovani creino delle barriere tra di loro in base all età diversa, che un ragazzo di terza mai si rivolgerebbe ad un piccolo undicenne, senza insultarlo o deriderlo. Ma non è affatto così: all interno della scuola siamo tutti amici, tutti legati e ci consideriamo coetanei. Quindi, perché giudicare atto di bullismo una spinta data, per scherzo, ad un ragazzo più piccolo e non attribuire lo stesso significato ad un pugno rifilato di soppiatto ad un compagno di classe? Fortunatamente nella nostra scuola non esiste bullismo, quindi perché insistere sul contrario? Fatevene una ragione, voi, fissati con questo argomento, che salta fuori in ogni discussione. Forse tutti usano questo termine perché è la tendenza, perché sembra più ricercato rispetto a ragazzo cattivo. Una volta tanto, tappiamoci occhi e orecchie, ignorando i telegiornali, per riaprirli solo per ascoltare le opinioni dei ragazzi che ne sanno di più, su questo argomento. I pulcini che insegnano alle chiocce, una volta tanto. 160
164 L adolescenza, l età in cui ti senti vulnerabile o forte come una roccia di Roberta V., 3 a A scuola media Mameli-Falconetto Quante volte sentiamo e apprendiamo notizie di ragazzi che si sono suicidati, perché derisi fino all esaurimento dagli altri compagni? Quanti si sono portati dentro per tutta la vita le offese e i maltrattamenti ricevuti in passato? Viene da chiedersi perché succede tutto questo. Cos è questo bullismo di cui tutti parlano? Gli episodi di bullismo avvengono soprattutto durante il periodo dell adolescenza, l età in cui ti senti estremamente vulnerabile o forte come una roccia, in grado di affrontare qualsiasi cosa. Un ragazzo si rende conto di crescere, ma non è abbastanza maturo e quindi vive ancora alcune cose con superficialità. Inizia a fare gruppo, diventa magari un leader, si sfoga sugli altri, in particolare chi vede diverso, solo, emarginato. La classica vittima del bullismo è il ragazzo chiamato da tutti secchione, il solito ragazzo che pensa solo a studiare, senza amici. Questi episodi di bullismo sono presenti in molte scuole, ma nella mia no. A scuola mia esistono le vittime del bullismo al contrario, cioè molti ragazzi di terza vengono considerati bulli solo per il loro aspetto fisico. Ragazzini pieni di pregiudizi influenzati dai propri genitori. Gli adulti vivono nella paranoia che qualsiasi ragazzo di statura imponente sia un bullo. Nei luoghi in cui, invece è presente il bullismo, è necessario tentare di prevenirlo, dando più sostegno alle famiglie e ai ragazzi ed essendo assolutamente intransigenti se questi fenomeni avvengono. La severità è fondamentale per far comprendere ai ragazzi le loro azioni, ma deve esserci anche l ascolto e un aiuto concreto. Non va dimenticato che la violenza non è solo fisica, ma anche verbale e psicologica, e molto spesso sono proprio queste che feriscono di più. Diventano quasi un livido perenne dentro le vittime, un livido non facile da superare. Ogni volta che ti vedono scherzare con uno di prima, scatta l allarme di Sofia D., 3 a A scuola media Mameli-Falconetto Comportamento aggressivo che si manifesta in ambito scolastico: questa è la definizione di bullismo che ha trovato nel vocabolario, e che sempre più spesso sento al telegiornale. Ma non solo: ogni tanto a scuola arrivano dei tipi (strambi) dell università che ci propongono un questionario sull argomento, così ogni volta che ne compilo uno mi chiedo: ma io sono una bulla? No, non può essere, perché nella nostra scuola il bullismo non esiste, visto che siamo tutti amici e non si è mai verificata una rissa, o qualcosa di così violento da definirlo un atto di bullismo. Però questa paura aleggia sempre di più tra gli adulti, così ogni volta che ti vedono scherzare con un bambino di prima o parlare con lui, scatta l allarme antibullismo e quindi ti dicono: Non fare male a mio figlio e circola alla larga da lui. Così, quando cerchi di scandire la tua prima difesa verbale, loro ti ripetono quella frase assurda, e tu non puoi obbiettare, perché sei un bullo. Allora, con questo articolo, vorrei lanciare loro un messaggio: non fidatevi dei mass media e della televisione, perché spesso ingigantiscono i problemi e non sempre dicono la verità. 161
165 Non capisco perché nascono tutti questi pregiudizi su noi ragazzi di Elena P., 3 a A scuola media Mameli-Falconetto Bullismo: questo è il termine per indicare gli atti di violenza a scuola, solitamente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale. In questi giorni, alla televisione, sta emergendo sempre più questo tema. In tv i bulli vengono descritti come persone cattive, con un fisico robusto, che perseguitano i ragazzi più piccoli per farsi dare dei soldi o anche solo la merenda. Ultimamente mi sto rendendo conto di come anche i genitori dei ragazzi vengono condizionati dalla televisione e si preoccupano sempre più della vita dei propri figli. Queste preoccupazioni si sono ingigantite soprattutto dopo aver sentito dei casi in tv dove dei ragazzi grandi e forti approfittano della debolezza dei più piccoli, talora con handicap, o di ragazzi che vengono da altri paesi. Nella nostra scuola, degli studenti universitari sono venuti per sottoporci dei test proprio su questo argomento. Io, in quel momento leggendo delle domande, come ad esempio: Chi è bullo in classe tua? o Chi picchia i compagni?, mi sono sentita in difficoltà a rispondere, perché nella mia classe non si sono mai verificati questi casi di bullismo, anzi, la nostra è una classe molto unita! Non capisco perché nascono tutti questi pregiudizi su noi ragazzi.talvolta succede che i compagni più piccoli si spaventano di fronte alla fisicità di quelli più grandi, quando invece questi non hanno nessuna intenzione di intimidirli o minacciarli. Mi rendo conto che il bullismo è un problema e che può manifestarsi con gesti molto gravi e conseguenze per chi lo subisce, però non mi sento di generalizzare per tutte le scuole, in quanto io personalmente non ho mai assistito a gesti tali da potersi definire manifestazioni di bullismo. Penso che ora come ora, invece di dare sempre più importanza ai gesti violenti che si verificano nelle scuole, sarebbe più giusto valorizzare tutti i buoni gesti e le azioni costruttive che facciamo noi ragazzi. Ma queste cose, forse, non riempirebbero tante pagine di giornale Se hai lo sguardo di chi è arrabbiato con il mondo allora ti crederanno un bullo! di Ilenia S., 3 a A scuola media Mameli-Falconetto Bullismo = comportamento o atteggiamento da bullo. Bullo = giovane prepotente. Queste sono le definizioni di due termini, in questo ultimo periodo, molto sentiti. Le vittime del bullismo sono, di solito, soggetti calmi e sensibili, e che se vengono attaccati reagiscono chiudendosi in se stessi. L immagine del bullo è quella dello studente che, con prepotenza e arroganza, intimidisce gli altri. L immagine della vittima, invece, è solitamente quella del ragazzo diverso dagli altri : perché magari magrolino o che usa un linguaggio complicato, il solito secchione Spesso si sente parlare del bullismo nelle scuole, a mio parere nella mia scuola non esiste nessuna forma di bullismo, anzi sì, ma al contrario! Cioè mi spiego, se sei alto e hai sempre lo sguardo di chi è arrabbiato con tutto il mondo beh, allora sei spacciato, sei un bullo! Questo è quello che pensano i bambini più piccoli, o forse quello che fanno loro credere ai loro genitori. Ma io dico, come facciamo ad essere bulli se ogni mese o poco più veniamo sottoposti a test di bullismo o cyber-bullismo?!?! Questo resterà un mistero! 162
166 Io penso che i giornali ci stanno creando una ossessione di Valeria C., 3 a A scuola media Mameli-Falconetto Chi sono i bulli? I bulli sono ragazzi o ragazze più grandi, spesso sono alti e hanno un seguito di due o tre ragazzi che fanno loro da spalla. Rubano la merenda, prendono in giro e picchiano i più deboli. Da un po di tempo si parla e ci sono sempre più notizie sul bullismo, a scuola ci fanno test, ci sono articoli sui giornali e servizi alla televisione. Secondo me stanno esagerando; il bullismo è sempre esistito, ma perché se ne parla solo ora? Io penso che i giornali ci stanno creando una ossessione, avevano bisogno di una notizia scioccante, di qualche cosa che fosse alla portata di mano, che ci fosse sempre stata ma di cui si fosse discusso poco. Così hanno fatto diventare questo problema una emergenza. Hanno creato ai ragazzini di prima delle paranoie, hanno fatto loro vivere i primi giorni di scuola con la continua paura di essere aggrediti. A scuola nostra non credo ci siano atti di bullismo, ma solo i soliti rapporti con i coetanei. Si parla così tanto di bullismo che ormai lo si vede anche dove non c è. Io sono alta e anche molto all inizio dell anno stavo passeggiando per i corridoi con delle mie amiche, ho notato che i ragazzini di prima si ritiravano impauriti: io non avevo fatto loro niente, non ci avevo mai neanche parlato. Quando l ho fatto notare a una mia amica, lei si è messa a ridere e mi ha detto: ti avranno presa per un bullo. Capisco che esiste il bullismo e che è un problema reale, ma non credo sia bello generalizzare; chiunque può essere un bullo ma non per questo tutti lo sono. Si parla spesso di pregiudizi e stereotipi, si dice che non bisognerebbe averne, ma spesso sono solo parole buttate al vento. 163
167 NEL CERCARE DI ESSERE DIVERSI, SI RISCHIA DI ESSERE L ESATTO OPPOSTO, CIOÈ TUTTI UGUALI Un laboratorio per capire che cos è la trasgressione per i ragazzi È impossibile che i genitori non ti pongano mai dei limiti di Angelica M., 2 a B I.S.A. P. Selvatico I giovani di questi giorni pensano che la trasgressione non esiste più pensano di poter avere tutto quello che vogliono, di essere liberi da ogni cosa ma secondo me è soltanto un immaginazione, è impossibile che i genitori non ti pongano mai dei limiti, che ti lascino la libertà più assoluta senza essere in disaccordo. Per trasgredire basta cambiare il proprio look, il modo di rapportarsi con gli altri, di parlare e perfino di mangiare. Spesso i giovani trasformano i loro corpi con tatuaggi, piercing e si rifanno anche qualsiasi parte del corpo che possa attirare maggiore attenzione. Non vanno alla ricerca dei propri valori ma cercano piuttosto di farsi notare il più possibile, arrivando perfino a crearsi un identità falsa, sembrano abitanti di un mondo fantastico dove l ozio è di casa e la trasgressione è la loro regola di vita. Secondo me queste persone si sentono insicure; non si sentono all altezza delle altre persone e non sentono abbastanza fiducia da parte dei propri genitori e nei loro confronti, e allora cercano di evadere dalle regole, di attirare l attenzione degli altri e di mostrarsi più forti, decisi e liberi da tutto e tutti. La trasgressione caratterizza tutti coloro che vogliono apparire o ottenere qualcosa ribellandosi alle regole. Al contrario di quello che pensano questi giovani, è importante avere delle regole perché altrimenti ognuno farebbe quello che vuole e ci sarebbe il caos. A lungo andare queste persone senza valori e personalità si ritroveranno vuote e sempre insicure e si accorgeranno di aver sprecato un po della loro vita senza aver ottenuto qualcosa. Per i nostri genitori la maggior parte di quello che facciamo è trasgressivo di Andrea R., 2 a B I.S.A. P. Selvatico Per me la trasgressione esiste e si può vedere in tutti i ragazzi di oggi, che si vogliono far notare con pettinature strambe, fumando o vestendosi in modo stravagante. Ovviamente per i nostri genitori tutto, o la maggior parte di quello che facciamo noi adolescenti, è trasgressivo perché sono cresciuti con una mentalità diversa dalla nostra. I ragazzi trasgressivi non hanno una cognizione giusta della realtà e sono immaturi, bevono, fumano e si drogano pensando solo alla propria immagine e di appartenere ad un gruppo in, invece che alla propria salute, e continuano fino alla loro autodistruzione o alla distruzione di un altra vita per colpa dell alcol o della droga. Cambiano totalmente la loro identità per essere conosciuti da tutti. Ovviamente tutti gli adolescenti trasgressivi litigano molto con i genitori proprio per la diversità di mentalità, e possono arrivare al punto di lasciare la propria casa seguendo gli sciocchi ideali che portano solo all autodistruzione. 164
168 Cercare le avventure che il nostro spirito ci dà di Dina, 2 a B I.S.A. P. Selvatico Piercing, droga, vite spericolate: non sono forme per trasgredire, ormai ci sono talmente tante persone che lo fanno, che per noi ciò che vediamo è a dir poco tutto nella norma. C è chi si vuole differenziare dal modello che la gente propone, allora si tinge i capelli di fucsia; gli altri si vestono di bianco, lui di nero. Poi l amico lo copia e gli amici copiano l amico e tutti inizieranno a vestirsi di nero e a tingersi i capelli di fucsia, e tutti si crederanno dei trasgressori, quando sono solamente dei seguaci di moda. Insieme infrangeranno le regole, andranno in giro sputando idee che nemmeno loro credono giuste, ma lo faranno tutti per uno stesso scopo: APPARIRE. Apparire agli altri come qualcuno da imitare, da seguire, inseguire, un punto di riferimento, un Dio, quando basterebbe solamente ESSERE SE STESSI: ognuno è Dio di se stesso, basterebbe cercare dentro di noi, senza l aiuto di uno psicologo ma con tutta la forza che abbiamo, il nostro vero essere noi, le nostre vere idee, cercare le avventure che il nostro spirito ci dà, senza condizioni o costrizioni, quello sì che sarebbe il bel modo di trasgredire e di non essere omologati, perché così ognuno sarebbe diverso da tutti e tutti saremmo dei veri trasgressori, che senza bisogno di sballarsi, uccidere ed uccidersi, vivono la vita al meglio, lasciandosi andare. Questo è tutto ciò che penso sulla trasgressione, sul trasgressore ed il trasgredire: tutta abitudine e monotonia del giorno. L adulto trasgredisce per tornare ragazzo, i ragazzi per essere grandi di Janija F., 2 a B I.S.A. P. Selvatico La trasgressione e la normalità per i giovani. Il resoconto delle mie interviste a ragazzi e adulti sulla trasgressione e la normalità è stato per entrambe le età uguale o simile, cioè che la trasgressione è quando si compiono azioni che sono al di fuori delle proprie abitudini e quasi al limite delle regole. La normalità, invece, è quando si conduce la propria vita secondo le regole. È inevitabile dire che la trasgressione è completamente cambiata rispetto al tempo dei nostri genitori; che per le ragazze mettere la minigonna e le calze trasparenti era trasgressivo mentre oggi è completamente normale, ed era impossibile vedere un ragazzo con piercing o un tatuaggio mentre adesso è impossibile non vederne uno con le seguenti caratteristiche. Bisogna mettere in considerazione anche il fatto che la trasgressione varia da età e paesi, voglio dire che la trasgressione di un uomo di quarant anni è differente da quella di un ragazzo di sedici, a volte queste età si intrecciano, perché l uomo di quarant anni trasgredisce per ritornare ragazzo, mentre i ragazzi trasgrediscono per dimostrare di essere grandi. La trasgressione nei vari Paesi è diversa dal nostro tipo di trasgressione; ad esempio la trasgressione per le donne arabe è non coprirsi il volto con il velo, un fatto che per noi è naturale. La domanda che dobbiamo porci non è: cos è la trasgressione, ma perché si trasgredisce? Perché andiamo contro le regole? Forse la maggior parte della gente trasgredisce per il semplice piacere di farlo o trasgredisce per sfuggire alla monotonia della vita. 165
169 Bisognerebbe eliminare qualche programma tv che insegue cose sbagliate di Daniele P., 2 a B I.S.A. P. Selvatico Ogni essere umano non vive da solo. Durante la giornata viene a contatto con ambienti diversi, che sono la famiglia, l ambiente di lavoro, e per quanto riguarda i giovani la scuola. L individuo però, pur dovendo stare assieme agli altri, sviluppa durante tutta la sua vita delle forti esigenze individuali, che richiedono spazi di autonomia negli ambienti in cui si trova. Spesso, noi giovani sentiamo la libertà individuale, che viene in conflitto con le esigenze degli altri che incontriamo durante la giornata, che sembrano opprimerci e violare la nostra personalità. Trasgredire allora, e cioè fare ciò che non si può fare, diventa quasi un esigenza. Alcuni dei conflitti più frequenti sono rappresentati da quelli con i genitori. È però durante l adolescenza che l esigenza della nostra libertà ci mette in conflitto con gli ordini e i divieti degli adulti, sia in famiglia che a scuola. Non è che noi giovani non avvertiamo l importanza di seguire le regole, ma la voglia di essere liberi e di affermarci spesso è superiore. Noi adolescenti non ne possiamo più: uscire dalle regole, unirsi con i compagni in bande che vogliono prendere il posto delle nostre famiglie, compiere stravaganze per distinguerci dagli altri e farci ammirare dai coetanei, vestirci in modo particolare, sembrano spesso gli obiettivi da perseguire. A volte si può arrivare a degli eccessi pericolosi per affermare noi stessi e fregarsene di divieti che gli adulti ci impongono: uso scorretto di bere, attaccarsi alle sigarette che diventano simbolo della libertà, compiere atti vandalici, i cui danni devono essere pagati dai genitori. Qual è l atteggiamento più costruttivo per risolvere il problema della trasgressione? Secondo il mio punto di vista, per risolvere questo problema si dovrebbe eliminare qualche programma televisivo (vedi reality show), che insegue cose sbagliate, o che ti fa vedere la vita nel lato semplice e felice mentre in realtà non lo è. La cosa più giusta da fare è sempre seguire i consigli delle persone giuste che ne sanno più di noi, e sanno come vivere la vita. La voglia di trasgressione è un modo per sfogarsi contro il mondo di Manuele P., 3 a A I.S.A. P. Selvatico Devo confessare che la morte di quel ragazzo di vent anni nel rave party di Segrate, non mi ha sorpreso più di tanto. Anzi, a voler essere sincero fino in fondo, mi stupisco che le morti siano così poche! Non voglio entrare nel merito della polemica politica che si è subito scatenata, ma sono convinto che dietro i rave party si nasconde il loro vero nome: coca party. Anche se in questo caso temo non sia una questione di sola cocaina E mi fa paura vedere che dopo i drammi tutti parlano, ma nessuno fa niente È logico che poi la continua voglia di trasgressione dei giovani, il desiderio di andare fuori dalle regole, di distinguersi dagli altri è un modo per sfogarsi contro il mondo, il voler fare ciò che si vuole in qualunque momento annebbia la vista sui diritti degli altri che ci stanno intorno, prediligendo se stessi. La droga è il peggior modo di trasgredire alle regole, perché si danneggia se stessi e gli altri. Ho la sensazione che chi si droga non lo faccia solo per sentirsi bene, ma anche perché vuole andare oltre, essere migliore degli altri, voltare faccia al mondo. 166
170 Trasgressione significa rimanere liberi, senza condizionamenti e ipocrisie di Federica B., 2 a B I.S.A. P. Selvatico Affrontare l argomento della trasgressione è abbastanza complesso, anche se ormai ai giorni nostri sembra essere diventata una consuetudine. Cosa significa trasgredire? Uscire da ciò che è considerato usuale e rassicurante? Violare delle regole? Non penso che di per sé la trasgressione sia negativa. Nell adolescenza, che è la fase della vita in cui più si manifesta, può avere una funzione importante: si contesta per trasformare, per inserirsi in qualcosa che si sente come proprio, ci si misura con i limiti prestabiliti da entità che si pensa come superiori mettendo alla prova se stessi. Oggi i giovani perlopiù manifestano la loro trasgressione attraverso l abbigliamento, e dunque l aspetto, biglietto da visita importantissimo, andando contro le scelte famigliari, rifiutando la scuola, talvolta assumendo le droghe, e in casi più estremi compiendo atti vandalici o di bullismo. Forse credendo di essere controcorrente, quando in realtà (e basta guardarsi intorno), ormai tutto questo è diventato consuetudine, normalità che indica superficialità, spesso ignoranza, l apatia dei giovani d oggi. È evidente che in una società civile devono esserci delle regole che disciplinano l agire umano, altrimenti vigerebbero il caos e l anarchia che andrebbero inevitabilmente ad intaccare il delicato equilibrio tra esseri umani. Per me trasgressione significa anche trasgressione del pensiero. Rimanere liberi, senza falsi condizionamenti e ipocrisie. Cercare di comportarmi sempre nel modo che io ritengo più giusto possibile, manifestare sempre le mie idee confrontandomi con gli altri. Forse fare anche qualcosa che non è previsto dalla società, che oggi ci vuole tutti burattini e che crede di poter disciplinare anche le nostre anime, ma senza violare la libertà e la dignità di nessun altro. Insomma rispettare prima di tutto me stessa e gli altri. Se non infrangi le regole, un po vieni messo da parte di Viviana L., 2 a B I.S.A. P. Selvatico Per alcuni può essere trasgressivo drogarsi, bere o sballarsi. Per me, oltre che questo, è anche come una persona si pone, come si veste, come si comporta. Io non mi ritengo una persona trasgressiva perché non mi è mai capitato di infrangere le regole o fare cose strane. Vado d accordo con i miei genitori, che invece per alcuni miei compagni sono come un peso perché magari non lasciano fare quello che vogliono. Non ho questo problema, certo a volte ci litigo, è normale, però cerchiamo sempre di trovare un accordo che vada bene a tutti. Dei miei compagni invece non vanno d accordo con i propri genitori, li trattano male e non li rispettano, lo si capisce anche da come trattano gli insegnanti: alcuni non hanno rispetto per quello che ci insegnano. Molti anni fa, invece, i ragazzi erano molto rispettosi delle regole e non osavano rispondere né ai genitori né ai professori. Per i ragazzi di cinquant anni fa era tutto trasgressivo: un tatuaggio, un piercing, portare le borchie, anche darsi baci in pubblico era trasgressivo. Adesso, invece, tutte queste cose passano quasi inosservate dato che per noi è diventato normale, è quasi un obbligo fare determinate cose. Infatti se hai un tatuaggio o un piercing vieni definito un ganzo, un forte, un giusto, e secondo me vieni valutato di più dai gruppi di amici, invece se magari non hai niente o non infrangi le regole, un po vieni messo da parte e quasi non considerato. 167
171 Ai ragazzi non interessa trasgredire, ma pensare di aver provato tutto di Elisabetta B., 2 a B I.S.A. P. Selvatico Trasgredire: non rispettare, violare, eludere, venir meno ad un comando (essere ragazzi aggiungerei io). Trasgressore: si dice di chi non rispetta una regola o un ordine (un ragazzo, mi permetto di aggiungere nuovamente). I ragazzi sono la volontà vivente della trasgressione, la prova che hanno voglia di cambiare, di provare nuove esperienze, magari fuori dagli schemi. Poco tempo fa un semplice tatuaggio era segno di trasgressione, un piercing apparteneva a chi di principio odiava le regole. Al giorno d oggi però poche cose sono trasgressive. I ragazzi sono cresciuti cercando di distinguersi e non si stupiscono ormai di nulla. C è chi è riuscito a crearsi uno stile, trasgredendo le mode che ci impongono Gucci e Prada e chi invece segue i due artisti credendo che loro stessi trasgrediscono. Ad altri la moda non interessa. Agli adulti poi, piace pensare che il ragazzo vestito di nero, con qualche piercing e la sigaretta in mano sia un trasgressore, ma provate a chiederglielo. Vi risponderà che è un punk. Che cosa vuol dire probabilmente non lo sa nemmeno lui. Il bullismo. Il bullismo non è più trasgressione. È un rimedio contro la noia, ispirato da cartoni e film violenti e dai vari videogiochi super tecnologici. Non che prima, senza di essi, i ragazzi non picchiassero i più deboli, solo che ora lo fanno per assomigliare a qualche irreale personaggio di Dragonball. Tanto poi recuperano le sfere e torna tutto come prima. La trasgressione ormai è diventata la quotidianità e non ci si fa più caso. Il livello massimo di trasgressione per un ragazzo sono le droghe. Cannabis. Hashish. Anfetamina. Metanfetamina. Ketamina. Speed. Mdma. Allucinogeni. Lsd. Funghi. Cocaina. Eroina. E poi magari anche la morte, non necessariamente fisica, ma soprattutto mentale e sociale. Ai ragazzi non interessa più trasgredire, ma arrivare alla fine pensando di aver provato tutto, che poi la fine sia a cent anni o a venticinque non ha importanza. E magari si pensa bene della ragazza vestita di marca, brava a scuola, apparentemente tranquilla. Probabilmente la domenica pomeriggio si sfonda di cocaina fino agli estremi. Tanto a vent anni smette. Forse. Ho sentito diversi ragazzi dire che fare uso di stupefacenti non significa trasgredire. Forse in Olanda, ma qui in Italia si trasgredisce la legge e se si è sfortunati si finisce anche schedati dalla polizia. Questo è trasgredire. La diversità fra il trasgredire di trent anni fa e quello di oggi sta principalmente nel fatto che l ideale del ragazzo moderno è fare i soldi. L onore, l etica, il sapere, la natura, si scavalca tutto per arrivare al piacere finale dei soldi, della fama (derivante dal tuo conto in banca). E della bellezza (derivante dall intervento chirurgico finanziato dai tuoi soldi). Un ragazzo che non conosce i principi, non li può trasgredire. I ragazzi non trasgrediscono più perché tutto è loro concesso, perché si è arrivati ad un punto in cui la società umana approva il totale benessere dei ragazzi, che crescono con le idee che vengono loro imposte perché comode. La società è comoda. 168
172 Perché dobbiamo oltrepassare la linea di confine e non uscirne più? di Nicolò G., 3 a A I.S.A. P. Selvatico Alcuni giorni fa, al telegiornale ho sentito che un ragazzo di 19 anni è morto per overdose in un rave party. Da giorni si parlava di queste feste che molti giovani fanno con musica ad altissimo volume: droghe ovunque e alcolici. Però io mi pongo questa domanda: per quale motivo noi ragazzi, che agli occhi degli adulti siamo il futuro, e per adesso non più di tanto, ci vogliamo rovinare in questo modo? Capisco il senso di divertimento, gli amici, la musica, il sesso ma perché arrivare fino ad assumere le droghe? Perché dobbiamo oltrepassare la linea di confine e non uscirne più? Intendiamoci: errare è umano, ma se prendi il vizio, stanne certo che è arduo ritornare indietro, e quando arriveranno al capolinea, coloro che hanno fatto questa scelta la rimpiangeranno. In questo discorso vorrei introdurre la riflessione che ciò non accade solo nel rave party ma ovunque, e sottolineo ovunque: scuole, piazze, bagni comunali, bar, parchi, discoteche, e tanti altri luoghi ancora. La mortalità dei giovani per cocktail di droghe, overdose, incidenti stradali a causa di ebbrezza, risse causate per stupidaggini collegate alla droga, all alcolismo, o addirittura al taccheggio, ha una buona percentuale, ed è vergognoso tutto ciò. Negli ultimi anni la maggior parte di noi ragazzi è troppo libera di fare ciò che vuole e a lungo andare diventa una abitudine, che ci portiamo sempre dietro. Questo non va bene, perché è indice di irresponsabilità e pigrizia, che portano a trascurare addirittura elementi fondamentali per l avvenire come la scuola. Ormai molti giovani si ritirano per carattere pigro, e più avanti ne risentiranno di questa scelta, provano a ritornaci, o frequentano le scuole serali, o continuano a lavorare. Però tutto ciò non è solo colpa nostra, ma è tutto più difficile, la colpa è anche dello Stato, è grazie a lui che noi possiamo fare questo, abbiamo la possibilità di divertirci. Quello che manca in questo Stato è il rispetto delle regole, che vengono sempre contraddette, e l altruismo o meglio l attenzione nei confronti della intera popolazione. Per me molti ragazzi non amano molto la vita, la danno per scontata di Giorgia M., 3 a A I.S.A. P. Selvatico Gli incidenti stradali causati dall alcol ci sono soprattutto tra ragazzi dai 15 anni in su, perché spesso si va in discoteca, ci si ubriaca, e si torna a casa con qualcuno che non ha la patente ma che ha bevuto anche lui. Secondo me se una persona ha la patente vuol dire che ha raggiunto un età, 18 anni, in cui si crede sia maturo, e quindi responsabile di se stesso e delle proprie azioni. Ma molti ragazzi oggi pensano solo a divertirsi e non al dopo-divertimento. Stanno male perché hanno bevuto, per me uno può anche bere, basta che sappia quali sono i suoi limiti, soprattutto se maggiorenne, e se deve ritornare a casa o accompagnare altri. Se uno non è responsabile di se stesso, non può esserlo di altri. Anche la tv per me dà un esempio sbagliato, ci sono un sacco di programmi dove attori fanno cose idiote per farsi male, come Paperissima, ma la gente che si fa male non fa ridere. Per me molti ragazzi non amano molto la vita, la danno per scontata. Non danno importanza, come fosse un loro diritto essere in vita e restarci, e non è che loro non sanno che bere e poi guidare non è una cosa giusta, che è pericoloso, ma non ci pensano proprio, non pensano possa capitare a loro, ma solo agli altri. Non sono responsabili, non si rendono conto di ciò che fanno. 169
173 Da giovani si cerca di assumersi meno responsabilità possibile di Alice B., 3 a A I.S.A. P. Selvatico Che cos è la trasgressione? Dipende da ogni individuo. Per molti trasgressione significa uscire dagli schemi, per alcuni queste tre parole possono essere tradotte nell andare contro le regole e purtroppo, sempre più spesso, anche contro la legge, fumando spinelli, facendo uso di droga, girando per le strade con i veicoli elaborati e quindi correndo ad alta velocità. In questi casi ci si diverte senza valutare le conseguenze. Trasgressione può anche voler dire vestirsi in un determinato modo, farsi piercing e tatuaggi. Trasgressione viene considerata da molti la normalità, la vita quotidiana. Certo, ormai certi atteggiamenti non stupiscono più, neanche i genitori. Esistono infinite trasgressioni, dalle più comuni alle più fantasiose e personali. Per me la trasgressività è la droga; non mi piace trasgredire in questo modo (drogandomi) perché lo ritengo incredibilmente stupido poiché autodistruttivo. Solitamente trasgredisco quando non rispetto gli ordini imposti dai miei genitori, sinceramente non capita spesso. Non vale la pena farli stare in ansia e farli arrabbiare. Bisogna porsi del limiti. Dichiarazioni di un magistrato di Trento: Ormai il senso di trasgressione e l indifferenza nei confronti delle regole e del vivere civile hanno raggiunto livelli tali da annullare il rispetto per la propria vita e per la vita altrui. Ritengo che questa frase rispecchi pienamente la situazione che si è venuta a creare, tra i giovani, attualmente. Durante il periodo giovanile si cerca di assumersi meno responsabilità possibile, si vuole rimanere bambini, divertendosi senza pensarci due volte. In discoteca, nel pub, ai rave party, spesso si trasgredisce bevendo e assumendo droga. Non si valutano le conseguenze, e non si ha più rispetto per la propria vita e per quella degli altri, specialmente se poi si utilizza un veicolo in condizioni fisiche non appropriate. Bisogna farsi un esame di coscienza, bisogna porsi dei limiti. Chi riesce a fare ciò dovrebbe aiutare a far riflettere gli amici che non si pongono limiti e rischiano la distruzione di sé e degli altri. È difficile, ma con buona volontà si può aiutare il prossimo e addirittura salvargli la vita, facendolo ragionare! Una vita perfetta perderebbe il suo significato di Alexandro B., 3 a A I.S.A. P. Selvatico Il rispetto reciproco è una delle cose fondamentali della nostra vita. Se ognuno riuscisse a convivere e a comunicare in una maniera rispettosa, su ogni aspetto della vita, la maggior parte dei problemi si risolverebbe automaticamente. Dal mio punto di vista troppo rispetto provocherebbe una vita di depressione, una vita semplice, quasi seriale, demoralizzando la gente. Da qui, per me, nasce la trasgressione. Un azione di diversa gravità utilizzata per manifestare e lottare in modo improprio. La trasgressione può essere vista sotto diversi aspetti; può essere una trasgressione per esprimere la propria arte: come i murales, disegni sui muri (azione vietata dalla legge, ma di minore importanza). Possiamo trovare anche trasgressioni più gravi come il furto, un gesto illecito che danneggia altre persone. È questo, forse, che ci fa ancora concentrare sulla nostra vita, una vita perfetta perderebbe il suo significato, non potremmo più provare la paura e l emozione di fare qualche piccola trasgressione fuori dalle regole per fuggire dalla solita giornata. La trasgressione e il rispetto sono aspetti importanti, ma per me bisogna trovare sempre una mediazione. 170
174 Nel cercare di essere diversi si rischia di essere tutti uguali di Elisa B., 3 a A I.S.A. P. Selvatico Ultimamente accadono sempre più spesso incidenti stradali, soprattutto durante i fine settimana, in cui sono coinvolti quasi sempre giovani che non superano anni. Questi incidenti, a volte mortali, accadono per l alta velocità e soprattutto a causa dell alcol, di cui molti ragazzi abusano. Questo accade perché logicamente si pensa che per divertirsi bisogna bere alcolici (a volte superalcolici) e nei casi più estremi fare uso di droghe. I ragazzi, magari ubriachi, escono tardi dalle discoteche o dai pub e fanno la cosa peggiore da farsi, cioè prendere la macchina e guidare in queste condizioni, rischiano la vita, ma soprattutto la vita altrui! Sì, perché magari nella macchina ci sono altri ragazzi, ubriachi anche loro, che non si accorgono che il ragazzo che sta al volante non è sicuramente nelle condizioni di guidare e magari si divertono pure ad andare veloci per strada tanto pensano che nulla e nessuno possa fermarli ma ecco che tutto finisce nei peggiori dei casi la macchina va fuori strada, addosso a qualche cosa se hanno fortuna se la cavano con qualche contusione ma nel peggiore dei casi muoiono, e assieme a loro anche i pedoni, gli innocenti, oppure le persone dall altra vettura coinvolta nell incidente, tutto questo a causa dell incoscienza! Forse il loro problema è che adesso è di moda la trasgressione, andare contro le regole e soprattutto fare il possibile per essere diversi degli altri. Ma è proprio questo il fatto, perché nel cercare di essere diversi, di non essere ragazzi normali, si rischia di essere l esatto opposto, cioè tutti uguali, visto che tutti fanno uso di alcol e/o droghe quindi non capisco dove sta questa differenza! Io mi considero una ragazza normale, insomma non fumo, non bevo a parte qualche sabato, ma niente di forte e a scuola mi impegno abbastanza. La cosa che mi dà più fastidio è che secondo questi ragazzi è proprio quello che fanno loro la normalità, e invece considerano i ragazzi come me diversi, anzi a dire la verità sfigati Quello che penso è che in realtà sono loro gli sfigati, perché credono che per divertirsi devono bere e drogarsi. In alcuni casi (e la stessa cosa vale per tantissimi altri ragazzi) per divertirmi preferisco andare in centro storico con gli amici, andare al cinema, mangiare un gelato al duomo, ma sicuramente non ubriacarmi. Insofferenti a leggi, divieti e controlli di Marco R., 3 a A I.S.A. P. Selvatico La trasgressione ha fatto perdere il rispetto verso gli altri. Sono d accordo con questa considerazione sotto molti punti di vista. La voglia di trasgressione si è trasformata, nel corso degli anni, dal tardare un po sull orario di rientro, parlando di noi giovani, al guidare una macchina strapiena di gente alle 5 del mattino, strafatti di coca e alcol. Si è perso il senso della misura. Gli adolescenti di oggi sono insofferenti a leggi, divieti e controlli, perché i propri genitori, provenienti da una generazione di sessantottini, erano i primi a volerli trasgredire, questi divieti; e cresciuti in 171
175 questo clima di insofferenza e di abbandono e persa ogni tipo di educazione morale, gli animi si sono adeguati al cambiamento. È anche vero che esiste pure una parte di giovani che crescono educati e sereni, ma sono in netto ribasso rispetto alla classe emergente e dominante. Le menti dei giovani d oggi sono piene di idee, fantasia, voglia di divertirsi e di crescere, ma se vengono incanalati tutti in un vicolo cieco come la droga, l alcol o cose del genere, si rischia di perderle. Solo indirizzandole nel modo giusto riusciranno a trovare in loro la voglia di avere rispetto per se stessi, e anche rispetto per gli altri. In parte la storia narrata nel film Uno su due si può ricollegare a questo tema sotto l aspetto della sfacciataggine e della superbia del personaggio principale, mischiata a quel senso di trasgressione che deriva da una sorta di potere. Il film parla della storia di Lorenzo Maggi (Fabio Volo), avvocato spaccone di successo, quando, nel vivo della carriera, viene colpito da un sospetto tumore. Durante la convalescenza conosce Giovanni (Ninetto Davoli) e in lui riscopre la saggezza e il vero significato della vita. Maggi, che aveva consacrato la sua vita al successo, alla fama e ai soldi, fregandosene di tutto e di tutti, viene riconvertito al vero piacere della vita, cioè quello del viaggio introspettivo, quello del provare veri sentimenti e forti emozioni, perché ci è stata data solo una vita da vivere, ed è bene non sprecarla. 172
176 Capitolo 7 IL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEGNANTI Sono tanti gli insegnanti che hanno scelto di fare questo progetto, alcuni con entusiasmo, altri con una naturale diffidenza verso un percorso così complesso e così tutto da sperimentare. Perché l elemento di fondo è che anche loro hanno dovuto accettare di intraprendere una strada del tutto nuova, accettando il rischio di esiti imprevisti, come sempre quando ci si confronta con qualcosa di sconosciuto, abbandonando il terreno delle materie tradizionali. Ma il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere proprio grazie a loro è diventato uno straordinario laboratorio con due sedi, le classi e una grande cella adibita a redazione in carcere. E ogni tappa di questo complesso percorso viene analizzata, discussa, messa a punto ogni volta con passione, ma anche senso critico, curiosità, capacità di rimettersi ogni volta in discussione. 173
177 174
178 ROMPERE LA ROUTINE QUOTIDIANA DEI PROGRAMMI PER OCCUPARCI DELLA VITA VISSUTA È quello che facciamo esplorando una realtà come quella del carcere, posta ai margini della società e quindi separata, sconosciuta di Giuliana De Cecchi insegnante di Lettere dell Itas P. Scalcerle Sono molte e molto potenti le occasioni per riflettere che il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere può offrire. In quattro anni di esperienza con questa straordinaria attività di studio e di confronto ne abbiamo incontrate parecchie: rompere la routine quotidiana dei programmi per occuparci della vita vissuta; esplorare una realtà come quella del carcere posta ai margini della società e quindi separata, sconosciuta; toccare con mano funzioni e disfunzioni della giustizia italiana; intercettare quel mondo sommerso che si chiama volontariato e scoprire umanità e risorse impensabili; lavorare sui pregiudizi che gravano sull opinione pubblica Ognuna di queste angolature potrebbe costituire, da sola, una valida ragione per imbarcarci, studenti e docenti, in questo percorso. In realtà credo che la più efficace e la più suggestiva sia un altra: potremmo dire quella della banalità del male, lo scoprire cioè che il male è davvero a portata di mano, angolo buio dentro ognuno di noi o nascosto in persone assolutamente normali, simili a noi. Questa angolatura ha affascinato i ragazzi: perché si sono riconosciuti, hanno scoperto impreviste e inimmaginabili connessioni tra chi sta dentro e chi sta fuori, hanno soppesato quell ambigua attrattiva della trasgressione, potentissima alla loro età (ma anche oltre) e sperimentabile quotidianamente. Non a caso tra le molte domande che urgono, anno dopo anno, negli incontri tra studenti e detenuti, una ricorre sempre: che cosa ha spinto a varcare il confine tra legalità e illegalità; come un impulso naturale, comune sia diventato azione illecita; quando e quanto consapevolmente si finisce dall altra parte del guado. Ma arrivare a formulare in questi termini questa domanda significa già aver percepito che chi sta in carcere non è necessariamente un alieno o un mostro, come magari si è pensato fino a pochi minuti prima. Ecco, questo cambiamento di prospettiva, il vedere gli altri con occhi diversi, e quindi il percepire diversamente anche se stessi è già un traguardo importante nella costruzione di un valido percorso didattico. Come costruirlo allora, questo percorso? Innanzitutto la scelta della classe: ho sempre preferito la quarta, sia perché si lavora con ragazzi abbastanza grandi sia perché la proposta della metodologia della ricerca richiede un minimo di esperienza, che la terza ancora non ha, e una disponibilità di tempo-scuola che la quinta non consente. In secondo luogo la programmazione: un percorso lungo, da spalmare nell arco di due/tre mesi, magari intrecciando nell orario settimanale l attività ordinaria con questo percorso straordinario. Lungo perché richiede tempi lunghi di digestione e riflessione, visto che si tratta di esperienze forti ed intense, anche sul piano emozionale; lungo poi, e soprattutto, perché va proposto con un ampia articolazione, un menù differenziato, con sapori diversi 175
179 ed esperienze eterogenee: c è lo spazio della lettura e della documentazione, c è lo spazio del dibattito e del confronto, c è quello dell auto-analisi e della scrittura autobiografica, c è poi il momento della visita al carcere e così via. In terzo luogo il coinvolgimento: la proposta di questo tipo di percorso è, appunto, una proposta, non un imposizione. Va lanciata alla classe, va detto chiaramente che si può fare o si può non fare, che il farla implica certi costi in termini di impegno, di motivazione, di disponibilità; va quindi discussa e solo a questo punto viene decisa dagli studenti stessi. E poi il percorso viene strutturato nelle sue diverse fasi e illustrato agli studenti, con possibilità di modifica da parte loro, in modo che sia assolutamente condiviso. Da qui la necessità di effettuare via via bilanci in classe sulle esperienze/attività che si sono effettuate, per garantire una seria motivazione ed una convinzione profonda. I ragazzi insomma devono percepire che questo lavoro è diverso, che lo si fa non perché fa parte del programma e dunque, obbligatoriamente, magari svogliatamente; devono percepirne chiaramente il senso e il valore, per loro stessi, per la loro crescita. Un attenzione particolare per i genitori: vanno informati molto onestamente, per esempio attraverso una lettera a ciascuno di loro; vanno ascoltati in caso di perplessità o timori; vanno coinvolti invitandoli a partecipare ad alcune attività, come gli incontri a scuola con detenuti e volontari o la visita al carcere. Quanto alla strutturazione del percorso: si potrebbero programmare quattro diverse attività. Vediamole in sequenza. 1. Attività di documentazione e scrittura saggistica: primo impatto con il problema-carcere: brain storming su domande a ruota libera e curiosità degli studenti in relazione alla realtà carceraria; un esperienza cinematografica per mettere a fuoco possibili piste di indagine; per saperne di più: un ora di libera esplorazione del sito di Ristretti Orizzonti, da cui i ragazzi selezionano problematiche che ritengono interessanti. Attorno a questi nuclei tematici, si formano gruppi di ricerca: lavoreranno in classe su materiale di documentazione, storie e testimonianze; produzione di saggi brevi: i gruppi stendono relazioni sul loro percorso di ricerca, intrecciando relazioni individuali e relazioni collettive; dalle relazioni verrà ricavato alla fine un dossier complessivo; presentazione delle ricerche di gruppo: ognuno è relatore e ascoltatore; questa è l unica attività oggetto di valutazione: tra i criteri di valutazione, uno spazio speciale per la creatività e la capacità di coinvolgimento. 2. Attività di approfondimento lettura e discussione sul testo settecentesco di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), la prima analisi scientifica relativa ai problemi della giustizia, nel contesto dell Assolutismo illuminato (questa parte costituisce l aggancio ai programmi di Italiano e Storia). esperienze di lettura/recensione di romanzi sulla devianza e la legalità. 3. Attività di confronto e discussione un primo incontro a scuola con detenuti/e (che usufruiscono di misure alterna- 176
180 tive) e volontari: discussione e confronto di esperienze di vita, utilizzando il punto di vista di chi vive in carcere; un secondo incontro a scuola con esperti (giudice di Sorveglianza, o mediatore penale, o docente universitaria di Diritto minorile), utilizzando il punto di vista di magistrati, operatori, studiosi; incontro in carcere con la redazione di Ristretti Orizzonti; partecipazione alla giornata conclusiva: incontro con uno scrittore e premiazione del concorso di scrittura. 4. Attività di laboratorio breve laboratorio di scrittura autobiografica: come esplorare dentro di sé e produrre racconti di vita vissuta, attraverso giochi colorati per far affiorare memorie, emozioni, percezioni intorno al tema della trasgressione; produzione di testi conclusivi sull esperienza fatta, adottando specifiche tipologie di scrittura: dal racconto al reportage, dalla lettera alla pagina di diario. Si tratta dei testi che partecipano al concorso di scrittura. Dunque un lavoro complesso e sfaccettato, ma ricchissimo di suggestioni, capace di attivare il lato emozionale come anche la riflessione e l introspezione; non di rado ha fatto scoprire agli studenti che si può studiare con passione e profonda convinzione. Talora anche i testi letterari sono stati letti con occhi diversi: con una nuova attenzione per i cattivi di carta, per i personaggi creati dalla letteratura con le loro storie oscure, perché l esperienza del male ha dato vita ad una nuova sensibilità. 177
181 PERSONE CHE OFFRONO ALL ATTENZIONE E ALLO STUDIO DEI GIOVANI LA LORO TORMENTATA ESPERIENZA Come potrebbero altrimenti i nostri studenti conoscere realisticamente la dimensione del delitto, dell espiazione, del riscatto? di Antonio Bincoletto, insegnante di Lettere del Liceo Marchesi-Fusinato È il quinto anno che partecipo al progetto scuola-carcere. Vi ho coinvolto finora una decina di classi, in prevalenza del Liceo delle Scienze sociali, alcune del Liceo linguistico; anche qualche studente del Classico ha avuto modo di intervenire ad alcuni incontri. Nel nostro istituto abbiamo dato al progetto un titolo significativo e programmatico: A scuola di libertà. Ormai molti iscritti delle Scienze sociali sanno che nel triennio c è questa possibilità, e aspettano con ansia il momento in cui avranno a che fare con i detenuti e entreranno in visita nel carcere Due Palazzi. Diversi ragazzi in quarta chiedono di fare lo stage di alternanza scuola-lavoro in carcere, altri continuano a svolgere attività di volontariato in questo ambito anche dopo la fine del liceo. Il bilancio di questa esperienza, al compiersi del primo lustro, è estremamente positivo. Più di uno studente alla fine ha dichiarato che è stata l attività scolastica che l ha maggiormente coinvolto, e da cui ha più imparato, addirittura nell intero corso di studi. Posso dire che l incontrare persone che stanno pagando per gli errori commessi e che, anche per espiare, offrono all attenzione e allo studio dei giovani la loro tormentata esperienza, ha un valore formativo enorme. Quando mai avrebbero modo i nostri studenti di confrontarsi dal vivo con una tale realtà? Come potrebbero altrimenti conoscere realisticamente la dimensione del delitto, dell espiazione, del riscatto? In quali altre situazioni potrebbero disporre di un osservatorio tanto interno, che consente loro di approcciare sistemi e istituzioni penali, di confrontarsi in modo diretto e non deformato con questo mondo e con le persone che vi sono coinvolte? Chi ha scelto un corso di studi imperniato sulle scienze sociali acquisisce in questo modo un esperienza che gli risulterà preziosa. Ma anche gli studenti degli altri indirizzi che partecipano a queste particolari lezioni hanno l opportunità di confrontarsi con le sfere complesse dei vissuti umani, delle istituzioni sociali e dei valori, dimensioni in cui ci s imbatte nell ambito di ogni percorso formativo e studiando qualunque disciplina. Chiunque entri in questo percorso di studio e approfondimento ha modo di farsi un idea non omologata o stereotipata su problematiche di cui si discute ogni giorno (sicurezza, legalità, emarginazione, immigrazione ), usando informazioni originali, non di seconda mano, e concetti elaborati anche attraverso l osservazione diretta e il dialogo. Il fine e l esito di questo studio, di questi incontri, è far crescere la consapevolezza, la capacità d interrogarsi, il senso critico nei nostri ragazzi, e con ciò offrire loro un percorso 178
182 formativo oltreché conoscitivo, in grado di aiutarli a evitare comportamenti di rischiosa devianza. Fare prevenzione significa anche questo. Il rapporto coi giovani dà ai detenuti senso di realtà, e li carica di responsabilità Detto ciò, c è un aspetto non meno importante del progetto che voglio qui mettere in evidenza: mi riferisco al fatto che, con queste attività, la scuola e gli studenti in primo luogo possono contribuire alla prevenzione del crimine e al recupero degli individui che hanno sbagliato. Mi sono reso conto sempre più in questi anni di quanto sia importante anche per i detenuti mantenere aperto un dialogo con l esterno, per uscire dai vicoli ciechi in cui si sono cacciati e per tenere aperto un filo di speranza nel futuro. In particolare il rapporto coi giovani dà ai detenuti senso di realtà, e li carica di responsabilità. In tutti gli incontri che abbiamo organizzato a scuola o in carcere fra studenti e detenuti ho percepito un forte coinvolgimento reciproco. Non si può restare impassibili quando si parla della vita, del vissuto proprio e altrui, specie quando si tratta di esperienze tragiche, che lasciano un segno profondo. Questo scatena reazioni, non sempre tranquille e piacevoli, ma in ogni caso autentiche: i ragazzi sono spesso duri con chi ha sbagliato, ed è giusto che lo siano, perché in questo modo partecipano, non restano indifferenti, magari si dimostrano manichei, ma dicono apertamente ciò che pensano e non si nascondono dietro al velo di un vogliamoci bene aprioristico e, in quanto tale, potenzialmente ipocrita. In questo modo avviano un confronto reale, nel corso del quale spesso arrivano a liberarsi di molti pregiudizi e a farsi, delle persone, figure e istituzioni che incontrano, un idea più complessa e meno stereotipata rispetto a quella che avevano inizialmente. I detenuti, dal canto loro, parlando di sé si espongono al giudizio di estranei: non lo fanno per un interesse opportunistico, non hanno di fronte giudici, poliziotti, operatori o funzionari del carcere da cui possano ottenere qualche beneficio immediato; se si mettono a nudo è perché ne hanno maturato l esigenza o perlomeno hanno creato le condizioni per farlo, hanno compreso che raccontare la propria storia è il primo passo per rivederla, riconsiderarla. Raccontarsi significa anche fare i conti anzitutto con se stessi e col proprio passato, intraprendere un percorso di possibile catarsi e riscatto. Come tutti gli individui, anch essi hanno bisogno di uno specchio in cui riflettersi, per potersi vedere, e ho avuto l impressione che molti detenuti, anche stranieri, abbiano una grande necessità di parlare, ascoltare, confrontarsi. Forse abbiamo avuto a che fare con detenuti speciali, con persone che comunque un percorso di revisione di sé l hanno avviato o lo stanno intraprendendo. I nostri contatti sono stati col carcere penale, non col circondariale ; inoltre abbiamo parlato con reclusi che dentro al carcere cercano di svolgere un attività utile per sé e per gli altri, attraverso la redazione della rivista Ristretti Orizzonti, i corsi di studio, i progetti gestiti dai volontari. Non m illudo che sia così sempre e con tutti. Ma una convinzione l ho maturata: per questi detenuti lo scambio con gli studenti, assieme ad altre iniziative che permettono loro di mantenere il contatto fra il carcere e l esterno, è ossigeno, aria pura, aiuto a credere che un futuro diverso è possibile e che il tempo della reclusione non sia solo vuoto a perdere. 179
183 Questo l ho capito percependo gli imbarazzi, la fatica ma anche la voglia di comunicare che i nostri esperti manifestavano durante gli incontri, vedendo le espressioni e le reazioni loro e quelle degli studenti alla fine delle lezioni, avendo notizia dei percorsi di reinserimento che tanti tentano e, se aiutati, portano a compimento. Così la scuola esce dall autoreferenzialità che spesso le viene rimproverata Credo perciò che sarebbe un grave errore assecondare, come pare andar oggi di moda, l idea che i problemi della sicurezza e del crimine si risolvano con una logica meramente repressiva, semplicemente irrigidendo le regole della detenzione e abolendo i percorsi di recupero. Ciò che si può constatare nel corso di progetti come quello che noi da cinque anni portiamo avanti, è che i percorsi di recupero, sostenuti da misure alternative, dall opera preziosa di volontari e dal permanere di un confronto con la società civile (di cui il mondo della scuola è parte essenziale) funzionano, poiché consentono a chi ha commesso dei delitti di comprendere il male fatto e di espiarlo, e nello stesso tempo di tenere aperta una speranza nel futuro, preparando quel reinserimento che la nostra stessa Costituzione contempla come uno degli obbiettivi centrali del sistema penale e carcerario. Dunque, perché chiudere questa finestra? Oltretutto la scuola che, mentre svolge la propria funzione formativa, collabora al raggiungimento di questo obbiettivo, potrà finalmente fregiarsi di un merito particolare: quello di essere uscita dall autoreferenzialità che spesso le viene rimproverata, di aver saputo agganciarsi al mondo rendendosi utile ad un fine sociale supplementare. In tempi in cui la scuola balza immeritatamente all onore delle cronache solo quando si parla di bullismo, o attraverso rappresentazioni del peggio on line, non mi par di poco conto mostrare come in realtà essa sia, e possa continuare ad essere, anche e specialmente qualcosa di diverso 180
184 PROGETTO CARCERE: UN CAMMINO DI CONOSCENZA Da un atteggiamento diffidente e colpevolista alla scoperta di un mondo ricco di umanità e di sofferenza di Maria D Abruzzo, insegnante di Lettere del Liceo delle Scienze Sociali Duca D Aosta Quando le colleghe mi hanno proposto di partecipare al Progetto Carcere ho aderito con entusiasmo: sono stata sempre vicina al mondo del volontariato e questa era un occasione per conoscere un ambito di cui avevo sentito parlare solo marginalmente, tramite insegnanti che lavorano in carcere o che avevano già partecipato al progetto; inoltre conoscevo Ornella per alcune sue iniziative rivolte all aggiornamento dei docenti e soprattutto, lavorando in un Liceo delle Scienze Sociali, ritenevo indispensabile inserirmi attivamente nei percorsi caratterizzanti questo specifico indirizzo. Alcune attività (lettura e analisi di testi letterari attinenti l argomento, stesura di relazioni) erano quasi scontate per la mia materia, ma l aspetto che è risultato più arricchente, per me come per le alunne, oltre naturalmente agli incontri con i reclusi e con gli operatori, è stato lo scambio di riflessioni ed emozioni che in più occasioni siamo riuscite ad avere fra di noi in classe. Ho potuto assistere ad un vero cammino di maturazione che le alunne hanno compiuto, da un atteggiamento diffidente e colpevolista che spesso ho notato nei giovani (ad esempio affrontando il dibattito sulla pena di morte) e che d altronde è fortemente alimentato oggi da certa stampa e dal clima in cui viviamo, alla scoperta di un mondo ricco di umanità e di sofferenza, ma anche pieno di energia e di determinazione. La lettura del libro Donne in sospeso, che le ragazze avevano iniziato senza molta convinzione, ha spalancato dinanzi a loro un universo femminile che le ha fortemente coinvolte, portandole quasi ad immedesimarsi in alcune situazioni; penso alla vivacità con cui hanno dibattuto il problema del rapporto delle donne detenute con i figli piccoli, o quello dell organizzazione dei colloqui con i familiari, o ancora della convivenza fra donne di nazionalità diversa. Uno dei momenti più emozionanti che ricordo è stato quando abbiamo letto la testimonianza di una detenuta che affermava che, dopo un cammino di conoscenza di sé e di riabilitazione, si sentiva libera : con stupore molte di noi si sono rese conto che, pur vivendo fuori, non ci sentiamo per niente libere, bensì vincolate da una marea di obblighi e di convenzioni che ci vengono imposti dagli altri (ma a volte anche da noi stesse). Abbiamo così scoperto che dai detenuti abbiamo molto da imparare. Molto forte è stato anche l impatto con la testimonianza di Elton (che poi abbiamo conosciuto di persona) sull importanza della lettura e della scrittura: quello che ormai per molti giovani appare solo un penoso dovere scolastico si è rivelato prepotentemente come uno strumento per entrare in se stessi e per comunicare con gli altri. Non voglio tacere, infine, la crescita di consapevolezza che ho notato nelle ragazze da un punto di vista professionale: la maggioranza si è sentita molto coinvolta dall approccio con un ambiente in cui potrebbero essere chiamate, un domani, a lavorare; si sono rese conto che non si tratta di casi né tantomeno di cose di cui occuparsi astrattamente, ma di persone con una storia alle spalle e tanta voglia di futuro. Grazie a tutti voi: non vi dimenticheremo. 181
185 UN PROGETTO PER ABITUARE I RAGAZZI A PENSARE CON LA PROPRIA TESTA È importante allora coinvolgerli in un dibattito aperto, dove un gruppo assuma il ruolo della tesi e l altro quello dell antitesi di Lucia Tussardi, insegnante di Lettere, Scuola media Falconetto Ho partecipato al Progetto scuole-carcere per la prima volta due anni fa e oggi ritengo opportuno riproporlo agli alunni che frequentano la terza media, perché ne ho constatato la valenza educativa. Allora abbiamo scelto, insieme ad Ornella Favero, di adottare la seguente metodologia: compilazione da parte dei ragazzi di un questionario informativo attraverso il quale si potesse capire quali erano le convinzioni degli adolescenti in merito alla pena, compresa la pena di morte, e alla detenzione e alla sua utilità; lettura e commento in classe di alcune testimonianze di detenuti pubblicate sull opuscolo Ragazzini e ragazzacci e della raccolta di racconti Tredici casi per un agente speciale ; dibattito in classe per sviscerare i problemi e preparare i ragazzi all incontro con i detenuti; incontro con alcuni detenuti che lavorano all esterno in misura alternativa o prossimi alla scarcerazione (l incontro è indubbiamente il momento più emozionante); interventi in classe di una giornalista (Ornella Favero) e di un detenuto della redazione di Ristretti Orizzonti (con formazione giornalistica) per effettuare un laboratorio di scrittura su temi non strettamente legati alla detenzione, ma nati dalle proposte dei ragazzi; visione di un film sull argomento e stesura di testi di tipo argomentativo; compilazione di un questionario di uscita per verificare se i ragazzi successivamente a questa esperienza avevano modificato le loro idee; Proposte per introdurre alcune innovazioni in questo percorso metodologico: sostituirei il questionario di apertura con un testo scritto da proporre ai ragazzi, anche dopo la lettura di un brano attinente all argomento (ho già letto con i miei alunni l intervista a un condannato a morte); proporrei ai ragazzi tracce di scrittura libera su sicurezza, pene, carcere, per estrapolare poi i loro pensieri all inizio del percorso; preparerei l incontro con i detenuti attraverso riflessioni e dibattiti che scaturiscano sempre dalla lettura di esperienze dirette; come verifica finale, considerando che si è scelto di non somministrare il questionario di entrata, sostituirei quello di uscita con la produzione di testi argo- 182
186 mentativi inerenti al tema trattato, dai quali possano eventualmente scaturire anche posizioni opposte; coinvolgerei i ragazzi in un dibattito aperto dove un gruppo assuma il ruolo della tesi e l altro quello dell antitesi. Attraverso quest ultimo momento di confronto si potrebbe verificare se le idee dei ragazzi si sono modificate e come. Le tappe concrete del percorso che sto realizzando quest anno: presentazione del progetto carceri agli alunni per coinvolgerli e suscitare il loro interesse; lettura di un intervista ad un condannato a morte e conseguente dibattito sulla pena di morte e la detenzione: questo ha portato a una prima messa a fuoco dei pareri dei ragazzi; lettura e commento degli articoli sulla semilibertà concessa a Pietro Maso, e successiva produzione, da parte degli alunni, di testi argomentativi, che per molti aspetti risultano davvero interessanti; la classe vedrà poi il dvd Voci da dentro, con alcune interviste ai minori nell Istituto penale minorile di Treviso; è prevista la partecipazione alla rappresentazione Boia chi molla, spettacolo organizzato da Amnesty International sulla pena di morte, al quale seguirà un dibattito con gli attori e alcuni rappresentanti dell associazione. Tutte queste sono le tappe preparatorie dell incontro in classe con detenuti e volontari, e di un successivo incontro con un docente di Diritto penale minorile 183
187 UNA SCUOLA IN CUI IL PROGETTO CON IL CARCERE È DIVENTATO DAVVERO DI TUTTI I nostri allievi riflettono così su cosa sanno o pensano di sapere del carcere e delle pene, e sono meno esposti al rischio di commettere qualcosa che li porterebbe a doversi confrontare con la Giustizia di Stefano Cappuccio, insegnante tecnico pratico nei Laboratori di Automazione Industriale,.I.T.I.S. G. Natta Quando, la primissima volta alcuni anni fa, una collega mi propose di accompagnare una delle nostre classi a un incontro con alcuni volontari e detenuti, mi tornò in mente, come ripescato dal nulla, il ricordo di un afoso pomeriggio d estate. A quel tempo, a cavallo della mia bicicletta, io e i miei amici sciamavamo per le solite strade attorno alle nostre case. Era il nostro unico vero passatempo, e così le nostre vacanze trascorrevano. Lentamente. Quel pomeriggio, però, accadde qualcosa che avrebbe sottolineato in modo indelebile, anche senza traumi reali, una data in quel calendario senza tempo. Erano tempi, quelli, in cui per le strade quando avevi prestato attenzione alle macchine, eri tutto sommato salvo da pericoli e da tentazioni. Eravamo noi i dominatori di quelle vie, ne sapevamo ogni metro e alcuni angoli e spazi erano tappe obbligate, anche per calmare la noia del pigro pedalare. E conoscevamo, e ci conosceva a sua volta, ogni abitante di quelle vie e di ogni casa. Tutti, ma proprio tutti. La prima volta che lo vidi aveva un aria sospetta, certamente dimessa e sembrava camminasse cercando una via che però non trovava. Fu così per alcuni di quei pomeriggi e mi incuriosì più che la sua estraneità, il fatto che camminasse tanto. Avanti e indietro. Cercando e non trovando. Fu lui ad avvicinarsi al nostro appostamento, davanti alla farmacia, lungo via Chiesanuova. Sorrise e salutò ma non si fermò. Ricordo che pensai, con compassione È matto. Qualche giorno dopo mi trovavo da solo a percorrere con la mia vecchia bici la statale, e quando vidi quell uomo a cavalcioni di un muretto, pensai di dover cambiare strada. Ero abbastanza lontano da poterlo fare senza che nessuno scambiasse il mutamento di rotta con la paura. Ma sono sempre stato pericolosamente curioso, in fatto di persone strane, diverse. Credo di aver deciso che quell avvicinamento fosse inevitabile. A pochi metri, proprio quando immaginavo che troppo preso dai suoi pensieri non avrebbe alzato la testa in tempo per vedermi passare, lo fece e di nuovo salutò. Ricambiai il saluto. Non so perché ma mi fermai. Mi chiese dove abitavo, della mia famiglia e, ricordo ancora chiaramente, di mio padre. Volle sapere il suo lavoro, se era un bravo padre, se andavamo d accordo Poi io, 184
188 spudoratamente come solo un ragazzino e la sua incoscienza possono fare, gli domandai chi fosse e perché camminasse tutti i pomeriggi avanti e indietro per le nostre strade. Non credo di avere mai usato il termine nostro ma certamente, dalle mie parole, gli doveva essere suonato proprio così. Ricordo che per la prima volta un adulto si stava scusando con tono mortificato con me e ricordo anche quello sguardo che, per descrivere, non ho mai trovato un solo aggettivo. Triste, impaurito, sospettoso, cattivo; da soli non significano abbastanza e comunque, non tutto ciò di cui avrei bisogno per raccontarlo davvero. Mi disse che cercava un lavoro, probabilmente mi riproposi ingenuamente di aiutarlo a trovargliene uno, e poi mi disse, con il tono della confidenza all amico, che era dell oasi indicando prudentemente con un dito oltre la caserma. Più indietro, i miei amici parlottavano tra loro in attesa che li raggiungessi. Quel pomeriggio, io lo ricordo bene. Ricordo volentieri alcune emozioni sconosciute provocate credo più che per la novità che quell incontro rappresentava, per la complessità di sentimenti che avevo provato ascoltando le parole di quell uomo dall accento così strano, la sua maglia pulita ma con il collo usurato dalla barba, le scarpe da tennis nuovissime e i pantaloni che scuciti di lato, scoprivano qualche centimetro di gamba bianca come il latte e quel tono mai implorante ma che così tanto mi aveva costretto poi, una volta a casa, a chiedere a mia madre se conoscesse qualcuno che dava del lavoro. A 15 anni del resto, cos altro avrei potuto fare per aiutare quell uomo? Il ricordo di un uomo che cercava di costruirsi una nuova vita Lo incontrai e parlammo ancora. Sembrava fossimo diventati amici. In uno dei nostri brevi ma intensi incontri mi confidò che era stato in carcere perché aveva ucciso la moglie. Mi mostrò anche una cicatrice sul petto. Una cicatrice da lama. Era stato il suo modo disperato di trovare riparo dal rimorso e dal mondo. Perché l unica cosa che aveva voluto, in quell attimo di disperazione, era andarsene e per sempre. Mi disse senza severità di rigare dritto, di fare il bravo. Poi, da un certo giorno in poi, e per sempre, non lo vidi più. Quando mia madre mi chiese nuovamente del perché tutto quell interessamento per un datore di lavoro, così evidentemente inadeguato per la mia età, raccontai di quell incontro e di quell uomo. Ricordo che volle sapere bene ogni cosa ma non si dimostrò mai allarmata. Mi fece promettere di avvisarla in caso lo avessi rivisto. Quando però le raccontai di quella vita, di quel poco ma così tanto che mi era stato confidato, ricordo di aver condiviso con lei alcune emozioni, a cui non saprei dare oggi un nome o un colore per descriverle, ma che immagino possano somigliare alla compassione. Lei mi spiegò che quando uno ha pagato non per forza è un uomo migliore, ma comunque ha pagato. Rispetto alla società dovrebbe partire da zero, senza favori ma senza svantaggi. Per questo sperava, come lo speravo io, che quell uomo trovasse lavoro e casa. Anzi, mi tranquillizzò, disse che il fatto che fosse scomparso senza nemmeno un saluto era certamente la prova che le cose per lui erano cambiate e certamente in meglio. Solo più tardi negli anni, dovendo scegliere un ente in cui spendere gli allora venti mesi di servizio sostitutivo civile, chiesi un colloquio e in quell occasione ne parlai con padre Gerardo, il padre mercedario responsabile all OASI, la Casa di accoglienza che spesso ospita detenuti ed ex detenuti. Non lo ricordava e comunque non avevo abbastanza elementi per risalire a lui. 185
189 Mi sono chiesto moltissime volte che fine abbia fatto e ancora oggi mi piace immaginare sia riuscito a vivere il resto della sua vita con accanto delle persone amiche, qualcuno a cui dare e da cui ricevere quell affetto che da solo, mi è stato insegnato, può dare senso a un intera esistenza. Mi sono anche domandato se lui si è mai ricordato di me, di quel tipetto dalle tante domande ma sempre silenzioso quando lui parlava di sé, raccontando la sua storia e il suo dolore. Un messaggio prezioso per tutti è che la Legalità è un valore insopprimibile Quando la collega mi ha chiesto se ero disponibile ad accompagnare una classe a incontrare i volontari di una associazione, impegnata nel carcere, e alcuni detenuti, ho trovato irrinunciabile risponderle sì. Oggi, il progetto Educazione alla Legalità nella scuola dove presto servizio come docente, ha una storia di diversi anni, molti incontri a scuola e altrettanti in carcere, presso la redazione di Ristretti Orizzonti. Le classi coinvolte nel progetto sono la quasi totalità anche se quest anno ( ) proprio per il peso che l organizzazione comporta, si è deciso di dare la precedenza alle seconde e alle quinte, classi terminali. Nel tempo la collaborazione con Ornella Favero, coordinatrice di Ristretti Orizzonti e i volontari e detenuti che collaborano al progetto, si è rivelata fondamentale per promuovere alcuni valori fondamentali, altrimenti destinati al massimo a brevi commenti da cineforum sul tema del Carcere e della Legalità. Ogni anno, organizzati in una media di tre incontri per classe, i nostri allievi si confrontano con tematiche e riflessioni partendo dalla scrittura libera e spontanea di ognuno di loro, su cosa sanno o pensano di sapere del carcere, delle pene, della giustizia; scrittura grazie alla quale scaturiscono la cattiva informazione dei mass media e i pregiudizi di una sottocultura spesso superficiale che, come conseguenza, ha quella di esporre proprio i più giovani al rischio di commettere qualcosa che li porterà a doversi confrontare con il carcere o comunque con la giustizia. Moltissimi, infatti, sono convinti che le pene siano brevi, quando non inesistenti; che la maggior parte delle volte nessuno paghi per i reati che ha commesso. Troppi ancora, anche tra gli adulti, credono poi che il detenuto sia un predestinato, con il carcere scritto nel proprio DNA. Fondamentale poi è la comprensione che il detenuto non è il reato che ha commesso. È una persona che ha commesso uno o più errori, legalmente e moralmente stigmatizzabili ma che comunque resta una persona. È un occasione che personalmente trovo ogni volta perfetta perché si possa parlare, ai tanti ragazzi e ragazze che accettano di partecipare, mossi da quella sana curiosità che ricordo molto bene, di valori altrimenti poco facilmente trasmissibili, considerati poi i tempi, gli esempi e la stessa informazione che spingono ad una lettura della realtà spesso superficiale e assai povera di contenuti autentici quando non illegali anch essi. I tre incontri sono pensati quali tappe di un percorso in cui ogni aspetto essenziale del problema trova uno spazio suo: i detenuti, in classe ad incontrare i ragazzi, per rispondere alle loro tante domande, raccontando così il vissuto, da dentro ; gli agenti, che con le loro problematiche e testimonianze rappresentano una faccia del problema carcere altrimenti conosciuto in modo parziale, incompleto; il magistrato di Sorveglianza che porta con la sua testimonianza quei contenuti di legalità e normative che comple- 186
190 tano e danno senso compiuto alle tematiche affrontate negli incontri precedenti. Quella della visita in carcere, presso la redazione di Ristretti Orizzonti, rappresenta solitamente la tappa fondamentale per mezzo della quale consolidare, nel vissuto e nella memoria di ognuno (studenti, docenti e detenuti) le emozioni, le testimonianze, le tante voci e storie che coralmente vogliono, in fondo, comunicare alcune cose fondamentali quali il bisogno di non essere confusi o peggio identificati con il proprio delitto, ma riconosciuti come esseri umani con un messaggio prezioso da dare a tutti, e cioè che quello della Legalità è un valore insopprimibile, perché è il presupposto affinché se ne garantiscano altri quali la Libertà e la Convivenza Civile, obiettivo che ogni cittadino dovrebbe perseguire. Anche grazie alla scuola che permette esperienze simili. 187
191 È FONDAMENTALE EDUCARE ALLA POSSIBILITÀ E NON AL GIUDIZIO A PRIORI Attraverso questo progetto i ragazzi sentono la necessità di avvicinarsi con consapevolezza alla conoscenza dei concetti di diritto, dovere, legalità di Incoronata Pergola, insegnante di Lettere, Scuola media M. Buonarroti di Sarmeola di Rubano Ho cominciato questo percorso con i ragazzi di una classe terza che ho seguito soltanto a partire dal loro ultimo anno. Considerando l età più adulta degli allievi e avendo riscontrato un gruppo non ancora molto omogeneo, sono partita dalla risorsa dell eterogeneità, e il mio obiettivo primario è stato quello di creare tra loro la forza della collaborazione e della solidarietà, pur rispettando e facendo risaltare le numerose personalità presenti. Ho voluto dedicare molta attenzione all educazione alla salute intesa come: educazione all affettività, alla sessualità, all armoniosità del movimento del corpo, all espressione e alla comunicazione nelle sue svariate forme. A tal proposito importantissima è stata la partecipazione della classe ai numerosi progetti offerti dalla scuola ma, in particolar modo, a quello riguardante il carcere. Questa esperienza ha unito i ragazzi e li ha visti tutti impegnati, in prima persona, loro e le loro famiglie, di fronte ai problemi della legalità, della necessità della norma e della pena, ma anche della solidarietà, dell attenzione verso il diverso, della scoperta di mondi nuovi, di persone nuove, dell attenzione verso la parte positiva, o attiva e capace di costruire e verso quella che, al contrario, sa distruggere, sa nascondere, essa stessa presente in ciascuno di noi. Tutto ciò è servito per superare alcune barriere che erano presenti tra loro, favorendo la relazione, il confronto, il dibattito e la conoscenza e portando ad un amalgamarsi del gruppo, che è andato sempre più assumendo la caratteristica della compattezza. Per quanto mi riguarda è stato un lavoro difficile, faticoso e nuovo, da cui però ho avuto risposte aperte e talvolta anche libere da condizionamenti. Questo progetto ha dato un valore nuovo al mio pensiero di educatore e, nello specifico, d insegnante di lettere, fondato sulla radicale certezza che l educare i ragazzi alla possibilità e non al giudizio a priori è fondamentale per dar spazio a menti aperte, disponibili a conoscere mondi nuovi o sconosciuti, esperienze eterogenee nel loro essere, persone che non avrebbero mai pensato d incontrare, di conoscere, di stimare ed apprezzare e, talvolta, da prendere ad esempio anche se in alcuni momenti della loro vita non si sono proposti come esempi positivi. 188
192 È importante pensare di far emergere nei nostri ragazzi la peculiarità della plasticità del loro pensiero e del loro modo di essere, permettendo in tal modo, alle varie tonalità della luce offerteci dalla nostra esistenza, di renderli protagonisti e generando in loro riflessioni, sentimenti, emozioni profonde e personali tali da opporsi all apatia, all accidia e alla staticità, così diffuse in questi tempi, dove la conoscenza e la cultura sono viste come una minaccia all obbligo di seguire solo alcuni modi di essere. In tal senso i ragazzi accettano anche le sanzioni, i vincoli, le limitazioni intesi come strumenti per garantire, in seguito, la loro identità e quella altrui. In tal senso i ragazzi sentono la necessità di avvicinarsi con consapevolezza alla conoscenza dei concetti di diritto, dovere, legalità, dipendenza, rispetto, libertà, identità, persona, autonomia, solidarietà e tradizione. In tal senso diventano loro stessi promotori di comportamenti rivolti al confronto inter-personale, inter-religioso, inter-etnico, inter-culturale. Penso che la valenza di questo progetto sia di ampio respiro e porti vantaggi a tutti i soggetti che lo compongono, dalla scuola alle famiglie ai detenuti e all istituzione carcere, intesa non soltanto come luogo di sanzione, ma anche come realtà in cui si può coltivare la possibilità di iniziare un nuovo percorso, un nuovo modo di essere, un luogo della possibilità. 189
193 IMPARARE A COMBATTERE L ABITUDINE AL MALE È anche questo un insegnamento di un progetto, che nella nostra scuola ha coinvolto insegnanti, studenti, genitori di Ombretta Fittà, insegnante di Lettere, Scuola media M. Buonarroti di Rubano Dicembre È questa la data che ha segnato l inizio dell incontro con il carcere Due Palazzi di Padova. Ho usato di proposito il verbo segnare perché mi sembra sia quello che meglio può rendere il senso di un esperienza che anziché dirsi conclusa, si è invece ampliata e confermata nelle sue finalità ultime, lasciando in tutti coloro che, a vario titolo e in tempi differenti, ne sono stati coinvolti ragazzi, genitori, insegnanti un impronta difficilmente cancellabile, perché appartiene a quelle che cambiano dentro, nell intimo dei pensieri e delle visioni del mondo o dei mondi, quelli altri, quelli che talvolta riteniamo di conoscere anche se pensiamo non ci appartengano. Ma andiamo con ordine. Quel giorno di dicembre, per la prima volta nella storia dell istituto nel quale insegno, due detenuti, accompagnati da due volontarie, varcavano la soglia della scuola, per darsi in pasto ad un gruppo di adolescenti timorosi certo, ma anche curiosi e desiderosi di soddisfare tutte le loro domande, che erano comprensibilmente numerose. Non sono in grado di raccontare lo svolgersi di quelle due ore, anche perché la distanza temporale ne ha sfumato e in alcuni momenti anche cancellato il ricordo; quello che ho vivo nella mente e soprattutto nell anima è il mutamento di clima verificatosi nel corso dell incontro. Se all inizio serpeggiava un ovvia curiosità mescolata ad un malcelato nervosismo - chi verrà a parlarci? Non sarà certo qualcuno con pesanti reati sulle spalle!? - man mano che Nicola e Graziano parlavano, si avvertiva un calo di diffidenza, e il timore lasciava il posto ad un partecipato interesse. Quando poi Graziano ha toccato il punto più difficile del suo racconto, allora il respiro si è fermato, gli occhi di 23 ragazzi si sono dilatati nello stupore immediatamente velato di commosso rispetto per il dolore di un uomo che metteva a nudo una parte del suo sentire, cercando di non ferire le fragili anime che aveva davanti, ma senza neppure nascondere o minimizzare il peso di un azione che ti cambia, per sempre, e con te cambia quelli che ti sono rimasti accanto. Al termine delle due ore, mentre Graziano e Nicola, in piedi, sembravano quasi impacciati e certo erano molto provati per il tanto dato, i ragazzi li hanno letteralmente contornati, avvolgendoli in un certo senso in uno scomposto cerchio, accalcandosi per stringere loro la mano. E l hanno fatto con la spontaneità e l immediatezza che talvolta gli adulti trattengono, dimostrando che ora loro li avevano visti per ciò che erano: due persone, costrette a pagare per quanto compiuto, ma pur sempre due persone. La conferma di ciò se ne avessi avuto bisogno l ho avuta nei giorni seguenti, quando a più riprese abbiamo commentato ciò che Graziano e Nicola ci avevano comunicato, ricordando frasi, passaggi di quella lunga chiacchierata, cercando di fermare emozioni e 190
194 sentimenti; alcuni alunni si erano connessi con il sito di Ristretti ed avevano letto le pagine scritte da alcuni detenuti, dei quali riportavano storie o affermazioni che li avevano particolarmente colpiti. Poi la domanda: prof, andiamo al Due Palazzi, vero, a trovare anche gli altri? E qui devo ammettere che mi trovai a trattenere il respiro, prima di dare una risposta piuttosto vaga: vedremo In realtà non sapevo fino a che punto una visita al carcere sarebbe stata utile a tutti e non piuttosto troppo forte almeno per alcuni, che ritenevo molto sensibili; del resto ero certa che per altri ragazzi sarebbe stata assolutamente necessaria. Poi sono entrati in gioco anche i genitori A questo punto sono entrati in gioco i genitori che, fino ad allora, avevano seguito un po da lontano lo svolgimento del progetto. Alla proposta di visitare la redazione di Ristretti all interno del carcere, un certo numero di loro si è dimostrato interessato e così con una decina circa di genitori ho varcato una volta in più i cancelli del Due Palazzi. Inutile dire che è stata un esperienza unica: non so chi fosse più agitato ed emozionato, se noi o i detenuti, schierati al nostro cospetto; il ghiaccio è stato rotto in pochi minuti e, come era avvenuto per i ragazzi, anche in questo caso l atmosfera si è fatta via via meno tesa, lasciando il posto ad una umana partecipazione che si esprimeva in domande formulate con cautela, cercando di scegliere i termini per non ferire i sentimenti. All uscita nessuno aveva voglia di parlare; si sono percorsi in silenzio i pochi passi fino alle auto, dove una volta giunti, ho avuto calorose strette di mano insieme a una serie di ringraziamenti per l opportunità avuta di vivere un esperienza che stava facendo maturare in molti un opinione differente sul carcere. Tutti erano d accordo, comunque, che per i ragazzi fosse importante visitare i detenuti al Due Palazzi e parlare con loro così com era avvenuto per i genitori. Rinfrancata dall esito dell incontro, ho preparato con la classe il secondo grande momento, come lo chiamavano loro. I ragazzi questa volta non avevano domande da rivolgere, né particolari aspettative, se non quella di conoscere alcune persone detenute, delle quali avevo avuto modo di parlare, spiegando loro, per quanto era in mio potere, la dolorosa condizione in cui vivevano. Neppure in questo caso posso raccontare lo svolgersi dell incontro, posso però riassumere quello che tutti noi abbiamo imparato da questo progetto: 1. il confine tra legalità ed illegalità è estremamente labile e basta davvero poco per oltrepassarlo; 2. bisogna imparare a combattere l abitudine al male, inteso nelle sue più varie forme, come ci ha spiegato così bene Marco, il detenuto-ingegnere della redazione. Alla domanda di un alunna: Ti sei accorto quando stavi passando il confine tra bene e male?, Marco ha risposto che accade come a scuola: non si ha la percezione di rischiare la bocciatura durante l anno, perché anche se prendi un brutto voto oggi, domani poi andrà meglio, perciò hai la sensazione di farcela, di essere ancora in grado di gestire la tua vita. In realtà stai ABITUANDOTI ad un comportamento che, se pure lentamente ed in modo ingannevole, ti trascina verso il basso. Poi arriva giugno e Per i ragazzi è stato un discorso illuminante! 191
195 3. non bisogna avere, verso il carcere, una mentalità da discarica (i cattivi dentro e che si arrangino: hanno commesso il male, che stiano lì, in quale condizione non importa): questo modo di pensare accresce i problemi, non li risolve; 4. i detenuti tutti, indipendentemente dal reato commesso, sono persone e come tali hanno diritto al lavoro, alla salute, all affettività, aspetti che non in tutte le carceri, anzi davvero in poche, sono rispettati; 5. i detenuti tutti sono persone ed hanno bisogno di essere ascoltati e seguiti, per smettere di sentirsi una calamità. Dicembre 2008 e primi mesi del 2009: il progetto continua, con un altra classe, di un anno più giovane, per iniziare un dialogo che vorremmo durasse più tempo. Il carcere può diventare la provvida sventura di manzoniana memoria solo se tutti ci impegneremo a realizzare qualcosa di concreto e allora credo saranno tanti quelli che, come il ladrone sulla croce, ritorneranno a sentirsi parte dell umanità. 192
196 INSEGNARE IN CARCERE I miei studenti detenuti che hanno imparato l italiano dalla strada di Daniela Lucchesi, insegnante di Lettere nella Casa di reclusione di Padova La mia esperienza come insegnante delle medie in carcere è cominciata l anno scorso, quindi si tratta di un esperienza ancora immatura. Quando ho scelto d insegnare nella struttura carceraria non immaginavo che la realtà nella quale mi sarei trovata ad operare fosse così complessa e anche difficile da gestire, per svariati motivi. Immaginavo che insegnare a studenti adulti fosse, per certi aspetti, più facile, in quanto gli adulti sono più consapevoli dei ragazzi del valore dello studio e i detenuti scelgono liberamente di frequentare la scuola. Inoltre, nel corso della vita, le persone adulte hanno accumulato e maturato conoscenze e competenze di diverso genere che permettono loro di approfondire e riflettere su determinati argomenti, quindi immaginavo che il mio insegnamento sarebbe stato stimolante e si sarebbe basato più sul confronto e lo scambio di idee piuttosto che sull apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di abilità. Certo non ignoravo che l utenza carceraria è formata per lo più da studenti stranieri per i quali le difficoltà linguistiche costituiscono un grosso problema, ma questo non mi spaventava in quanto, nella mia carriera d insegnante, avevo già avuto modo di misurarmi con l insegnamento dell italiano come lingua seconda. Poi è cominciata l avventura vera ed è stata molto più difficile e complessa di quanto mi aspettassi. I detenuti che scelgono di frequentare la scuola media in carcere, per la maggior parte, sono adulti con una scolarità pregressa assai limitata e con delle competenze della lingua italiana molto scarse, in quanto hanno imparato la lingua dalla strada. Ammiro molto i miei studenti per aver appreso una lingua così diversa per struttura, lessico e sistema grafico dalla loro lingua madre (molti di loro sono arabi) in modo spontaneo, senza essere andati a scuola. Alcuni detenuti s iscrivono a scuola anche per passare il tempo e solo pochi sono davvero consapevoli di quanto importante sia studiare e sviluppare la mente, anche se devo ammettere che questo genere di consapevolezza, poco presente all inizio, viene maturata durante il percorso di studi. Una persona adulta che ha frequentato poco la scuola da giovane e che non è abituata a leggere e a riflettere sulla realtà che la circonda, non ha l elasticità e la duttilità di un ragazzo e fa fatica ad apprendere cose nuove e ad esprimere in maniera compiuta il proprio pensiero. Se, a ciò, aggiungiamo le notevoli difficoltà linguistiche, la situazione si complica molto e rende il lavoro di un insegnante estremamente complesso ma, certamente, anche stimolante. 193
197 Le classi in carcere solitamente non sono molto numerose ma sono estremamente eterogenee per composizione; infatti, nello stesso gruppo vi sono studenti provenienti da paesi diversi insieme a studenti italiani, i livelli di competenze linguistiche così come i percorsi di scolarizzazione pregressa di ciascun discente sono molteplici ed è arduo trovare una linea didattica che possa accomunare studenti con esigenze didattiche così diverse. Le sfide che la scuola deve affrontare in una struttura come quella penitenziaria Molti detenuti hanno avuto un percorso scolastico difficile nel loro passato, alcuni hanno abbandonato la scuola presto per problemi personali o familiari o per una scarsa attitudine allo studio e anche ora, che la scelta di frequentare la scuola è spontanea, tendono a riportare al presente la negatività della loro esperienza pregressa, in forma di pregiudizi nei confronti del metodo e dei contenuti delle proposte didattiche e, non di rado, nei confronti degli insegnanti stessi. Si nota spesso una certa resistenza alla scuola che l insegnante deve essere in grado di comprendere e gestire per trasformarla. Inoltre, un fattore molto importante in carcere è anche il tono dell umore dei detenuti, e anche questo incide sulla disponibilità e le capacità di apprendimento ed elaborazione intellettuale. Le persone detenute infatti vengono a scuola con la testa zeppa di pensieri che riguardano la loro difficile vita in carcere, di preoccupazioni per la lettera dei loro cari che non hanno ancora ricevuto, per la visita del medico che hanno richiesto da tempo e che si fa attendere ancora, per il colloquio con l educatrice o con l avvocato, per la data del processo che si avvicina e spesso dimostrano poco interesse per gli argomenti proposti in classe. La programmazione dei contenuti, per esempio, deve essere elastica e non può seguire pedissequamente le proposte ministeriali, ma si deve conformare alle esigenze di quei particolari utenti che sono gli adulti stranieri detenuti. Credo che la prima cosa fondamentale che un insegnante si debba chiedere sia: quali sono i bisogni degli studenti che si trova di fronte? Su quali specifiche motivazioni può fare leva per stimolare i propri studenti? Quali sono gli obiettivi che il suo insegnamento deve perseguire, qual è il ruolo della scuola in carcere e in che modo può soddisfare le esigenze dei detenuti senza però sconfinare e ricoprire altri ruoli che non le competono? Le risposte a questi quesiti non sono immediate. Personalmente, dopo un anno d insegnamento, non credo di avere compreso totalmente la realtà carceraria e sto ancora sperimentando proposte e metodologie didattiche diverse. È importante, comunque, che un insegnante tenga conto di alcune peculiarità che caratterizzano gli adulti in formazione: gli adulti apprendono a partire dalla loro esperienza e il loro vissuto di formazione è fondamentale e condiziona anche apprendimenti successivi; l adulto straniero va riconosciuto e apprezzato nella sua peculiare identità culturale; gli adulti non sono bambini o adolescenti da indirizzare, ai quali si devono insegnare elementari norme comportamentali, e devono essere trattati dall insegnante come persone capaci di gestirsi autonomamente, sebbene spesso alcuni detenuti (molti di loro sono comunque molto giovani) abbiano ancora bisogno di essere 194
198 gentilmente, ma fermamente guidati nell acquisizione di alcune norme comportamentali di convivenza civile che non hanno ancora appreso nel corso della loro vita; è opportuno rendere partecipi i discenti nella programmazione di metodi, contenuti e obiettivi delle varie proposte didattiche; è necessario comprendere e, successivamente, mettere in discussione gli atteggiamenti di difesa e resistenza nei confronti sia del sistema carcere che della scuola. Sono molteplici le sfide e le problematiche che la scuola deve affrontare in una struttura come quella penitenziaria ma, qualora riesca a superare, a trasformare le difficoltà, costituisce certamente una grande opportunità di crescita per i detenuti e un prezioso strumento a servizio della missione rieducativa propria del carcere. In conclusione la scuola dovrebbe offrire ai propri utenti: maggiori competenze linguistiche per formulare ed esprimere il proprio pensiero sviluppo di capacità analitiche e riflessive per una comprensione migliore della realtà; incremento di conoscenze tecniche e scientifiche; opportunità per ripensare e narrare la propria storia; capacità di rielaborazione di sé e della propria esperienza; maggiore consapevolezza di sé e rafforzamento del sentimento d identità personale; nuova definizione di sé (non più solo negativa e ancorata al passato, ma aperta ai desideri e alla dimensione progettuale del futuro). 195
199 196
200 Capitolo 8 IL PUNTO DI VISTA DEI GENITORI È importante che questo progetto resti saldamente in mano ai ragazzi, che cioè siano loro a insegnare finalmente qualcosa ai loro genitori, che probabilmente un progetto scolastico che porta a conoscere direttamente il carcere non l hanno mai neppure pensato. Ma è importante anche che i genitori siano informati, consultati, chiamati a ragionare insieme su un percorso di conoscenza delle pene e del carcere, che per ora riguarda soprattutto i loro figli, ma che è destinato a coinvolgere anche loro, sia attraverso i racconti dei ragazzi, sia attraverso una loro partecipazione diretta al progetto, come è già avvenuto per alcuni gruppi di genitori, che hanno chiesto di fare l esperienza di un incontro in carcere con la redazione di Ristretti Orizzonti. 197
201 198
202 UN PROGETTO NEL QUALE POSSONO ESSERE I RAGAZZI STESSI A COINVOLGERE I LORO GENITORI Gli insegnanti scrivono ai genitori per spiegare il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere Gentili Signori, siamo le docenti di Italiano e Storia delle classi che quest anno hanno proposto ai ragazzi un attività di ricerca e approfondimento, che ha consentito loro di analizzare i problemi della legalità e della devianza: a partire dal valore della giustizia e dalla conoscenza del sistema giudiziario per arrivare a scoprire che cosa succede a chi viola le regole della convivenza. Questa attività di studio e documentazione rientra nel progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere, progetto coordinato dalla rivista dal carcere Ristretti Orizzonti e patrocinato dal Comune di Padova, dal Centro di Servizio per il Volontariato e dalla Casa di reclusione Due Palazzi di Padova, cui hanno aderito numerose scuole medie superiori e inferiori della città, tra cui la nostra scuola: l obiettivo è far affrontare agli studenti una realtà assai diversa dalla loro, per far loro conoscere l organizzazione di un carcere e discutere della sua funzione rieducativa. L attività ha previsto, oltre allo studio ed alla documentazione su questi problemi, la produzione di testi scritti da parte dei ragazzi ed un incontro in classe con detenuti e volontari. Riteniamo che sarebbe molto positiva la vostra partecipazione a questa attività, che potrebbe realizzarsi attraverso una visita al carcere di Padova, in cui sarebbe possibile incontrare il gruppo di detenuti e volontari (associazione Granello di senape) che lavorano alla rivista Ristretti Orizzonti. Se siete interessati, siete pregati di comunicarcelo al più presto Cordiali saluti Ai genitori dei ragazzi e delle ragazze della classe Un esempio di lettera inviata da una insegnante ai genitori dei suoi studenti per spiegare il progetto. insegnante di.. 199
203 QUANDO I GENITORI ACCETTANO DI FARSI INSEGNARE QUALCOSA DAI LORO FIGLI Le impressioni dei genitori della 4 a SD dell Istituto professionale Leonardo da Vinci sul progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere La propria cosiddetta normalità può sparire in un attimo Buongiorno, io sono Marzia, mamma di una studentessa, che mi ha raccontato di un incontro a scuola con detenuti e di stupirsi di trovarsi di fronte persone assolutamente normali, senza nessun elemento che denoti la qualità di assassino, ladro o quant altro. Allora ci si chiede che cos è la norma, che cos è la differenza. Evidentemente non esiste, esiste solo quello che si è conosciuto, se un individuo dalla nascita conosce solo abbandono, violenza, fame, non potrà mai sapere cos è affetto, protezione, quindi si comporterà di conseguenza. Non si può dare ciò che non si ha. Tutti noi sappiamo dare giudizi quando ci sono fatti di cronaca particolarmente efferati, ma pochi cercano di entrare a fondo nel cuore degli altri, altrimenti scopriremmo cose che ci fanno più paura dell efferatezza del fatto stesso. Per quanto riguarda la rieducazione, la storia ci dovrebbe insegnare che la punizione fine a se stessa non è mai servita a nulla se non ad acuire la violenza di chi commette un reato. Nei paesi dove vige la pena di morte i reati non sono minori né meno feroci. Io penso che molti si sentano migliori degli altri, a volte si potrebbe pensare un po di più, si potrebbe pensare che la propria cosiddetta normalità può sparire in un attimo, si può perdere il lavoro, l amore, una persona cara e passare dall altra parte, dalla parte del non ritorno, ma io spero che un ritorno ci possa essere per tutti. Ciao. PS : La violenza non è sterile, genera altra violenza. Marzia Penso siano esperienze irripetibili e molto arricchenti Ritengo molto positiva l esperienza vissuta in questo periodo all interno della scuola dagli alunni, in quanto penso siano esperienze irripetibili e molto arricchenti, soprattutto dal punto di vista della crescita e della maturazione personale dei ragazzi. A questa età, entrare in contatto diretto con persone che hanno vissuto o stanno vivendo l esperienza del disagio e della sofferenza e si impegnano al massimo delle proprie possibilità per uscirne, porta ad una visione più completa della propria esperienza analizzata da punti di vista diversi da quelli fino ad ora considerati. Credo siano esperienze che andrebbero vissute in tutte le scuole superiori a prescindere dal loro orientamento. Michela 200
204 È stato molto positivo lo scambio di informazioni tra noi e nostra figlia Nostra figlia ci ha parlato della presenza in classe, il giorno 19 novembre, di alcune persone che hanno relazionato sulla loro esperienza di reclusione vissuta recentemente e che ora godono di particolari forme di sconto della pena. Sono al corrente di alcune norme giudiziarie anche perché il mio lavoro, in un certo senso, mi ha introdotto nell ambiente giudiziario (sono istruttore di Polizia locale). Da poco ho anche concluso un esperienza di Giudice Popolare in un processo svoltosi in Corte d Assise a Venezia. Reputo importante che vi sia la conoscenza di queste esperienze che toccano i più importanti valori dell esperienza umana, se non il più importante: la libertà. È stato molto positivo lo scambio di informazioni tra noi genitori e nostra figlia perché questo permette lo scambio di esperienze e l approfondimento dei valori umani. Piergiulio Sono stata in pensiero per mia figlia Mia figlia mi ha raccontato dell incontro con tre carcerati, mi è sembrato abbia raccontato attentamente quello che hanno detto ed è stata interessata al colloquio. Sia io che lei abbiamo saputo cose di cui non eravamo a conoscenza, per esempio che hanno un fornelletto da campeggio per prepararsi qualcosa da mangiare, oppure che si devono lavare la biancheria o che le persone accusate di pedofilia vengono tenute separate dagli altri altrimenti potrebbero essere in pericolo. ono stata in pensiero per mia figlia perché veniva a conoscenza di una realtà molto dura e cruda, ma sia io che mia figlia abbiamo capito che il carcere può aiutare veramente qualche persona a migliorare. Katya È fondamentale che un ragazzo faccia scoprire cose nuove ad un genitore Oggi mia figlia è tornata a casa da scuola e mi ha raccontato che c è stato un incontro con dei carcerati e delle persone che collaborano con loro nelle attività. Definirei questo incontro altamente educativo nella formazione della propria maturità perché si è evidenziata una realtà che si conosceva ben poco. L impressione che ho percepito dal racconto di mia figlia è stato negativo, in parte, perché penso che queste persone non devono uscire dal carcere fino al termine della pena anche se, da quello che mi ha spiegato, la loro libertà è dovuta ad un graduale inserimento nella società. Le informazioni ricevute sono state discusse e argomentate da diversi punti di vista; alla fine ho tratto la conclusione che sia possibile e allo stesso tempo fondamentale che un ragazzo faccia scoprire cose nuove ad un genitore. Tutto ciò crea un rafforzamento nel rapporto tra figlio e genitore. Raffaella 201
205 Un approccio con la realtà carceraria non è facile, per i nostri pregiudizi La realtà carceraria viene spesso vissuta come qualcosa di esterno alla nostra società e al nostro vivere. Se si scava in fondo a tale realtà ci si può accorgere che ci riguarda molto più da vicino di quello che si pensa. Proviamo a vedere se all interno del nostro parentato, facendosi aiutare magari dai propri genitori, vi siano persone che abbiano avuto problemi con la giustizia. Oppure guardiamo i nostri vicini. Nei palazzoni della nostra zona si sa di certo, poiché le situazioni sono state riportate sui giornali locali, che abita una coppia arrestata perché trovata con un chilo di eroina; un altro signore alcolizzato più volte arrestato perché picchiava la madre anziana; un ragazzo minorenne tenuto alcuni mesi in galera per alcuni semi di marijuana che aveva in casa; ecc. Periodicamente sul quotidiano Il Mattino di Padova vi è una rubrica curata dall associazione Ristretti Orizzonti, che riporta lettere di detenuti e detenute che trattano i loro problemi di reclusi e le relative problematiche: scuola, affetti, sogni, lavoro, affollamento, situazione igienica. Spesso può essere molto più semplice di quanto si pensi finire in prigione e aggiungersi ai circa detenuti che vi sono nelle carceri italiane, poiché il confine tra legalità ed illegalità è molto ristretto (anche per un parcheggio si commettono omicidi). In ogni caso esistono delle regole previste dalle leggi, migliorabili quanto si vuole, ma se non vengono rispettate ognuno deve risponderne e pagare il proprio debito. In certe realtà e periodi storici la carcerazione è stata utilizzata anche per neutralizzare l opposizione ai regimi a scapito dei singoli oppositori. Un esempio importante è riferito ad un intellettuale politico rinchiuso e fatto morire in carcere durante il regime fascista in Italia, Antonio Gramsci, importante per i suoi scritti e studi riportati nei Quaderni dal carcere. Il carcere è sempre stato una istituzione presente, soprattutto nella storia moderna. Gli studenti impegnati in corsi per Operatori sociali, dovrebbero avvicinarsi in linea generale a tali problematiche, soprattutto per quel che riguarda le possibilità di recupero dei detenuti, almeno di quelli che si possono recuperare. L esigenza di conoscenza di tale mondo non esclude la possibilità di un futuro approccio professionale in tale settore, poiché riguarda varie figure professionali (avvocati assistenti sociali personale amministrativo guardie carcerarie) e associazioni di volontariato. Si potrebbe anche pensare a dei gruppi di lavoro su alcuni argomenti specifici riferiti al carcere di Padova, per esempio quanti detenuti usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge Gozzini, quanti hanno usufruito dell ultimo indulto e quanti sono rientrati in carcere, oppure formulare un questionario da far compilare, se possibile, ad alcuni detenuti (età titolo di studio periodo di detenzione provenienza reato commesso problemi di vitto e alloggio servizi igienici attività lavorativa che svolge o vorrebbe svolgere all interno della struttura ). Iniziare un approccio con la dura realtà carceraria non è facile, soprattutto per i nostri pregiudizi culturali. In ogni caso non si può far finta di non vedere poiché si tratta, pur se hanno sbagliato e commesso violenza, di esseri umani con le loro storie di vita e speranze, rinchiusi dietro le sbarre di una prigione. Buon lavoro! Angelo 202
206 RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA, LE PENE, LA FUNZIONE DEL CARCERE In qualche scuola gli insegnanti hanno pensato di proporre le stesse tracce di riflessione sulla giustizia, sulle pene, sul carcere agli studenti e anche ai loro genitori. Proponiamo alcune risposte dei genitori della scuola media di Ospedaletto, perché ci sembra interessante capire il punto di vista degli adulti su questi temi, e affrontare anche con loro una discussione che superi gli stereotipi e i luoghi comuni spesso diffusi dai mezzi di informazione. a cura dei genitori dei ragazzi della Scuola media di Ospedaletto Prima traccia: Oggi si parla molto di sicurezza. Ci sono situazioni nelle quali vi sentite insicuri? Cosa pensate sarebbe utile per rendere la vostra città più sicura e vivibile? Papà: No, non ci sono situazioni in cui mi sento insicuro. Mamma: Sì, mi sento insicura quando sono a casa da sola o quando esco di sera. Papà e mamma: Per rendere più sicura e vivibile la nostra città ci vorrebbero le leggi più severe come negli altri Stati. Redi D. e Donato M. Più che situazioni, il nostro disagio si evidenzia soprattutto quando ci troviamo in determinati luoghi: stazioni ferroviarie, giardini pubblici che in certe ore della giornata sono frequentati da persone poco raccomandabili. Pensiamo che una presenza più assidua delle forze dell ordine, magari in borghese, possa dare ai cittadini più sicurezza e tranquillità. i genitori di Elisabetta P. Oggi il problema della sicurezza anche nei nostri piccoli paesi esiste e non ci sono situazioni particolari che mi preoccupano, ma è un po tutto l ambiente in cui viviamo che mi preoccupa. Per rendere la mia città più vivibile e sicura penso che il problema vada molto a monte e penso che le cose da fare sarebbero più di una. Ad esempio non condivido il via vai di extracomunitari che entrano e che escono dal nostro paese come vogliono. Caterina S. Credo che oggi ci sia poco da stare sicuri, la tv ci trasmette quotidianamente notizie di scippi, violenze, gente che viene ammazzata per 20 euro. Credo che questo incremento di criminalità sia il risultato dell affluenza di immigrazione. Barbara F. 203
207 Quando si parla del tema della sicurezza gli animi si scaldano sempre, fortunatamente nella nostra cittadina di Ospedaletto la situazione è ancora accettabile, ci sono sporadici furti e di altri crimini del tipo violenze, stupri, pedofilia, per quel che ci riguarda non ne abbiamo sentito parlare, anche se comunque ai nostri figli facciamo sempre mille raccomandazioni sugli estranei e anche sui conoscenti. Alessandra G., mamma di Elia Ci sentiamo abbastanza sicuri nel nostro paese anche perché è ancora a misura d uomo rispetto alle grandi città. Diciamo comunque abbastanza perché purtroppo le notizie che leggiamo sui giornali e ascoltiamo alla televisione condizionano in modo negativo i nostri comportamenti quotidiani, io ad esempio come donna se devo tornare la sera dal lavoro cerco di parcheggiare la macchina vicino alla farmacia perché ho un po di paura a camminare da sola, cosa che prima non mi succedeva. Come genitori ci rendiamo conto di queste nostre emozioni e ne parliamo con le nostre due figlie facendo loro delle raccomandazioni ma senza terrorizzarle, perché crediamo sia giusto che vivano la loro adolescenza nel modo più sereno possibile. Quindi se dobbiamo lasciare loro un po di libertà cerchiamo di indirizzarle in un ambiente dove possono frequentare compagni della loro età, e dove ci sia comunque la presenza dei genitori o animatori come ad esempio il patronato. Gabriella G. Seconda traccia: Che idea avete del carcere, di chi ci finisce dentro e dei motivi che spingono a commettere reati? Il carcere è buono per il fatto che mantiene le persone che commettono reati fuori dalla società, quindi ci dà una sorta di protezione, ma credo non vada assolutamente a migliorare le persone che ci finiscono dentro. Penso che le persone che commettono reati non si possano giudicare con molta facilità poiché si deve sempre scavare nella vita delle persone, vedere se si tratta di qualche problema a livello psichico, possono esserci persone che commettono reati perché non sono mai cresciute con dei valori o con una educazione adeguata. Ci sono persone veramente disperate che per potersi mantenere si mettono a fare le attività più illecite come rubare o spacciare la droga, per loro stare rinchiuse in una gabbia con persone instabili sicuramente non è formativo. Riccardo e Michela L. Il carcere è un luogo opportuno per scontare le pene in quanto priva l individuo della sua libertà, che è uno dei più importanti valori dell uomo. Chi ci finisce dentro è gente che vive di esperienze sbagliate probabilmente perché spinta da un disagio sociale. Viviana D. e Stefano F. 204
208 Secondo noi il carcere assorbe solo il compito di reclusione dei detenuti e non quello di riabilitazione degli stessi. Sono persone che non hanno trovato un ruolo ben preciso all interno della società e della propria famiglia, e la strada della delinquenza è diventata l unica via del riscatto. i genitori di Elisabetta P. La mia idea del carcere è che quello italiano purtroppo non è abbastanza severo come in altri Paesi e che i motivi che spingono certe persone a commettere dei reati sono svariati. Vanno dalla disoccupazione, alla mafia, alla droga e come dicevo prima alla troppa libertà di entrare e uscire dall Italia specialmente per i paesi dell Est. Caterina S. So che queste risposte scatenano molte polemiche ma non mi interessa: sono contraria al carcere, credo che di fronte alla commissione di un delitto l unica soluzione sia la pena di morte. Non ci si può svegliare una mattina, rapire un bimbo innocente e poi ucciderlo per pochi soldi. Non può esserci perdono di fronte a tanta barbarie, assolutamente no. È facile essere buonisti quando non si è toccati nei propri interessi. Credo se capitasse a una di queste persone che gli venisse ucciso un figlio o un parente non la penserebbe ancora così. Barbara F. Il carcere dovrebbe essere un luogo dove una persona sconta una pena ma anche dove dovrebbe capire il grande errore che ha commesso, per non doverlo ripetere più, quindi soprattutto un luogo di recupero, in particolare nei riguardi di ragazzi giovani. Mio marito, ad esempio, conosce per motivi di lavoro i titolari di una cooperativa di Padova che opera nel sociale e si occupa dell inserimento nel mondo del lavoro di detenuti del carcere Due Palazzi. Per quanto riguarda i motivi che spingono a commettere reati sono sicuramente il bisogno di denaro, la droga o la mafia. Gabriella G. Terza traccia: Che idea vi siete fatti della Giustizia nel nostro paese? Come pensate che dovrebbero essere le pene? Il problema della giustizia nel nostro Paese è, secondo noi, una delle priorità da affrontare perché i tempi lunghissimi con cui vengono affrontati i processi non sembrano assicurare una giusta pena, che dovrebbe essere, secondo noi, molto più severa di quelle attuali, soprattutto nei casi in cui si ha la certezza del reato commesso. i genitori di Elisabetta P. 205
209 Non esiste secondo me una vera giustizia specialmente dove ci sono politica, soldi, conoscenze, poteri Andrea F., padre di Maila Deludente al massimo: la legge in Italia è come un elastico, la si tira dove, e quando si vuole a secondo delle interpretazioni di giudici incapaci e poco professionali. Veronica e Romeo F. La giustizia è lacunosa, le pene dovrebbero essere certe, severe e chi sta in carcere sicuramente ha fatto del male. È giusto garantire i diritti civili anche a chi sconta una condanna ma non la deve scontare di certo in albergo. Leonida S. Circa la severità delle pene nel nostro Paese penso che dovrebbero essere più dure, in modo che le persone prima di commettere dei reati, sapendo che ci sono veramente pene severe, ci penserebbero due volte. Caterina S. La giustizia come tante altre cose nel nostro Paese non funziona, non si può arrestare qualcuno e poi per scadenza dei termini di custodia cautelare si rilascia senza processo, libero di rifare ciò che ha fatto. Le pene dovrebbero essere più severe soprattutto per alcuni reati, io adotterei alcune leggi che vengono praticate nei Paesi arabi, forse ci sarebbero le carceri meno affollate e non si dovrebbe adottare letteralmente il motto La legge è uguale per tutti. Alessandra G., mamma di Elia Penso che la giustizia nel nostro Paese sia facilmente manovrabile da forti poteri economici e politici, inoltre sono contraria ai processi trasformati in spettacolo dalla televisione e dai mass media. Vorrei dire il contrario ma purtroppo non ho molta fiducia. I processi dovrebbero avere tempi più brevi e le pene dovrebbero essere giuste e proporzionate al fatto. Gabriella Garbin 206
210 Quarta traccia: Come pensate che reagireste, se sapeste che un vostro amico ha dei comportamenti illegali? Cercherei di aiutarlo con le mie conoscenze e poi se qualcosa per lui non cambia denuncerei il fatto alle persone competenti. Riccardo e Michela L. Penserei che ho sbagliato amici. Veronica e Romeo F. Per il suo bene proviamo prima a parlargli, in caso non capisca la gravità ricorreremmo ad altre decisioni. Redi D. e Donato M. Rimarremmo sicuramente delusi dal suo comportamento, e amareggiati dal fatto di non essere stati per lui degli amici veri su cui poteva contare per risolvere i suoi problemi. Comunque la nostra amicizia si dimostrerebbe nell aiutarlo e consigliarlo a ritornare ad avere comportamenti corretti. i genitori di Elisabetta P. Non so come reagirei se venissi a sapere che un mio amico ha compiuto un reato. Sono del parere che in certe situazioni bisognerebbe trovarsi per poter decidere, però così a freddo potrei dire che mi rivolgerei alle forze dell ordine. Caterina S. Se avessi un amico che commette atti illegali? Probabilmente prima parlerei con questo mio amico per capire perché fa così, poi, avvisandolo che andrei a denunciarlo, andrei dal comando di polizia più vicino e farei la denuncia. Alessandra G., mamma di Elia Ho sempre cercato di aiutare, di consigliare, anche col rischio di creare problemi in famiglia, però non sono stata sempre ascoltata. Maria Irina P. 207
211 Se sapessi che un mio amico ha dei comportamenti illegali, cercherei in tutti i modi di aiutarlo, ma se persevera ad un certo punto mi metto da parte. Viviana D. e Stefano F. Se scoprissi che un mio amico ha degli atteggiamenti illegali cercherei di fargli cambiare idea e di aiutarlo. Claudio Z. Se un mio amico avesse comportamenti illegali lo segnalerei alle forze dell ordine, sicuramente il vincolo d amicizia non mi tratterrebbe minimamente. Sono per le cose giuste e legali e ho già denunciato amici e parenti per comportamenti illegali. Barbara F. All inizio reagiremmo male, ma poi proprio perché si tratta di una persona che ha bisogno di aiuto cercheremmo di capire i motivi che lo hanno spinto a questo comportamento. Gabriella G. Quinta traccia: Di che cosa sentireste di più la mancanza se foste voi a essere privati della libertà? Della libertà con me stesso, mi mancherebbe la libertà di realizzare la mia vita. Riccardo e Michela L. Di tutto, sicuramente è una sensazione devastante soprattutto per le persone oneste. Leonida S. Se fossi io ad essere privata della mia libertà penso che la cosa che mi mancherebbe di più sono gli affetti a me cari e i miei famigliari. Caterina S. Se io dovessi finire in carcere, la cosa di cui sentirei di più la mancanza sarebbe la mia famiglia, di non poter abbracciare i miei figli quando ne ho voglia. Poi sicuramente dei miei rari momenti di pace solo con me stessa e non per ultima né meno importante la libertà, la libertà di andare e venire come voglio, la libertà di mangiare, dormire, leggere e molte altre cose quando voglio io. Alessandra G., mamma di Elia 208
SE SBAGLI TI CANCELLO
 Ristretti Orizzonti Ristretti Orizzonti SE SBAGLI TI CANCELLO Ogni volta che leggiamo le riflessioni degli studenti su questo percorso di avvicinamento tra scuole e carcere, restiamo sbalorditi dalla capacità
Ristretti Orizzonti Ristretti Orizzonti SE SBAGLI TI CANCELLO Ogni volta che leggiamo le riflessioni degli studenti su questo percorso di avvicinamento tra scuole e carcere, restiamo sbalorditi dalla capacità
G idee per coinvolgere le famiglie. Iniziativa realizzata col contributo del Comune di Padova
 Quello che si può trovare dentro a Parole in libertà tra carcere e scuole: G i materiali di base per iniziare il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere e dar modo agli insegnanti,
Quello che si può trovare dentro a Parole in libertà tra carcere e scuole: G i materiali di base per iniziare il progetto Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere e dar modo agli insegnanti,
LA PENA RACCONTATA AI RAGAZZI
 Ristretti Orizzonti Ristretti Orizzonti LA PENA RACCONTATA AI RAGAZZI Di solito, per spiegare gli obiettivi di un progetto, si usano parole spesso noiose o descrizioni con tanti termini tecnici e poca
Ristretti Orizzonti Ristretti Orizzonti LA PENA RACCONTATA AI RAGAZZI Di solito, per spiegare gli obiettivi di un progetto, si usano parole spesso noiose o descrizioni con tanti termini tecnici e poca
Argomentazione A braccia aperte S. Ferrari. Alice
 Argomentazione A braccia aperte S. Ferrari Alice Stefano Ferrari ha preparato un documentario che s intitola A braccia aperte pubblicato nel 2009 che parla di un ragazzo, Christian che è alla ricerca di
Argomentazione A braccia aperte S. Ferrari Alice Stefano Ferrari ha preparato un documentario che s intitola A braccia aperte pubblicato nel 2009 che parla di un ragazzo, Christian che è alla ricerca di
SPEZZARE LA CATENA DEL MALE. Esiste un modo per riparare quello strappo profondo prodotto da chi ha commesso un reato?
 SPEZZARE LA CATENA DEL MALE Esiste un modo per riparare quello strappo profondo prodotto da chi ha commesso un reato? Progetto editoriale ed editing di Ornella Favero, in collaborazione con Francesco Morelli,
SPEZZARE LA CATENA DEL MALE Esiste un modo per riparare quello strappo profondo prodotto da chi ha commesso un reato? Progetto editoriale ed editing di Ornella Favero, in collaborazione con Francesco Morelli,
La maschera del cuore
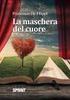 La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere. Ma non è uno zoo
 Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere. Ma non è uno zoo La prof ci ha raccomandato di osservare tutto tutto tutto quando entravamo in carcere. E io ho osservato tutto tutto tutto. A osservare
Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere. Ma non è uno zoo La prof ci ha raccomandato di osservare tutto tutto tutto quando entravamo in carcere. E io ho osservato tutto tutto tutto. A osservare
La vita dell uomo ha senso? 13/09/1991 Molte persone non si pongono il problema del senso dell esistenza umana, alcuni per scelta personale, altri
 La vita dell uomo ha senso? 13/09/1991 Molte persone non si pongono il problema del senso dell esistenza umana, alcuni per scelta personale, altri per indifferenza o per immaturità. Eppure il problema
La vita dell uomo ha senso? 13/09/1991 Molte persone non si pongono il problema del senso dell esistenza umana, alcuni per scelta personale, altri per indifferenza o per immaturità. Eppure il problema
5. A pranzo bevo sempre un bicchiere di vino. Ieri un bicchiere di vino. 6. Oggi puoi andare al cinema. Ieri sera.. al cinema.
 PASSATO PROSSIMO 1. Franca arriva domani alle 6.00. Franca ieri. 2. Il treno per Napoli arriva in ritardo. Ieri il treno per Napoli.. in ritardo. 3. Lavori fino a tardi? Ieri fino a tardi? 4. Marco e Maria
PASSATO PROSSIMO 1. Franca arriva domani alle 6.00. Franca ieri. 2. Il treno per Napoli arriva in ritardo. Ieri il treno per Napoli.. in ritardo. 3. Lavori fino a tardi? Ieri fino a tardi? 4. Marco e Maria
La vibrante testimonianza di Salvatore Borsellino: Paolo aveva solo un super potere: l amore
 Il fratello di Paolo Borsellino incontra gli studenti del Volta 1 La vibrante testimonianza di Salvatore Borsellino: Paolo aveva solo un super potere: l amore Per combattere la mafia bisogna iniziare dai
Il fratello di Paolo Borsellino incontra gli studenti del Volta 1 La vibrante testimonianza di Salvatore Borsellino: Paolo aveva solo un super potere: l amore Per combattere la mafia bisogna iniziare dai
CATTIVI E BUONI RAGAZZI
 CATTIVI E BUONI RAGAZZI Sommario Il progetto dell associazione Granello di senape e di Ristretti Orizzonti pag. 8 - Progetto Il carcere entra a scuola, la scuola entra in carcere Scegliersi il proprio
CATTIVI E BUONI RAGAZZI Sommario Il progetto dell associazione Granello di senape e di Ristretti Orizzonti pag. 8 - Progetto Il carcere entra a scuola, la scuola entra in carcere Scegliersi il proprio
dott. Sara La Malfa Psicologa Psicoterapeuta Liceo Leonardo e 21 aprile 2016
 dott. Sara La Malfa Psicologa Psicoterapeuta sara.lamalfa@unicatt.it Liceo Leonardo - 1 14 e 21 aprile 2016 Perché il liceo ti prepara all Università e da grande mi piacerebbe fare un lavoro stabile dove
dott. Sara La Malfa Psicologa Psicoterapeuta sara.lamalfa@unicatt.it Liceo Leonardo - 1 14 e 21 aprile 2016 Perché il liceo ti prepara all Università e da grande mi piacerebbe fare un lavoro stabile dove
IL VANGELO CONCRETAMENTE. dalla penna dei partecipanti
 IL VANGELO CONCRETAMENTE dalla penna dei partecipanti Un esperienza significativa vissuta in questi giorni Mi ha colpito l'attività sul vangelo a quattro colori... aiuta molto a capirlo anche se può essere
IL VANGELO CONCRETAMENTE dalla penna dei partecipanti Un esperienza significativa vissuta in questi giorni Mi ha colpito l'attività sul vangelo a quattro colori... aiuta molto a capirlo anche se può essere
L 8 marzo cosa rappresenta e a cosa mi fa pensare?
 L 8 marzo cosa rappresenta e a cosa mi fa pensare? L'8 marzo non è solo la data che indica la Festa della donna ma deve essere un momento di riflessione sulle vicende quotidiane e sullo sviluppo personale
L 8 marzo cosa rappresenta e a cosa mi fa pensare? L'8 marzo non è solo la data che indica la Festa della donna ma deve essere un momento di riflessione sulle vicende quotidiane e sullo sviluppo personale
seguici su: Edizioni Mesogea Culture Mediterranee Edizioni Mesogea
 LA PICCOLA 92 ISBN 978-88-469-2165-9 2017, MESOGEA by GEM s.r.l. via Catania 62, 98124 Messina seguici su: www.mesogea.it Edizioni Mesogea Culture Mediterranee Edizioni Mesogea Tutti i diritti sono riservati
LA PICCOLA 92 ISBN 978-88-469-2165-9 2017, MESOGEA by GEM s.r.l. via Catania 62, 98124 Messina seguici su: www.mesogea.it Edizioni Mesogea Culture Mediterranee Edizioni Mesogea Tutti i diritti sono riservati
Trascrizione del videomessaggio inviato al Congresso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti
 Trascrizione del videomessaggio inviato al Congresso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti Buongiorno a tutti, grazie per l invito che mi avete rivolto, purtroppo non riesco
Trascrizione del videomessaggio inviato al Congresso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti Buongiorno a tutti, grazie per l invito che mi avete rivolto, purtroppo non riesco
LIBO' L'ITALIANO ALLA RADIO
 LIBO' L'ITALIANO ALLA RADIO ESERCIZI PUNTATA N 2 LA FAMIGLIA A cura di Marta Alaimo Voli Società Cooperativa - 2011 LA FAMIGLIA DIALOGO PRINCIPALE A- Ciao, Alina. B- Ciao, Omar. Come stai? A- Bene, tutto
LIBO' L'ITALIANO ALLA RADIO ESERCIZI PUNTATA N 2 LA FAMIGLIA A cura di Marta Alaimo Voli Società Cooperativa - 2011 LA FAMIGLIA DIALOGO PRINCIPALE A- Ciao, Alina. B- Ciao, Omar. Come stai? A- Bene, tutto
In I A, di questo percorso, ci vogliamo tenere in mente
 In I A, di questo percorso, ci vogliamo tenere in mente la bellezza di descrivere l oggetto che ci rappresenta e scoprire cosa significa per l altro il suo oggetto. x che è stato bello! Ho capito più cose
In I A, di questo percorso, ci vogliamo tenere in mente la bellezza di descrivere l oggetto che ci rappresenta e scoprire cosa significa per l altro il suo oggetto. x che è stato bello! Ho capito più cose
I.C. «ANTONIO GRAMSCI» ALBANO LAZIALE loc. PAVONA (RM) la nonna bambina che racconta la Shoah
 I.C. «ANTONIO GRAMSCI» ALBANO LAZIALE loc. PAVONA (RM) la nonna bambina che racconta la Shoah CLASSI PRIMA e SECONDA sez. C Pavona, 13 febbraio 2018 Carissima nonna Susanne, è ormai da qualche anno, prima
I.C. «ANTONIO GRAMSCI» ALBANO LAZIALE loc. PAVONA (RM) la nonna bambina che racconta la Shoah CLASSI PRIMA e SECONDA sez. C Pavona, 13 febbraio 2018 Carissima nonna Susanne, è ormai da qualche anno, prima
per gentile concessione dell'autore
 Lettera aperta ai Giudici della Corte Costituzionale di Carmelo Musumeci per gentile concessione dell'autore "Non è consentito avere in cella più di tre libri" ( Voce dal regime di tortura del 41 bis).
Lettera aperta ai Giudici della Corte Costituzionale di Carmelo Musumeci per gentile concessione dell'autore "Non è consentito avere in cella più di tre libri" ( Voce dal regime di tortura del 41 bis).
Non ConGelateci il Sorriso quinta edizione(2012) Gli alunni commentano l esperienza vissuta
 Domanda 1. n ConGelateci il Sorriso quinta edizione(12) Gli alunni commentano l esperienza vissuta Ti è piaciuta l'attività teatrale sul tema del bullismo? 96,7% 3,3% E' stata un'esperienza interessante
Domanda 1. n ConGelateci il Sorriso quinta edizione(12) Gli alunni commentano l esperienza vissuta Ti è piaciuta l'attività teatrale sul tema del bullismo? 96,7% 3,3% E' stata un'esperienza interessante
Un solo sogno diventare mamma
 Un solo sogno diventare mamma Venera Carratello UN SOLO SOGNO DIVENTARE MAMMA racconto Ai miei Angeli che con la loro presenza, le loro monellerie e i loro baci mi aiutano ad andare avanti in questa
Un solo sogno diventare mamma Venera Carratello UN SOLO SOGNO DIVENTARE MAMMA racconto Ai miei Angeli che con la loro presenza, le loro monellerie e i loro baci mi aiutano ad andare avanti in questa
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII PIANIGA (VE) REDAZIONE DI RISTRETTI CASA DI RECLUSIONE DUE PALAZZI - PADOVA
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII PIANIGA (VE) REDAZIONE DI RISTRETTI CASA DI RECLUSIONE DUE PALAZZI - PADOVA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII PIANIGA (VE) Anno scolastico 2012/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII PIANIGA (VE) REDAZIONE DI RISTRETTI CASA DI RECLUSIONE DUE PALAZZI - PADOVA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII PIANIGA (VE) Anno scolastico 2012/2013
CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI
 CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI settembre ottobre 2018 LA MIA IMPRONTA NELLA TUA DIARIO DI BORDO (spazio per pensare oltre l incontro) di Caro partecipante, ma cos è il Diario di bordo? Questo fascicolo
CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI settembre ottobre 2018 LA MIA IMPRONTA NELLA TUA DIARIO DI BORDO (spazio per pensare oltre l incontro) di Caro partecipante, ma cos è il Diario di bordo? Questo fascicolo
(Messa vigiliare del sabato: la voce guida quando inizia la processione all altare)
 18 marzo 2012 quarta di quaresima anno B: del cieco nato ore 18.00 ore 11.30 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida quando inizia la processione all altare) Celebriamo la Messa vigiliare della quarta
18 marzo 2012 quarta di quaresima anno B: del cieco nato ore 18.00 ore 11.30 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida quando inizia la processione all altare) Celebriamo la Messa vigiliare della quarta
Le misure alternative alla detenzione
 Le misure alternative alla detenzione Autore: Concas Alessandra In: Schede di Diritto Le misure alternative alla detenzione sono dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, in ottemperanza
Le misure alternative alla detenzione Autore: Concas Alessandra In: Schede di Diritto Le misure alternative alla detenzione sono dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, in ottemperanza
Palacongressi di Rimini Dicembre 2016
 Palacongressi di Rimini 02-03 Dicembre 2016 Le avventure di Oliver testi narrativi scritti per e con i bambini Esperienze a sostegno dell inclusione scolastica Cooperativa sociale Genova Integrazione a
Palacongressi di Rimini 02-03 Dicembre 2016 Le avventure di Oliver testi narrativi scritti per e con i bambini Esperienze a sostegno dell inclusione scolastica Cooperativa sociale Genova Integrazione a
Quando Sveva si sveglia la mattina dopo trova Gabriele in
 Capitolo 4 Quando Sveva si sveglia la mattina dopo trova Gabriele in cucina. Il televisore è acceso. Al telegiornale una delle prime notizie riguarda proprio lei. La ballerina Sveva Grimaldi, 24 anni,
Capitolo 4 Quando Sveva si sveglia la mattina dopo trova Gabriele in cucina. Il televisore è acceso. Al telegiornale una delle prime notizie riguarda proprio lei. La ballerina Sveva Grimaldi, 24 anni,
EVENTI JESOLO Metodo per essere felici. Io sono una Missione. Festa dei Giovani. di Marco Gallo 1. #Perlavitadeglialtri
 EVENTI JESOLO 2019 Metodo per essere felici 10 Festa dei Giovani 03 di Marco Gallo 1 Io sono una Missione #Perlavitadeglialtri tratto dal libro Marco Gallo: Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare
EVENTI JESOLO 2019 Metodo per essere felici 10 Festa dei Giovani 03 di Marco Gallo 1 Io sono una Missione #Perlavitadeglialtri tratto dal libro Marco Gallo: Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare
Fare la nostra parte
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMOZZI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA G. ROSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Fare la nostra parte Percorso di educazione alla legalità Dalla lettura del libro di Don Luigi Ciotti La classe
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMOZZI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA G. ROSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Fare la nostra parte Percorso di educazione alla legalità Dalla lettura del libro di Don Luigi Ciotti La classe
Le regole della scuola sono molto simili alle regole della società, che sono state scritte non per dispetto ma per il nostro bene.
 Le regole della scuola sono molto simili alle regole della società, che sono state scritte non per dispetto ma per il nostro bene. Se riuscissimo a rispettare tutte le regole sia in una piccola comunità
Le regole della scuola sono molto simili alle regole della società, che sono state scritte non per dispetto ma per il nostro bene. Se riuscissimo a rispettare tutte le regole sia in una piccola comunità
L Inrca per un invecchiamento attivo IMPORTANTI SVAGO E TEMPO LIBERO. Esplorati i progetti dei lavoratori a fine carriera in tre Paesi
 L Inrca per un invecchiamento attivo IMPORTANTI SVAGO E TEMPO LIBERO Esplorati i progetti dei lavoratori a fine carriera in tre Paesi Ancona, 31 agosto 2017 Includere l attività di svago e tempo libero
L Inrca per un invecchiamento attivo IMPORTANTI SVAGO E TEMPO LIBERO Esplorati i progetti dei lavoratori a fine carriera in tre Paesi Ancona, 31 agosto 2017 Includere l attività di svago e tempo libero
Perché studiare Infermieristica?
 Perché studiare Infermieristica? Perchè mi piace il contatto umano, relazionarmi con le persone e provare empatia. Perché posso prendermi cura di persone e questo mi gratifica e mi dà molte soddisfazioni.
Perché studiare Infermieristica? Perchè mi piace il contatto umano, relazionarmi con le persone e provare empatia. Perché posso prendermi cura di persone e questo mi gratifica e mi dà molte soddisfazioni.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA ISTANZA DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E DIFFERIMENTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA ISTANZA DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E DIFFERIMENTO
PROTEGGIAMOCI IN RETE
 PROTEGGIAMOCI IN RETE Pericoli ed opportunità di internet e dei social A cura dott. Massimo Vologni MuVi - Viadana 30 Novembre 2016 Cos è internet? ALCUNE RISPOSTE DA UN SONDAGGIO NELLE SCUOLE Come accediamo
PROTEGGIAMOCI IN RETE Pericoli ed opportunità di internet e dei social A cura dott. Massimo Vologni MuVi - Viadana 30 Novembre 2016 Cos è internet? ALCUNE RISPOSTE DA UN SONDAGGIO NELLE SCUOLE Come accediamo
Allegato n. 6 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA
 Allegato n. 6 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA ISTANZA DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E
Allegato n. 6 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA ISTANZA DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E
itinerario di conoscenza dei nostri adolescenti e dei percorsi scolastici e formativi dopo la terza media
 «ORIENTA ESPRESS» itinerario di conoscenza dei nostri adolescenti e dei percorsi scolastici e formativi dopo la terza media Dott.ssa Monica Panzeri Rassegna OrientaLamente Lecco 26/09/2013 «Ogni scelta
«ORIENTA ESPRESS» itinerario di conoscenza dei nostri adolescenti e dei percorsi scolastici e formativi dopo la terza media Dott.ssa Monica Panzeri Rassegna OrientaLamente Lecco 26/09/2013 «Ogni scelta
Le norme UNI in versione facile da leggere
 Le norme UNI in versione facile da leggere Prima bozza a cura di Anffas Onlus Pag. 1 a 14 Alcune informazioni sulle norme UNI Cosa sono le norme UNI? Le norme UNI sono delle regole che dicono come fare
Le norme UNI in versione facile da leggere Prima bozza a cura di Anffas Onlus Pag. 1 a 14 Alcune informazioni sulle norme UNI Cosa sono le norme UNI? Le norme UNI sono delle regole che dicono come fare
VERSIONE ITALIANA DELLA SESM, SCALA DEGLI UTENTI PER MISURARE L EMPOWERMENT NEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE (Ettore Straticò et al.
 VERSIONE ITALIANA DELLA SESM, SCALA DEGLI UTENTI PER MISURARE L EMPOWERMENT NEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE (Ettore Straticò et al., 2007) MODULO A 1. Sigla strumento 2. Identificazione del paziente 3. Età
VERSIONE ITALIANA DELLA SESM, SCALA DEGLI UTENTI PER MISURARE L EMPOWERMENT NEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE (Ettore Straticò et al., 2007) MODULO A 1. Sigla strumento 2. Identificazione del paziente 3. Età
Casatenovo: ''la fede che salva'' dopo la perdita di un figlio. Il dr Achilli presenta il libro scritto dopo la scomparsa di Andrea
 Il primo giornale online della provincia di Lecco Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Sabato 09 novembre 2013 alle 17:46 Casatenovo: ''la fede che salva'' dopo la perdita di un figlio. Il dr
Il primo giornale online della provincia di Lecco Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Sabato 09 novembre 2013 alle 17:46 Casatenovo: ''la fede che salva'' dopo la perdita di un figlio. Il dr
GESÙ SPIEGATO A TUTTI
 JOSEPH DORÉ GESÙ SPIEGATO A TUTTI Queriniana Ouverture Questa opera si propone, né più né meno, non solo di spiegare Gesù, ma di spiegarlo a tutti! Per permettere a chi lo desidera di mettersi in cammino
JOSEPH DORÉ GESÙ SPIEGATO A TUTTI Queriniana Ouverture Questa opera si propone, né più né meno, non solo di spiegare Gesù, ma di spiegarlo a tutti! Per permettere a chi lo desidera di mettersi in cammino
GIOVANI, ATTORI DI CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE
 GIOVANI, ATTORI DI CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE RICERCA CITTADINANZA ATTIVA, PER ME, PER GLI ALTRI Progetto realizzato da e con il finanziamento di Risultati della ricerca Cittadinanza attiva, per me,
GIOVANI, ATTORI DI CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE RICERCA CITTADINANZA ATTIVA, PER ME, PER GLI ALTRI Progetto realizzato da e con il finanziamento di Risultati della ricerca Cittadinanza attiva, per me,
Figliol prodigo L incontro è iniziato leggendo la parte del racconto in cui il figlio, ormai senza più nulla, prende atto della propria situazione e
 21 Febbraio 2016 Figliol prodigo L incontro è iniziato leggendo la parte del racconto in cui il figlio, ormai senza più nulla, prende atto della propria situazione e decide di chiedere perdono al Padre.
21 Febbraio 2016 Figliol prodigo L incontro è iniziato leggendo la parte del racconto in cui il figlio, ormai senza più nulla, prende atto della propria situazione e decide di chiedere perdono al Padre.
ALLEGATOA alla Dgr n del 29 dicembre 2014 pag. 1/6
 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 2776 del 29 dicembre 2014 pag. 1/6 Progetto : Organizzazione Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 2776 del 29 dicembre 2014 pag. 1/6 Progetto : Organizzazione Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
10 Scegli la felicità con Ho oponopono
 Introduzione N el giugno 2009, dopo che tenni i miei primi corsi in Israele, Yael, il mio editore in quel Paese, venne da me e disse: «Mabel, il tuo libro Scopri Ho oponopono. La via più semplice è fantastico,
Introduzione N el giugno 2009, dopo che tenni i miei primi corsi in Israele, Yael, il mio editore in quel Paese, venne da me e disse: «Mabel, il tuo libro Scopri Ho oponopono. La via più semplice è fantastico,
Test di Livello lingua Italiana
 Test di Livello lingua Italiana NOME COGNOME... DATA... Indicare con una x la risposta corretta: 1. Piacere! Il mio nome è Anna. Come chiami, tu? # ti sei VALUTAZIONE:... DOCENTE:... 2. Io abito Pordenone.
Test di Livello lingua Italiana NOME COGNOME... DATA... Indicare con una x la risposta corretta: 1. Piacere! Il mio nome è Anna. Come chiami, tu? # ti sei VALUTAZIONE:... DOCENTE:... 2. Io abito Pordenone.
Ho paura di somigliare a mio padre con i miei figli
 Cara dottoressa mi chiamo S. ho 36 anni un marito e tre splendidi figli. le scrivo forse soprattutto per sfogarmi di alcune mie paure che con le persone che ho vicino non riesco a fare penso sempre che
Cara dottoressa mi chiamo S. ho 36 anni un marito e tre splendidi figli. le scrivo forse soprattutto per sfogarmi di alcune mie paure che con le persone che ho vicino non riesco a fare penso sempre che
La mia preparazione molto carente sufficiente discreta buona ottima
 Tirocini curricolari a. s. 21-16: relazioni dei tirocinanti ( I dati si riferiscono a 39 alunni in stage su 44) La mia preparazione 2 2 1 23 1 8 3 molto carente sufficiente discreta buona ottima Le mie
Tirocini curricolari a. s. 21-16: relazioni dei tirocinanti ( I dati si riferiscono a 39 alunni in stage su 44) La mia preparazione 2 2 1 23 1 8 3 molto carente sufficiente discreta buona ottima Le mie
Cara Susanna... Cara Susanna, mi ha colpito quello che lei ha vissuto e vorrei rispondere alle sue domande. Per me è successo questo perché certa
 Cara Susanna... mi ha colpito quello che lei ha vissuto e vorrei rispondere alle sue domande. Per me è successo questo perché certa gente non capisce che non si risolve tutto uccidendo le persone ma basterebbe
Cara Susanna... mi ha colpito quello che lei ha vissuto e vorrei rispondere alle sue domande. Per me è successo questo perché certa gente non capisce che non si risolve tutto uccidendo le persone ma basterebbe
Progetto SCUOLA di comunità
 Progetto SCUOLA di comunità Conosci Don Milani e l esperienza di Barbiana? All inizio non capivo che cosa c entrasse la scuola di Barbiana con noi, era una scuola di 50 anni fa, poi leggendo alcuni stralci
Progetto SCUOLA di comunità Conosci Don Milani e l esperienza di Barbiana? All inizio non capivo che cosa c entrasse la scuola di Barbiana con noi, era una scuola di 50 anni fa, poi leggendo alcuni stralci
La mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa
 La mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa Atonino Caponnetto ( 1920-2002) Egli è stato un magistrato italiano, noto soprattutto per aver
La mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa Atonino Caponnetto ( 1920-2002) Egli è stato un magistrato italiano, noto soprattutto per aver
Catania, parte la protesta. Le libraie di "Vicolo Stretto" indignate, rifiutano il libro di Salvo Riina
 Catania, parte la protesta. Le libraie di "Vicolo Stretto" indignate, rifiutano il libro di Salvo Riina di Agnese Maugeri - 07, Apr, 2016 http://www.siciliajournal.it/catania-le-libraie-di-vicolo-stretto/
Catania, parte la protesta. Le libraie di "Vicolo Stretto" indignate, rifiutano il libro di Salvo Riina di Agnese Maugeri - 07, Apr, 2016 http://www.siciliajournal.it/catania-le-libraie-di-vicolo-stretto/
I contenuti ed i pareri espressi nel presente libro sono da considerarsi opinioni personali dell Autore, che non possono, pertanto, impegnare l
 Morte della mente I contenuti ed i pareri espressi nel presente libro sono da considerarsi opinioni personali dell Autore, che non possono, pertanto, impegnare l Editore, mai e in alcun modo. Ogni riferimento
Morte della mente I contenuti ed i pareri espressi nel presente libro sono da considerarsi opinioni personali dell Autore, che non possono, pertanto, impegnare l Editore, mai e in alcun modo. Ogni riferimento
ha tanto da fare qui come ha avuto tanto da fare là, Perché voi lo state facendo nella vostra dimensione,
 ha tanto da fare qui come ha avuto tanto da fare là, io dirigo il traffico da qui; non sapete quanto è meraviglioso saper aiutare da qui. Perché voi lo state facendo nella vostra dimensione, dove vivo
ha tanto da fare qui come ha avuto tanto da fare là, io dirigo il traffico da qui; non sapete quanto è meraviglioso saper aiutare da qui. Perché voi lo state facendo nella vostra dimensione, dove vivo
CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI
 CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI settembre ottobre 2016 QUATTRO PASSI PER CAMBIARE INSIEME DIARIO DI BORDO (spazio per pensare oltre l incontro) di Caro partecipante, ma cos è il Diario di bordo? Questo
CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI settembre ottobre 2016 QUATTRO PASSI PER CAMBIARE INSIEME DIARIO DI BORDO (spazio per pensare oltre l incontro) di Caro partecipante, ma cos è il Diario di bordo? Questo
AMA TE STESSO PUOI GUARIRE LA TUA VITA
 AMA TE STESSO PUOI GUARIRE LA TUA VITA HEAL YOUR LIFE WORKSHOP 14/15 NOVEMBRE 2015 1 E il corso dei due giorni ideato negli anni 80 da Louise Hay per insegnare il metodo con cui lei è riuscita a guarire
AMA TE STESSO PUOI GUARIRE LA TUA VITA HEAL YOUR LIFE WORKSHOP 14/15 NOVEMBRE 2015 1 E il corso dei due giorni ideato negli anni 80 da Louise Hay per insegnare il metodo con cui lei è riuscita a guarire
PROGETTO ERASMUS Febbraio 2019
 PROGETTO ERASMUS 17-23 Febbraio 2019 Il mio viaggio in Grecia PAOLETTI MICHELE 17 Febbraio 2019 Domenica 17 Febbraio, mi sono alzato alle 04 di mattina, pieno di tanta energia e agitazione. Sinceramente
PROGETTO ERASMUS 17-23 Febbraio 2019 Il mio viaggio in Grecia PAOLETTI MICHELE 17 Febbraio 2019 Domenica 17 Febbraio, mi sono alzato alle 04 di mattina, pieno di tanta energia e agitazione. Sinceramente
Un progetto dell Istituto scolastico di Porza in collaborazione con l Assemblea dei genitori e l Ispettorato scolastico
 Un progetto dell Istituto scolastico di Porza in collaborazione con l Assemblea dei genitori e l Ispettorato scolastico Anno scolastico 2010 / 2011 Non possiamo andare avanti così! I guai a ricreazione,
Un progetto dell Istituto scolastico di Porza in collaborazione con l Assemblea dei genitori e l Ispettorato scolastico Anno scolastico 2010 / 2011 Non possiamo andare avanti così! I guai a ricreazione,
Dr.ssa Alice Corà Dr.ssa Irene Fiorini
 Dr.ssa Alice Corà Dr.ssa Irene Fiorini La perdita per me è perdere qualcosa a cui si tiene, che sia qualcosa di materiale o anche qualcosa di spirituale. Il dolore può essere suddiviso in: dolore della
Dr.ssa Alice Corà Dr.ssa Irene Fiorini La perdita per me è perdere qualcosa a cui si tiene, che sia qualcosa di materiale o anche qualcosa di spirituale. Il dolore può essere suddiviso in: dolore della
Capelletti Stefano Angelo
 Capelletti Stefano Angelo Soldato 1^ Compagnia, II Battaglione mortai da 81 nato a Covo (BG) il 29/12/1922 caduto in prigionia presso Tambov il 14/01/1943 foto e lettere concesse dalla nipote Albina Capelletti
Capelletti Stefano Angelo Soldato 1^ Compagnia, II Battaglione mortai da 81 nato a Covo (BG) il 29/12/1922 caduto in prigionia presso Tambov il 14/01/1943 foto e lettere concesse dalla nipote Albina Capelletti
MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2015
 MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2015 All alba del 21 Ottobre 2015, da Cerro al Lambro, partirono i nostri eroi con la guida di due «sergenti» qui ne vedete solo uno - alla volta del profondo Sud. DESTINAZIONE:
MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2015 All alba del 21 Ottobre 2015, da Cerro al Lambro, partirono i nostri eroi con la guida di due «sergenti» qui ne vedete solo uno - alla volta del profondo Sud. DESTINAZIONE:
IL METODO DI STUDIO. Prof.ssa Donatiello Angela
 IL METODO DI STUDIO Prof.ssa Donatiello Angela Cosa vuol dire studiare? Applicarsi metodicamente all apprendimento di qualcosa (studiare il pianoforte, studiare una lingua straniera, ) Ricercare, indagare
IL METODO DI STUDIO Prof.ssa Donatiello Angela Cosa vuol dire studiare? Applicarsi metodicamente all apprendimento di qualcosa (studiare il pianoforte, studiare una lingua straniera, ) Ricercare, indagare
Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Bob Marley
 Il ritmo La lezione inizia senza che il Maestro dica nulla. Solo una musica accompagna i suoi movimenti e i ragazzi, dopo un primo momento di esitazione, lo seguono. Il bello della musica è che quando
Il ritmo La lezione inizia senza che il Maestro dica nulla. Solo una musica accompagna i suoi movimenti e i ragazzi, dopo un primo momento di esitazione, lo seguono. Il bello della musica è che quando
Carcere & scuola: ne vale la Pena. Associazione Carcere e Territorio
 Carcere & scuola: ne vale la Pena Associazione Carcere e Territorio ONLUS Associazione di Volontariato in Brescia Via Spalto San Marco n.19, 25124 BRESCIA 1) Titolo del progetto Carcere & scuola: ne vale
Carcere & scuola: ne vale la Pena Associazione Carcere e Territorio ONLUS Associazione di Volontariato in Brescia Via Spalto San Marco n.19, 25124 BRESCIA 1) Titolo del progetto Carcere & scuola: ne vale
LA Memoria Partecipata L eccidio di Sant Anna di Stazzema analizzato dagli studenti della Versilia e dalle loro famiglie 74 anni dopo
 LA Memoria Partecipata L eccidio di Sant Anna di Stazzema analizzato dagli studenti della Versilia e dalle loro famiglie 74 anni dopo Workshop per studenti e genitori della scuola Martiri di Sant Anna
LA Memoria Partecipata L eccidio di Sant Anna di Stazzema analizzato dagli studenti della Versilia e dalle loro famiglie 74 anni dopo Workshop per studenti e genitori della scuola Martiri di Sant Anna
PROGETTO DI LEGGE N. 2055
 PROGETTO DI LEGGE N. 2055 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi
PROGETTO DI LEGGE N. 2055 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi
io vivo in una casa, per me non èuna struttura.
 Dove vivo ci sono tante case e negozi nel mio quartiere, conosco molta gente che abita e lavora intorno a me. io vivo in una casa, per me non èuna struttura. UN PO DI TEMPO FA, CON L AIUTO DELL ASSISTENTE
Dove vivo ci sono tante case e negozi nel mio quartiere, conosco molta gente che abita e lavora intorno a me. io vivo in una casa, per me non èuna struttura. UN PO DI TEMPO FA, CON L AIUTO DELL ASSISTENTE
Legge sui disabili. Spiegata in linguaggio semplice
 Legge sui disabili Spiegata in linguaggio semplice Importante Le leggi non possono essere scritte in linguaggio semplice. Le leggi hanno regole proprie. Si dice anche requisiti giuridici. Per questo motivo
Legge sui disabili Spiegata in linguaggio semplice Importante Le leggi non possono essere scritte in linguaggio semplice. Le leggi hanno regole proprie. Si dice anche requisiti giuridici. Per questo motivo
Sandra Martini AMICI. Alta Leggibilità. a cura di Alan Pona. sestante edizioni
 Sandra Martini Alta Leggibilità AMICI sestante edizioni a cura di Alan Pona Sandra Martini AMICI a SCUOLA a cura di Alan Pona sestante edizioni Un ringraziamento speciale a Chiara Manzan per aver sperimentato
Sandra Martini Alta Leggibilità AMICI sestante edizioni a cura di Alan Pona Sandra Martini AMICI a SCUOLA a cura di Alan Pona sestante edizioni Un ringraziamento speciale a Chiara Manzan per aver sperimentato
Evento finale Roma, 12 maggio 2014
 FERMO IMMAGINE - FRATELLI A CONFRONTO PERCORSI CULTURALI SULLA VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI LORO FRATELLI E SORELLE Evento finale Roma, 12 maggio 2014 Intervento di Anna, Debora e Giulia Enderle
FERMO IMMAGINE - FRATELLI A CONFRONTO PERCORSI CULTURALI SULLA VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI LORO FRATELLI E SORELLE Evento finale Roma, 12 maggio 2014 Intervento di Anna, Debora e Giulia Enderle
La narrazione di sé come finestra su sé stessi e sul mondo
 La narrazione di sé come finestra su sé stessi e sul mondo «L uomo nasce e piange. È così. Lo ha deciso madre natura. Ma io nasco e non piango. Non respiro nemmeno. Provano disperatamente a rianimarmi,
La narrazione di sé come finestra su sé stessi e sul mondo «L uomo nasce e piange. È così. Lo ha deciso madre natura. Ma io nasco e non piango. Non respiro nemmeno. Provano disperatamente a rianimarmi,
ESITI PEER EDUCATOR. Domande 1, 4, 6 e 7
 ESITI PEER EDUCATOR Domande 1, 4, 6 e 7 Ti è piaciuta ques'esperienza 1 Sì No Non so RISPOSTE N. RISPOSTE Sì 18 No 0 Non so 0 0% SINTESI Al 100% peer educator è piaciuta questa esperienza 100% MOTIVAZIONI
ESITI PEER EDUCATOR Domande 1, 4, 6 e 7 Ti è piaciuta ques'esperienza 1 Sì No Non so RISPOSTE N. RISPOSTE Sì 18 No 0 Non so 0 0% SINTESI Al 100% peer educator è piaciuta questa esperienza 100% MOTIVAZIONI
dieci anni di orientamento con adolescenti e giovani in Piemonte
 2001-2011 dieci anni di orientamento con adolescenti e giovani in Piemonte REGIONE PIEMONTE Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento professionale Nadia Cordero Torino, 2 ottobre 2012 1 Guida
2001-2011 dieci anni di orientamento con adolescenti e giovani in Piemonte REGIONE PIEMONTE Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento professionale Nadia Cordero Torino, 2 ottobre 2012 1 Guida
SEDICESIMA PUNTATA In cantiere
 SEDICESIMA PUNTATA In cantiere Personaggi principali: i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo). Personaggi secondari: Munir Ambienti: casa Fappani, esterno strada e cantiere. INTERNO CUCINA Ciao
SEDICESIMA PUNTATA In cantiere Personaggi principali: i Fappani (mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo). Personaggi secondari: Munir Ambienti: casa Fappani, esterno strada e cantiere. INTERNO CUCINA Ciao
Parte la 26esima edizione del Corso di preparazione al volontariato internazionale di Diritti al cuore onlus!
 Parte la 26esima edizione del Corso di preparazione al volontariato internazionale di Diritti al cuore onlus! Quando abbiamo iniziato a progettare un giornale di quartiere che divenisse uno spazio di condivisione,
Parte la 26esima edizione del Corso di preparazione al volontariato internazionale di Diritti al cuore onlus! Quando abbiamo iniziato a progettare un giornale di quartiere che divenisse uno spazio di condivisione,
PARTECIPA ALLA EUROPE CODE WEEK OTTOBRE 2016
 LA 2D PARTECIPA ALLA EUROPE CODE WEEK 10-18 OTTOBRE 2016 L ATTIVITÀ In occasione della Europe Code Week i bambini della 2D hanno lavorato sul coding. Siamo partiti da qui: Immagina di incontrare un marziano
LA 2D PARTECIPA ALLA EUROPE CODE WEEK 10-18 OTTOBRE 2016 L ATTIVITÀ In occasione della Europe Code Week i bambini della 2D hanno lavorato sul coding. Siamo partiti da qui: Immagina di incontrare un marziano
L Affidamento in prova ai servizi sociali
 L Affidamento in prova ai servizi sociali Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Le cronache giornalistiche spesso parlano di affidamento in prova ai servizi sociali, vediamo di seguito
L Affidamento in prova ai servizi sociali Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Le cronache giornalistiche spesso parlano di affidamento in prova ai servizi sociali, vediamo di seguito
OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA
 OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA Cooperativa Sociale P.I.D. Pronto Intervento Disagio O.N.L.U.S. - Roma www.pid.coop La cooperativa
OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA Cooperativa Sociale P.I.D. Pronto Intervento Disagio O.N.L.U.S. - Roma www.pid.coop La cooperativa
Parole ed immagini in Libertà
 Parole ed immagini in Libertà Thomas Russo PAROLE ED IMMAGINI IN LIBERTÀ www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Thomas Russo Tutti i diritti riservati A Stefania che mi accompagna da oltre 10 anni. Ai
Parole ed immagini in Libertà Thomas Russo PAROLE ED IMMAGINI IN LIBERTÀ www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Thomas Russo Tutti i diritti riservati A Stefania che mi accompagna da oltre 10 anni. Ai
Leggete tutte e cinque le domande di un gruppo e quindi rispondete a ciascuna delle domande.
 ISTRUZIONI Il seguente questionario pone delle domande riguardo ai vostri sentimenti rispetto alla vostra vita e voi stessi da quando avete sviluppato il disturbo. Alcune domande riguardano momenti in
ISTRUZIONI Il seguente questionario pone delle domande riguardo ai vostri sentimenti rispetto alla vostra vita e voi stessi da quando avete sviluppato il disturbo. Alcune domande riguardano momenti in
COSA VORRESTI CHE IL/LA TUO/A EX PARTNER TI SCRIVESSE DI BELLO? LE VOSTRE RISPOSTE
 COSA VORRESTI CHE IL/LA TUO/A EX PARTNER TI SCRIVESSE DI BELLO? LE VOSTRE RISPOSTE DIMMI QUALCOSA DI BELLO ( Qualcosa è cambiato, di James L. Brooks, 1997) 2 DIMMI QUALCOSA DI BELLO COSA VORRESTI CHE IL/LA
COSA VORRESTI CHE IL/LA TUO/A EX PARTNER TI SCRIVESSE DI BELLO? LE VOSTRE RISPOSTE DIMMI QUALCOSA DI BELLO ( Qualcosa è cambiato, di James L. Brooks, 1997) 2 DIMMI QUALCOSA DI BELLO COSA VORRESTI CHE IL/LA
Il 29 marzo scorso si è concluso nella casa circondariale di S. Vittore a Milano il
 PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON IL MONDO CARCERARIO Il 29 marzo scorso si è concluso nella casa circondariale di S. Vittore a Milano il progetto Educare alla legalità attraverso
PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON IL MONDO CARCERARIO Il 29 marzo scorso si è concluso nella casa circondariale di S. Vittore a Milano il progetto Educare alla legalità attraverso
INTELLIGENZA EMOTIVA IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELLO SVILUPPO
 INTELLIGENZA EMOTIVA IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELLO SVILUPPO Perché occuparsi di educazione emotiva? In adolescenza e nella vita adulta EMOZIONI: sostanze stupefacenti naturali le uniche in grado di proteggere
INTELLIGENZA EMOTIVA IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELLO SVILUPPO Perché occuparsi di educazione emotiva? In adolescenza e nella vita adulta EMOZIONI: sostanze stupefacenti naturali le uniche in grado di proteggere
2 Ascolta tutta la conversazione e verifica le risposte al punto 1.
 1 Ascolta e rispondi alle domande. 12 1. Chi sono le persone che parlano? a. Madre e figlio. b. Fratello e sorella. c. Marito e moglie. 2. Qual è l argomento della conversazione? a. Lasciare la vecchia
1 Ascolta e rispondi alle domande. 12 1. Chi sono le persone che parlano? a. Madre e figlio. b. Fratello e sorella. c. Marito e moglie. 2. Qual è l argomento della conversazione? a. Lasciare la vecchia
Episodio #002: I certificati di lingua
 Episodio #002: I certificati di lingua Ciao a tutti! Io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach, e sono qui per aiutarvi a imparare a parlare l italiano. Benvenuti al secondo episodio del mio podcast.
Episodio #002: I certificati di lingua Ciao a tutti! Io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach, e sono qui per aiutarvi a imparare a parlare l italiano. Benvenuti al secondo episodio del mio podcast.
Jani, Jani, Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. la storia di Malala Yousafzai. la storia di Malala Yousafzai
 Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo Jani, Jani, la storia di Malala Yousafzai la storia di Malala Yousafzai Erika.Lerma Erika.Lerma Jani, la storia di Malala Yousafzai
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo Jani, Jani, la storia di Malala Yousafzai la storia di Malala Yousafzai Erika.Lerma Erika.Lerma Jani, la storia di Malala Yousafzai
Concita De Gregorio: "Sognavo di diventare come Oriana Fallaci"
 Concita De Gregorio: "Sognavo di diventare come Oriana Fallaci" di Elisa Guccione - 31, ago, 2015 http://www.siciliajournal.it/concita-de-gregorio-sognavo-di-diventare-come-oriana-fallaci/ 1 / 5 2 / 5
Concita De Gregorio: "Sognavo di diventare come Oriana Fallaci" di Elisa Guccione - 31, ago, 2015 http://www.siciliajournal.it/concita-de-gregorio-sognavo-di-diventare-come-oriana-fallaci/ 1 / 5 2 / 5
LEONI ANTONIO Brisighella, 3 gennaio 1986.
 LEONI ANTONIO Brisighella, 3 gennaio 1986. [Inizio dell'intervista nel lato A della cassetta n 47 al giro 001] D: Brisighella 3 gennaio 1986, ore 15 e un quarto. Dunque cognome, nome R: Leoni Antonio.
LEONI ANTONIO Brisighella, 3 gennaio 1986. [Inizio dell'intervista nel lato A della cassetta n 47 al giro 001] D: Brisighella 3 gennaio 1986, ore 15 e un quarto. Dunque cognome, nome R: Leoni Antonio.
Palazzo del Quirinale, 15 giugno Sintesi
 Intervento del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro all Incontro con una Delegazione di partecipanti all VIII Assemblea Nazionale dell Associazione Italiana Donatori organi Palazzo del Quirinale,
Intervento del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro all Incontro con una Delegazione di partecipanti all VIII Assemblea Nazionale dell Associazione Italiana Donatori organi Palazzo del Quirinale,
Matteo Torluccio IPIA Alberghetti 4 A TL
 Matteo Torluccio IPIA Alberghetti 4 A TL REPORT N 2 La tua strategia personale per entrare nel mondo del lavoro. Quando finirò la scuola media superiore avrò in mano un diploma di tecnico delle industrie
Matteo Torluccio IPIA Alberghetti 4 A TL REPORT N 2 La tua strategia personale per entrare nel mondo del lavoro. Quando finirò la scuola media superiore avrò in mano un diploma di tecnico delle industrie
CITTA DI VARAZZE VALUTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO Alessia Ballerini Coordinamento progetto Marco Maggi
 CITTA DI VARAZZE PROGETTO RETI DI SICUREZZA Contro la violenza e per la legalità VALUTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2008-2009 Redatto da Alessia Ballerini Coordinamento progetto Marco
CITTA DI VARAZZE PROGETTO RETI DI SICUREZZA Contro la violenza e per la legalità VALUTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2008-2009 Redatto da Alessia Ballerini Coordinamento progetto Marco
INCONTRARSI Ascoltare, essere Vicini, Accompagnare Lettera aperta ai giovani. Ama e fa ciò che vuoi (S. Agostino)
 INCONTRARSI Ascoltare, essere Vicini, Accompagnare Lettera aperta ai giovani Ama e fa ciò che vuoi (S. Agostino) Carissimo Amico, mi permetto di chiamarti così, anche se forse non ci conosciamo o ci siamo
INCONTRARSI Ascoltare, essere Vicini, Accompagnare Lettera aperta ai giovani Ama e fa ciò che vuoi (S. Agostino) Carissimo Amico, mi permetto di chiamarti così, anche se forse non ci conosciamo o ci siamo
Ricerca sul reinserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti a Padova
 Ricerca sul reinserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti a Padova Questionario per i detenuti ed ex detenuti Intervista n I. Dati anagrafici - Sesso: M F - Età: - Regione di origine (se italiano)
Ricerca sul reinserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti a Padova Questionario per i detenuti ed ex detenuti Intervista n I. Dati anagrafici - Sesso: M F - Età: - Regione di origine (se italiano)
Conquista la donna dei tuoi sogni anche se non hai mai osato corteggiare nessuno prima d ora!
 Conquista la donna dei tuoi sogni anche se non hai mai osato corteggiare nessuno prima d ora! Grazie per aver richiesto l'introduzione di questo manuale, spero che lo troverai interessante Al tuo successo
Conquista la donna dei tuoi sogni anche se non hai mai osato corteggiare nessuno prima d ora! Grazie per aver richiesto l'introduzione di questo manuale, spero che lo troverai interessante Al tuo successo
di PIERDOMENICO CORTE RUGGIERO
 di PIERDOMENICO CORTE RUGGIERO 1 / 7 Un padre entra nella stanza dove stanno dormendo il figlio e la figlia. Dormono sereni, non hanno nulla da temere. Il figlio si è laureato da pochi mesi, già lavora.
di PIERDOMENICO CORTE RUGGIERO 1 / 7 Un padre entra nella stanza dove stanno dormendo il figlio e la figlia. Dormono sereni, non hanno nulla da temere. Il figlio si è laureato da pochi mesi, già lavora.
DAL 11 al 17 GENNAIO 2014
 DAL 11 al 17 GENNAIO 2014 Acquario L amore potrebbe tornare nella vostra vita anche in modo abbastanza prepotente ed addirittura una nuova persona potrebbe interessarvi. Cercate di non reprimere le vostre
DAL 11 al 17 GENNAIO 2014 Acquario L amore potrebbe tornare nella vostra vita anche in modo abbastanza prepotente ed addirittura una nuova persona potrebbe interessarvi. Cercate di non reprimere le vostre
Questo è possibile seguendo due fasi ben distinte:
 CONGRATULAZIONI! Se stai leggendo questo manuale è perché stai cercando qualcosa in più, perché sei una persona con la mente aperta, hai voglia di guardare oltre e di crescere come persona ed economicamente
CONGRATULAZIONI! Se stai leggendo questo manuale è perché stai cercando qualcosa in più, perché sei una persona con la mente aperta, hai voglia di guardare oltre e di crescere come persona ed economicamente
Immagino che la Michela di 10 anni fa, indecisa sul il percorso universitario da scegliere, intervisti la Michela di oggi.
 Immagino che la Michela di 10 anni fa, indecisa sul il percorso universitario da scegliere, intervisti la Michela di oggi. Michela: Come mai hai scelto Ingegneria Ambiente e Territorio? L. Michela: Ero
Immagino che la Michela di 10 anni fa, indecisa sul il percorso universitario da scegliere, intervisti la Michela di oggi. Michela: Come mai hai scelto Ingegneria Ambiente e Territorio? L. Michela: Ero
27 novembre 2013 LABORATORIO DI ECOSOFIA le aspettative
 Avvertenze: 1. i testi, prodotti dagli studenti e dalle studentesse, sono stati integralmente trascritti, senza variazioni se non per le correzioni di sviste ortografiche. 2. La SCEDA A riproduce le riflessioni
Avvertenze: 1. i testi, prodotti dagli studenti e dalle studentesse, sono stati integralmente trascritti, senza variazioni se non per le correzioni di sviste ortografiche. 2. La SCEDA A riproduce le riflessioni
