modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 229 del 15/02/2013 e con deliberazione della Giunta provinciale n.
|
|
|
- Raimonda Valentino
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 229 del 15/02/2013 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 41 del 18/1/2019 Num. prog. 8 di 46
2 Linee guida per la formazione del Fascicolo integrato di acquedotto - Vers. 2.0 Num. prog. 9 di 46
3 Linee guida per la formazione del Fascicolo integrato di acquedotto - Vers. 2.0 Num. prog. 10 di 46
4 Linee guida per la formazione del Fascicolo integrato di acquedotto - Vers. 2.0 Num. prog. 11 di 46
5 Le presenti Linee Guida ed il relativo Glossario, sono quelle da ultimo modificate nel 2018 con la deliberazione della Giunta Provinciale evidenziata in copertina. A chi sono rivolte le presenti Linee Guida: Enti locali titolari del servizio pubblico di acquedotto Enti locali capofila delle opere di acquedotto intercomunali Cosa è richiesto: È richiesta la predisposizione del FIA, composto da tre sezioni: Libretto di acquedotto (LIA) Piano di autocontrollo delle acque destinate al consumo umano (PAC) Piano di adeguamento dell utilizzazione alle disposizioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e del Piano di Tutela delle acque, in materia di rinnovi di utilizzazioni esistenti (PAU) Alla predisposizione del FIA provvede un tecnico abilitato (tecnico comunale referente del servizio di acquedotto o professionista esterno incaricato dal Comune titolare del servizio, di seguito denominato Incaricato FIA ), sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall Ente titolare e dalle strutture provinciali competenti nonché tramite l acquisizione degli elementi conoscitivi necessari mediante l effettuazione di indagini e rilievi. Nel caso di acquedotti intercomunali il responsabile per la predisposizione del FIA è il Comune capofila, in caso di gestione su base convenzionale, oppure l Unione dei Comuni, la Comunità o il territorio se a questi ultimi è stata attribuita la titolarità del servizio. Le tre sezioni sono precedute da un preambolo denominato Generalità FIA contenente alcune informazioni trasversali alle sezioni stesse. Termini: i termini per la predisposizione, perfezionamento e approvazione del FIA sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva le Linee guida. Glossario: in appendice è riportato il glossario delle principali definizioni utilizzate nel presente documento; con il simbolo ( ) accanto ad un termine scritto in corsivo, è segnalata la presenza di una definizione riportata nel glossario. titolo a derivare( ) ( ) titolare( ) utilizzazione idrica( ) uso potabile( ) ambito di utenza ( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 5 Num. prog. 12 di 46
6 titolare ( ) titolare( ) utilizzazione idrica( ) gestore( ) Approvazione di direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 servizio pubblico di acquedotto ( ) ambito di utenza( ) titolari( ) utilizzazioni idriche( ) titolo a derivare( ) titolari ( ) acquedotto ( ) acquedotti ( ) ambito di utenza ( ) funzionalità della rete alimentata( ) titolare( ) ambito di utenza ( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 6 Num. prog. 13 di 46
7 A prescindere dal tipo di supporto utilizzato, risulta essenziale che per ogni elaborato sia univocamente individuabile l autore dello stesso e l esecutore delle attività in campo. Per i dettagli inerenti la stesura dei documenti e l effettuazioni delle attività vengono fornite le specifiche tecniche (SPE) da seguire. La codifica delle specifiche tecniche è costituita dal prefisso SPE seguito da una chiave numerica progressiva (SPE01, SPE02, ecc.), ed è richiamata nelle sezioni del presente documento alle quali si riferiscono. Gli Enti locali che hanno già in essere studi, monitoraggi, rilevazioni o sistemi informativi, realizzati direttamente o per il tramite di soggetti gestori o in forma associata per lo svolgimento di alcune fasi del servizio idrico, possono proporre, fatta salva l approvazione da parte della struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, specifiche modalità per la raccolta dei dati, per l effettuazione delle verifiche e per la stesura della documentazione, per non duplicare la raccolta e l organizzazione dei dati già precedentemente acquisiti in forma diversa da quanto stabilito per la predisposizione del FIA. I soggetti che, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n del 2008, hanno già presentato una parte della documentazione necessaria, dovranno completarla, ai fini di quanto previsto dalle presenti Linee guida, proponendo alla struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, specifiche modalità d integrazione che tengano conto di quanto già depositato. Nelle presenti Linee guida vengono evidenziati gli elementi necessari alla formazione del FIA mentre il dettaglio dei dati e della documentazione nonché le specifiche tecniche di formato e di contenuto sono illustrate nel Manuale FIA. A partire dal 2013, per la gestione di tutti i dati relativi al FIA, è stato adottato un adeguato sistema informativo, già in embrione sviluppato da una società partecipata dai Comuni delle Giudicarie, e successivamente acquisito dalla Provincia ed ottimizzato per gestire tutti gli aspetti previsti dalle presenti; tale iniziativa ha permesso di realizzare quello che attualmente è denominato Sistema informativo provinciale per i servizi idrici in rete (SIR) Il continuo aggiornamento della sopracitata base dati diventa quindi di fondamentale importanza per la verifica e gestione di PAC, PAU e LIA in modalità condivisa tra enti gestori, APRIE ed APSS. A partire dal 2018 è stata infine attivata la codifica univoca di tutti elementi, che a vario titolo costituiscono i singoli acquedotti,, necessaria premessa ad una successiva fase di sviluppo che permetterà l'inserimento semiautomatico nel sistema, di qualsiasi dato rilevato sul territorio (immagini, note, misurazioni,...) o derivante ad esempio da determinazioni analitiche eseguite per il controllo periodico. Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 7 Num. prog. 14 di 46
8 Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 8 Num. prog. 15 di 46
9 Informazioni generali sul FIA: denominazione dell ambito di utenza ( ) titolare del FIA responsabili della stesura del FIA acquedotti associati al FIA dati caratteristici dell ambito di utenza: dati statistici PAT (forniti da APRIE; Utenti di acquedotto equivalenti (UAE) ( ) effettivi ricavati dalla sommatoria dei dati delle singole aree di utenza di ciascun acquedotto associato al FIA; altri dati riepilogativi inerenti l ambito di utenza ( ) come ad esempio il numero di acquedotti, di opere delle diverse tipologie, la lunghezza complessiva delle reti di adduzione e di distribuzione, la dotazione idrica di concessione e calcolata secondo i parametri fissati dal PGUAP, ecc. Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 9 Num. prog. 16 di 46
10 Da cosa è composto il LIA: schede tecniche contenenti la codifica e gli elementi descrittivi degli acquedotti afferenti ad un ambito di utenza ( ) e di tutti gli elementi che lo compongono rappresentazioni grafiche altra documentazione esplicativa relazione descrittiva dell ambito di utenza scheda tecnica contenente i dati descrittivi dell ambito di utenza Possono essere escluse dal LIA le opere, anche se di competenza comunale, relative ad impianti di captazione, adduzione ed utilizzo a scopo potabile in singole strutture isolate (come ad esempio malghe, colonie, rifugi, ecc.), non collegate alla rete di acquedotto. rete alimentata ( ) acquedotti( ) punti di connessione( ). acquedotto Codifica RISI ( ) e/o codifica univoca SIR dell acquedotto ( ) Schema idraulico Ubicazione sulla cartografia 1: delle fonti di alimentazione, serbatoi, impianti di trattamento, eventuali gruppi di produzione o di altro impianto in serie con l acquedotto ( ), eventuali connessioni tra acquedotti, rete di adduzione primaria, perimetro dell area servita ( ) Regolamento di acquedotto Opere di captazione Codifica del corpo idrico ( ) interessato, codifica univoca della captazione e dell acquedotto (RISI ( ) e/o codifica univoca SIR) Dati tecnici (portata in magra e in morbida, data realizzazione del manufatto se nota) Dati di concessione ( ) (n. pratica, portata media ( ) e portata massima ( ), periodo, scadenza) Anno di realizzazione / Anno di ristrutturazione Delimitazione delle aree di salvaguardia ( ) (Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche deliberazione della Giunta provinciale n del 5/9/2008 e successivi aggiornamenti) Descrizione delle misure di protezione delle aree di salvaguardia Relazione idrogeologica per l individuazione delle aree di salvaguardia per le captazioni non inserite nella Carta delle risorse idriche Caratteristiche dell opera di captazione ( ) Documentazione fotografica Rilievo dello stato di fatto delle opere (piante e sezioni significative) Sistemi di limitazione e di misurazione della portata Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 10 Num. prog. 17 di 46
11 Serbatoi Codifica univoca del manufatto e dell acquedotto (RISI ( ) e/o codifica univoca SIR) Dati tecnici (data realizzazione del manufatto se nota, cubatura manufatto, volume d acqua) Anno di realizzazione / Anno di ristrutturazione Caratteristiche dell opera di captazione ( ) Documentazione fotografica Rilievo dello stato di fatto delle opere (piante e sezioni significative) Sistemi di limitazione, regolazione e di misurazione della portata N.B. È opportuno, secondo il grado di dettaglio dei rilievi eseguiti, riportare anche le opere accessorie posizionate lungo la rete di adduzione ( ) come ad esempio camere di manovra, camere di scarico ecc. Per questa tipologia di opere i dati richiesti sono quelli minimi per descrivere la posizione e la tipologia del manufatto Impianti di trattamento Codifica univoca del manufatto, dell acquedotto e dell impianto (RISI ( ) e/o codifica univoca SIR) Tipologia dell impianto (trattamento o pompaggio) Per impianti di trattamento: - tipologia, scheda tecnica e capacità dell apparecchio di potabilizzazione - prodotti chimici utilizzati nel processo di potabilizzazione - specifiche tecniche dei prodotti impiegati Per impianti di pompaggio: - punto di imbocco - punto di sbocco - caratteristiche della pompa Anno di realizzazione/anno di ristrutturazione Documentazione fotografica Rilievo dello stato di fatto delle opere (piante e sezioni significative) Rete di adduzione Codifica univoca di ogni tratto omogeneo di tubazione e dell acquedotto (RISI ( ) e/o codifica univoca SIR) Anno di realizzazione/anno di ristrutturazione Mappatura/rilievo della rete di adduzione Rete di distribuzione Codifica della rete di distribuzione ( ) e dell acquedotto (RISI ( ) e/o codifica univoca SIR) Anno di realizzazione/anno di ristrutturazione Mappatura/rilievo della rete di distribuzione con tutti gli elementi ed i tratti di rete che la costituiscono Sviluppo della rete di distribuzione Indicazione di eventuali distretti ( ) della rete che possano essere isolati mediante manovre su organi idraulici Ubicazione dei Punti di controllo ( ) Ubicazione e tipologia di utenze sensibili (vedere PAC) acquedotto Dati tecnici (tipologia, data realizzazione, caratteristiche dei macchinari, portata e salto di concessione ( ), ecc.) Anno di realizzazione/anno di ristrutturazione Documentazione fotografica Rilievo dello stato di fatto delle opere (piante e sezioni significative) sistemi di limitazione e di misurazione della portata Punti di connessione acquedotti Codifica univoca del punto di connessione ( ) (RISI ( ) e/o codifica univoca SIR) Tipologia della connessione: prelievo da altro acquedotto ( ) (indicare codice RISI ( ) e/o codifica univoca SIR, o cessione ad altro acquedotto ( ) (indicare codice RISI ( ) e/o codifica univoca SIR) Modalità di utilizzo (ordinario o di soccorso) Confronto con il progetto posto a base del titolo a derivare ( ) Stato di conservazione di strutture ed impianti Materiali utilizzati Possibili situazioni di rischio e misure di protezione Descrizione generale dell acquedotto e informazioni storiche sulla realizzazione e sui principali interventi attuati Eventuali peculiarità o problematiche di tipo impiantistico Località servite Dati storici riferiti a: Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 11 Num. prog. 18 di 46
12 - mappe ed elaborati progettuali con storico degli ampliamenti e delle modifiche - misurazioni di portata - riparazioni perdite Ubicazione degli strumenti di misura e controllo dei parametri idraulici (PAU) Sistemi di regolazione, limitazione e misurazione della portata e loro descrizione (PAU) Classe metrologica, anno di fabbricazione ed anno medio di posa, dei contatori ( ) posti nei punti di consegna ( ) PAU Descrizione del piano di monitoraggio per verificare il corretto stato di servizio (PAU) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 12 Num. prog. 19 di 46
13 Da cosa è composto il PAC: relazione descrittiva elenco dei punti di controllo pianificazione annuale delle analisi gestione dei dati dei rapporti di prova/certificati di analisi gestione del quaderno di acquedotto e delle non conformità analitiche e strutturali ambito di utenza Soggetto incaricato dell esecuzione dei controlli analitici Laboratorio di analisi Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 13 Num. prog. 20 di 46
14 Estensore della relazione descrittiva del PAC Valutazione del rischio igienico associato al pericolo ed individuazione dei limiti critici. Sulla base delle conoscenze storiche della qualità dell acqua e della situazione impiantistica deve essere individuata la sussistenza o meno di condizioni di rischio per la salute, definendo, anche in accordo con l APSS le misure/criteri di seguito elencate: - Modelli analitici - Frequenze dei campionamenti - Programma di monitoraggio basato su rilevamenti analitici di tipo fisico, chimico e microbiologico - Punti di controllo ( ) e utenze sensibili (scuole, asili nido, scuole materne dove vi è la preparazione e somministrazione di cibo; centri di preparazione pasti per ospedali, mense aziendali, scuole, ecc.; industrie alimentari; comunità, (ristoranti, alberghi, ospedali e case di cura, caratterizzati da un elevato numero di presenze e dall impossibilità di sospensione dell erogazione) - Tipologia dei controlli: controlli di routine e controlli di verifica - Piano di azioni correttive - Conservazione e trasmissione dei risultati dei controlli (il SIR sarà lo strumento per la gestione di tali dati permettendone l accessibilità a tutti i soggetti competenti) È necessario definire le modalità di gestione delle non conformità che possono essere rilevate mediante: - controlli interni del Titolare del servizio/gestore; - comunicazioni dell APSS relative alle risultanze analitiche dei controlli esterni; - comunicazioni effettuati dagli utenti. Nei casi in cui il Titolare del servizio/gestore, durante l attività di controllo, evidenzi un superamento dei parametri di legge, lo deve comunicare tempestivamente all APSS ed al Sindaco competente per definire insieme un piano d intervento urgente e adottare le misure specifiche per garantire le utenze, in modo particolare quelle sensibili, quali ospedali, scuole, ecc.. D intesa con le autorità sopra indicate dovranno essere informati gli utenti interessati. Il superamento della non conformità dovrà essere attestato dall invio all APSS, dell esito analitico attestante la conformità ai parametri di qualità fissati dalla normativa vigente. Gli interventi di igiene, pulizia e di disinfestazione contro gli animali indesiderati nonché quelli di manutenzione ordinaria, dovranno essere eseguiti secondo i tempi e le modalità previste in un piano annuale di interventi. Tai interventi dovranno essere riportati in un Quaderno di acquedotto con le seguenti informazioni: - data di esecuzione degli interventi - nominativi e firma degli esecutori degli interventi - descrizione dell attività eseguita - materiali, prodotti e tecniche adottate - certificazione dei materiali - eventuali inconvenienti o guasti rilevati e le eventuali riparazioni effettuate (manutenzione straordinaria) - trattamenti di potabilizzazione e/o disinfezione Deve essere predisposto un piano d intervento per le emergenze idriche, riguardante le azioni da mettere in atto per fronteggiare pericoli dovuti a disfunzioni impiantistiche e a fenomeni di inquinamento o in caso di carenza idrica; i possibili rischi igienici associati a ogni pericolo possono essere causati da: - guasti agli impianti di pompaggio /potabilizzazione (mancata erogazione energia elettrica dovuta all assenza di gruppi elettrogeni) - rotture alle reti di adduzione/distribuzione - indisponibilità delle fonti di alimentazione ( ) - inquinamento delle fonti di alimentazione ( ) - contaminazione intenzionale delle fonti di alimentazione ( ), degli impianti o delle reti di distribuzione ( ) Il piano deve riguardare le modalità di comunicazione all utenza ed alle autorità competenti nei seguenti casi: a) interruzioni programmate per manutenzione e guasti degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione; le interruzioni programmate possono essere originate da manutenzioni e quindi previste nei piani attuativi delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie oppure da guasti particolari la cui riparazione definitiva può essere programmata senza interferire con la qualità del servizio. b) interruzioni non programmate per inquinamento e/o indisponibilità delle fonti d approvvigionamento; le misure che possono essere adottate devono riguardare sia la crisi idrica quantitativa che la crisi idrica qualitativa. In entrambi i casi, d - causa dell emergenza idrica; - soluzioni possibili da adottare per eliminare l inconveniente (utilizzo fonti di alimentazione già classificate, utilizzo di fonti di alimentazione sconosciute, utilizzo di acqua superficiale, trasporto tramite autobotte, altro); - eventuali sistemi di potabilizzazione adottati - richiesta di autorizzazione all APSS - certificazione d analisi in autocontrollo sull acqua erogata Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 14 Num. prog. 21 di 46
15 A conclusione dell emergenza, il gestore dovrà comunicare al Comune, al sindaco e all APSS, le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi impiegati per il ripristino della normalità Definizione delle modalità per la formazione del personale sulla base delle esigenze relative all attività, al fine di consentire al personale di acquisire le capacità a svolgere le mansioni previste dal ruolo. Deve essere prevista anche una specifica istruzione sull uso dei DPI e del pronto soccorso. La verifica del piano è la fase in cui si valuta se quello che è stato deciso, pianificato ed attuato consente di raggiungere gli obiettivi; in caso contrario si procede alla revisione del piano. Il Piano deve essere aggiornato a seguito di variazioni significative quali ad esempio variazioni impiantistiche, creazioni di nuovi tratti di reti di adduzione e distribuzione, utilizzi nuove fonti ecc. I gestori sono tenuti a produrre opportuna documentazione di aggiornamento all APSS nei casi di nuovi interventi e/o variazioni agli impianti acquedottistici e alle reti. Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 15 Num. prog. 22 di 46
16 Da cosa è composto il PAU: scheda tecnica sulla dotazione idrica ed i volumi di accumulo, per ciascun acquedotto e relative specificazioni report del PAU (R-PAU), redatto secondo la schematizzazione pubblicata da APRIE; secondo tale schema è possibile, caricando in SIR tutti i dati necessari, predisporre l R-PAU e stamparlo per poter essere firmato dall estensore e dai soggetti responsabili dell ambito di utenza eventuale relazione sui calcoli e sulle valutazioni delle grandezze definite nel PAU report relativo alla proposta tecnica per la revisione quantitativa delle concessioni, per adeguarle agli standard definiti dal PGUAP (PRC-PAU) dotazione idrica( ) ( ) corpo idrico ( ) deflusso minimo vitale( ) funzionalità delle rete alimenta ( ) perdite ( ) titolo a derivare ( ) funzionalità della rete alimentata ( ) sviluppo sostenibile ( ) deflusso minimo vitale ( ) quinquies, ter Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 16 Num. prog. 23 di 46
17 ambito di utenza ( ) acquedotti intercomunali ( ) fonti di alimentazione( ) ambito di utenza( ) titolare( ) uso potabile( ) corpo idrico( ) funzionalità della rete alimentata ( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 17 Num. prog. 24 di 46
18 ambito di utenza ( ) ( ) ambito di utenza ( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 18 Num. prog. 25 di 46
19 aree di utenza ( ) ambito di utenza ( ) ambito di utenza( ) ( ) uso potabile( ) domestico( ) fontane( ) titolo a derivare ( ) tipologia d uso( ) dotazione idrica( ) usi diversi dal potabile serviti tramite l acquedotto ( ) acquedotto( ) Il documento LGAP-1 è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n dell 8/10/2010 Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 19 Num. prog. 26 di 46
20 fontane ( ) acquedotto( ) fontane( ) portata massima( ) ambito di utenza( ) dotazione idrica ( ) dotazione idrica( ) funzionalità della rete alimentata ( ) Portate medie ( ) e massime ( ) complessivamente fissate dagli esistenti titoli a derivare ( ) per l intero ambito di utenza ( ): - utilizzo ordinario: fonte di alimentazione idrica ( ) utilizzata in condizioni ordinarie; - utilizzo di soccorso: fonte di alimentazione idrica ( ) utilizzata in condivisioni straordinarie di insufficienza quali/quantitativa delle fonti utilizzate in via ordinaria; l'utilizzazione di soccorso può essere attivata solamente sulla base di uno specifico piano di emergenza. - riserva: fonte di alimentazione idrica( ) o corpo idrico ( ) naturale che, per le sue caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità ( ), può essere riservata in tutto od in parte ad un futuro utilizzo esclusivamente per consumo umano, con uno specifico provvedimento della Giunta provinciale; può essere dotata o meno di un opera di captazione, ma comunque deve essere disconnessa fisicamente dalla rete di acquedotto; le modalità e condizioni per il futuro utilizzo sono stabilite dal suddetto provvedimento della Giunta provinciale; - inutilizzabile: fonte di alimentazione idrica ( ) utilizzata nel passato e disconnessa fisicamente dalla rete di acquedotto, non più di interesse per un eventuale futuro utilizzo potabile; in questo caso il titolare( ) deve comunicare la rinuncia al titolo a derivare ( ) e provvedere al ripristino dei luoghi alle condizioni originarie o, in ogni caso, alla messa in sicurezza di eventuali manufatti ancora esistenti. Esistono infine altre modalità di trasferimento di acqua da e verso l acquedotto: prelievo da altri acquedotti: hanno segno positivo; sono considerate tali anche le portate destinate all alimentazione di aree comprese nell ambito di utenza ( ) dell Ente, effettuata da Enti diversi, in base a specifiche convenzioni; cessione ad altri acquedotti: hanno segno negativo; sono considerate tali anche le portate destinate all alimentazione di aree diverse dall ambito di utenza ( ) dell Ente, effettuata in base a specifiche convenzioni con gli Enti beneficiari. Volumi annui complessivi, desunti dalle portate medie ( ) fissate dai titoli a derivare ( ), per l intero ambito di utenza ( ) [mc/anno], con riferimento all utilizzo ordinario Volumi annui complessivi, desunti dalle portate medie ( ) fissate dai titoli a derivare ( ), per l intero ambito di utenza ( ) [mc/anno]; con riferimento all utilizzo di soccorso; Dotazione complessiva del volume di accumulo nei serbatoi; Dotazione idrica ( ) media giornaliera di acqua in concessione ( ) [volume annuo complessivo/365/24/3600/utenti di acquedotto equivalenti (UAE) ( )] Portata media del giorno di massimo consumo determinata secondo quanto stabilito dal PGUAP, con riferimento all utilizzo potabile ( ) e domestico ( ) [l/s]. La dotazione idrica ( ) stabilita dal PGUAP nella misura di 250 l/g per residente e posto letto e di 100 l/g per pendolare ( ), è da intendersi come portata media necessaria per costituire il volume giornaliero del giorno di massimo consumo. Portata media del giorno di massimo consumo determinata secondo quanto stabilito dal PGUAP, per gli usi diversi dal potabile serviti tramite l acquedotto ( ), eccedenti rispetto a quanto definito nel punto precedente [l/s]. Laddove non vi siano specifici criteri fissati dal PGUAP, si dovrà fare riferimento ad un calcolo analitico dei fabbisogni strettamente necessari. Ove non sia possibile procedere in via analitica, si farà riferimento a dati misurati o, in ultima analisi, a dati stimati Portata media ( ) complessiva riferita all ambito di utenza ( ) da fissare nel nuovo titolo a derivare ( ) È la sommatoria dei due valori sopra riportati: - Portata media del giorno di massimo consumo con riferimento all utilizzo potabile ( ) e domestico ( ) [l/s] - Portata media del giorno di massimo consumo per gli usi diversi dal potabile serviti tramite l acquedotto ( ) Portata massima ( ) [l/s], da fissare nel nuovo titolo a derivare ( ), eventualmente suddivisa sulle singole captazioni Di norma la portata massima ( ) da fissare nel titolo a derivare ( ) deve corrispondere alla Portata media ( ) complessiva riferita all ambito di utenza ( ) in relazione alla presenza o alla previsione di adeguati volumi di accumulo. Qualora la portata massima ( ) ritenuta necessaria risulti superiore alla portata media del giorno di massimo consumo, determinata secondo quanto stabilito dal PGUAP, la sua entità va calcolata secondo le indicazioni specificate nel Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 20 Num. prog. 27 di 46
21 Manuale FIA. Differenza fra la portata massima ( ) fissata dal titolo a derivare ( ) e la portata del giorno di massimo consumo determinata secondo quanto stabilito dal PGUAP [l/s] Se il risultato è nullo oppure ha segno negativo, non dovrà essere attuato alcun adeguamento dell utilizzazione sul piano quantitativo; negli altri casi l entità risultante rappresenta la riduzione da apportare all utilizzazione per adeguarla, sul piano quantitativo, alle disposizioni del PGUAP funzionalità della rete alimentata derivazione idrica funzionalità della rete alimentata 2.1 Conformità delle opere al progetto posto a base del titolo a derivare 2.2 Idoneità e corretto dimensionamento delle opere titolo a derivare 2.3 Efficienza della rete alimentata perdite( ) perdite ( ) perdite ( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 21 Num. prog. 28 di 46
22 perdite( ) rete di distribuzione distretti di distribuzione Risultato atteso Per ogni distretto di distribuzione ( ) deve essere possibile la misurazione diretta della portata, mediante strumenti di misurazione ad hoc, o indiretta, utilizzando un unico misuratore, per esempio quello in uscita al serbatoio, le cui misure siano correlabili con l alimentazione dei singoli distretti ( ). La suddivisione dei distretti ( ) deve tenere in considerazione le caratteristiche funzionali della rete ma anche l utenza servita (è ad esempio necessario che uno dei distretti ( ) coincida con la zona industriale/artigianale, se esistente). La distrettualizzazione viene effettuata a partire dagli organi di manovra esistenti sulla rete e dovrà essere affinata mediante l aggiunta di tratti di condotta, nuove saracinesche e strumenti di misurazione delle portate da programmare nel PAU. La successiva attività di ricerca perdite ( ) va attuata dando priorità ai distretti ( ) che rilevano i maggiori consumi notturni o che presentano particolari anomalie nel funzionamento idraulico (variazioni di portata o di pressione eccessive, ecc.). opere di captazione rete di adduzione Risultato atteso Le misurazioni vanno condotte con differenti modalità nel caso si tratti di captazioni a gravità (tipo sorgenti, drenaggi, ecc.) oppure a pompaggio (tipicamente pozzi ( )). Nel primo caso, la determinazione della portata a monte della derivazione a scala almeno giornaliera permette la quantificazione della potenzialità dell attingimento nonché il suo andamento temporale da relazionarsi con le Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 22 Num. prog. 29 di 46
23 richieste da parte degli utenti. Per quanto attiene invece i pozzi ( ) vanno contabilizzati i volumi giornalieri derivati e memorizzato almeno giornalmente il livello della falda intercettata (rilevato direttamente nel pozzo ( ) oppure in opportuni piezometri). Questi dati, oltre alla valenza funzionale all acquedotto ( ), acquistano anche valore ambientale in quanto permettono valutazioni in merito al comportamento delle fonti di alimentazione rispetto all andamento idrologico. È opportuno che, a regime, le misurazioni avvengano mediante acquisitori automatici adottando le specifiche in coerenza con quelle stabilite per i dispositivi di misurazione dei quantitativi d acqua derivata previsti dall art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP (rif. DGP n del 2007) [ SPE09] serbatoi Risultato atteso Le verifiche quantitative devono comprendere la misurazione delle portate in uscita al/i serbatoio/i da relazionarsi con il distretto servito in diversi momenti della richiesta idrica. Le misurazioni in continuo, effettuate a scala almeno oraria, e correlate con il dato del livello di riempimento del serbatoio ( ), devono quantificare i consumi tipici notturni e diurni estivi ed invernali. Le misure, da effettuarsi sia durante i periodi di massimo carico antropico che durante i periodi ordinari nei giorni feriali e festivi, possono essere utilizzate per una prima quantificazione dei fabbisogni idrici. La portata erogata media del giorno di picco e la portata erogata oraria massima rappresentano degli indicatori da confrontare con la portata media ( ) e massima ( ) di concessione ( ). Il quadro conoscitivo della rete acquedottistica deve comprendere la misurazione dei quantitativi in uscita ai serbatoi da relazionarsi con il distretto servito in diversi momenti della richiesta idrica. In assenza di misuratori fissi, alcune misurazioni temporanee in continuo effettuate a scala almeno oraria, sono in grado di quantificare i consumi tipici notturni-diurni, feriali-festivi, estivi-invernali. Per le località a propensione turistica dovranno essere inoltre monitorati i periodi di presenza turistica e, all interno di tali periodi, anche i giorni festivi. I consumi minimi notturni, al netto delle utenze note (fontane ( ), utenze notturne, etc.), costituiscono le perdite ( ) apparenti (possono comprendere utenze non contabilizzate) della rete. Dovranno essere previsti due differenti campagne di misurazione in grado di coprire il periodo ordinario e un periodo di picco (presenze turistiche, adacquamento orti, etc.) a seconda della vocazione del territorio. L intervallo temporale notturno di interesse va, di norma, dalle ore alle ore perdite ( ) perdite ( ) perdite ( ) perdite ( ) perdite ( ) Risultato atteso L attività di ricerca, affiancata dalla distrettualizzazione della rete, deve essere effettuata in primo luogo attraverso la verifica dei consumi minimi notturni di ogni singolo distretto. Valori di perdite eccessivi devono quindi analizzati, individuando la causa anche tramite una campagna di ricerca perdite ( ) specifica per il distretto, con la successiva riparazione delle perdite stesse; la riparazione deve essere verificata tramite un nuovo monitoraggio dei consumi notturni. Va verificata inoltre l eventuale presenza di pressioni elevate nella rete di distribuzione in quanto esse sono causa di vulnerabilità dell impianto, con aumento della probabilità di generazione di nuove perdite ( ). Vanno effettuate alcune misurazioni saltuarie notturne - quando è minima la richiesta di acqua e massima risulta la pressione in rete - per la programmazione di interventi mirati a limitarne l escursione. Una ricerca delle perdite ( ) puntuali può essere effettuata mediante l utilizzo di metodi elettroacustici (geofonici e/o correlativi) che consentono, seguendo il tracciato della rete nei distretti ( ) che evidenziano consumi anomali, di localizzare con buona precisione le perdite ( ). Altri metodi, quali quelli termografici o di utilizzo di gas inerti risultano più onerosi e vanno generalmente applicati ove non sia possibile l utilizzo dei metodi elettroacustici. Infine i sistemi fissi di monitoraggio delle perdite ( ) (noise-logger) sono applicabili su reti distrettualizzate, le cui caratteristiche tecniche sono ben note; tali metodi richiedono però personale specializzato per il controllo del monitoraggio in continuo su software specialistico. 2.4 Bilancio idrico di acquedotto (BIA) ed indicatori [SPE04] Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 23 Num. prog. 30 di 46
24 rete alimentata( ) perdite ( ) volume immesso nell acquedotto SIV (A02+A07) (oppure) volume immesso in rete GIV (A09) consumi autorizzati AC perdite idriche WL (A17+A03) consumi autorizzati fatturati BAC consumi autorizzati non fatturati UAC (A12) perdite apparenti AL perdite reali RL (A15+A03+A13) consumo fatturato misurato BMC (A10+A08) consumo fatturato non misurato BUC (A11) consumo non fatturato misurato UMC consumo non fatturato non misurato UUC consumo non autorizzato UC (A14) Imprecisione delle misurazioni MI (A16) perdite nella rete di trasporto (LTM) e distribuzione (LDM) perdite e sfiori dai serbatoi LOUST (A13) perdite dagli allacciamenti fino ai contatori LSCCM acqua contabilizzata RW acqua non contabilizzata NRW Grandezza da misurare volume immesso nell acquedotto SIV volume immesso in rete GIV consumi autorizzati AC consumi autorizzati fatturati BAC consumo fatturato misurato BMC consumo fatturato non misurato BUC consumi autorizzati non fatturati UAC consumo non fatturato misurato UMC consumo non fatturato non misurato UUC acqua fatturata RW acqua non fatturata NRW definizione Volume d acqua che viene immesso nell acquedotto; in mancanza di misurazioni viene considerato il volume ricavato dalla portata media fissata dai titoli a derivare; vengono considerati anche i volumi ceduti ad altri acquedotti (con segno negativo) e prelevati da altri acquedotti (con segno positivo) Volume d acqua che viene immesso nella rete di distribuzione, a valle del serbatoio; vengono considerati anche i volumi ceduti ad altri acquedotti (con segno negativo) e prelevati da altri acquedotti (con segno positivo) Acqua consumata da utenze note; corrisponde alla somma dei consumi autorizzati fatturati (BAC) e dei consumi autorizzati non fatturati (UAC) Somma di BUC e BMC Consumi autorizzati direttamente misurati; quantità d acqua misurata e rilevata attraverso le letture periodiche dei contatori Consumi autorizzati e basati su valori stimati o tariffe fisse, in assenza di contatori Consumi autorizzati concessi a titolo gratuito (ad esempio: pulizia strade, bocche antincendio, usi tecnici connessi all esercizio e alla manutenzione dell acquedotto, autoconsumi, fontane ecc.) Consumi autorizzati non fatturati misurati Consumi autorizzati non fatturati e non misurati Acqua consumata per la quale il titolare del servizio riceve un pagamento; è formato da dati misurati e da dati stimati Acqua consumata per la quale il titolare del servizio non riceve alcun pagamento; Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 24 Num. prog. 31 di 46
25 perdite idriche WL perdite apparenti AL consumo non autorizzato UC imprecisione delle misurazioni MI perdite reali RL perdite nella rete di trasporto (LTM) e distribuzione (LDM) perdite e sfiori dai serbatoi LOUST perdite dagli allacciamenti fino ai contatori LSCCM è costituita da acqua autorizzata, non autorizzata o da perdite Sono suddivise in perdite apparenti ed in perdite reali Sono costituite da consumi non autorizzati e imprecisione delle misure Quantità d acqua sottratta al sistema senza autorizzazione e, presumibilmente, senza la conoscenza del gestore; include allacci abusivi, danneggiamenti, utilizzo improprio di idranti. Tali quantità sono difficili da stimare ma devono essere individuate e ridotte attraverso azioni amministrative. I prelievi non autorizzati possono essere anche potenziali punti di contaminazione perché non dotati di valvole di non ritorno. L imprecisione e il possibile malfunzionamento degli apparecchi di misura e gli errori nella gestione dei dati possono essere visti come perdite; questa quantità di acqua non è realmente persa ma se non viene contabilizzata può dare risultati ingannevoli nella stima delle perdite. Gli errori possono essere dovuti a errori di calibrazione, lettura dei contatori, gestione dei dati e fatturazione, ecc. Tali quantità sono difficili da stimare ma devono essere individuate e ridotte attraverso azioni amministrative. Sono le perdite fisiche dell impianto; consistono nelle dispersioni nelle reti di adduzione e di distribuzione, perdite e sfiori dei serbatoi, perdite negli allacciamenti fino ai contatori. Per prevenire e riparare le perdite reali sono necessari investimenti infrastrutturali Possono gravemente danneggiare l affidabilità del sistema se non riparati e possono provocare problemi di qualità dell acqua Nei serbatoi in calcestruzzo interrati le perdite sono praticamente inesistenti; gli sfiori dai serbatoi possono essere ridotti al minimo con semplici accorgimenti come le valvole di chiusura del flusso a galleggiante Quantità di acqua persa per dispersioni lungo l allacciamento, a monte del contatore; anche le perdite a valle del contatore rappresentano dei problemi, sebbene in questo caso l acqua dispersa venga comunque contabilizzata dal gestore acquedotto ( ) perdite ( ) perdite ( ) perdite( ) Risultato atteso Bilancio idrico di acquedotto con indicazione di tutti gli elementi che lo compongono; deve essere indicato se il dato è misurato o stimato, evidenziando, in questo secondo caso, la metodologia adottata. Se il dato è misurato, si dovrà indicare l errore del sistema di misura nelle condizioni operative; gli strumenti utilizzati per le misurazioni devono essere adeguati al range di portata da misurare. L unità di misura da utilizzare è il m3/anno Indicatori di efficienza: - [I1] = indice di rendimento complessivo: (RW/SIV) [%]; - [I2] = perdite percentuali in distribuzione (WL/GIV) [%]; - [I3] = indice lineare delle perdite in distribuzione (WL/lunghezza rete di distribuzione/anno) [l/km/giorno]; - [I4] = indice delle perdite per allacciamento (WL/numero allacciamenti/giorno) [l/allacciamento/giorno] Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 25 Num. prog. 32 di 46
26 2.5 Funzionalità della rete alimentata funzionalità della rete alimentata perdite perdite perdite( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 26 Num. prog. 33 di 46
27 titolare ( ) rete alimentata( ) rete alimentata( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 27 Num. prog. 34 di 46
28 Obiettivo Quaderno di acquedotto Bilancio idrico di acquedotto con dati misurati Riduzione quantitativa dell utilizzazione Gestione dell emergenza sotto gli aspetti quantitativi Eliminazione, in modo strutturale, delle eventuali criticità evidenziate nel PAC Adeguamento alle specifiche fornite dallo SGRIE Contabilizzazione delle quantità d'acqua destinate agli utilizzi diversi dal potabile serviti tramite l acquedotto Installazione di sistemi di limitazione della portata massima su ogni opera di presa e di valvole a galleggiante di regolazione delle adduzioni Installazione di contatori anche per le utenze a titolo gratuito Piano per il risparmio idrico note È necessario prevedere la gestione in SIR del quaderno di acquedotto sul quale tenere traccia delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle risultanze dei controlli sulla qualità dell acqua immessa in rete ed erogata all utenza ( ) Il bilancio idrico, a regime, dovrà essere basato su dati misurati; in particolare dovrà essere prevista la misurazione delle portate in uscita dai serbatoi, e di quelle sollevate dai sistemi di pompaggio. Ove possibile e/o obbligatorio (per volumi di concessione superiori ad m 3 /anno) dovranno essere misurate anche le portate nei punti di captazione. Indicare le azioni necessarie per rientrare nei parametri stabiliti dal PGUAP, qualora risulti che i valori di portata fissati dal titolo a derivare ( ) eccedono quelli fissati dal PGUAP, indicando le motivazioni che allo stato attuale causano tale eccedenza. I principali interventi strutturali che consentono un uso più efficiente della risorsa sono: - risanamento della rete; - integrazione dei volumi di compenso dei serbatoi; - interconnessione fra reti sia comunali che sovracomunali. Ai fini della gestione delle emergenze per scarsità idrica, si dovranno definire innanzitutto delle soglie quantitative di allerta e di allarme;il superamento delle soglie di allerta dovrà essere comunicato alla struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche; in caso di allarme dovrà essere prevista anche la modalità di intervento mediante la distrettualizzazione della rete; dovranno infine essere stabilite le regole di attivazione delle derivazioni di soccorso o altre ipotesi di intervento Si dovranno prendere in considerazione anche gli interventi volti ad eliminare, in modo strutturale, le eventuali criticità evidenziate nel PAC, compresi gli interventi di ammodernamento delle opere di presa, quelli per la realizzazione di adeguate protezioni della zona di tutela assoluta (ZTA) e per la riduzione della vulnerabilità delle fonti di alimentazione, nonché gli studi idrologici ed idrogeologici di approfondimento, ecc. Dovranno essere descritte le carenze riscontrate rispetto alle specifiche fornite dal SGRIE (DGP n. 132 del 2 febbraio Indirizzi tecnici per la progettazione, la costruzione, l adeguamento e la manutenzione degli acquedotti pubblici situati sul territorio della provincia di Trento) e gli interventi necessari per l adeguamento alle stesse Le quantità d'acqua destinate agli utilizzi diversi dal potabile serviti tramite l acquedotto andranno rilevate tramite specifici contatori ed evidenziate in appositi registri d'esercizio in modo separato È opportuno prevedere l installazione, presso i serbatoi, di valvole a galleggiante di regolazione delle adduzioni, per consentire lo sfioro presso le sorgenti delle portate in esubero (indicare eventualmente le motivazioni dell impossibilità di installazione) in particolare dove ci sono cumuli di utilizzi a valle sul corso d acqua o carenza dello stato qualitativo Nelle opere di presa dovrà essere prevista la limitazione delle portate derivate ai nuovi valori di portata, fissati in coerenza con i parametri del PGUAP. La descrizione dei dispositivi adottati o da installare dovrà essere fornita dai soggetti concessionari su richiesta della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, quando la stessa ne ravvisi la necessità, in relazione alla rilevanza della portata derivata e/o alla necessità di tutelare altre derivazioni o il contesto idrico nel quale avviene la derivazione È necessario prevedere l installazione di contatori anche per le utenze a titolo gratuito, quali ad esempio le fontane ( ); se non risulta possibile l installazione di contatori, dovrà essere comunque prevista una contabilizzazione, mediante una stima analitica, delle portate e dei volumi annui forniti Oltre agli interventi necessari ai fine di ridurre le dotazioni unitarie entro i quantitativi fissati dal PGUAP, il rispetto del DMV qualora previsto e la riduzione delle eventuali perdite ( ) e disfunzioni riscontrate, l Ente dovrà predisporre un piano per il risparmio dell acqua prevedendo l adozione di quanto previsto dal comma 3 dell art. 14 delle Norme di attuazione del PGUAP Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 28 Num. prog. 35 di 46
29 In base all entità della riduzione quantitativa necessaria per non superare, al termine della fase di adeguamento, i limiti stabiliti dal PGUAP riferiti all intero ambito d utenza, il titolare dovrà individuare le captazioni che verranno limitate, dismesse o utilizzate solo a fini di soccorso. Obiettivo Indicazione delle captazioni che verranno limitate, dismesse o utilizzate solo a fini di soccorso note I dati devono essere indicati, per ogni singola opera di derivazione, in forma di proposta di revisione delle portate di concessione per il raggiungimento degli obiettivi del PGUAP nell'apposita sezione predisposta nel SIR (PRC- PAU), con riferimento all'intero ambito di utenza, anche considerando le eventuali concessioni relative ad acquedotti intercomunali connessi all'ambito stesso Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 29 Num. prog. 36 di 46
30 Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 30 Num. prog. 37 di 46
31 titolo a derivare titoli a derivare titoli a derivare titoli a derivare titoli a derivare Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 31 Num. prog. 38 di 46
32 Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 32 Num. prog. 39 di 46
33 abitanti equivalenti utenti di acquedotto equivalenti (UAE)( ) abitanti residenti:area servita ( ) acquedotto (idropotabile) acquedotto intercomunale( ) uso potabile( ) area di utenza ( ) Ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici (RISI)( ) acquedotto( ) punti di connessione( )acquedotti( ) ( ) rete alimentata( ) serbatoio( )impianto di potabilizzazione ( ), acquedotto (idropotabile) intercomunale: acquedotto privato, ma di interesse pubblicoacquedotto( ) portata fissati dal titolo a derivare( ) acquedotto pubblico: acquedotto ( ) servizio pubblico di acquedotto ( ) allacciamento (allaccio, connessione, presa): punto di consegna ( ) contatore ( ) contatore( ) ambito di utenza: aree di utenza( ) servizio di acquedotto pubblico ( ) intercomunale ( ) servizio di acquedotto pubblico ( ) area di utenza o area servita: acquedotto( ) fonti di alimentazione( ) aree di salvaguardia delle captazioni potabili Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 33 Num. prog. 40 di 46
34 Carta delle risorse idriche( ) consumo umano( ) Carta delle risorse idriche aree di salvaguardia( ) ( ) categorie d uso dell acqua (all utenza) regolamento ( ) servizio pubblico di acquedotto ( ) uso domestico( )uso non domestico( ) fontane ( ) collaudo della derivazione idrica titolo a derivare ( ) titolare ( ) derivazione idrica( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 34 Num. prog. 41 di 46
35 concessionetitolo a derivare( ) derivazione idrica( ) controlli esterni controlli interni consumo umano tipologia ( ) uso potabile( ); contatore o misuratore dei consumi: utenza ( ) corpo idrico: deflusso minimo vitale (DMV): derivazione idrica: corpo idrico( ) utilizzazione idrica( ) distretti di distribuzione: acquedotto( ) dotazione idrica ad uso potabile: utenza( ) fabbisogno: utenti ( ) concessione( ) fontana: rete di distribuzione ( ) acquedotto( ) utilizzazione idrica( ) fonte di alimentazione idrica: corpo idrico ( ) opera di presa( ) utilizzazione idrica ( ) funzionalità della rete alimentata acquedotto ( ) utenti ( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 35 Num. prog. 42 di 46
36 gestore: acquedotto pubblico( ) impianto di potabilizzazione: mappatura/rilievo della rete: opera di presa o di captazione: corpo idrico ( ) opera di trasporto: opera di presa ( ) opera di presa( ) pendolari: ( )( ) perdite totali o lorde - perdite apparenti contatore( ) - perdite reali rete didistribuzione( ) serbatoi( ) portata massima fissata dal titolo a derivare: corpo idrico ( ) titolo a derivare ( ) portata media fissata dal titolo a derivare: Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 36 Num. prog. 43 di 46
37 titolo a derivare ( ) punto di consegna rete di distribuzione ( ) contatore( ) punto di connessione acquedotti ( ) punto di connessione( ) punto di controllo (o di campionamento) regolamento del servizio pubblico di acquedotto (Regolamento di acquedotto) servizio pubblico di acquedotto ( ) restituzione (o punto di restituzione): corpo idrico( )titolo a derivare( ) corpo idrico ( ) rete alimentataopera di presa ( ) punto di consegna( ) restituzione( ) utenti( ) rete di distribuzione: serbatoi ( ) punto di consegna ( ) Ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici del Trentino (RISI): riconoscimento di antico diritto: titolo a derivare( ) corpo idrico( ) serbatoio opere di presa( ) opera di presa ( ) rete alimentata ( ) servizio pubblico di acquedotto: acquedotto pubblico( ) sviluppo sostenibile: Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 37 Num. prog. 44 di 46
38 tariffa di acquedotto utente( ) utente( ) tipologia d uso dell acqua titolo a derivare ( ) tariffa ( ) utente( ) uso domestico( ) non domestico ( ) titolare dell utilizzazione idrica:titolo a derivare( ) titolare del servizio di acquedotto pubblico: servizio pubblico di acquedotto( ) titolo a derivare utilizzazione idrica( ) usi diversi dal potabile serviti tramite l acquedotto tipologie di uso( )fontane( ) acquedotto ( ) uso domestico: - titolare ( ) titolo a derivare ( ) tipologia d uso ( ) titolare( ) - titolare( ) gestore( ) utente( ) utenza ( ) uso non domestico: uso domestico( )categorie ( ) servizio pubblico di acquedotto( ) uso potabile o idropotabile tipologia d uso dell acqua ( ) uso potabile per acquedotto pubblico tipologia d uso dell acqua( ) acquedotto pubblico( ) uso potabile per acquedotto privato, ma di interesse pubblico tipologia d uso ( ) acquedotto privato, ma di interesse pubblico( ) uso potabile per impresa alimentare utente Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 38 Num. prog. 45 di 46
39 utenti di acquedotto equivalenti (UAE): ( ) ambito di utenza( ) utenza contatore( ) acquedotto( ) utenti di acquedotto equivalenti (UAE) ( ) utenza sensibile utilizzazione idrica: restituzione( ) portata massima ( ) portata media ( ) volume annuo di concessione portata media fissata dal titolo a derivare( ) vulnerabilità dell acquifero: zona di fornitura idrica: ( ) ( ) Linee guida per la formazione del FIA - Vers. 2.0 pagina 39 Num. prog. 46 di 46
Registro: Novareti, Prot.: del: 05/12/2016 Assegnatari: DT; IAC; Note:
 Registro: Novareti, Prot.: 015301 del: 05/12/2016 Assegnatari: DT; IAC; Note: Acquedotto CALLIANO Data 29/11/2016 1. Descrizione del sistema idrico Informazioni generali sull'acquedotto Codice RISI: J035001
Registro: Novareti, Prot.: 015301 del: 05/12/2016 Assegnatari: DT; IAC; Note: Acquedotto CALLIANO Data 29/11/2016 1. Descrizione del sistema idrico Informazioni generali sull'acquedotto Codice RISI: J035001
USO ZOOTECNICO. PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri quantitativi fissati dal PGUAP
 SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-ZOO) USO ZOOTECNICO PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri quantitativi
SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-ZOO) USO ZOOTECNICO PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri quantitativi
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE (A.P.R.I.E.) Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 189 DI DATA 12 Ottobre 2018 OGGETTO: Individuazione delle modalità di
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE (A.P.R.I.E.) Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 189 DI DATA 12 Ottobre 2018 OGGETTO: Individuazione delle modalità di
Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA]
![Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA]](/thumbs/92/109193926.jpg) Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] ACQUEDOTTI POTABILI In Trentino ci sono circa 850 acquedotti pubblici: 1860 punti di captazione d acqua 1710 da sorgenti 120 da pozzi 1600 serbatoi 30 da acque superficiali
Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] ACQUEDOTTI POTABILI In Trentino ci sono circa 850 acquedotti pubblici: 1860 punti di captazione d acqua 1710 da sorgenti 120 da pozzi 1600 serbatoi 30 da acque superficiali
Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] D.G.P.n. 1111/2012
![Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] D.G.P.n. 1111/2012 Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] D.G.P.n. 1111/2012](/thumbs/93/112245639.jpg) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L ENERGIA Osservatorio provinciale dei Servizi idrici Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] D.G.P.n. 1111/2012 ACQUEDOTTI POTABILI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L ENERGIA Osservatorio provinciale dei Servizi idrici Fascicolo Integrato di Acquedotto [FIA] D.G.P.n. 1111/2012 ACQUEDOTTI POTABILI
CERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO/TITOLARE RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DELLA RETE ALIMENTATA DALLA DERIVAZIONE IDRICA
 CERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO/TITOLARE RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DELLA RETE ALIMENTATA DALLA DERIVAZIONE IDRICA STAP-CFR-00 (numero/pratica del titolo a derivare) Il
CERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO/TITOLARE RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DELLA RETE ALIMENTATA DALLA DERIVAZIONE IDRICA STAP-CFR-00 (numero/pratica del titolo a derivare) Il
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comune di XXXXXXXX FIA FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO PIANO DI ADEGUAMENTO DELL UTILIZZAZIONE (PAU) 1 Elenco acquedotti 2 Denominazione data Relazione illustrativa del PAU
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comune di XXXXXXXX FIA FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO PIANO DI ADEGUAMENTO DELL UTILIZZAZIONE (PAU) 1 Elenco acquedotti 2 Denominazione data Relazione illustrativa del PAU
SCHEDA TECNICA PER DERIVAZIONI AD USO POTABILE (STAP-POS) A1. Disponibilità idrica secondo il titolo a derivare
 SCHEDA TECNICA PER DERIVAZIONI AD USO POTABILE (STAP-POS) A. Confronto delle caratteristiche del titolo a derivare con le disposizioni fissate dalle Norme di attuazione del PGUAP 1 A1. Disponibilità idrica
SCHEDA TECNICA PER DERIVAZIONI AD USO POTABILE (STAP-POS) A. Confronto delle caratteristiche del titolo a derivare con le disposizioni fissate dalle Norme di attuazione del PGUAP 1 A1. Disponibilità idrica
CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l Energia Osservatorio dei Servizi idrici FIA FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO 1 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PER LE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l Energia Osservatorio dei Servizi idrici FIA FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO 1 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PER LE
ALTRI USI (scheda da compilare anche nel caso in cui il titolo a derivare preveda più di una tipologia di utilizzo)
 SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-ALT) ALTRI USI (scheda da compilare anche nel caso in cui il titolo a derivare preveda
SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-ALT) ALTRI USI (scheda da compilare anche nel caso in cui il titolo a derivare preveda
COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE Provincia di Salerno
 Provincia di Salerno PROT. NR. DEL 24.05.2011 PIANO TRIENNALE DI AUTOCONTROLLO DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO Approvazione di direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano
Provincia di Salerno PROT. NR. DEL 24.05.2011 PIANO TRIENNALE DI AUTOCONTROLLO DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO Approvazione di direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano
Volume massimo annuo (mc) Portata. Portata istantanea. misurata
 SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-INN) USO INNEVAMENTO PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri quantitativi
SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-INN) USO INNEVAMENTO PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri quantitativi
D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
 CONSORZIO D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE Prot.717 del 23.08.2017 Via PEC Ai Gestori del Servizio Idrico Integrato dell ATO 2 - Catania E p.c. Assemblea Territoriale Idrica
CONSORZIO D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE Prot.717 del 23.08.2017 Via PEC Ai Gestori del Servizio Idrico Integrato dell ATO 2 - Catania E p.c. Assemblea Territoriale Idrica
LINEE PROGRAMMATICHE PIANIFICATORIE DEL PIANO D'AMBITO Conferenza dei Comuni del 20 gennaio 2016
 LINEE PROGRAMMATICHE PIANIFICATORIE DEL PIANO D'AMBITO 2016-2045 Conferenza dei Comuni del 20 gennaio 2016 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUEDOTTO pozzi, sorgenti, potabilizzazione e trasporto in rete
LINEE PROGRAMMATICHE PIANIFICATORIE DEL PIANO D'AMBITO 2016-2045 Conferenza dei Comuni del 20 gennaio 2016 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUEDOTTO pozzi, sorgenti, potabilizzazione e trasporto in rete
PIANO DI GESTIONE. Allegato D Livelli di servizio obiettivo
 PIANO DI GESTIONE Allegato D Livelli di servizio obiettivo DICEMBRE 2015 A A1 A2 Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) assenza delle infrastrutture di acquedotto alto tasso di
PIANO DI GESTIONE Allegato D Livelli di servizio obiettivo DICEMBRE 2015 A A1 A2 Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) assenza delle infrastrutture di acquedotto alto tasso di
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione relativa allo stato di fatto delle opere di captazione principali ed accessorie:
 Elenco allegati richiesta rinnovo di derivazione da acque sorgive (da presentare in forma cartacea e su supporto informatico possibilmente firmati digitalmente) Alla domanda deve essere allegata la seguente
Elenco allegati richiesta rinnovo di derivazione da acque sorgive (da presentare in forma cartacea e su supporto informatico possibilmente firmati digitalmente) Alla domanda deve essere allegata la seguente
IL CICLO DELL ACQUA: CHE COS È IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO La filiera dell acqua potabile. Relatore: Riccardo MORI
 IL CICLO DELL ACQUA: CHE COS È IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO La filiera dell acqua potabile Relatore: Riccardo MORI Il ciclo dell acqua: che cos è il servizio idrico integrato PIOMBINO - 17 Dicembre 2009
IL CICLO DELL ACQUA: CHE COS È IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO La filiera dell acqua potabile Relatore: Riccardo MORI Il ciclo dell acqua: che cos è il servizio idrico integrato PIOMBINO - 17 Dicembre 2009
Parte I ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI
 Parte I ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R. Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione
Parte I ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R. Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione
1. Disponibilità idrica 1.1. Caratteristiche dei titoli a derivare con riferimento alla medesima area di utenza N Pratica. Portata massima (l/s)
 SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-IRA) USO IRRIGUO E/O ANTIBRINA PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri
SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-IRA) USO IRRIGUO E/O ANTIBRINA PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto delle opere di captazione principali ed accessorie:
 Elenco allegati richiesta nuova derivazione da acque sorgive (da presentare in forma cartacea e su supporto informatico possibilmente firmato digitalmente) Alla domanda deve essere allegata la seguente
Elenco allegati richiesta nuova derivazione da acque sorgive (da presentare in forma cartacea e su supporto informatico possibilmente firmato digitalmente) Alla domanda deve essere allegata la seguente
ACQUEDOTTO (FIA) DEL COMUNE DI CASTELNUOVO.
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2018 OGGETTO: RECEPIMENTO ED APPROVAZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (FIA) DEL COMUNE DI CASTELNUOVO. Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2018 OGGETTO: RECEPIMENTO ED APPROVAZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (FIA) DEL COMUNE DI CASTELNUOVO. Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE
AVANZAMENTO ATTIVITÀ CONFRONTO TECNICO. Incontro con i Comuni delle Aree Omogenee Cuneo,
 AVANZAMENTO ATTIVITÀ CONFRONTO TECNICO Incontro con i Comuni delle Aree Omogenee Cuneo, 08.05.2017 AVANZAMENTO ATTIVITÀ A - INFRASTRUTTURE RICOGNIZIONE RETI E IMPIANTI COMPLETATA RICOGNIZIONE STATO DI
AVANZAMENTO ATTIVITÀ CONFRONTO TECNICO Incontro con i Comuni delle Aree Omogenee Cuneo, 08.05.2017 AVANZAMENTO ATTIVITÀ A - INFRASTRUTTURE RICOGNIZIONE RETI E IMPIANTI COMPLETATA RICOGNIZIONE STATO DI
ACQUA RISORSA VITALE INCONTRO DEL PER. IND. ETTORE ACERBIS ING. ANGELA BENETTI UFFICIO SERVIZIO DI MISURA GARDA UNO SPA
 ACQUA RISORSA VITALE INCONTRO DEL 17.10.17 PER. IND. ETTORE ACERBIS ING. ANGELA BENETTI UFFICIO SERVIZIO DI MISURA GARDA UNO SPA PROGRAMMA ACQUEDOTTO Principi generali, commento dimensionamento, diametri,
ACQUA RISORSA VITALE INCONTRO DEL 17.10.17 PER. IND. ETTORE ACERBIS ING. ANGELA BENETTI UFFICIO SERVIZIO DI MISURA GARDA UNO SPA PROGRAMMA ACQUEDOTTO Principi generali, commento dimensionamento, diametri,
REGIONE PIEMONTE BU10 06/03/2014
 REGIONE PIEMONTE BU10 06/03/2014 Codice DB1014 D.D. 12 dicembre 2013, n. 536 Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Veli", ubicato
REGIONE PIEMONTE BU10 06/03/2014 Codice DB1014 D.D. 12 dicembre 2013, n. 536 Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Veli", ubicato
USO IRRIGUO. Portata media. (l/s) Portata
 SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-IRR) USO IRRIGUO PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri quantitativi
SCHEDA TECNICA PER L ADEGUAMENTO DELLE UTENZE AL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) (STAP-IRR) USO IRRIGUO PARTE PRIMA Esame di conformità dell utenza con i parametri quantitativi
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE Comune di Ravenna Compilatore: GEB srl IN SE SR
 Aggiornato al: 18.09.2009 SCENARI DI EVENTO pag. 2.1 2 SCENARI DI EVENTO Il primo passo nella redazione di un Piano di Emergenza di Protezione Civile si realizza con la creazione degli Scenari di Evento.
Aggiornato al: 18.09.2009 SCENARI DI EVENTO pag. 2.1 2 SCENARI DI EVENTO Il primo passo nella redazione di un Piano di Emergenza di Protezione Civile si realizza con la creazione degli Scenari di Evento.
CATALOGO SERVIZI TECNICI DI DISTRIBUZIONE GAS. Rev. 00 del 01/01/17
 CATALOGO SERVIZI TECNICI DI DISTRIBUZIONE GAS Rev. 00 del 01/01/17 INDICE 1 OGGETTO DEL CATALOGO... 3 1.1 Scopo e campo di applicazione... 3 1.2 Validità... 3 2 GLOSSARIO... 3 2.1 Definizioni... 3 3 GENERALITA...
CATALOGO SERVIZI TECNICI DI DISTRIBUZIONE GAS Rev. 00 del 01/01/17 INDICE 1 OGGETTO DEL CATALOGO... 3 1.1 Scopo e campo di applicazione... 3 1.2 Validità... 3 2 GLOSSARIO... 3 2.1 Definizioni... 3 3 GENERALITA...
ISTRUZIONI SULLA RELAZIONE TECNICA E SUGLI ALLEGATI VALIDE PER TUTTI GLI USI RELAZIONE TECNICA
 ISTRUZIONI SULLA RELAZIONE TECNICA E SUGLI ALLEGATI VALIDE PER TUTTI GLI USI RELAZIONE TECNICA Attenzione: - la relazione tecnica deve essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico in formato
ISTRUZIONI SULLA RELAZIONE TECNICA E SUGLI ALLEGATI VALIDE PER TUTTI GLI USI RELAZIONE TECNICA Attenzione: - la relazione tecnica deve essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico in formato
DGP n.204/2015 DISPOSIZIONI DI SICUREZZA IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOGGETTI A CONCESSIONE
 Abteilung 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Amt 29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung Ripartizione 29 Agenzia provinciale per l ambiente e la tutela del clima Ufficio 29.11 Ufficio gestione
Abteilung 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Amt 29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung Ripartizione 29 Agenzia provinciale per l ambiente e la tutela del clima Ufficio 29.11 Ufficio gestione
Emergenza idrica 2017 Contesto, misure, azioni. Bari, 22 novembre 2017
 Contesto, misure, azioni Bari, 22 novembre 2017 GLI SCHEMI IDRICI Il sistema dei grandi vettori Il sistema integrato di approvvigionamento e trasporto è tra i più lunghi del mondo: 5.000 km. Sei schemi
Contesto, misure, azioni Bari, 22 novembre 2017 GLI SCHEMI IDRICI Il sistema dei grandi vettori Il sistema integrato di approvvigionamento e trasporto è tra i più lunghi del mondo: 5.000 km. Sei schemi
1) nuove domande, domande di rinnovo
 1) nuove domande, domande di rinnovo RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, dovrà contenere: i motivi per cui viene chiesto il rinnovo della concessione principali
1) nuove domande, domande di rinnovo RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, dovrà contenere: i motivi per cui viene chiesto il rinnovo della concessione principali
Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Urbanistica ed Ambiente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche
 Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Urbanistica ed Ambiente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche Bilanci idrici Relazione Tecnica I bacini di primo livello secondari - ILLASI - ISARCO - Ing. Mirko
Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Urbanistica ed Ambiente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche Bilanci idrici Relazione Tecnica I bacini di primo livello secondari - ILLASI - ISARCO - Ing. Mirko
WATER SAFETY PLAN. La rete di distribuzione: possibile «catalizzatore» in caso di contaminazione
 WATER SAFETY PLAN La rete di distribuzione: possibile «catalizzatore» in caso di contaminazione Relatore: Massimo Chignola Responsabile Efficienza Reti Road map RETE DI DISTRIBUZIONE: ANALISI DEI RISCHI
WATER SAFETY PLAN La rete di distribuzione: possibile «catalizzatore» in caso di contaminazione Relatore: Massimo Chignola Responsabile Efficienza Reti Road map RETE DI DISTRIBUZIONE: ANALISI DEI RISCHI
Il sistema di supervisione come ausilio nella ricerca attiva delle perdite
 Il sistema di supervisione come ausilio nella ricerca attiva delle perdite Giuseppe Giuliano ATO 5 Piemonte Corrado Calvi Calvi Sistemi Andrea Mesturini Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato Forum Telecontrollo
Il sistema di supervisione come ausilio nella ricerca attiva delle perdite Giuseppe Giuliano ATO 5 Piemonte Corrado Calvi Calvi Sistemi Andrea Mesturini Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato Forum Telecontrollo
I corpi idrici termali (testo adottato) (In corsivo le aggiunte, barrate le frasi eliminate)
 10.1.6 I corpi idrici termali (testo vigente) 10.1.6 I corpi idrici termali (testo adottato) (In corsivo le aggiunte, barrate le frasi eliminate) 10.1.6 I corpi idrici termali (testo con modifiche proposte
10.1.6 I corpi idrici termali (testo vigente) 10.1.6 I corpi idrici termali (testo adottato) (In corsivo le aggiunte, barrate le frasi eliminate) 10.1.6 I corpi idrici termali (testo con modifiche proposte
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI CALDONAZZO
 COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI CALDONAZZO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Dott. Ing. ANGELO CANTATORE Dott. Ing. CLAUDIO MODENA Dott. Ing. LORENZO RIZZOLI Via Praga 7, 38121 TRENTO web: http://www.etc-eng.it
COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI CALDONAZZO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Dott. Ing. ANGELO CANTATORE Dott. Ing. CLAUDIO MODENA Dott. Ing. LORENZO RIZZOLI Via Praga 7, 38121 TRENTO web: http://www.etc-eng.it
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R.
 Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R. Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R. Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua
IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
 Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E LE NUOVE CONCESSIONI IDRICHE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E MONITORAGGIO
 SEMINARIO IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E LE NUOVE CONCESSIONI IDRICHE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) - ing. Franco Pocher - 5 MAGGIO
SEMINARIO IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E LE NUOVE CONCESSIONI IDRICHE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) - ing. Franco Pocher - 5 MAGGIO
MODELLO MATEMATICO PER L OTTIMIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ASIAGO (VI)
 MODELLO MATEMATICO PER L OTTIMIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ASIAGO (VI) Ing. Loris Pavanetto Ing. Francesco Munari Torino, 14-15 Ottobre 2015 AREA DI STUDIO
MODELLO MATEMATICO PER L OTTIMIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ASIAGO (VI) Ing. Loris Pavanetto Ing. Francesco Munari Torino, 14-15 Ottobre 2015 AREA DI STUDIO
La Pianificazione degli Interventi del Servizio Idrico Integrato da parte del Regolatore Locale.
 Azienda Speciale Ufficio d Ambito della Provincia di Mantova La Pianificazione degli Interventi del Servizio Idrico Integrato da parte del Regolatore Locale. Ing. Francesco Peri Per Servizio Idrico Integrato
Azienda Speciale Ufficio d Ambito della Provincia di Mantova La Pianificazione degli Interventi del Servizio Idrico Integrato da parte del Regolatore Locale. Ing. Francesco Peri Per Servizio Idrico Integrato
LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO
 LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO Valido per il CRITERIO n. 1 e 2 (da consegnare entro il 7 agosto 2006) 1. DESCRIZIONE DELLA DERIVAZIONE IN ATTO 1.1 Inquadramento geografico della derivazione in
LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO Valido per il CRITERIO n. 1 e 2 (da consegnare entro il 7 agosto 2006) 1. DESCRIZIONE DELLA DERIVAZIONE IN ATTO 1.1 Inquadramento geografico della derivazione in
Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche. a) Relazione b) Norme di attuazione
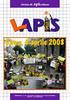 Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata. Gli adeguamenti alle normative europee nell A.T.O. 3 Marche Centro-Macerata
 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata Forum Nazionale sull Acqua Roma Teatro Capranica, 18 ottobre 2011 Gli adeguamenti alle normative europee nell A.T.O. 3 Marche Centro-Macerata
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata Forum Nazionale sull Acqua Roma Teatro Capranica, 18 ottobre 2011 Gli adeguamenti alle normative europee nell A.T.O. 3 Marche Centro-Macerata
MANUALE DELLA SICUREZZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI (CON RIFERIMENTO A TECNICHE ANTINTRUSIONE ED ANTITERRORISMO)
 Pagina 1 di 8 MANUALE DELLA SICUREZZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI (CON RIFERIMENTO A TECNICHE ANTINTRUSIONE ED ANTITERRORISMO) REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE DATA Xx/xx 2016 R Servizio Idrico RSPP R AD
Pagina 1 di 8 MANUALE DELLA SICUREZZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI (CON RIFERIMENTO A TECNICHE ANTINTRUSIONE ED ANTITERRORISMO) REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE DATA Xx/xx 2016 R Servizio Idrico RSPP R AD
Gestione sostenibile delle risorse idriche superficiali e sotterranee INQUINAMENTO DELLE ACQUE PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
 INQUINAMENTO DELLE ACQUE PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA Uno dei temi afferenti alla problematica della Gestione sostenibile delle acque sotterranee e di superficie è quello dell Inquinamento
INQUINAMENTO DELLE ACQUE PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA Uno dei temi afferenti alla problematica della Gestione sostenibile delle acque sotterranee e di superficie è quello dell Inquinamento
d d d d d d d d d d d
 mod. B2 Relazione di fine lavori acque superficiali (Ai sensi dell art. 20 del Regolamento in materia di utilizzazione di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23.06.2008, n. 22-129/Leg.) PROVINCIA AUTONOMA
mod. B2 Relazione di fine lavori acque superficiali (Ai sensi dell art. 20 del Regolamento in materia di utilizzazione di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23.06.2008, n. 22-129/Leg.) PROVINCIA AUTONOMA
ALLEGATOA alla Dgr n del 14 ottobre 2014 pag. 1/6
 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1874 del 14 ottobre 2014 pag. 1/6 Procedure di indirizzo regionali per il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano con riferimento alla
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1874 del 14 ottobre 2014 pag. 1/6 Procedure di indirizzo regionali per il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano con riferimento alla
Ferrara da bere: i controlli fra tradizione e innovazione
 Ferrara da bere: i controlli fra tradizione e innovazione Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione Direttore Dott. Giuseppe Cosenza Ferrara 09.06.2010 Perché controllare
Ferrara da bere: i controlli fra tradizione e innovazione Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione Direttore Dott. Giuseppe Cosenza Ferrara 09.06.2010 Perché controllare
Corrado Calvi. Andrea Mesturini. AssoAutomazione Associazione Italiana Automazione e Misura
 Telecontrollo ed Efficienza della rete idrica: la determinazione delle dispersioni tramite l analisi automatica dei dati raccolti di sistemi di supervisione Corrado Calvi Calvi Sistemi Andrea Mesturini
Telecontrollo ed Efficienza della rete idrica: la determinazione delle dispersioni tramite l analisi automatica dei dati raccolti di sistemi di supervisione Corrado Calvi Calvi Sistemi Andrea Mesturini
Allegato A alla delibera n. 138/00
 Allegato A alla delibera n. 138/00 DIRETTIVA AL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE PER L ADOZIONE DI REGOLE TECNICHE PER LA MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA E DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO AI SENSI
Allegato A alla delibera n. 138/00 DIRETTIVA AL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE PER L ADOZIONE DI REGOLE TECNICHE PER LA MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA E DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO AI SENSI
ALLEGATO 5 PROCEDIMENTI PER L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI QUALITA' E D' IDONEITA' D'USO
 ALLEGATO 5 PROCEDIMENTI PER L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI QUALITA' E D' IDONEITA' D'USO 1- PROCEDIMENTO: ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI QUALITA' PER ACQUE DI NUOVA UTILIZZAZIONE Titolarità: Dipartimento di
ALLEGATO 5 PROCEDIMENTI PER L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI QUALITA' E D' IDONEITA' D'USO 1- PROCEDIMENTO: ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI QUALITA' PER ACQUE DI NUOVA UTILIZZAZIONE Titolarità: Dipartimento di
ISTANZA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE (*) DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI
 ISTANZA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE (*) DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI ai sensi del R.D. 11.12.1933 N. 1775 e della L. 05.01.1994 n. 36 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ISTANZA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE (*) DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI ai sensi del R.D. 11.12.1933 N. 1775 e della L. 05.01.1994 n. 36 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
e rischio idraulico Applicazione alle reti fognarie Invarianza idraulica, idrologica Ruolo del gestore Crema, 23 maggio 2019
 Invarianza idraulica, idrologica e rischio idraulico Ruolo del gestore Applicazione alle reti fognarie ing. Sara Fertonani Servizio Fognatura di Padania Acque SpA Crema, 23 maggio 2019 1 Gestore unico
Invarianza idraulica, idrologica e rischio idraulico Ruolo del gestore Applicazione alle reti fognarie ing. Sara Fertonani Servizio Fognatura di Padania Acque SpA Crema, 23 maggio 2019 1 Gestore unico
DELIBERAZIONE N. 60/1 DEL
 Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali". Programma di Intervento: 9 - Infrastrutture - POR FESR 2014-2020 Asse VI, Azione 6.3.1. Approvazione
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali". Programma di Intervento: 9 - Infrastrutture - POR FESR 2014-2020 Asse VI, Azione 6.3.1. Approvazione
ASL TERAMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
 ASL TERAMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE P.O.S. 01 Protocollo FORNITURA DI ACQUE POTABILI MEDIANTE Revisione N. Pag. 1 di 7 Emessa il 10 maggio 2007 Predisposta
ASL TERAMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE P.O.S. 01 Protocollo FORNITURA DI ACQUE POTABILI MEDIANTE Revisione N. Pag. 1 di 7 Emessa il 10 maggio 2007 Predisposta
Piano Operativo Triennale
 Piano Operativo Triennale 2015-2017 Ufficio d Ambito della Provincia di Monza e Brianza Luglio 2015 1 Indice Il Piano d Ambito di Monza e Brianza e Piano degli Interventi 2014-2017... 3 Le variazioni necessarie
Piano Operativo Triennale 2015-2017 Ufficio d Ambito della Provincia di Monza e Brianza Luglio 2015 1 Indice Il Piano d Ambito di Monza e Brianza e Piano degli Interventi 2014-2017... 3 Le variazioni necessarie
DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D ACQUA
 Alla Direzione centrale ambiente ed energia Servizio gestione risorse idriche Sede di : ambiente@certregione.fvg.it MARCA DA BOLLO Euro 16,00 Per domande in forma cartacea. Per domande presentate via allegare
Alla Direzione centrale ambiente ed energia Servizio gestione risorse idriche Sede di : ambiente@certregione.fvg.it MARCA DA BOLLO Euro 16,00 Per domande in forma cartacea. Per domande presentate via allegare
INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 1 3 TERMINI E DEFINIZIONI 3
 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 1 3 TERMINI E DEFINIZIONI 3 4 SIMBOLI 4 4.1 Tubazioni... 4 4.2 Guarnizioni per tubazioni... 4 4.3 Accessori per tubazioni... 5 4.4 Valvolame...
INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 1 3 TERMINI E DEFINIZIONI 3 4 SIMBOLI 4 4.1 Tubazioni... 4 4.2 Guarnizioni per tubazioni... 4 4.3 Accessori per tubazioni... 5 4.4 Valvolame...
Maurizio Giugni Problemi di pianificazione e gestione delle risorse idriche.
 Maurizio Giugni Problemi di pianificazione e gestione delle risorse idriche. 1 Lezione n. Parole chiave: Gestione risorse idriche. Disponibilità e fabbisogni. Corso di Laurea: Ingegneria per l Ambiente
Maurizio Giugni Problemi di pianificazione e gestione delle risorse idriche. 1 Lezione n. Parole chiave: Gestione risorse idriche. Disponibilità e fabbisogni. Corso di Laurea: Ingegneria per l Ambiente
CRITERI E PROCEDURE PER L ESECUZIONE DEI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI DELLA TOSCANA
 Allegato D CRITERI E PROCEDURE PER L ESECUZIONE DEI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI DELLA TOSCANA Il presente allegato definisce i criteri e le procedure
Allegato D CRITERI E PROCEDURE PER L ESECUZIONE DEI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI DELLA TOSCANA Il presente allegato definisce i criteri e le procedure
La gestione della risorsa idrica in house l esperienza di APM. Relatore: Dott. Giorgio Piergiacomi Macerata, 12 luglio 2019
 La gestione della risorsa idrica in house l esperienza di APM Relatore: Dott. Giorgio Piergiacomi Macerata, 12 luglio 2019 11 1 1 12 2 2 L acqua è una risorsa preziosa ma limitata Sebbene il 72% della
La gestione della risorsa idrica in house l esperienza di APM Relatore: Dott. Giorgio Piergiacomi Macerata, 12 luglio 2019 11 1 1 12 2 2 L acqua è una risorsa preziosa ma limitata Sebbene il 72% della
CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO
 CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO Obiettivi generali M1 M2 M3 Ogni impianto a tecnologia complessa deve essere progettato, realizzato e condotto secondo i principi della garanzia della qualità,
CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO Obiettivi generali M1 M2 M3 Ogni impianto a tecnologia complessa deve essere progettato, realizzato e condotto secondo i principi della garanzia della qualità,
Documentazione da allegare alla domanda l.r. n. 6 del 31 marzo procedura valutativa
 1. ACQUISTO TERRENO E COSTRUZIONE 1. Documentazione relativa all acquisto con dati catastali e superfici del terreno oggetto di acquisto; 2. Copia del progetto definitivo, nella forma prevista all ottenimento
1. ACQUISTO TERRENO E COSTRUZIONE 1. Documentazione relativa all acquisto con dati catastali e superfici del terreno oggetto di acquisto; 2. Copia del progetto definitivo, nella forma prevista all ottenimento
Il telecontrollo dei distretti idrici di una località turistica: uno strumento a supporto del risparmio idrico e dell efficienza del servizio.
 Telecontrollo: uno strumento per il risparmio e l efficienza Il telecontrollo dei distretti idrici di una località turistica: uno strumento a supporto del risparmio idrico e dell efficienza del servizio.
Telecontrollo: uno strumento per il risparmio e l efficienza Il telecontrollo dei distretti idrici di una località turistica: uno strumento a supporto del risparmio idrico e dell efficienza del servizio.
Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)
 Derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 18.6.2 Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia Concessioni per la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche illimitato 18.6.2 Agenzia
Derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 18.6.2 Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia Concessioni per la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche illimitato 18.6.2 Agenzia
Bollettino Ufficiale n. 36/I-II del 04/09/2012 / Amtsblatt Nr. 36/I-II vom 04/09/
 Bollettino Ufficiale n. 36/I-II del 04/09/2012 / Amtsblatt Nr. 36/I-II vom 04/09/2012 99 80815 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del
Bollettino Ufficiale n. 36/I-II del 04/09/2012 / Amtsblatt Nr. 36/I-II vom 04/09/2012 99 80815 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del
SCHEDA - TIPO DEI PROGETTI
 Sezione 1 - Informazioni generali 1.0 Codici d'identificazione del progetto 2 4 1 1 1 F 0 7 1.1 Denominazione del progetto Completamento fognature nelle località collinari del Comune di Valdagno, anche
Sezione 1 - Informazioni generali 1.0 Codici d'identificazione del progetto 2 4 1 1 1 F 0 7 1.1 Denominazione del progetto Completamento fognature nelle località collinari del Comune di Valdagno, anche
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA. "Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico".
 LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 03-06-2002 REGIONE BASILICATA "Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico". Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 03-06-2002 REGIONE BASILICATA "Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico". Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA La domanda va presentata in una copia originale con marca da bollo di 16,00 e due copie. Nel caso
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA La domanda va presentata in una copia originale con marca da bollo di 16,00 e due copie. Nel caso
Procedura del Sistema Qualità. Gestione operativa dei lavori. Pubblico Servizio Distribuzione Metano ELENCO PREZZI PRESTAZIONI
 Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.E.E.G.S.I. n. 108/06 del 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di MONTE PORZIO (PU) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito www.sadorireti.it - 2017 - Prezzi
Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.E.E.G.S.I. n. 108/06 del 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di MONTE PORZIO (PU) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito www.sadorireti.it - 2017 - Prezzi
Relazione sullo Stato dell Ambiente Comuni di Capurso (capofila), Cellamare e Triggiano Bozza Aprile 2006
 3. RISORSE IDRICHE 3.1. Inquadramento Il sistema idrografico del territorio della Provincia di Bari è caratterizzato dalle lame, incisioni carsiche che, ormai del tutto prive di acque, costituiscono impluvi
3. RISORSE IDRICHE 3.1. Inquadramento Il sistema idrografico del territorio della Provincia di Bari è caratterizzato dalle lame, incisioni carsiche che, ormai del tutto prive di acque, costituiscono impluvi
Sez.6 Misurazioni, analisi e miglioramento
 Pagina 1 di 6 Sez.6 Misurazioni, analisi e miglioramento 6.1 REQUISITI GENERALI L ACA determina, pianifica ed attua i processi di misurazione, di monitoraggio, di analisi e di miglioramento per garantire
Pagina 1 di 6 Sez.6 Misurazioni, analisi e miglioramento 6.1 REQUISITI GENERALI L ACA determina, pianifica ed attua i processi di misurazione, di monitoraggio, di analisi e di miglioramento per garantire
Regione Lombardia. Giunta Regionale Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali
 Regione Lombardia Giunta Regionale Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali Criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica
Regione Lombardia Giunta Regionale Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali Criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013 475/2013/E/EEL AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA RELATIVA ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione
DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013 475/2013/E/EEL AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA RELATIVA ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione
LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO
 LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO ARTICOLO 1. Oggetto delle linee guida e definizioni. Il presente
LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO ARTICOLO 1. Oggetto delle linee guida e definizioni. Il presente
AUTORITA INTERREGIONALE
 AUTORITA INTERREGIONALE di BACINO della BASILICATA www.adb.basilicata.it Piano di bacino stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale NORME DI ATTUAZIONE Collaborazione Sogesid S.p.A. Consulenza
AUTORITA INTERREGIONALE di BACINO della BASILICATA www.adb.basilicata.it Piano di bacino stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale NORME DI ATTUAZIONE Collaborazione Sogesid S.p.A. Consulenza
Autorità Idrica Toscana. Relazione illustrativa sulla Carta di Qualità dei Servizi di Acque
 Relazione illustrativa sulla Carta di Qualità dei Servizi di Acque 1 1. Premessa I livelli dei servizi che devono garantire i gestori sono regolamentati da due principali strumenti, previsti dalle Convenzioni
Relazione illustrativa sulla Carta di Qualità dei Servizi di Acque 1 1. Premessa I livelli dei servizi che devono garantire i gestori sono regolamentati da due principali strumenti, previsti dalle Convenzioni
TABELLE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
 TABELLE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DATI DI SISTEMA tot. 300 2016 2017 NOTE Abitanti residenti serviti [Acquedotto] Numero utenti serviti [Acquedotto] Ripartizione dei volumi prelevati per tipologia
TABELLE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DATI DI SISTEMA tot. 300 2016 2017 NOTE Abitanti residenti serviti [Acquedotto] Numero utenti serviti [Acquedotto] Ripartizione dei volumi prelevati per tipologia
La pianificazione regionale delle risorse idriche: il settore civile
 La pianificazione regionale delle risorse idriche: il settore civile CONVEGNO Cambiamenti climatici, efficientamento dell uso dell acqua, contrasto delle rotture delle reti di acquedotto Bologna, 19 luglio
La pianificazione regionale delle risorse idriche: il settore civile CONVEGNO Cambiamenti climatici, efficientamento dell uso dell acqua, contrasto delle rotture delle reti di acquedotto Bologna, 19 luglio
REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO.
 REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO. Dott. Agr. Giuseppe Castaldi Regione Campania - UOD Infrastrutture Rurali ed Aree Interne (cod. 50.07.03) Normativa di contesto
REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO. Dott. Agr. Giuseppe Castaldi Regione Campania - UOD Infrastrutture Rurali ed Aree Interne (cod. 50.07.03) Normativa di contesto
Corso di Infrastrutture Idrauliche II
 Corso di Infrastrutture Idrauliche II a.a. 2006-2007 Laurea in Ingegneria Civile Facoltà di Ingegneria Prof.ssa Elena Volpi Ricevimento: Materiale didattico: evolpi@uniroma3.it martedì 15:30-16:30, Dipartimento
Corso di Infrastrutture Idrauliche II a.a. 2006-2007 Laurea in Ingegneria Civile Facoltà di Ingegneria Prof.ssa Elena Volpi Ricevimento: Materiale didattico: evolpi@uniroma3.it martedì 15:30-16:30, Dipartimento
Acque sotterranee: l analisi conoscitiva in relazione agli impianti ittici, all industria e all agricoltura
 Acque sotterranee: l analisi conoscitiva in relazione agli impianti ittici, all industria e all agricoltura DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia San Vito al Tagliamento 12 maggio 2015 Il modello
Acque sotterranee: l analisi conoscitiva in relazione agli impianti ittici, all industria e all agricoltura DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia San Vito al Tagliamento 12 maggio 2015 Il modello
ALLEGATO B. ai sensi. degli artt. 5.2.a e 5.3.a della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR
 ALLEGATO B ISTANZA DI DEROGA NEL COMUNE DI CAPENA, PER LA TEMPORANEA ESCLUSIONE, EX ANTE, DALL APPLICAZIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI ASSOCIATI AL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD E DEL MECCANISMO INCENTIVANTE,
ALLEGATO B ISTANZA DI DEROGA NEL COMUNE DI CAPENA, PER LA TEMPORANEA ESCLUSIONE, EX ANTE, DALL APPLICAZIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI ASSOCIATI AL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD E DEL MECCANISMO INCENTIVANTE,
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PTCP 2007
 CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PTCP 2007 Piacenza, Sala del Consiglio Provinciale, 12 febbraio 2008 DAL QUADRO CONOSCITIVO AL PIANO La qualità delle acque superficiali e sotterranee O b i e t t i v i attuare
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PTCP 2007 Piacenza, Sala del Consiglio Provinciale, 12 febbraio 2008 DAL QUADRO CONOSCITIVO AL PIANO La qualità delle acque superficiali e sotterranee O b i e t t i v i attuare
TECNICO SUPERIORE PER I
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE SETTORE AMBIENTE TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI IDRICI STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 73 UNITÀ
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE SETTORE AMBIENTE TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI IDRICI STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 73 UNITÀ
ISTRUZIONI SULLA RELAZIONE TECNICA E SUGLI ALLEGATI VALIDE PER TUTTI GLI USI RELAZIONE TECNICA
 ISTRUZIONI SULLA RELAZIONE TECNICA E SUGLI ALLEGATI VALIDE PER TUTTI GLI USI RELAZIONE TECNICA Attenzione: - la relazione tecnica deve essere a firma di un tecnico abilitato; - la relazione tecnica deve
ISTRUZIONI SULLA RELAZIONE TECNICA E SUGLI ALLEGATI VALIDE PER TUTTI GLI USI RELAZIONE TECNICA Attenzione: - la relazione tecnica deve essere a firma di un tecnico abilitato; - la relazione tecnica deve
La telegestione e la distrettualizzazione quali fondamentali strumenti per il risparmio idrico ed energetico.
 La telegestione e la distrettualizzazione quali fondamentali strumenti per il risparmio idrico ed energetico. Mauro Rossetti Product Manager LACROIX Softec Forum Telecontrollo Reti Acqua Gas ed Elettriche
La telegestione e la distrettualizzazione quali fondamentali strumenti per il risparmio idrico ed energetico. Mauro Rossetti Product Manager LACROIX Softec Forum Telecontrollo Reti Acqua Gas ed Elettriche
Relazione Tecnica Specialistica : progetto rete idrica antincendio
 Relazione Tecnica Specialistica : progetto rete idrica antincendio Committente: COMUNE DI CEVA Edificio: Fabbricato adibito a scuola media inferiore sita in Via Leopoldo Marenco, 1-12073 CEVA (CN) Progettista:
Relazione Tecnica Specialistica : progetto rete idrica antincendio Committente: COMUNE DI CEVA Edificio: Fabbricato adibito a scuola media inferiore sita in Via Leopoldo Marenco, 1-12073 CEVA (CN) Progettista:
ATO 2 PIANO GESTIONE ESTIVA 2019
 ATO 2 PIANO GESTIONE ESTIVA 2019 1 AGENDA CONTESTO GENERALE DISPONIBILITA IDRICA SCENARIO ROMA - FIUMICINO SCENARIO COMUNI ATO2 2 Rapporto idrologico 2019 L analisi dei dati pluviometrici nel periodo settembre
ATO 2 PIANO GESTIONE ESTIVA 2019 1 AGENDA CONTESTO GENERALE DISPONIBILITA IDRICA SCENARIO ROMA - FIUMICINO SCENARIO COMUNI ATO2 2 Rapporto idrologico 2019 L analisi dei dati pluviometrici nel periodo settembre
Procedura del Sistema Qualità. Gestione operativa dei lavori. Pubblico Servizio Distribuzione Metano ELENCO PREZZI PRESTAZIONI
 Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.R.E.R.A. n. 108/06 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di ARCEVIA (AN) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito www.sadorireti.it - 2019 - Prezzi in vigore
Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.R.E.R.A. n. 108/06 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di ARCEVIA (AN) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito www.sadorireti.it - 2019 - Prezzi in vigore
L esperienza di ricerca e controllo delle perdite idriche di Gruppo CAP
 L esperienza di ricerca e controllo delle perdite idriche di Gruppo CAP Labirinto d Acque 2018 22 marzo 2018 Massimo Chignola Responsabile Efficientamento Sistemi Acquedotto IL GRUPPO CAP IL GRUPPO CAP
L esperienza di ricerca e controllo delle perdite idriche di Gruppo CAP Labirinto d Acque 2018 22 marzo 2018 Massimo Chignola Responsabile Efficientamento Sistemi Acquedotto IL GRUPPO CAP IL GRUPPO CAP
SCHEDA «H»: SCARICHI IDRICI
 N Scarico finale 1 Totale punti di scarico finale N Attuali:2 - dal 30.06.2012:3 Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza 2 1 Servizi igienici continuo SCHEDA «H»: SCARICHI IDRICI Sezione H1 - SCARICHI
N Scarico finale 1 Totale punti di scarico finale N Attuali:2 - dal 30.06.2012:3 Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza 2 1 Servizi igienici continuo SCHEDA «H»: SCARICHI IDRICI Sezione H1 - SCARICHI
TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI IDRICI
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE SETTORE AMBIENTE TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI IDRICI STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI IDRICI DESCRIZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE SETTORE AMBIENTE TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI IDRICI STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI IDRICI DESCRIZIONE
REG. (UE) 1305/2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE MISURA
 REG. (UE) 1305/2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l ammodernamento
REG. (UE) 1305/2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l ammodernamento
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE. Water Safety Plans. Omegna, 18/12/2017. Dr.ssa Renza Berruti
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE Water Safety Plans Omegna, 18/12/2017 Dr.ssa Renza Berruti L OMS, già nella terza edizione delle linee guida per la qualità dell acqua
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE Water Safety Plans Omegna, 18/12/2017 Dr.ssa Renza Berruti L OMS, già nella terza edizione delle linee guida per la qualità dell acqua
ELABORATO Rapporto Ambientale. Monitoraggio. Adozione 2018
 ELABORATO Adozione 2018 Rapporto Ambientale Monitoraggio 13.3 7 Monitoraggio Il monitoraggio costituisce l attività di controllo degli effetti del Piano Operativo, prodotti durante il suo periodo di validità
ELABORATO Adozione 2018 Rapporto Ambientale Monitoraggio 13.3 7 Monitoraggio Il monitoraggio costituisce l attività di controllo degli effetti del Piano Operativo, prodotti durante il suo periodo di validità
INDICE. Premessa... 13
 INDICE Premessa... 13 1. Il regolamento (UE) 305/2011 Prodotti da Costruzione... 17 1.1. Definizioni... 17 1.2. Il campo di applicazione e le esclusioni... 18 1.3. I requisiti di base delle opere (CPR)
INDICE Premessa... 13 1. Il regolamento (UE) 305/2011 Prodotti da Costruzione... 17 1.1. Definizioni... 17 1.2. Il campo di applicazione e le esclusioni... 18 1.3. I requisiti di base delle opere (CPR)
ISTANZA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE (*) DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
 ISTANZA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE (*) DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE ai sensi del R.D. 11.12.1933 N. 1775 e della L.R. 30.04.1996 n. 22 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ISTANZA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE (*) DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE ai sensi del R.D. 11.12.1933 N. 1775 e della L.R. 30.04.1996 n. 22 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SMART WATER NETWORKS ACCADUEO 2016
 Per il gestore di un acquedotto è fondamentale conoscere ed eliminare le perdite idriche. Persino laddove vi è abbondanza d acqua ed il servizio idrico è garantito, la presenza di perdite comporta effetti
Per il gestore di un acquedotto è fondamentale conoscere ed eliminare le perdite idriche. Persino laddove vi è abbondanza d acqua ed il servizio idrico è garantito, la presenza di perdite comporta effetti
