LA DECOSTRUZIONE DELLA COMPLESSITÀ
|
|
|
- Margherita Salvadori
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1
2 STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SERGIO BARILE PRIMIANO DI NAUTA FRANCESCA IANDOLO LA DECOSTRUZIONE DELLA COMPLESSITÀ Novembre 2016 STUDI MOA
3 STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Presentazione della Collana La Collana di Management e Organizzazione Aziendale, diretta dal Prof. Marcello Martinez, pubblica saggi e monografie frutto del lavoro di ricerca di studiosi italiani ed internazionali nel campo delle scienze manageriali ed organizzative. La Collana si propone di contribuire alla crescita e alla diffusione della conoscenza dei temi del management e dell organizzazione aziendale con l obiettivo di favorire l approccio multidisciplinare, eliminando le barriere settoriali e promuovendo la costituzione di un luogo scientifico e di pensiero, ove gli autori di ricerche originali possano trovare un opportunità per dare ampia diffusione ai loro contributi. Sebbene i volumi della Collana sono prevalentemente pubblicati in lingua italiana le trattazioni sono collocate nei più ampi stream di ricerca internazionale. Principi fondanti della Collana sono l originalità e il rigore metodologico. Le proposte, dopo l accurata revisione del Comitato Scientifico, saranno pubblicate in volumi su supporto fisico a testo stampato e/o altro tipo di supporto statico (ebook). Le proposte dovranno pervenire all redazione@collanamoa.it in formato Word (Times New Roman 12 interlinea 1), o pdf. I contributi saranno sottoposti ad un doppio referaggio anonimo con all ausilio di referee qualificati e di riconosciuto prestigio. Sono accettati contributi in lingua italiana e inglese.
4 Procedura di referaggio Tutti i volumi della Collana di Management e Organizzazione Aziendale sono soggetti a un processo di double blind review gestito da un componente del Comitato Scientifico della Collana secondo la seguente procedura: al ricevimento del file del manoscritto in formato Word o pdf, sarà verificata la sussistenza delle condizioni per l avvio del processo di referaggio, tra cui il controllo antiplagio; se il risultato di tali verifiche consente l avanzamento del processo, il manoscritto sarà sottoposto all attenzione del Presidente del Comitato Scientifico; il Presidente del Comitato Scientifico, in base alla tematica del manoscritto, assegna il referaggio a due Reviewer o identifica un Editor in seno al Comitato Scientifico che sceglie due Reviewer; i Reviewer, completato il processo di revisione del manoscritto, inviano all Editor un report stabilito secondo il format definito dall Editrice; l Editor riceve i report dei Reviewer e predispone un Editorial Report; l Editorial Report viene inviato all autore; in caso di accettazione senza rilievi, l autore/i potrà pubblicare il volume nella forma in cui è stato inoltrato, ma inviandolo in formato word; in caso di accettazione con riserva, l autore/i potrà apportare le modifiche suggerite e risottomettere il manoscritto in word, per un ulteriore round di referaggio.
5 SOMMARIO Premessa...9 Capitolo I Verso la qualificazione del concetto di complessità Introduzione Elementi prospettici utili all indagine Le dimensioni della complessità nelle discipline sociali e nell economia d impresa Alcune considerazioni di raccordo al capitolo...48 Capitolo II Alcuni esempi di eliminazione della complessità attraverso ricostruzione del contesto problematico Introduzione Alcuni semplici rompicapo logici Il problema dei 9 punti Il problema dell arsenale militare...57
6 Il problema della sequenza numerica Dimostrazione del teorema di Wilson Calcolo del tronco di piramide Trisezione di un angolo con riga e compasso Individuazione del punto di trisezione usando riga e compasso Procedura di trisezione di un qualsivoglia angolo con l utilizzo di un goniometro realizzato sulla base di quanto dimostrato Determinazione dei primi n primi Considerazioni non conclusive Capitolo III L ipotesi costruttivistica della realtà in ottica sistemica Introduzione Prime formulazioni del pensiero sistemico e i concetti fondanti Il consolidamento delle teorie formali Estensione concettuale ai sistemi sociali Il soggetto decisore quale costruttore della realtà Del costruttivismo Degli elementi del pensiero sistemico Del decidere e dell agire / Del sistema vitale Dell ambiente e del contesto Del sistema vitale come varietà informativa...161
7 Capitolo IV Business Management in ottica sistemico vitale Introduzione Un nuovo approccio al processo decisionale Le Categorie valoriali e gli Schemi interpretativi quali fattori di Consonanza e Risonanza Un possibile insieme di Categorie valoriali Le principali Categorie valoriali nelle scelte imprenditoriali Individuazione di Categorie valoriali latenti attraverso l analisi fattoriale Condotta etica Propensione al successo Senso del dovere Focalizzazione sui rapporti e sulle relazioni Ricerca di consenso Orientamento opportunistico Schemi interpretativi di sintesi e loro derivazione Una rappresentazione di sintesi: l albero della conoscenza Capitolo V Introduzione alla fisica della mente Il fenomeno del cambiamento in una varietà informativa (variazione di configurazione) Ipotesi paradigmatica Contenuti...223
8 5.2. La descrizione del fenomeno dell apprendimento: cambiamento di una varietà informativa Il concetto di configurazione La descrizione del fenomeno del cambiamento: cambiamento di una configurazione di varietà informativa Il vettore cambiamento L osservabile consonanza L osservabile risonanza Evoluzione con r costante in modulo: conoscenza da riflessione Il sistema vitale come sistema dinamico Bibliografia Sitografia...275
9 La decostruzione della complessità Sono complessi i problemi non risolvibili attraverso deduzioni logiche automatizzabili da fatti noti (assiomi e teoremi). Kurt Gödel PREMESSA Il volume La decostruzione della complessità è il risultato di un percorso di riflessione volto a sviluppare un interpretazione della complessità utile all analisi delle dinamiche sociali, e basato su una rilettura, talvolta critica, della letteratura sul tema. Dopo aver argomentato sulla necessità di concepire la complessità come relativa a un soggetto percettore, e fortemente influenzata dal contesto di riferimento, prova a ripercorrere considerazioni e conclusioni che sono tipiche nello studio delle organizzazioni, calandole in ambiti di riflessione più ampi, alla ricerca di modelli di validità più generale 1. Introducendo, in 1 L approccio interpretativo utilizzato rispecchia l opinione del fisico americano Richard Feynman che riteneva la dinamica degli eventi riconducibile ad un enorme gioco degli scacchi, in cui i livelli di complessità sono solo apparenti. Una volta note le regole del gioco, per quanto complicate esse siano, il mondo diviene MOA 1/2016 9
10 Sergio Barile, Primiano Di Nauta, Francesca Iandolo particolare, la distinzione tra complessità strutturale e complessità sistemica, si rende possibile l individuazione di elementi utili ai fini di un interpretazione sociologica del concetto: se la complessità strutturale finisce per essere assoggettabile ad una misura quantitativa, la complessità sistemica sfugge a tale possibilità aprendo tuttavia la mente all individuazione di profili interpretativi diversi. L annoso problema della misurazione, importante nella riflessione, trova una chiave interpretativa riconducibile al pensiero di Brillouin, secondo il quale l incertezza del possibile comportamento di un sistema (l informazione che non si possiede) finisce per essere la misura della sua complessità. Emerge, così, con chiarezza quanto il potenziale sia complessivamente prevalente sull attuale 2 ; quindi, quanto la complessità del bosone sia enormemente superiore a quella dell universo. Nel prosieguo della trattazione, l attenzione è focalizzata sul concetto di incertezza, centrale negli studi sulla complessità. Nelle scienze sociali, il concetto di incertezza palesa una difficoltà innanzitutto nella qualificazione dell ambito problematico esperito, poi nell interpretazione e descrizione delle leggi che, in tale ambito, statuiscono i comportamenti dei diversi attori. Tale difficoltà si sostanzia nella necessità di disporre di schemi interpretativi idonei a supportare efficacemente i processi cognitivi. Come si illustrerà nel lavoro, il concetto di schema interpretativo è utile a qualificare come lineare tutto ciò che rientra nel novero di problematiche affrontabili con la dotazione di schemi interpretativi consolidati, e non lineare tutto ciò che caratterizza un problema non comprensibile, inesplorato, e pertanto complesso. Un concetto non nuovo che è appartenuto a menti straordinarie quali quelle di Kurt Gödel e John Von Neumann 3. L accezione proposta riconfigura così la distinzione tra i concetti di lineare e non lineare e offre una chiave interpretativa utile alla lettura dei caratteri della complessità decifrabile e le mosse divengono semplici. 2 Atlan H. (1986). Tra il cristallo e il fumo. Saggio sull organizzazione del vivente, Hopefulmonster, Firenze. 3 Cfr. Gödel K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. I. Monatshefte für Mathematik und Physik, 38, pp Translated in van Heijenoort: From Frege to Gödel. Harvard University Press, 1971; von Neumann J. (1999). Il computer e il cervello. Bompiani. 10 Premessa
11 La decostruzione della complessità emergente e alla ricerca delle relative direttrici generative. Una tale chiave interpretativa, necessaria per governare gli effetti della complessità, conferisce stabilità e solidità al processo interpretativo. In particolare, diviene possibile comprendere le condizioni che concorrono ai cicli sistemici in cui si assiste al succedersi di fasi di perdita di stabilità (emergere di complessità), e fasi di recupero di equilibrio (individuazione di nuovi schemi interpretativi): un circuito virtuoso, quale quello che caratterizza la dinamica attraverso la quale, a partire da leggi e attraverso norme e regole, si sviluppano nuove consuetudini, per poi determinare una evoluzione del contesto e addivenire a nuove leggi da cui norme e regole e così via in una infinita ricorsività. La prima parte del volume introduce alla prospettiva di approccio adottata. Fornisce elementi concettuali e riferimenti in letteratura per giustificare la possibilità (se non l opportunità) di utilizzo di una prospettiva esplicativa alquanto diversa rispetto alle accezioni consolidate che riferiscono a ciò che debba intendersi per complessità. Segue una seconda parte con specifiche elaborazioni ed evidenze empiriche, basate su problemi di geometria elementare e teoria dei numeri, che esemplificano la validità dell approccio adottato, fornendo una casistica interpretativa inusuale; l utilizzo di schemi nuovi, capaci di riconfigurare la complessità presupposta, porta a formulare ipotesi risolutive inusitate. La terza parte espone, in termini introduttivi, una metodologia interpretativa, con applicabilità ampia e generale, che consente di descrivere quelle fasi tipiche che si attraversano quando si vive la complessità, per cui: data una condizione problematica iniziale, si perviene all individuazione di configurazioni evolutive di rappresentazione della situazione problematica vissuta, per poi giungere progressivamente a una soluzione. Nella quarta parte, l approccio prima introdotto è riletto in termini costruttivistici e ne è proposta una rappresentazione che è alla base della riformulazione di assetti e dinamiche di management in ottica sistemico vitale. Una proposta operativa di indirizzi MOA 1/
12 Sergio Barile, Primiano Di Nauta, Francesca Iandolo e prescrizioni utili all individuazione e attuazione di percorsi di cambiamento schematico. Una sintesi introduttiva, per essere più precisi, di una tale proposta operativa, corredata tuttavia da un adeguata dotazione strumentale, utile per affrontare problematiche qualificabili come complesse nella configurazione interpretativa proposta, e che necessitano di modalità di governo e controllo innovative. Conclude il volume una quinta parte, di frontiera, per ceri versi ambiziosa. Una parte certo ricca di spunti innovativi, ma altrettanto periferica rispetto a un campo di studi, quello organizzativo e manageriale, finisce pertanto per recuperare una coerenza tematica soltanto nella mente di studiosi per così dire meno ortodossi ed alla ricerca di nuovi stimoli culturali. Quei lettori che hanno sperimentato e sperimentano un senso di insoddisfazione rispetto alla capacità esplicativa degli schemi di cui dispongono relativamente a tematiche disciplinari in costante (anomala) evoluzione 4. Il tema trattato introduce ad una articolazione di principi, leggi e deduzioni, riassunta nel costrutto fisica della mente 5. L intento primo dello sforzo prodotto è quello di avviare un ipotesi di lavoro indirizzata alla possibilità di sviluppare un framework teorico che, basato su un ambiente logico all interno del quale le varietà informative che qualificano i sistemi realizzano la propria dinamica Vitale, richiama premesse, condizioni e risultanze riconducibili alle consolidate modalità della fisica del mondo materiale. A partire dalla triade percetto sensazione cognizione, viene sviluppato un modello rappresentativo delle dinamiche relazionali e internazionali non degli individui in quanto tali, ma della loro espressione mentale: la configurazione di varietà informativa. Concludo con il precisare che la prima, la terza e la quarta parte del volume sono frutto di elaborazione condivisa tra gli autori. La seconda parte e in particolare, 4 L aggettivo anomalo è inteso qui proprio a qualificare il fatto o fenomeno non riconducibile alla maggior parte dei casi presi in esame. 5 Alcune delle considerazioni, delle concettualizzazioni e delle riflessioni proposte, in particolare per i capitoli I, III, IV sono state già affrontate in altri lavori. Cfr. Barile S. (2009). Verso la qualificazione del concetto di complessità sistemica. Sinergie, vol. 79; Barile S. (2009). Management Sistemico Vitale. Giappichelli, Torino; Barile S., Sancetta G., Saviano M. (2015). Management. Il modello sistemico e le decisioni manageriali. Vol. I, Giappichelli, Torino. 12 Premessa
13 La decostruzione della complessità la quinta parte sono da attribuire al sottoscritto. Ne assumo, pertanto, la piena responsabilità ritrovandomi nel pensiero di Fernando Pessoa, quando significativamente afferma quanto segue: Porto addosso le ferite di tutte le battaglie che ho evitato. Sergio Barile Roma, 6 ottobre 2016 MOA 1/
Marta Maria Montella I MUSEI D IMPRESA HERITAGE E TOTAL RELATIONSHIP MARKETING STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 Marta Maria Montella I MUSEI D IMPRESA HERITAGE E TOTAL RELATIONSHIP MARKETING STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE COMITATO
Marta Maria Montella I MUSEI D IMPRESA HERITAGE E TOTAL RELATIONSHIP MARKETING STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE COMITATO
INDICE CAPITOLO PRIMO IL PENSIERO SISTEMICO
 INDICE Prefazione alla terza edizione............................. pag. XIII Prefazione alla seconda edizione............................» XV Prefazione alla prima edizione.............................»
INDICE Prefazione alla terza edizione............................. pag. XIII Prefazione alla seconda edizione............................» XV Prefazione alla prima edizione.............................»
Indice. Pensare per sistemi 1. dell impresa sistema vitale 67. Capitolo I. Capitolo II. pag.
 Indice Capitolo I Pensare per sistemi 1 1.1. Introduzione 1 1.2. Le prime formulazioni del pensiero sistemico e i concetti fondanti 3 1.3. Il consolidamento delle teorie formali 10 1.4. Estensione concettuale
Indice Capitolo I Pensare per sistemi 1 1.1. Introduzione 1 1.2. Le prime formulazioni del pensiero sistemico e i concetti fondanti 3 1.3. Il consolidamento delle teorie formali 10 1.4. Estensione concettuale
Management. Anno accademico 2017/2018. Dipartimento di Management. Prof. Sergio Barile Prof. Giuseppe Sancetta
 Management Anno accademico 2017/2018 Dipartimento di Management Il docente Prof. Sergio Barile (A-L) Posizione accademica Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P 08) 2 Prof. Giuseppe
Management Anno accademico 2017/2018 Dipartimento di Management Il docente Prof. Sergio Barile (A-L) Posizione accademica Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P 08) 2 Prof. Giuseppe
DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE
 DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE La differenza concettuale tra Decision Making e Problem Solving I possibili ambiti decisionali Proff. Sergio Barile e Giuseppe Sancetta Che cos è
DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE La differenza concettuale tra Decision Making e Problem Solving I possibili ambiti decisionali Proff. Sergio Barile e Giuseppe Sancetta Che cos è
Capitolo III. Verso un interpretazione dell impresa come sistema vitale
 Capitolo III Verso un interpretazione dell impresa come sistema vitale Sommario 1. Considerazioni introduttive 2. La necessità di una matrice concettuale 3. I concetti portanti della matrice concettuale
Capitolo III Verso un interpretazione dell impresa come sistema vitale Sommario 1. Considerazioni introduttive 2. La necessità di una matrice concettuale 3. I concetti portanti della matrice concettuale
DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE
 DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE Il sistema vitale come modello di decisore universale Equivalenza algoritmica tra i percorsi di apprendimento e i percorsi di Decision Making Proff.
DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE Il sistema vitale come modello di decisore universale Equivalenza algoritmica tra i percorsi di apprendimento e i percorsi di Decision Making Proff.
Management. Anno accademico 2016/2017. Dipartimento di Management. Prof. Mario Calabrese
 Management Anno accademico 2016/2017 Dipartimento di Management Obiettivi del corso Il Corso ha l obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze di base indispensabili per il governo e la gestione d
Management Anno accademico 2016/2017 Dipartimento di Management Obiettivi del corso Il Corso ha l obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze di base indispensabili per il governo e la gestione d
Management. Anno accademico 2018/2019. Dipartimento di Management. Prof. Sergio Barile Prof. Giuseppe Sancetta
 Management Anno accademico 2018/2019 Dipartimento di Management Il docente Prof. Sergio Barile (A-L) Posizione accademica Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P 08) 2 Prof. Giuseppe
Management Anno accademico 2018/2019 Dipartimento di Management Il docente Prof. Sergio Barile (A-L) Posizione accademica Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P 08) 2 Prof. Giuseppe
MATEMATICHE COMPLEMENTARI
 MATEMATICHE COMPLEMENTARI Il settore include competenze e ambiti di ricerca relativi ai fondamenti, alla storiae alla didattica della matematica anche concernenti lo sviluppo di metodi e tecnologie innovativi
MATEMATICHE COMPLEMENTARI Il settore include competenze e ambiti di ricerca relativi ai fondamenti, alla storiae alla didattica della matematica anche concernenti lo sviluppo di metodi e tecnologie innovativi
Management. Dipartimento di Management. Prof. Sergio Barile. Università Sapienza 23/09/2014
 Management Dipartimento di Management Il docente Prof. Sergio Barile (A-L) 2 Obiettivi del corso Il Corso ha l obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze di base indispensabili per il governo e la
Management Dipartimento di Management Il docente Prof. Sergio Barile (A-L) 2 Obiettivi del corso Il Corso ha l obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze di base indispensabili per il governo e la
Obiettivo della ricerca e oggetto di analisi
 Analisi dei comportamenti imprenditoriali ed organizzativi delle imprese del comparto del materiale rotabile nella realtà produttiva pistoiese e definizione di di politiche di di intervento a sostegno
Analisi dei comportamenti imprenditoriali ed organizzativi delle imprese del comparto del materiale rotabile nella realtà produttiva pistoiese e definizione di di politiche di di intervento a sostegno
L impresa sistema vitale e la complessità
 Lezione 24 L impresa sistema vitale e la complessità prof. ssa Clara Bassano Corso di Economia e Gestione delle Imprese IV 1 A.A. 2005-2006 Sommario 1. L azione di governo in un contesto complesso 2. La
Lezione 24 L impresa sistema vitale e la complessità prof. ssa Clara Bassano Corso di Economia e Gestione delle Imprese IV 1 A.A. 2005-2006 Sommario 1. L azione di governo in un contesto complesso 2. La
DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE
 DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE La differenza concettuale tra Decision Making e Problem Solving I possibili ambiti decisionali Proff. Sergio Barile e Giuseppe Sancetta Che cos è
DECISIONI E SCELTE D IMPRESA IN OTTICA SISTEMICO VITALE La differenza concettuale tra Decision Making e Problem Solving I possibili ambiti decisionali Proff. Sergio Barile e Giuseppe Sancetta Che cos è
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO. Rischio, vulnerabilità e resilienza territoriale: il caso delle province italiane
 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dottorato di ricerca in Politica Economica ciclo XXIV S.S.D: SECS-S/05; ICAR/21; SECS-P/02 Rischio, vulnerabilità e resilienza territoriale: il caso delle province
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Dottorato di ricerca in Politica Economica ciclo XXIV S.S.D: SECS-S/05; ICAR/21; SECS-P/02 Rischio, vulnerabilità e resilienza territoriale: il caso delle province
ORGANIZZAZIONE E OPERATIONS MANAGEMENT NEI SISTEMI OSPEDALIERI
 Debora Sarno ORGANIZZAZIONE E OPERATIONS MANAGEMENT NEI SISTEMI OSPEDALIERI STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE COMITATO
Debora Sarno ORGANIZZAZIONE E OPERATIONS MANAGEMENT NEI SISTEMI OSPEDALIERI STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STUDI MOA COLLANA DI MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE COMITATO
Capitolo VII. La struttura operativa
 Capitolo VII La struttura operativa Sommario 1. Considerazioni introduttive 2. Il concetto di struttura operativa 3. Le diverse configurazioni 4. La progettazione della struttura operativa l idea imprenditoriale
Capitolo VII La struttura operativa Sommario 1. Considerazioni introduttive 2. Il concetto di struttura operativa 3. Le diverse configurazioni 4. La progettazione della struttura operativa l idea imprenditoriale
Management sistemico vitale
 Management sistemico vitale Scelte e decisioni in ambito complesso Corso di Management Prof Sergio Barile Prof. Giuseppe Sancetta 10/10/2016 Lezione numero 5 1 Dalla percezione all emersione del nuovo
Management sistemico vitale Scelte e decisioni in ambito complesso Corso di Management Prof Sergio Barile Prof. Giuseppe Sancetta 10/10/2016 Lezione numero 5 1 Dalla percezione all emersione del nuovo
REGOLAMENTO DELLA COLLANA QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO
 REGOLAMENTO DELLA COLLANA QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Art. 1 Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico 1. Il Collegio
REGOLAMENTO DELLA COLLANA QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Art. 1 Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico 1. Il Collegio
INDICE SOMMARIO CAPITOLO I LA MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA NELL ELABORAZIONE DOTTRINALE
 INDICE SOMMARIO CAPITOLO I LA MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA NELL ELABORAZIONE DOTTRINALE I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. I. 6. I. 7. I. 8. Il retroterra teorico-concettuale alla base della configurazione dell
INDICE SOMMARIO CAPITOLO I LA MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA NELL ELABORAZIONE DOTTRINALE I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. I. 6. I. 7. I. 8. Il retroterra teorico-concettuale alla base della configurazione dell
Management sistemico vitale
 Management sistemico vitale Scelte e decisioni in ambito complesso Corso di Management Prof. Mario Calabrese 23/03/2017 Lezione numero 6 1 I diversi driver del Processo di apprendimento I fili, l ordito
Management sistemico vitale Scelte e decisioni in ambito complesso Corso di Management Prof. Mario Calabrese 23/03/2017 Lezione numero 6 1 I diversi driver del Processo di apprendimento I fili, l ordito
INTRODUZIONE
 Convegno SIREM - SIEL 2014$ 13-14-15 Novembre 2014$ Università degli Studi di Perugia$ Apertura e flessibilità nell istruzione superiore: oltre l e-learning? www.siremsiel2014.it INTRODUZIONE La Società
Convegno SIREM - SIEL 2014$ 13-14-15 Novembre 2014$ Università degli Studi di Perugia$ Apertura e flessibilità nell istruzione superiore: oltre l e-learning? www.siremsiel2014.it INTRODUZIONE La Società
Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo e dell Educazione
 Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo e dell Educazione Modulo condotto dal Dott. Inguscio Lucio, Ph.D. Psicofisiologia, Psicologia Cognitiva e Psicologia della Personalita «Sapienza» Università di Roma
Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo e dell Educazione Modulo condotto dal Dott. Inguscio Lucio, Ph.D. Psicofisiologia, Psicologia Cognitiva e Psicologia della Personalita «Sapienza» Università di Roma
Capitolo IV. L impresa sistema vitale e la complessità
 Capitolo IV L impresa sistema vitale e la complessità Sommario 1. L azione di governo in un contesto complesso 2. La complessità e il pensiero sistemico - il principio di indeterminatezza di Heisenberg
Capitolo IV L impresa sistema vitale e la complessità Sommario 1. L azione di governo in un contesto complesso 2. La complessità e il pensiero sistemico - il principio di indeterminatezza di Heisenberg
Allegato 2/C Giudizi individuali dei commissari sui curricula
 Allegato 2/C Giudizi individuali dei commissari sui curricula Candidato Kalchschmidt Matteo Giacomo Maria: Le attività scientifiche e didattiche del candidato vertono sui temi della gestione aziendale,
Allegato 2/C Giudizi individuali dei commissari sui curricula Candidato Kalchschmidt Matteo Giacomo Maria: Le attività scientifiche e didattiche del candidato vertono sui temi della gestione aziendale,
UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI MILANO. Facoltà di Economia. Corso di Laurea Specialistica in General Management
 UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI MILANO Facoltà di Economia Corso di Laurea Specialistica in General Management L IMPATTO DEI SOCIAL NETWORKS E DEGLI STILI COGNITIVI SULLA PERFORMANCE: UNA RICERCA
UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI MILANO Facoltà di Economia Corso di Laurea Specialistica in General Management L IMPATTO DEI SOCIAL NETWORKS E DEGLI STILI COGNITIVI SULLA PERFORMANCE: UNA RICERCA
Lezione 1: Introduzione. Prof. Massimo Aria
 Lezione 1: Introduzione Corso di Statistica Facoltà di Economia Università della Basilicata Prof. Massimo Aria aria@unina.it Introduzione La Statistica Il termine statistica deriva, nella lingua italiana,
Lezione 1: Introduzione Corso di Statistica Facoltà di Economia Università della Basilicata Prof. Massimo Aria aria@unina.it Introduzione La Statistica Il termine statistica deriva, nella lingua italiana,
2. I modelli concettuali e le condizioni di funzionamento delle aziende famigliari
 SOMMARIO 1. Sul concetto di dimensione aziendale di Giuseppina Iacoviello 1.1. Considerazioni introduttive... 3 1.2. Una possibile lettura della dimensione aziendale... 5 1.3. I fattori interni all azienda...
SOMMARIO 1. Sul concetto di dimensione aziendale di Giuseppina Iacoviello 1.1. Considerazioni introduttive... 3 1.2. Una possibile lettura della dimensione aziendale... 5 1.3. I fattori interni all azienda...
DOMENICO CROCCO PROFILI GIURIDICI DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
 DOMENICO CROCCO PROFILI GIURIDICI DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA JOVENE EDITORE NAPOLI 2012 INDICE Prefazione di Michael Sciascia... p. XI Premessa introduttiva...» 1 CAPITOLO PRIMO L EFFICIENZA
DOMENICO CROCCO PROFILI GIURIDICI DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA JOVENE EDITORE NAPOLI 2012 INDICE Prefazione di Michael Sciascia... p. XI Premessa introduttiva...» 1 CAPITOLO PRIMO L EFFICIENZA
Capitolo 1 Introduzione, Framework Teorico e Metodologia
 Indice Indice delle tabelle Prefazione IX XV XVII Capitolo 1 Introduzione, Framework Teorico e Metodologia 1.1. Introduzione e pianificazione della ricerca 1 1.2. Il Disegno della ricerca 8 1.3. Il Theoretical
Indice Indice delle tabelle Prefazione IX XV XVII Capitolo 1 Introduzione, Framework Teorico e Metodologia 1.1. Introduzione e pianificazione della ricerca 1 1.2. Il Disegno della ricerca 8 1.3. Il Theoretical
Management sistemico vitale
 Management sistemico vitale Scelte e decisioni in ambito complesso Corso di Management Prof. Sergio Barile Prof. Giuseppe Sancetta 10/10/2016 Lezione numero 4 1 Entropia ed informazione Abduzione: primo
Management sistemico vitale Scelte e decisioni in ambito complesso Corso di Management Prof. Sergio Barile Prof. Giuseppe Sancetta 10/10/2016 Lezione numero 4 1 Entropia ed informazione Abduzione: primo
Qualche riflessione sull essere e il divenire dell impresa
 Lezione 1 Qualche riflessione sull essere e il divenire dell impresa prof. ssa Clara Bassano Corso di Economia e Gestione delle Imprese A.A. 2005-2006 Finalità del corso Fornire la metodologia d indagine
Lezione 1 Qualche riflessione sull essere e il divenire dell impresa prof. ssa Clara Bassano Corso di Economia e Gestione delle Imprese A.A. 2005-2006 Finalità del corso Fornire la metodologia d indagine
PARTE PRIMA SVILUPPO AZIENDALE, CONOSCENZA ED ATTIVITÀ DI GOVERNO
 IX Introduzione... XV PARTE PRIMA SVILUPPO AZIENDALE, CONOSCENZA ED ATTIVITÀ DI GOVERNO CAPITOLO I LO SVILUPPO AZIENDALE E IL RUOLO DELLA CONOSCENZA 1. Premessa... 3 2. Lo sviluppo aziendale: sul suo significato
IX Introduzione... XV PARTE PRIMA SVILUPPO AZIENDALE, CONOSCENZA ED ATTIVITÀ DI GOVERNO CAPITOLO I LO SVILUPPO AZIENDALE E IL RUOLO DELLA CONOSCENZA 1. Premessa... 3 2. Lo sviluppo aziendale: sul suo significato
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre
Capitolo I La definizione del problema e il quadro di riferimento teorico: il territorio sistema vitale
 Indice Introduzione 11 Gli autori 17 Parte Prima - IL PROBLEMA DI RICERCA Capitolo I La definizione del problema e il quadro di riferimento teorico: il territorio sistema vitale 1. Ricognizione del concetto
Indice Introduzione 11 Gli autori 17 Parte Prima - IL PROBLEMA DI RICERCA Capitolo I La definizione del problema e il quadro di riferimento teorico: il territorio sistema vitale 1. Ricognizione del concetto
Università di Roma Tor Vergata Dipartimento di Economia e Finanza
 Università di Roma Tor Vergata Dipartimento di Economia e Finanza EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT IL PROGETTO-LABORATORIO AA 2018-2019 1.- GLI OBIETTIVI DEL MASTER L Executive Master in Procurement
Università di Roma Tor Vergata Dipartimento di Economia e Finanza EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT IL PROGETTO-LABORATORIO AA 2018-2019 1.- GLI OBIETTIVI DEL MASTER L Executive Master in Procurement
Società Italiana degli Economisti
 Società Italiana degli Economisti II^ INDAGINE SULLE RIVISTE ITALIANE DI ECONOMIA 2014 a cura di Paolo Pini (Vice Presidente Sie e Coordinatore Curv Commissione Università, Ricerca, Valutazione Sie) Trento,
Società Italiana degli Economisti II^ INDAGINE SULLE RIVISTE ITALIANE DI ECONOMIA 2014 a cura di Paolo Pini (Vice Presidente Sie e Coordinatore Curv Commissione Università, Ricerca, Valutazione Sie) Trento,
BAMBINI E INSEGNANTI A SCUOLA
 6 RICERCHE DOTTORALI DOTTORATO DI RICERCA IN INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE UNIVERSITÀ ROMA TRE Francesca Corradi BAMBINI E INSEGNANTI A SCUOLA Modelli educativi, relazioni intergenerazionali
6 RICERCHE DOTTORALI DOTTORATO DI RICERCA IN INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE UNIVERSITÀ ROMA TRE Francesca Corradi BAMBINI E INSEGNANTI A SCUOLA Modelli educativi, relazioni intergenerazionali
Il governo del Rischio informatico alla luce delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale
 ATTIVITA DI RICERCA 2014 Il governo del Rischio informatico alla luce delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale Metodologie, processi e strumenti PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE 1 TEMI E MOTIVAZIONI
ATTIVITA DI RICERCA 2014 Il governo del Rischio informatico alla luce delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale Metodologie, processi e strumenti PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE 1 TEMI E MOTIVAZIONI
Princìpi e strumenti dell economia aziendale
 Francesco Giaccari ISBN 978-88-6611-570-0 Il volume, rivolto primariamente agli studenti dei corsi di laurea magistrali, fornisce un supporto per l approfondimento di alcuni dei temi più rilevanti dell
Francesco Giaccari ISBN 978-88-6611-570-0 Il volume, rivolto primariamente agli studenti dei corsi di laurea magistrali, fornisce un supporto per l approfondimento di alcuni dei temi più rilevanti dell
METODI DI RICERCA E DI VALUTAZIONE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
 METODI DI RICERCA E DI VALUTAZIONE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO LUMSA 2016-17 Dott.ssa Giulia Pecora giulia.pecora@uniroma1.it Il prodotto della ricerca E il principale mezzo che la comunità scientifica
METODI DI RICERCA E DI VALUTAZIONE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO LUMSA 2016-17 Dott.ssa Giulia Pecora giulia.pecora@uniroma1.it Il prodotto della ricerca E il principale mezzo che la comunità scientifica
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "M. Fanno" - DSEA per il settore
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "M. Fanno" - DSEA per il settore
Matematica e Statistica Referente nazionale Prof. G. Anzellotti. Università di Genova Dipartimento di Matematica (DIMA)
 Matematica e Statistica Referente nazionale Prof. G. Anzellotti Università di Genova Dipartimento di Matematica (DIMA) Referente locale Prof. M.E.Rossi PLS al DIMA Tre azioni: 1. Laboratori PLS 2. Stages
Matematica e Statistica Referente nazionale Prof. G. Anzellotti Università di Genova Dipartimento di Matematica (DIMA) Referente locale Prof. M.E.Rossi PLS al DIMA Tre azioni: 1. Laboratori PLS 2. Stages
Esercitazioni: Ore: Argomenti: 4 Tassi e quozienti Costruzione tavole di mortalità Previsioni demografiche
 Indicatori statistici per lo sviluppo + Demografia dello sviluppo Cooperazione e sviluppo Codice: 13480 SSD: SECS-S/05 CFU: 6+3 Parte del modulo inserita Demografia dello sviluppo Titolo del corso: Laurea
Indicatori statistici per lo sviluppo + Demografia dello sviluppo Cooperazione e sviluppo Codice: 13480 SSD: SECS-S/05 CFU: 6+3 Parte del modulo inserita Demografia dello sviluppo Titolo del corso: Laurea
Prof.ssa Cinzia DESSI. Economia e Organizzazione Aziendale. Il Programma. Industriali A.A. A.A primo primo semestre
 Prof.ssa Cinzia DESSI Economia e Organizzazione Aziendale Il Programma Università degli degli studi studi di di Cagliari Cagliari Corso Corso di di Laurea Laurea in in Biotecnologie Industriali A.A. A.A.
Prof.ssa Cinzia DESSI Economia e Organizzazione Aziendale Il Programma Università degli degli studi studi di di Cagliari Cagliari Corso Corso di di Laurea Laurea in in Biotecnologie Industriali A.A. A.A.
Giuliano Vettorato Eb0921 AA
 Giuliano Vettorato Eb0921 AA 2015-2016 1. quadro di riferimento teorico 2.lettura fenomenologica e interpretativa 3. conoscenza sistematica delle problematiche dei giovani Offrire dei quadri di riferimento
Giuliano Vettorato Eb0921 AA 2015-2016 1. quadro di riferimento teorico 2.lettura fenomenologica e interpretativa 3. conoscenza sistematica delle problematiche dei giovani Offrire dei quadri di riferimento
RISULTATI QUESTIONARIO GRADIMENTO
 Università degli Studi di Messina RISULTATI QUESTIONARIO GRADIMENTO CORSO di FORMAZIONE Le novità apportate dal regolamento d attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture
Università degli Studi di Messina RISULTATI QUESTIONARIO GRADIMENTO CORSO di FORMAZIONE Le novità apportate dal regolamento d attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture
Lezione 5 Relazioni famiglia-impresa nelle PMI italiane
 Family Business Lezione 5 Relazioni famiglia-impresa nelle PMI italiane Contenuti La doppia prospettiva di proprietà e governance La prospettiva contrattuale La prospettiva relazionale Alcuni aspetti sulla
Family Business Lezione 5 Relazioni famiglia-impresa nelle PMI italiane Contenuti La doppia prospettiva di proprietà e governance La prospettiva contrattuale La prospettiva relazionale Alcuni aspetti sulla
Relazione Riassuntiva
 PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P01 PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P01 PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CIBERNETICA E SISTEMA
 CIBERNETICA E SISTEMA Dott. Antonio Caruso, psicologo psicoterapeuta direttore del Centro Panta Rei 1 Teoria di Campo (K. Lewin) Realtà psichica come sistema dinamico che comprende la persona e il suo
CIBERNETICA E SISTEMA Dott. Antonio Caruso, psicologo psicoterapeuta direttore del Centro Panta Rei 1 Teoria di Campo (K. Lewin) Realtà psichica come sistema dinamico che comprende la persona e il suo
Filosofia e acquisizione di competenze. Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 17 novembre 2014
 Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 17 novembre 2014 1. Che cosa si intende per competenza? 2. Come si insegnano o trasferiscono
Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 17 novembre 2014 1. Che cosa si intende per competenza? 2. Come si insegnano o trasferiscono
La Valutazione dei progetti a partire dalla conoscenza delle situazioni decisionali
 La Valutazione dei progetti a partire dalla conoscenza delle situazioni decisionali La proposta metodologica per i progetti del Piano Strategico di Pesaro Mercoledì 5 aprile 2006 - Pesaro 0- Organizzazione
La Valutazione dei progetti a partire dalla conoscenza delle situazioni decisionali La proposta metodologica per i progetti del Piano Strategico di Pesaro Mercoledì 5 aprile 2006 - Pesaro 0- Organizzazione
BANDO D.D. 1532/2016 SETTORE CONCORSUALE 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO CANDIDATO: TARASCO Antonio - FASCIA: I GIUDIZIO COLLEGIALE:
 BANDO D.D. 1532/2016 SETTORE CONCORSUALE 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO CANDIDATO: TARASCO Antonio - FASCIA: I GIUDIZIO COLLEGIALE: GIUDIZIO: Antonio Leo Tarasco è dirigente MIBACT. Ha fornito un contributo
BANDO D.D. 1532/2016 SETTORE CONCORSUALE 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO CANDIDATO: TARASCO Antonio - FASCIA: I GIUDIZIO COLLEGIALE: GIUDIZIO: Antonio Leo Tarasco è dirigente MIBACT. Ha fornito un contributo
INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE
 i INTRODUZIONE 1. Considerazioni preliminari sul difficile processo di valorizzazione di un sistema autonomistico che oscilla tra regionalismo e municipalismo... 1 2. Riflessioni sull opportunità di implementare
i INTRODUZIONE 1. Considerazioni preliminari sul difficile processo di valorizzazione di un sistema autonomistico che oscilla tra regionalismo e municipalismo... 1 2. Riflessioni sull opportunità di implementare
INDICE PREMESSA 15 INTRODUZIONE 19 CAPITOLO PRIMO L AGIRE IMPRENDITORIALE ED IL GOVERNO D IMPRESA
 5 INDICE PREMESSA 15 INTRODUZIONE 19 CAPITOLO PRIMO L AGIRE IMPRENDITORIALE ED IL GOVERNO D IMPRESA 1. Il governo dell agire 35 1.1 Una proposta di teoria dell agire imprenditoriale 35 1.2 L agire distinto
5 INDICE PREMESSA 15 INTRODUZIONE 19 CAPITOLO PRIMO L AGIRE IMPRENDITORIALE ED IL GOVERNO D IMPRESA 1. Il governo dell agire 35 1.1 Una proposta di teoria dell agire imprenditoriale 35 1.2 L agire distinto
Valentina Evangelista Sistemi locali di innovazione
 A13 Valentina Evangelista Sistemi locali di innovazione Copyright MMXII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065 isbn
A13 Valentina Evangelista Sistemi locali di innovazione Copyright MMXII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065 isbn
I LIVELLI DELLA CONOSCENZA. Francesco Maria Olivieri
 I LIVELLI DELLA CONOSCENZA Francesco Maria Olivieri Indice 1. APPROCCIO SISTEMICO ----------------------------------------------------------------------- 3 2. SISTEMI CHIUSI VS SISTEMI APERTI -----------------------------------------------------
I LIVELLI DELLA CONOSCENZA Francesco Maria Olivieri Indice 1. APPROCCIO SISTEMICO ----------------------------------------------------------------------- 3 2. SISTEMI CHIUSI VS SISTEMI APERTI -----------------------------------------------------
IL SENSO DELLA PSICOLOGIA
 INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA GENERALE IL SENSO DELLA PSICOLOGIA PROF.SSA ANNAMARIA SCHIANO Indice 1 IL SENSO DELLA PSICOLOGIA -----------------------------------------------------------------------------------------
LICEO GINNASIO STATALE G. B. BROCCHI Bassano del Grappa -VI. Progettazione didattico educativa di dipartimento CLASSE
 Pagina 1 di 8 DIPARTIMENTO DISCIPLINA CLASSE INDIRIZZO LETTERE LATINO 1 A E 2 A LICEO LINGUISTICO-SCIENTIFICO DELLE SCIENZE UMANE OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA
Pagina 1 di 8 DIPARTIMENTO DISCIPLINA CLASSE INDIRIZZO LETTERE LATINO 1 A E 2 A LICEO LINGUISTICO-SCIENTIFICO DELLE SCIENZE UMANE OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ COMPETENZA
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN
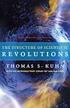 I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
I PARADIGMI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE DI KUHN Corso di Dottorato di Ricerca Lezioni di Filosofia e Metodologia della Ricerca Scientifica Giacomo Zanni Dipartimento ENDIF Università di Ferrara Thomas
Il percorso didattico presenta caratteristiche di trasversalità nell'approccio alle conoscenze, ispirate dai seguenti motivi:
 Classi IV 2018-2019 PROGRAMMAZIONE AMBITO ANTROPOLOGICO Il percorso didattico presenta caratteristiche di trasversalità nell'approccio alle conoscenze, ispirate dai seguenti motivi: pedagogici: per stimolare
Classi IV 2018-2019 PROGRAMMAZIONE AMBITO ANTROPOLOGICO Il percorso didattico presenta caratteristiche di trasversalità nell'approccio alle conoscenze, ispirate dai seguenti motivi: pedagogici: per stimolare
Economia e Gestione delle imprese
 Economia e Gestione delle imprese Anno accademico 2019/2020 Dipartimento di Management Il docente Posizione accademica Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P 08) 2 Obiettivi
Economia e Gestione delle imprese Anno accademico 2019/2020 Dipartimento di Management Il docente Posizione accademica Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P 08) 2 Obiettivi
PIANO INTERNO INTEGRATO DELLE AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA DI GENERE
 Area di Integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali PIANO INTERNO INTEGRATO DELLE AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA DI GENERE approvato
Area di Integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali PIANO INTERNO INTEGRATO DELLE AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA DI GENERE approvato
FIDUCIA NELLE RETI. Strategie per la crescita nei mercati internazionali delle PMI BARBARA MASIELLO. Editoriale Scientifica Napoli
 BARBARA MASIELLO FIDUCIA NELLE RETI Strategie per la crescita nei mercati internazionali delle PMI prefazione di Francesco Izzo Editoriale Scientifica Napoli Tutti i diritti sono riservati 2013 Editoriale
BARBARA MASIELLO FIDUCIA NELLE RETI Strategie per la crescita nei mercati internazionali delle PMI prefazione di Francesco Izzo Editoriale Scientifica Napoli Tutti i diritti sono riservati 2013 Editoriale
ECONOMIA, SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA: VALUTARE LA QUALITÀ DEI SISTEMI LOCALI ALLEGATO: REALIZZARE UN ANALISI SWOT Giulia Pesaro
 n.1 Fondazione Cariplo progetto Capacity building REesilienceLAB http://www.resiliencelab.eu Incontri di formazione Resilienza urbana e territoriale incontri di formazione 1 aprile 2014 APPROCCI E STRUMENTI
n.1 Fondazione Cariplo progetto Capacity building REesilienceLAB http://www.resiliencelab.eu Incontri di formazione Resilienza urbana e territoriale incontri di formazione 1 aprile 2014 APPROCCI E STRUMENTI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Cesare De Titta - E. Fermi
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Cesare De Titta - E. Fermi LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO ECONOMICO SOCIALE LICEO LINGUISTICO L O S T U D I O R E N DE P O S S I B I L E L I M P O S S I B I L E Indirizzo
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Cesare De Titta - E. Fermi LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO ECONOMICO SOCIALE LICEO LINGUISTICO L O S T U D I O R E N DE P O S S I B I L E L I M P O S S I B I L E Indirizzo
EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT
 Facoltà di Economia Dipartimento Di Economia e Finanza EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT IL PROGETTO-LABORATORIOO AA 2019-2020 1.- GLI OBIETTIVI DEL MASTER L Executive Master in Procurement Management
Facoltà di Economia Dipartimento Di Economia e Finanza EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT IL PROGETTO-LABORATORIOO AA 2019-2020 1.- GLI OBIETTIVI DEL MASTER L Executive Master in Procurement Management
Criteri per la verifica della consistenza
 Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT Formazione professionale Criteri per la verifica della consistenza Elaborazione di ordinanze
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT Formazione professionale Criteri per la verifica della consistenza Elaborazione di ordinanze
Indice. Prefazione. Capitolo primo Le risorse immateriali: aspetti definitori 1. Capitolo secondo L immaterialità nel bilancio d esercizio 29
 Indice IX Capitolo primo Le risorse immateriali: aspetti definitori 1 1.1 Premessa 1 1.2 Tendenze evolutive negli studi economico-aziendali 5 1.3 Aspetti definitori e caratteristiche qualificanti 14 1.3.1
Indice IX Capitolo primo Le risorse immateriali: aspetti definitori 1 1.1 Premessa 1 1.2 Tendenze evolutive negli studi economico-aziendali 5 1.3 Aspetti definitori e caratteristiche qualificanti 14 1.3.1
CAPITOLO CAPIT 0 Cultura organizzativa e valori ganizza etici
 CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
CAPITOLO 10 Cultura organizzativa e valori etici Agenda Cultura organizzativa Cultura e progettazione Cultura e performance Valori etici nelle organizzazioni Responsabilità sociale d impresa Formare cultura
Glauco Carlesi Misurazioni di processo e sistemi informativi a supporto delle strategie aziendali
 A13 69 Glauco Carlesi Misurazioni di processo e sistemi informativi a supporto delle strategie aziendali ARACNE Copyright MMIV ARACNE EDITRICE S.r.l. www.aracne editrice.it info@aracne editrice.it 00173
A13 69 Glauco Carlesi Misurazioni di processo e sistemi informativi a supporto delle strategie aziendali ARACNE Copyright MMIV ARACNE EDITRICE S.r.l. www.aracne editrice.it info@aracne editrice.it 00173
Università degli Studi di Perugia Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l Economia. Econometria. Introduzione al corso
 Università degli Studi di Perugia Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l Economia Econometria Introduzione al corso Febbraio 2015 Anno Accademico 2014-2015 D. Aristei Econometria
Università degli Studi di Perugia Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l Economia Econometria Introduzione al corso Febbraio 2015 Anno Accademico 2014-2015 D. Aristei Econometria
Progetto di azioni formative rivolte alla famiglia ( parte sperimentale del Programma Domus)
 Progetto di azioni formative rivolte alla famiglia ( parte sperimentale del Programma Domus) Premessa Il progetto presentato si muove nell ambito di una strategia di sostegno delle famiglie romane, realizzando:
Progetto di azioni formative rivolte alla famiglia ( parte sperimentale del Programma Domus) Premessa Il progetto presentato si muove nell ambito di una strategia di sostegno delle famiglie romane, realizzando:
Corso di Studio Magistrale in Strategia d Impresa e Management. Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail Maurizio Maraglino Misciagna
 Principali informazioni sull insegnamento Titolo insegnamento Corso di studio Crediti formativi Denominazione inglese Obbligo di frequenza Lingua di erogazione Economia dell innovazione (SSD SECS P/01)
Principali informazioni sull insegnamento Titolo insegnamento Corso di studio Crediti formativi Denominazione inglese Obbligo di frequenza Lingua di erogazione Economia dell innovazione (SSD SECS P/01)
Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (triennale classe L-18)
 Insegnamento Livello e corso di studio Settore scientifico disciplinare (SSD) ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (triennale classe L-18) SECS-P/08 Anno
Insegnamento Livello e corso di studio Settore scientifico disciplinare (SSD) ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (triennale classe L-18) SECS-P/08 Anno
LINGUA E CULTURA LATINA classe prima
 1 LINGUA E CULTURA LATINA classe prima Indicazioni nazionali ministeriali LATINO LINGUA Competenze 1. PADRONANZA DEI FONDAMENTALI STRUMENTI ESPRESSIVI DISCIPLINARI 2. RIFLESSIONE METALINGUISTICA ATTRAVERSO
1 LINGUA E CULTURA LATINA classe prima Indicazioni nazionali ministeriali LATINO LINGUA Competenze 1. PADRONANZA DEI FONDAMENTALI STRUMENTI ESPRESSIVI DISCIPLINARI 2. RIFLESSIONE METALINGUISTICA ATTRAVERSO
Corso di Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO
 Corso di Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO La relazione finale di tirocinio presenta in modo critico, riflessivo, concettualmente fondato
Corso di Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO La relazione finale di tirocinio presenta in modo critico, riflessivo, concettualmente fondato
MATEMATICA classe prima
 1 MATEMATICA classe prima Indicazioni nazionali ministeriali Competenze 1. UTILIZZARE LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO 2. INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI
1 MATEMATICA classe prima Indicazioni nazionali ministeriali Competenze 1. UTILIZZARE LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO 2. INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI
POLITICHE PUBBLICHE E FORMAZIONE. PROCESSI DECISIONALI E STRATEGIE
 POLITICHE PUBBLICHE E FORMAZIONE. PROCESSI DECISIONALI E STRATEGIE CORSO DI ALTA FORMAZIONE LO SCENARIO La ricchezza dell Europa è nel sapere e nella capacità delle sue persone: questa è la chiave per
POLITICHE PUBBLICHE E FORMAZIONE. PROCESSI DECISIONALI E STRATEGIE CORSO DI ALTA FORMAZIONE LO SCENARIO La ricchezza dell Europa è nel sapere e nella capacità delle sue persone: questa è la chiave per
Syllabus Descrizione del Modulo
 Titolo del modulo: Numero del modulo nel piano degli studi: Responsabile del modulo Corso di studio: Syllabus Descrizione del Modulo Linguistica e Didattica della L1 6 Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Titolo del modulo: Numero del modulo nel piano degli studi: Responsabile del modulo Corso di studio: Syllabus Descrizione del Modulo Linguistica e Didattica della L1 6 Corso di Laurea Magistrale in Scienze
SOMMARIO PREFAZIONE... XIII INTRODUZIONE... XVII PARTE I - ASPETTI TEORICI E METODI DI MISURAZIONE
 SOMMARIO PREFAZIONE... XIII INTRODUZIONE... XVII PARTE I - ASPETTI TEORICI E METODI DI MISURAZIONE Capitolo I - La misurazione del capitale umano: tematiche di base e sviluppi recenti... 3 1. La nozione
SOMMARIO PREFAZIONE... XIII INTRODUZIONE... XVII PARTE I - ASPETTI TEORICI E METODI DI MISURAZIONE Capitolo I - La misurazione del capitale umano: tematiche di base e sviluppi recenti... 3 1. La nozione
Riflessioni sull ASN
 Riflessioni sull ASN Roma, 7 ottobre 2016 Francesco Ballio 1 il documento GII luglio 2015 premesse Obiettivo: cosa vuol dire essere un buon ricercatore nelle nostre discipline riferimento per i giovani
Riflessioni sull ASN Roma, 7 ottobre 2016 Francesco Ballio 1 il documento GII luglio 2015 premesse Obiettivo: cosa vuol dire essere un buon ricercatore nelle nostre discipline riferimento per i giovani
INDICE. Prefazione...pag. XV PARTE PRIMA SCIENTIFICITÀ E CONSAPEVOLEZZA NELL AZIONE DI GOVERNO CAPITOLO PRIMO
 Prefazione...pag. XV PARTE PRIMA SCIENTIFICITÀ E CONSAPEVOLEZZA NELL AZIONE DI GOVERNO CAPITOLO PRIMO L AZIONE DI GOVERNO TRA COMPETITIVITÀ E CONSONANZA 1.1. Considerazioni introduttive...» 3 1.2. L azione
Prefazione...pag. XV PARTE PRIMA SCIENTIFICITÀ E CONSAPEVOLEZZA NELL AZIONE DI GOVERNO CAPITOLO PRIMO L AZIONE DI GOVERNO TRA COMPETITIVITÀ E CONSONANZA 1.1. Considerazioni introduttive...» 3 1.2. L azione
L ANALISI DISCIPLINARE
 L ANALISI DISCIPLINARE Alessandro Benedetti Analisi disciplinare 1 Una definizione di DISCIPLINA problemi argomenti metodi Analisi disciplinare 2 Definizione... Si può dire che la programmazione disciplinare
L ANALISI DISCIPLINARE Alessandro Benedetti Analisi disciplinare 1 Una definizione di DISCIPLINA problemi argomenti metodi Analisi disciplinare 2 Definizione... Si può dire che la programmazione disciplinare
Teoria trasformativa: i fondamenti
 Teoria trasformativa: i fondamenti Teoria trasformativa: i fondamenti L importanza del contesto sociale nell apprendimento trasformativo L interpretazione come costruzione del significato di un esperienza
Teoria trasformativa: i fondamenti Teoria trasformativa: i fondamenti L importanza del contesto sociale nell apprendimento trasformativo L interpretazione come costruzione del significato di un esperienza
Gesti di Cura. Elementi introduttivi per una pedagogia delle relazioni d aiuto
 Cristiana Bandini - Massimiliano Gallo Gesti di Cura. Elementi introduttivi per una pedagogia delle relazioni d aiuto Collana Didattica 04 Cristiana Bandini - Massimiliano Gallo Gesti di Cura. Elementi
Cristiana Bandini - Massimiliano Gallo Gesti di Cura. Elementi introduttivi per una pedagogia delle relazioni d aiuto Collana Didattica 04 Cristiana Bandini - Massimiliano Gallo Gesti di Cura. Elementi
Syllabus Descrizione del Modulo
 Syllabus Descrizione del Modulo Titolo del modulo: Linguistica e Didattica della L1 Numero del modulo nel piano degli 6 studi: Responsabile del modulo Dal Negro Silvia Corso di studio: Scienze della Formazione
Syllabus Descrizione del Modulo Titolo del modulo: Linguistica e Didattica della L1 Numero del modulo nel piano degli 6 studi: Responsabile del modulo Dal Negro Silvia Corso di studio: Scienze della Formazione
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE DI FISICA
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE DI FISICA INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI Analizzare Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE DI FISICA INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI Analizzare Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie
Capitolo I significati dell apprendere. Capitolo I significati dell apprendere
 Crisi del soggetto: Incrinature della soggettività indotte dall emergere delle istanze a-razionali, meta-razionali e irrazionali della mente crisi della scienza: a) Principio di indeterminazione b) Superamento
Crisi del soggetto: Incrinature della soggettività indotte dall emergere delle istanze a-razionali, meta-razionali e irrazionali della mente crisi della scienza: a) Principio di indeterminazione b) Superamento
Le prove INVALSI del 2018 Novità e caratteristiche
 Le prove INVALSI del 2018 Novità e caratteristiche Anna Maria Ajello Presidente INVALSI Roma, MIUR - 5 luglio 2018 Le novità Introduzione della prova di Inglese (grado 5 e 8) Prove al computer (CBT: grado
Le prove INVALSI del 2018 Novità e caratteristiche Anna Maria Ajello Presidente INVALSI Roma, MIUR - 5 luglio 2018 Le novità Introduzione della prova di Inglese (grado 5 e 8) Prove al computer (CBT: grado
Indicazioni Nazionali ed Esame di Stato per il Liceo Scientifico Claudio Zanone
 Indicazioni Nazionali ed Esame di Stato per il Liceo Scientifico Claudio Zanone Probabilità e Indicazioni Nazionali: primo biennio Probabilità e Indicazioni Nazionali: competenze primo biennio Probabilità
Indicazioni Nazionali ed Esame di Stato per il Liceo Scientifico Claudio Zanone Probabilità e Indicazioni Nazionali: primo biennio Probabilità e Indicazioni Nazionali: competenze primo biennio Probabilità
I.I.S Niccolò Machiavelli Pioltello
 Pagina 1 di 5 Materia MATEMATICA (secondo biennio) Anno Scolastico 2015-2016 Componenti del Consiglio di Materia: Docente Prof. Serafino Maria Antonia (Coordinatore di Materia) Prof. Adobbati Mauro Prof.
Pagina 1 di 5 Materia MATEMATICA (secondo biennio) Anno Scolastico 2015-2016 Componenti del Consiglio di Materia: Docente Prof. Serafino Maria Antonia (Coordinatore di Materia) Prof. Adobbati Mauro Prof.
Infanzia e linguaggi teatrali Gli esiti di una ricerca a Milano PLAYMAKERS BAMBINI E ADULTI CO -AUTORI DELLA SCENA SOCIALE
 Infanzia e linguaggi teatrali Gli esiti di una ricerca a Milano PLAYMAKERS BAMBINI E ADULTI CO -AUTORI DELLA SCENA SOCIALE UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO, 14 MAGGIO 2018 L avvio Domande
Infanzia e linguaggi teatrali Gli esiti di una ricerca a Milano PLAYMAKERS BAMBINI E ADULTI CO -AUTORI DELLA SCENA SOCIALE UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO, 14 MAGGIO 2018 L avvio Domande
Le immagini sono state curate da Luigi Riccitiello, Laboratorio RED del DPTU dell Università La Sapienza di Roma.
 Le immagini sono state curate da Luigi Riccitiello, Laboratorio RED del DPTU dell Università La Sapienza di Roma. Carlo G. Nuti La progettazione urbanistica nella formazione dell architetto Saggi di Adelaide
Le immagini sono state curate da Luigi Riccitiello, Laboratorio RED del DPTU dell Università La Sapienza di Roma. Carlo G. Nuti La progettazione urbanistica nella formazione dell architetto Saggi di Adelaide
Prof. Roberto Melchiori
 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PSICOLOGICHE DEL LAVORO E DELLE Anno Accademico2013/2014 PROGRAMMA DEL CORSO DI Pedagogia sperimentale Prof. Roberto
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PSICOLOGICHE DEL LAVORO E DELLE Anno Accademico2013/2014 PROGRAMMA DEL CORSO DI Pedagogia sperimentale Prof. Roberto
